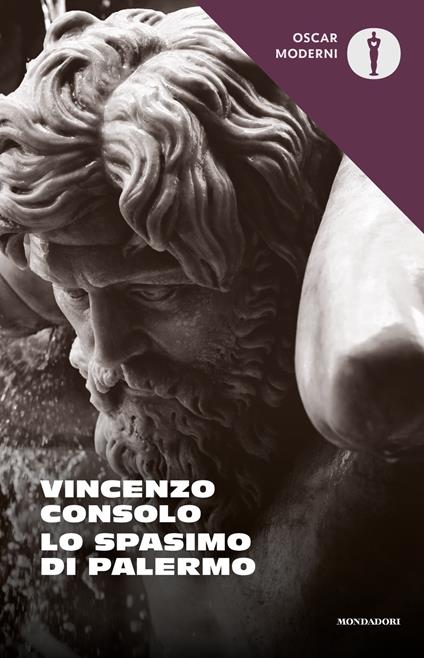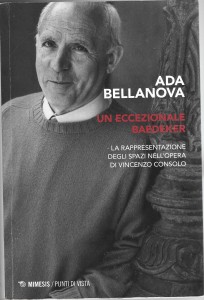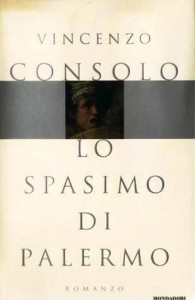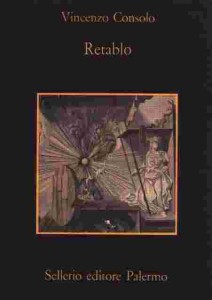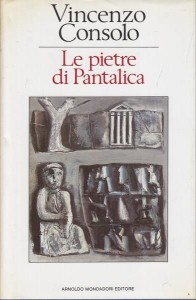Tag: L’olivo e L’olivastro
Narratori Fedele alla sua Sicilia, militante, dolceamaro, mai «facile». Il lascito dello scrittore a dieci anni dalla scomparsa
Il volto del Mediterraneo ha il sorriso di Consolo
di Paolo Di Stefano
Èvero che, oggi più di ieri, non c’è da scommettere nulla sulla sopravvivenza degli scrittori (anche dei cosiddetti «classici») nella memoria collettiva di un Paese. Chissà quanti dei lettori forti, quelli cioè che leggono almeno un libro al mese, conoscono Vincenzo Consolo, nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, e morto dieci anni fa a Milano. Eppure, Consolo è senza dubbio, come ha sancito la critica più attendibile, uno dei maggiori narratori del secondo Novecento: un Meridiano, curato da Gianni Turchetta nel 2015 e introdotto da Cesare Segre, raccoglie l’opera completa come si fa per gli autori entrati nel canone. Non è uno scrittore facile, Consolo, ma di quelli che hanno un riconoscimento sicuro non solo per la sua visione della storia (è soprattutto autore di romanzi storici, di cui però rifiutava la definizione di genere) ma anche grazie alla assoluta originalità dello stile con cui la storia viene raccontata e in qualche misura sfidata: una scelta «archeologica» che richiede una continua ricerca e una perenne voglia di sperimentare.

Quando gli si chiedeva dove si collocava idealmente come scrittore, Consolo rispondeva in prima battuta pensando al linguaggio e denunciando il rifiuto di uno stile comunicativo: pertanto tra i due filoni letterari definiti un po’ artificiosamente da Gianfranco Contini, quello monolinguista e quello espressionista, Consolo optava decisamente per il secondo, in parte verghiano, in parte gaddiano-barocco, ormai divenuto minoritario. Lui che era stato per una vita amico di Leonardo Sciascia diceva di porsi, per le scelte stilistiche, sulla sponda opposta: non solo rispetto a Sciascia (che a sua volta parlò scherzosamente di Consolo come di un parricida, sentendosi lui il padre), ma anche rispetto a Tomasi di Lampedusa, Moravia, Morante, Calvino. E riteneva fallita l’utopia unitaria del famoso «risciacquo in Arno» di Manzoni, che pure considerava un modello «sacramentale» per la capacità di mettere in scena la storia (quella secentesca) come metafora universale. Quell’utopia era fallita perché era naufragata, secondo Consolo, la società italiana moderna, da cui era nata una superlingua piatta, tecnologico-aziendale e mediatica, che faceva ribrezzo anche a Pasolini, per il quale l’omologazione linguistica (con il conseguente tramonto dei dialetti) era il segno più visibile di un nuovo fascismo.
Dunque, per Consolo l’opzione linguistica ha una valenza non estetica ma politica, di resistenza e di opposizione, che si traduce sulla pagina in una moltiplicazione di livelli, di generi, di registri, di stili, di voci: la sua è una lingua di lingue, cui si accompagna la pluralità dei punti di vista, una lingua ricchissima, un impasto di dialetti, preziosismi, arcaismi, echi dal greco, dal latino, dallo spagnolo, dal francese, dall’arabo, eccetera, il miscuglio dei depositi di civiltà sedimentati nella storia siciliana. Se per Consolo la letteratura è memoria dolorosa e irrisolta, essa è alimentata da una memoria linguistica altrettanto dolorosa, conflittuale e composita. Anche per questo, è giusto inserire Consolo dentro la vasta e plurima cultura mediterranea, come suggeriva il convegno milanese del 2019, di cui ora vengono pubblicati gli atti (Mimesis, pagine 233, e 20), a cura di Turchetta, sotto un titolo molto significativo: «Questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto», tra virgolette perché così lo scrittore intendeva il Mediterraneo, ma anche la Sicilia, che ne era (ne è) la sintesi.
Inutile negarselo. Leggere il capolavoro di Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, non è una passeggiata in aperta campagna: è vero che si pone nel solco della narrativa sicula sui moti risorgimentali, dal Mastro-don Gesualdo di Verga a I vicerè di De Roberto al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, quella narrativa che affronta il Risorgimento come un grumo di opportunismi, di miserie, di compromessi, di astuzie, di contraddizioni mai veramente superate. E però Consolo lo fa a modo suo, con tutta la diffidenza per le imposture della storia (si è parlato di anti-Gattopardo), facendo dialogare tra loro i documenti, frammentando i punti di vista e moltiplicando le voci. Del resto, non è una passeggiata neanche leggere Proust o Gadda o Faulkner o Céline o Joyce: ma ciò non toglie nulla alla loro grandezza e al piacere della lettura, anzi è una conquista di senso ad ogni frase. Scriveva giustamente qualche giorno fa Paolo Di Paolo sulla «Stampa» che la battuta di Valérie Perrin al Salone del Libro sulla noia che le procura la lettura della Recherche è una battuta irritante e populista: tesa solo a conquistarsi l’applauso del pubblico (arrivato puntualmente).
Il fatto è che la scrittura di Consolo viene fuori da un rovello morale e civile, non certo da una felicità narrativa spensierata. Ma i nodi e le interferenze inattese, simmetriche alle tragiche e spesso incomprensibili emergenze storiche, come ha scritto Cesare Segre, sono narrate in una prosa ritmica, «quasi colonna sonora di un viaggio nella storia che è anche, o soprattutto, giudizio sul tempo presente». Un «passo di danza», lo chiamava Consolo, che deriva anche dalla sensibilità lirica (accesa certamente dall’ammirazione per il poeta «barocco» Lucio Piccolo, il barone esoterico di Capo d’Orlando, cugino di Tomasi).
Musica della narrazione e implicito richiamo (per ipersensibilità etica) al presente sono la benzina dei suoi libri, si tratti dei romanzi, dal libro d’esordio La ferita dell’aprile (1963), romanzo di formazione autobiografico sul dopoguerra, si tratti di quel viaggio irreale nella Sicilia del Settecento che è Retablo (1987), fino a Nottetempo, casa per casa (1992) e a Lo spasimo di Palermo (1998). Si tratti dei saggi-racconti-reportage de Le pietre di Pantalica o de L’ulivo e l’olivastro o delle sequenze di quello specialissimo incrocio tra «operetta morale» e cuntu popolare (così Turchetta) che è Lunaria, definita dall’autore una «favola teatrale» (la magnifica trasposizione musicale di Etta Scollo è stata eseguita per i Concerti del Quirinale domenica scorsa e trasmessa da RadioRai3).
Il sorriso dolceamaro di Vincenzo assomigliava a quello dipinto da Antonello da Messina nella tavoletta che ispirò il suo capolavoro, ma si aggiungeva un che di dispettoso e di infantile, e soprattutto si accendeva o si oscurava, da lontano, al pensiero della Sicilia. L’ossessione di Consolo, come quella di tanti scrittori siciliani (tutti?), era la Sicilia, da cui partì verso Milano poco più che ragazzo prima per studiare, negli Anni 50, poi definitivamente nel 1968. I 58 elzeviri pubblicati sul «Corriere» non tradiscono la ferrea fedeltà verso la sua isola, a cominciare dal primo, datato 19 ottobre 1977, sulla «paralisi» della Sicilia paragonata alla malinconia di cui è vittima il «lupanariu», ovvero colui il quale è colpito dai malefici del lupo mannaro nelle notti di luna piena.
Ricordava, Consolo, che da studente dell’Università Cattolica, alloggiando in piazza Sant’Ambrogio, vedeva dalla sua finestra i minatori che dal vicino centro di smistamento immigrati, dopo la selezione medica, il casco e la lanterna in mano, salivano sui tram per prepararsi a partire, dalla Stazione Centrale, verso i bacini carboniferi del Belgio, e qualcuno certamente sarebbe andato a morire a Marcinelle o in altre miniere… Lo raccontò anche in un articolo del 1990 in cui recensiva i primi libri-testimonianza dei migranti africani che allora si chiamavano «extracomunitari» o «vu’ cumprà». Sono, è evidente, interventi sempre militanti, come quelli pubblicati per una vita in altri giornali: «L’Ora», «Il Messaggero», «La Stampa», «il Manifesto», «L’Espresso»…
Il 21 novembre 1989 gli toccò ricordare l’amico e maestro Leonardo, morto il giorno prima a Palermo. Cominciava evocando i luoghi reali e quelli immaginari dell’amico e accostandoli a quelli di Faulkner e di Camus: «Racalmuto, Regalpetra: la sua Yoknatapawpha, la sua Orano. La sua, di Leonardo Sciascia. Credo che non si possa capire questo straordinario uomo e questo grande scrittore, al di là o al di qua del più vasto teatro della Sicilia, dell’Italia o della civiltà mediterranea, senza questo piccolo mondo, questo suo piccolo paese di nascita e formazione, sperduto nella profonda Sicilia. Un paese “diverso”, singolare». Tutto diverso e singolare, in Sicilia, tutto sperduto e profondo.
Corriere della sera
20 gennaio 2022 pag.32
La mafia per Vincenzo Consolo: uno sciacallo che ci assomiglia

Vincenzo Consolo (a destra) con Leonardo Sciascia nel 1966
di Tano Grasso
Vincenzo Consolo, “Cosa Loro. Mafie tra cronaca e riflessione”, Bompiani, pp. 320, euro 18.
Sono dieci anni che Vincenzo Consolo, uno dei più importanti scrittori del secondo Novecento italiano, non è più tra noi. L’editore Bompiani nel 2017 ha mandato in stampa un libro, curato con intelligenza e competenza da Nicolò Messina, che raccoglie una serie di articoli, saggi, introduzioni pubblicati su riviste e quotidiani dal 1970 al 2010, sessantaquattro pezzi ordinati cronologicamente sulle “mafie tra cronaca e riflessione”.

Uno scrittore così intimamente legato alla sua Sicilia, con tormento, con affetto, con dolore, con speranza, non poteva non confrontarsi con la questione mafiosa che, purtroppo, in larga parte ha segnato un pezzo di storia dell’isola; e questa ambivalenza trova espressione nell’uso dell’immagine omerica dell’olivo e dell’olivastro, che aveva già dato il titolo ad uno dei suoi libri, per spiegare «il duplice atroce destino della Sicilia» (p. 257).
Consolo è stato poeta delle “profondità”, romanziere che non ha avuto mai timore a scandagliare le viscere più inquiete e meno consolatorie, e poi tentare, cercare di trovare, d’offrire spiegazioni e, come nel “Sorriso dell’ignoto marinaio”, suggerire soluzioni, vie d’uscita, a volte di fuga. Ogni suo romanzo, ogni sua parola rimanda alla Sicilia, alla sua bellezza e alle sue tragedie.
Il 23 maggio del 1992 sull’autostrada a Capaci esplode il tritolo in un Paese allo sbando, senza classe dirigente e con incerte istituzioni. Ai mesi di quell’estate rimandano le ultime pagine del romanzo “Lo Spasimo di Palermo” scritto, sin dall’inizio, con parole marchiate da sangue, dolore, malinconia, distanza: esilio dalla/nella terra dell’altra annunciata strage del 19 luglio. Bisogna partire da qui per apprezzare fino in fondo il senso di questi scritti sulla mafia, bisogna aver chiaro il rapporto dello scrittore con l’isola e con la parola decisiva: esilio.
Se la sua produzione creativa è il risultato di quella «nascita nell’isola, nell’assurdo della storica stortura, prigione dell’offesa, deserto della ragione, dissolvimento, spreco di vite, d’ogni umano bene», c’è sempre dell’altro: un carico di ragione, certamente di speranza. Nelle ultime pagine dello “Spasimo” scrive: “(Un lume occorre, una chiara luce)”, un lume timidamente indicato tra due parentesi tonde. Una fievole luce per sopravvivere? O, forse, per meglio capire. E questa luce si apre su ogni pagina di “Cosa loro”.
In un testo del luglio 2007 pubblicato sull’”Unità” in occasione dell’anniversario della strage di Via d’Amelio (“Borsellino, l’uomo che sfidò Polifemo”), quando Consolo affronta un tema cruciale riferendosi a quanti hanno creduto che la «mafia fosse qualcosa di separato dal nostro contesto civile, che essa sarebbe stata prima o dopo tagliata con un colpo d’ascia dal ceppo sano della nostra società da parte di organi a questo delegati» (p. 261), si avverte quella lucida consapevolezza propria sia di Leonardo Sciascia che di Giovanni Falcone.
In “Cose di Cosa nostra” il giudice contesta l’opinione di chi pensa che la mafia sia un soggetto esterno, un nemico che da fuori minaccia i siciliani. I mafiosi sono «uomini come noi» e, conclude, «se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia». Più dolente Sciascia (“La Sicilia come metafora”): «Prendiamo ad esempio questa realtà siciliana nella quale vivo: un buon numero dei suoi componenti io li disapprovo e li condanno, ma li vedo con dolore e “dal di dentro”; il mio “essere siciliano” soffre indicibilmente del gioco al massacro che perseguo. Quando denuncio la mafia, nello stesso tempo soffro poiché in me, come in qualsiasi siciliano, continuano a essere presenti e vitali i residui del sentire mafioso. Così lottando contro la mafia io lotto contro me stesso, è come una scissione, una lacerazione».
A partire dal primo intervento della raccolta, un dattiloscritto probabilmente del 1969, Consolo individua nell’assenza di fiducia nello Stato la causa del radicamento e rafforzamento della mafia; egli conosce bene l’Italia all’indomani dell’Unità quando le repressioni e «il trattamento da cittadini di seconda classe da parte del nuovo governo» (p. 14) non fanno altro che perpetuare anziché risolvere quella causa, tenendo «viva la sfiducia verso lo Stato», dando «maggior fiato alla mafia in un drammatico circolo vizioso», rinfocolando l’ostilità della popolazione «e questo, a sua volta, dava motivo per altri provvedimenti repressivi» (p. 15).
Ritorna in un altro testo del 1994 denunciando come «dopo l’impresa di Garibaldi […] la mafia rafforza ancora di più in Sicilia il suo potere, fidando su una maggiore lontananza del governo centrale e sul malcontento, sulla sfiducia nel potere costituito per le nuove leggi che impongono […] nuovi obblighi, come quello della leva militare, e pesanti tasse come quella sul macinato» (p. 158).
La mafia non è un fenomeno accidentale o casuale, continua a ricordarci Consolo, è l’effetto di precise responsabilità che chiamano in causa le classi dirigenti dell’isola e del Paese, sia nella fase di origine, sia nei decenni più recenti. Da questo punto di vista, nella riflessione dello scrittore un’attenzione particolare è riservata alla critica del “Gattopardo”. In un articolo del 1986 Consolo disvela la mistificazione ideologica del «sentenzioso romanzo che è “Il Gattopardo”».
`Noi fummo i Gattopardi e i Leoni; quelli che ci sostituiranno…», è la sentenza del Lampedusa. Ma non è stato così: «Che i gattopardi e i leoni non sono stati del tutto sostituiti, ma che essi stessi si sono trasformati in sciacalli e iene e che forse tali sono sempre stati» (p. 64). In un altro testo del 2007, più diretto è l’obiettivo polemico: «Ma il principe di Salina ignorava o voleva ignorare che le iene e gli sciacalli, i don Calogero Sedara, erano nati e cresciuti, si erano ingrassati nelle terre, nei feudi dei suoi pari, dei nobili, mentre loro, i feudatari, se ne stavano nei loro palazzi di Palermo a passare il tempo tra feste e balli» (p. 251).
La mafia era figlia di quel sistema economico e sociale, era l’effetto di concreti comportamenti delle classi dirigenti: «Tomasi di Lampedusa, l’autore del “Gattopardo”, ignorava questo?» Insomma: «Al Salina o al Lampedusa, grande scrittore e sapiente letterato, vogliamo dire che sciacalletti e iene erano anche loro, i Gattopardi, consapevoli complici di quei mafiosi che agivano là, nei loro feudi» (p. 296). Era già stato molto chiaro Leopoldo Franchetti nel libro dato alle stampe nel 1877. Il giovane studioso toscano, un liberale conservatore, sottolineava le gravi responsabilità della classi “abbienti” siciliane. La relazione tra mafiosi e classe dominante è «un fenomeno complesso» ma con una certezza: se la classe dominante lo volesse la mafia verrebbe immediatamente distrutta (ha i mezzi materiali e l’autorità morale). Invece la relazione è reciproca e i destini intrecciati.
In un saggio scritto dopo la strage di Capaci Consolo spiega come sia cambiato il rapporto tra mafia e politica. Se per decenni «mafia e potere politico procedevano trionfalmente in simbiosi perfetta […] l’una e l’altro si alimentavano di un vasto consenso […] insieme poi davano e ricevevano protezione e padrinaggio al e dal potere di Roma» (p. 110), tutto cambia con quello che lo scrittore chiama «il Grande affare»: «Il devastante traffico internazionale della droga, con i suoi traffici succedanei, ha mutato il rapporto di forza tra mafia e potere politico, Cosa nostra ha finito per dominare politica, invadere industria, commercio, finanza».
Ma è cambiata anche la percezione della mafia e delle sue vittime, adesso uomini delle istituzioni, giudici, prefetti, ufficiali, politici, imprenditori. Sino al secondo dopoguerra la mafia uccideva capilega e sindacalisti che si opponevano ai gabellotti, e queste morti «provocavano dolore e rimpianto forse soltanto nel gruppo politico, nella classe da cui provenivano» (p. 126). Cambia la mafia, cambiano le vittime, cambia l’antimafia. Umberto Santino (“Storia del movimento antimafia”) sottolinea il passaggio di fase: a cambiare sono soprattutto le motivazioni dell’opposizione: se prima la lotta alla mafia si intrecciava e in larga parte si sovrapponeva al conflitto sociale e politico (antimafia sociale), dagli anni ottanta in poi il movente è l’indignazione e la rivendicazione dei valori civili (il diritto, la democrazia, la non violenza, ecc.) che non hanno una specifica connotazione di classe. Scrive Consolo: «Il dolore e il rimpianto per le vittime non ritrovavano più risonanza in un gruppo politico, in una classe sociale, ma in tutta la società civile».
Il nuovo anno da poco entrato è anche quello del trentesimo anniversario di Mani pulite. Tangentopoli, scrive efficacemente Consolo in un articolo del 1994, è la «perfetta realizzazione di un’utopia negativa» (p. 145) in cui il malaffare è divenuto elemento fisiologico, «quasi legale, sistematicamente accettato, praticato e tacitamente regolarizzato dai partiti al governo e qualche volta pure dall’opposizione»; e le leggi, vane e violate, assomigliavano sempre più «alle “gride” nella Lombardia del Seicento, la cui applicazione era sempre lasciata “all’arbitrio di Sua Eccellenza”».
L’implacabile descrizione del degrado morale del mondo politico e imprenditoriale non impedisce a Consolo di esprimere una dura, e all’epoca in controtendenza, critica alla trasmissione televisiva del processo Enimont, «un orrendo, fascinoso spettacolo». Non c’è nelle sue parole solo la rivendicazione della forza del diritto, il rifiuto della gogna mediatica, il rispetto della dignità degli imputati, c’è la denuncia di quella ipocrisia nazionale che tiene incollati al video milioni di telespettatori che non hanno mancato di dare il proprio voto ai politici processati: «Elettori-telespettatori che nello spettacolo-gogna si autoassolvono» (p. 146).
Il caso ha voluto che la scorsa domenica in allegato all’Espresso e a Repubblica venisse venduto il primo volume di una raccolta di scritti di Umberto Eco; in una delle sue “Bustine di Minerva”, commentando un altro processo, il famoso semiologo mette in guardia sul “«dovere di difendere la dignità del colpevole, che paga già in altra moneta», non esitando a parlare di «attentato alla Costituzione»: «Non vediamo la Giustizia in azione, ma la Televisione che interpreta la Giustizia».
Forza del diritto, dunque, e irriducibile denuncia di ogni ipocrisia. Nell’ottobre del 1990 su “L’Ora” in risposta ad un articolo di giornale dopo le dimissioni dal Premio Racalmare – Leonardo Sciascia, Consolo spiega il suo un inevitabile gesto di protesta: «Finché la mafia uccide in Sicilia […] non possiamo permetterci di “celebrare cerimonie letterarie sovvenzionate da pubblico denaro”». Ci sono momenti in cui bisogna saper dire “no”, non si può far finta che tutto prima o poi passi. Nella polemica, poi, mette in guardia su un altro rischio: le “cerimonie” finanziate da denaro pubblico forniscono «soltanto alibi a gravi responsabilità altrui, [danno] una mano a imbellettare ingiuriosamente i cadaveri» (p. 80). «Ci sono momenti» – questa la dolorosa consapevolezza dello scrittore – «in cui bisogna rifiutarsi di suonare e cantare in pubbliche feste o cerimonie […] perché non s’ingenerino equivoci o fraintendimenti […] per non allietare i responsabili dei mali».
Infine, qualche parola a titolo personale sul rapporto di Consolo con l’esperienza del movimento antiracket a cui sono dedicati alcuni degli articoli di “Cosa loro”. Vincenzo nella rivolta dei commercianti di Capo d’Orlando individuava una ragione di speranza che covava proprio in quei Nebrodi in cui era cresciuto e a cui ritornava ogni estate e ad ogni occasione. A partire dal famoso articolo all’indomani dell’omicidio di Libero Grassi “Morti in licenza” e, poi, dopo la sciagurata decisione del governo Berlusconi nei confronti di chi scrive e, ancora, in un saggio del 2005, Enzo è sempre stato un appassionato e affettuoso compagno di viaggio che ha saputo apprezzare quella strategia contro la solitudine e l’isolamento che è stata alla base dell’ACIO di Capo d’Orlando e continua a essere la ragione di fondo delle associazioni nate ispirandosi a quel modello. E proprio guardando a questo centro di commercianti affacciato sul Tirreno si può a ragione dire che la mafia è Cosa “loro”.
Consolo cartografo
di Antonio Pane
Di Ada Bellanova, laureata in lettere classiche e insegnante di liceo, conoscevo la prima tesi di dottorato (sulla presenza dei classici greci e latini nell’opera di Borges) e avevo letto con interesse i racconti L’invasione degli omini in frac (e altre piccole nostalgie) (Siena, Pascal, 2010), Le mal du pays (vincitore del Concorso Scrivere Altrove – Associazione MaiTardi Nuto Revelli) e il romanzo Papamusc’ (Arcidosso, Effigi, 2016); mi trovo ora a sfogliarne la ponderosa monografia Un eccezionale baedeker: la rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo (rielaborazione della seconda tesi di dottorato discussa presso l’Université di Lausanne), accolta nella collana «Punti di vista. Testi e studi di letteratura italiana contemporanea» di Mimesis (2021), prova in cui la vocazione narrativa si sposa felicemente con l’attitudine allo studio assiduo e ponderato.
Narrativo ne è certamente l’incipit («Quando, alcuni anni fa, sono andata nella Sicilia occidentale per la prima volta, Retablo è stato il mio eccezionale baedeker»); narrativo è senz’altro l’avvio delle Conclusioni («Chiusi i libri, riposti gli articoli, resta un nastro di immagini, ‘fotografie’ accostate e sovrapposte: boschi, strade, aranceti, giardini, profili di palme e castelli, spiagge e isole, chiese e dimore di santi, rovine e musei, città che non esistono più e altre che restano eterne, altre ancora “invisibili” o chiuse l’una nell’altra in mirabile convivenza»); narrativi sono certi slanci esegetici, come la rêverie sulla pianta secentesca del Passafiume collocata di fronte all’Ignoto di Antonello da Messina, «quasi che lo sguardo penetrante del ritratto sia impegnato a scrutare e sorvegliare costantemente il microcosmo in cui è stato collocato»; ma rigorosa, oculatissima e ben documentata è l’indagine, suggerita dalla ragguardevole presenza, nell’opera di Consolo, di «indicazioni toponomastiche, direzionali, localizzative», dalla «segnalazione ricorrente di aree territoriali, contrade, vie, piazze, edifici», dall’«insistenza e l’accuratezza nel nominare i luoghi»: fenomeni ricondotti al «piacere precocemente sperimentato nella scoperta della stessa Sicilia, quando da ragazzino, al seguito del padre, imparava la novità e la varietà del paesaggio, pur segnato dalle macerie della guerra, al di là dei ristretti confini della natia Sant’Agata di Militello».
Sulla scorta di testi come Maps of the imagination: the writer as cartographer, di Peter Turchi, e con una preventiva discussione delle prospettive teoriche fiorite dallo spatial turn (geocritica, geopoetica, geotematica, ecocritica) e delle proposte della narratologia cognitivista, l’autrice cerca di definire il «principio territoriale» della scrittura di Consolo, di individuarne le cartografie (le mappe che orientano le sue esplorazioni e le mappe, reali o immaginarie, che lui stesso costruisce), distinguendovi in via preliminare due caratteri precipui: la natura ‘palinsestica’ (o, secondo il suggestivo battesimo di Daragh O’Connell, ‘palincestuosa’), ovvero il loro «legame particolarmente intenso e stretto con i testi anteriori»; i segni di «suggestioni sensoriali, risultato di una conoscenza ravvicinata e personale», di Storia (una «Storia che si può sperimentare, che si vive, una Storia dal basso, lontana dunque da quella dei grandi eventi») e di attività umane che vi sono impressi.
Quanto all’uso dei «testi anteriori», la ricerca stabilisce che il contributo dei classici greci e latini diventa apprezzabile «a partire dall’esperienza di traduzione dell’Ifigenia fra i Tauri euripidea del 1982», per costituire in seguito «un riferimento ricorrente, quasi un marchio presentato come garanzia di solennità e autorevolezza», che lo spazio ‘classico’ di Retablo si incista nella letteratura odeporica settecentesca (Von Riesedel, Brydone, Goethe), che L’olivo e l’olivastro si contagia (in specie nel cammino delle Latomie e nell’entusiasmo per la Venere Landolina) del Maupassant di La vie errante, che Di qua dal faro adotta lo sguardo tutto umano di Carlo Levi («un antiGoethe in carne e ossa»), valutando infine l’apporto degli scrittori siciliani plasmati dall’Isola che a loro volta plasmano in tratti memorabili: Pirandello, Sciascia e Tomasi di Lampedusa per l’area agrigentina; Cattafi e D’Arrigo per lo Stretto; Verga per il territorio dominato dall’Etna; Piccolo per l’arcadia dei Nebrodi; Vittorini per il simbolismo del nóstos.
Insieme a queste orditure intertestuali, Ada Bellanova prende in esame l’impiego originale di «geografie letterarie già divenute simbolo in forza di una lunga tradizione»: la Sicilia-Itaca (terra «irriconoscibile, luogo di mostruosità, di efferatezze, reggia in cui hanno vinto i Proci […] diventata Troia, perché non esiste più, se non nel ricordo», e dall’Ulisse-Enea che vi approda «in cerca di una nuova patria nella consapevolezza che la propria è ormai consumata dalle fiamme»; il «personale criterio di associazioni» che sovrintende al modello odissiaco di L’olivo e l’olivastro (esemplato dal particolare ‘trattamento’ delle Eolie: «La memoria delle regolari visite di un tempo a Lipari rende le isole un luogo intimo e l’elemento affettivo e personale prevale anche quando compare l’evocazione della vicenda odissiaca: il dio dei venti è l’oggetto della narrazione di Consolo ai nipoti, mentre la tempesta sull’equipaggio di Ulisse dopo l’incauta apertura dell’otre è sostituita dal tremendo mare che accompagna la fuga precipitosa dall’isola a causa della lettera di leva»); la declinazione dell’incontro con la madre a Sant’Agata «come ritorno a Itaca e insieme Nekya». Una particolare attenzione è poi riservata allo scenario di Ifigenia fra i Tauri (per la sorprendente associazione di Milano con la Tauride, come terra «gretta, inospitale, luogo di perdita della memoria, campo fertile per l’attecchimento di ideologie razziste», e per il suo contraltare di una Sicilia-Argo, oggetto del desiderio che può a suo luogo trasfigurare in violenta e prevaricatrice Tauride), alle suggestioni manzoniane di Il sorriso dell’ignoto marinaio (nel capitolo V, dove risuona, ma in un ambiente del tutto diverso, lo «scampanìo che prelude al mutamento d’animo dell’Innominato», e nel capitolo VII, per l’allusione alla peste e per lo «scendea per uno di quei vicoli», che «richiama alla mente l’immagine della madre di Cecilia che coltiva la compostezza e il decoro nella pietosa consegna dell’amato corpo della propria bambina al monatto»), all’eco, in Filosofiana, del Pitrè di Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, dell’Agamennone di Eschilo e delle Rane di Aristofane.
L’inventario considera poi gli apporti dell’universo figurativo (le ecfrasi dichiarate del Ritratto di ignoto, del Seppellimento di Santa Lucia, dello Spasimo di Sicilia, di una foto di Robert Capa, di reperti archeologici e beni architettonici, le citazioni pittoriche di Lo sposalizio della Vergine e di Los desastres de la guerra, le allusioni all’Ave Maria a trasbordo di Segantini e all’Angelus di Millet), delle recensioni artistiche dello stesso autore (sulle mostre di Michele Spadaro e di Franco Mulas), delle «trame sensoriali» che disegnano «paesaggi sonori, olfattivi, persino paesaggi gustativi» (come le offerte culinarie che accompagnano il viaggio di Clerici in Retablo, la fiera di San Calogero e la Pasqua in La ferita dell’aprile), delle fantasie scaturite da un «confronto personale con i luoghi», e del loro «uso simbolico» (così nel racconto giovanile Un sacco di magnolie «il profumo conturbante dei fiori e poi il nero delle corolle marcite rinvia alla morte del protagonista», in L’olivo e l’olivastro «il gelsomino lasciato marcire delle raccoglitrici in sciopero […] allude ai morti dell’industria di Milazzo», in Un filo d’erba al margine del feudo «il nero dominante sulle case e sulle persone del borgo di Tusa […] si lega alla morte drammatica di Carmine Battaglia»), dei tasselli di storia che, attraverso una «lingua non compromessa con il potere», danno voce «agli esclusi e alle loro utopie» e mettono in mora l’impresentabile presente, dei quadri che attestano il sofferto lavoro dell’uomo (la vita del latifondo in Ratumeni, la vendemmia in Nottetempo, casa per casa, la famiglia contadina in Il fosso, il museo contadino di Antonino Uccello in La casa di Icaro, gli agrumeti di Arancio, sogno e nostalgia, i cavatori di pomice di Il sorriso dell’ignoto marinaio, i pescatori in La ferita dell’aprile e La pesca del tonno).
Ma il cuore del libro è la sua seconda parte, Un percorso tra luoghi-simbolo, che verifica, per così dire, sul campo l’ampia e motivata premessa costituita dalla prima, Strumenti per percorrere i luoghi, nonché dall’Introduzione, perlustrando partitamente le sedi privilegiate della scrittura di Consolo: Sant’Agata; Cefalù; Palermo; Siracusa; le rovine dell’Isola; Milano.
Il paese natale – «limen», discrimine «tra un oriente e un occidente» che calamita una «grande ricchezza di notazioni affettive e di riferimenti a percezioni sensoriali» e diviene il prototipo di «un’immagine della Sicilia metafisica, arcaica e magica, e nel contempo viva e palpitante nei problemi sociali, economici e politici» – è chiamato, nel Sorriso, a una cruciale missione diegetica (per la scelta di mappare il suo castello Gallego con le scritte dei prigionieri di Alcara: «Lo spazio reale si traduce in scenario e simbolo: la scala diventa chiocciola, la chiocciola diventa storia, anzi la Storia, che si avvolge su se stessa e si confonde e confonde»), laddove in L’olivo e l’olivastro vi si incidono «i dettagli del ritorno doloroso […] mentre la madre si fa evanescente come Euridice e la casa viene distrutta, spazzata dalle ruspe, sostituita da un palazzo di banche e uffici che nasconde la vista della spiaggia e del mare».
Il microcosmo cefaludese, scena del Sorriso e di Nottetempo, è per Consolo già Occidente, una Palermo in miniatura (dove si può più facilmente leggere il meticciato arabo-normanno sotteso all’identità siciliana), epperò infinitamente espansibile come una «faulkneriana yoknapatawpha». In questo «labirinto di vicoli e strade» che – sebbene non sia «precisamente collocato nel territorio, tra la Rocca e la spiaggia della Calura, che ha il suo centro nel Duomo», come invece, in un volo poetico, lo vede l’autrice: la Calura si trova in verità dietro la Rocca, nel fianco opposto a quello che dà sull’abitato, e il Duomo sta semmai tra la Rocca e il porticciolo – è fedelmente restituito nei due romanzi (con l’ausilio di mappe a loro volta oggetto di ariose descrizioni), i percorsi dei personaggi sono delineati, con una ricca e persuasiva analisi, come itinerari sonori e luminosi. Quello di Sasà, nel Sorriso, è dapprima scandito dal «latrato dei cani», dal «gemito dei mulini attivi», da «galline ruspanti», dal «ronzìo di vespe e zanzare», dalle grida dei pescivendoli, dalle imprecazioni dei carcerati, mentre nella piazza del Duomo predomina «il senso della vista» e più innanzi le due percezioni sfociano nel «si videro oscillare le campane», dove «è proprio il propagarsi del suono che suggerisce uno sguardo più ampio sul paese, altrimenti impossibile».
Similmente, in Nottetempo, il suono dello zoccolo del cavallo di don Peppino «mentre si propaga, ci fa vedere» e, nell’incipit, «Il procedere dolorante del luponario, accompagnato da un ululato profondo, mostra i luoghi a gara con la luce. Le reazioni al suo passaggio […] costruiscono un itinerario sonoro. È proprio questa la prima immagine di Cefalù del romanzo, quella disegnata dal percorso disperato dell’uomo, sotto l’altro, luminoso, della luna». Altre epifanie del ‘sentiero luminoso’ saranno il ferino crepuscolo dal balcone di Don Nené (colto come controcanto ironico all’incipit del Piacere), il sole che illumina «la vista dei pascoli di Janu, quindi la Rocca» e «scandisce poi con le sue gradazioni le tappe dell’incontro e dell’amore con la thelemita», per culminare nel fulgido trionfo del Duomo che sarà ancora celebrato nella visitazione satanico-mistica di Crowley e nel racconto La corona e le armi.
«Se Cefalù è la porta del mondo, Palermo è il mondo», e la sua rappresentazione sarà quindi più complessa, attuata «integrando una varietà di sguardi letterari e testimonianze della stratificazione urbanistica e accogliendo innumerevoli stimoli sensoriali, alternativamente seducenti e inquietanti». Il palinsesto letterario (che annovera prelievi da Boccaccio, Ibn Giubayr, Amari, Tomasi di Lampedusa, Lucentini, Falcone, Goethe, Brydone, Pitrè, La Lumìa, Lucio Piccolo) si intreccia con le sontuose quanto ambigue «sollecitazioni sensoriali» cui è impossibile sottrarsi, tanto che «Solo l’immedesimazione permette di fare esperienza dell’universo multiforme di Palermo», e con il «multistrato» delle sue architetture, distribuito fra le sopravvivenze arabo-normanne e i più recenti misfatti urbanistici: un coacervo che trova il suo emblema nella pasta con le sarde, perfetta versione culinaria della feconda contaminazione di culture differenti che costituisce «l’identità più vera» della città che nello Spasimo di Palermo giunge a configurarsi come un’Itaca, se pure stravolta (dato che «non sa offrire consolazione all’esule nel momento del ritorno, ma non ha saputo offrirne neppure un tempo»), o a esibire finte topografie, come quella del palazzo di Martinez in cui Consolo trasferisce «la vicenda della propria casa natìa di Sant’Agata».
La Siracusa di Consolo (scoperta precocemente nel 1950, in una gita scolastica) è luogo di luce che prende un corpo di donna in cui confluiscono la statua di Venere Anadiomene, divinità del mito (Aretusa, Atena, Afrodite, Artemide, Kore), Santa Lucia, e ogni altra femminea sembianza, «a partire da quelle che per i loro capelli e il portamento apparvero diverse, nuove, nel primo incontro con la città ricordato in Siracusa il mio primo talismano» (caratteri restituiti con una insolita «ricchezza di riferimenti intertestuali», un «collage di citazioni e richiami» in cui entrano in gioco gli itinerari di Caravaggio, Maupassant, Von Platen, del ceroplasta Zummo, della Dichiarazione della pianta delle antiche Siracuse di Vincenzo Mirabella, i versi di Pindaro, Virgilio, Ibn Hamdis, Ungaretti), ma è insieme, soprattutto nelle ultime prove, icona del tramonto di una civiltà, divenuta (per il suo odierno degrado, per i mostri delle raffinerie, per il suo «squallore sonoro») «Argo del sogno e della nostalgia di Ifigenia, un luogo che non esiste più perché stravolto dall’orrore dall’omicidio».
Con il pellegrinaggio nelle rovine siciliane Consolo continua a coltivare un gusto appreso già nell’adolescenza, una consuetudine che vale anche a «evadere dal presente», in una «prospettiva idealizzante» anch’essa affidata a una «fitta trama intertestuale in cui spiccano pause ecfrastiche, memorie di autori antichi, narrazioni di miti, evasioni arcadiche». Con questa singolare contaminazione di fatti sensibili e fatti libreschi, Segesta, Selinunte e Mozia acquisiscono «tutta l’intensità di luoghi fisici, di cui si può fare esperienza, in una ricchezza di suggestioni non solo mentali – l’imponente passato a cui rinviano – ma anche visive, olfattive, uditive». Se Segesta induce anzitutto «la contemplazione estatica del paesaggio e l’evocazione del passato, delle infinite epoche trascorse, fino al rapimento nel passato», la Selinunte di Retablo è, nelle metope che la finzione restituisce al luogo d’origine, pietra che parla ed è parlata: nella descrizione del riquadro di Zeus e Era la studiosa ipotizza un attendibile richiamo «a uno specifico passo dell’Iliade, ovvero XIV 346-351» e nella bellissima fanciulla del témenos di Demetra Malophoros intravede l’allusione «ad uno dei Desastres de la guerra di Goya, ovvero Murió la verdad». Mozia è invece, sempre in Retablo, mistero: il mistero dei naufragi, nel passo suscitato dai relitti intravisti nei fondali al momento dello sbarco di Clerici (al cui riguardo si congettura «la conoscenza di Naufragio con spettatore di Hans Blumemberg»); il mistero dei reperti, oggetto di un «procedimento ecfrastico originale che restituisce la natura delle antiche opere d’arte ipotizzandone la collocazione settecentesca, quindi lo stato d’abbandono e l’accumulo casuale»; il mistero dell’efebo greco in terra fenicia, che il racconto destina ancora a un fondale marino, includendo, secondo l’autrice, una «reminiscenza di Morte per acqua di Eliot, IV sezione di The Waste Land», con lo scambio fra il ragazzo ellenico e Phlebas il Fenicio.
La rassegna dei ‘luoghi-simbolo’ si chiude con Milano, contrada della speranza divenuta inospitale e difficilmente narrabile, spazio ostile che respinge il migrante cresciuto nel suo mito: la relazione di Consolo con la città «non arriva mai ad essere equilibrata, pacifica». Con l’eccezione dell’oasi multiculturale e versicolore di Porta Venezia, «uno spazio di riconciliazione», la metropoli lombarda appare scialba e sorda e, nello Spasimo (dove l’amaro congedo di Chino profila «un Addio ai monti capovolto»), «recinto dei moribondi di manzoniana memoria», mentre in Retablo la corrotta città del Settecento filigrana «il degrado della Milano craxiana», deriva morale che provoca in ultimo le requisitorie contro i successi elettorali di Mascelloni/Berlusconi.
La terza parte del libro, Ecologie consoliane, articolata nelle sezioni Per un’ecologia del paesaggio e dell’identità e La prova della ricostruzione. Per un’ecologia del dopo disastro, ritaglia le zone che in Consolo investono il «delicato rapporto tra uomo e ambiente in Sicilia e nel Mediterraneo».
I casi dei poli industriali di Milazzo, Gela e Siracusa, gli incendi e la speculazione edilizia ne rappresentano, nella prima sezione, il versante negativo. A formare l’immagine di Milazzo concorrono un’antica familiarità con il luogo (l’adolescente Consolo era solito sostarvi «di ritorno dalle Eolie dove viveva una delle sorelle»), le notizie dello storico locale Giuseppe Piaggia (che ne fanno una terra d’idillio, promossa in La mia Sicilia «giardino di Alcinoo» e «sicula terra dei Feaci») e, con un «effetto straniante», il racconto odissiaco degli armenti del Sole (tradizionalmente posto nella piana di Mylai), quando l’empietà degli industriali e dei politici che hanno voluto la raffineria a spese del paesaggio e degli esseri umani viene assembrata a quella dei compagni di Ulisse, e l’esplosione è il momento in cui essi «banchettano con le carni dei buoi sacri, autoassolvendosi nella promessa del futuro sacrificio». Un analogo straniamento raggiunge il polo industriale siracusano, accostato a sorpresa, in L’olivo e l’olivastro, «al culmine di una descrizione che, per quanto cupa, ha tratti realistici», al paese dei Lestrigoni (che un passo tucidideo vuole in Sicilia), e dove si rileva che il modello omerico lotta con quello virgiliano («l’area si presenta come un’Itaca impossibile, non approdo del ritorno ma regno dei Lestrigoni, ed è allo stesso tempo la città di Troia devastata dalla guerra»), mentre il petrolchimico di Gela attira, per evocare l’inferno, anche morale, della città, la parola di Eschilo (quando condanna il delitto di Clitennestra), proponendo inoltre l’«associazione del petrolio alla trovatura nelle tombe greche, nelle cisterne saracene».
Passando alle devastazioni prodotte dagli incendi e dalla speculazione edilizia, l’accurato scandaglio dell’intera produzione di Consolo, soprattutto giornalistica, permette di concludere che esse sono per lui «il risultato di quella profonda e repentina trasformazione che consiste nella fine della civiltà contadina e nell’avvento forzato del miracolo industriale». Viceversa, il lato positivo del ‘pensiero ambientale’ di Consolo è comprovato dalla sua autentica militanza a favore di «una biodiversità naturale e umana ancora possibile», manifestata dalle pagine sui Nebrodi (che prevedono anche «un impegno attivissimo a favore dell’istituzione del parco») e sull’area dei monti Iblei («tratteggiata come un’alternativa di rinascita», con la necropoli di Pantalica a rappresentarvi «la resurrezione, la vita, pur essendo un luogo di morte, poiché in essa riposa la memoria identitaria», e presidiata dalle straordinarie persone di Antonino Uccello, del mielaio Blancato, del «vecchio Paolo Carpinteri, che intaglia il legno, costruisce zufoli e narra storie di erbe e animali fantastici», di Gina e Pino Di Silvestro, di Sebastiano Burgaretta), e annunziata dal pastore Nino Alaimo di Retablo, che raffigura «l’equilibrio, la serenità, un modo più umano e sostenibile di vivere».
La seconda sezione di Ecologie consoliane si concentra sui luoghi colpiti da disastri naturali e sulle «implicazioni antropologiche, identitarie, relazionali, storiche» del ricostruire. Le eruzioni dell’Etna, guardate attraverso il Leopardi della Ginestra e la filosofia di Empedocle, chiamano in causa il mito: il selvaggio Polifemo è identificato con il vulcano, e Ulisse con l’«uomo tecnologico», capace, con le sue arti, di fronteggiarne la devastante potenza. I brani sul terremoto di Noto si muovono invece, mediante l’«associazione Kore-ape-Noto», tra le note gaudiose che inneggiano alla mirabile ricostruzione dopo il terremoto del 1693 e il rammarico per il successivo degrado che ha prodotto la «dimenticata marcia scenografia teatrale» di L’olivo e l’olivastro, facendone l’«Argo amara, in guerra» di una «Ifigenia smarrita»: uno sfacelo che diviene «l’emblema di una rovina che non riguarda solo gli Iblei, ma la Sicilia, l’Italia, il mondo» e che si fa ancor più evidente nel caso di Gibellina e della sua discussa ricostruzione. In L’olivo e l’olivastro il sito «è innalzato a simbolo: è Ilio nel momento della partenza dopo il disastro, non sa essere Itaca nel ritorno, perché troppo diversa si presenta all’esule» (in Metamorfosi di una melodia, sarà «emblema della negazione dell’identità e della memoria», come la Gerusalemme distrutta dai Romani), mentre nei testi del 2008, chiamati a ricordare il quarantesimo anniversario del sisma, «prevale l’invito alla rinascita della Valle del Belice».
La quarta parte del libro, Leggere e scrivere il Mediterraneo, si sofferma sui modi in cui l’interesse di Consolo per la Sicilia e il sud si riverbera sull’intero spazio del mare nostrum. Se la Sicilia si identifica nel «flusso incessante di energie umane e culturali», tutta l’area mediterranea è «crocevia di popoli differenti»; ed entrambe sono insieme «scenario di devastazione» e «archivio di eredità preziose». Il loro Ulisse «non è l’eroe del ritorno, è piuttosto il migrante», condannato a un esilio perenne. Nel suo viaggio, «insieme all’ansia di scoperta e conoscenza, è evidenziato il senso di colpa e il rimorso per l’abuso della tecnologia che distrugge patrimoni e vite umane». Il Mediterraneo è per Consolo un «mondo unico». L’arancio diffuso nelle sue coste è «sogno di un Eden perduto», simbolo di «uno spazio sano in cui le piante odorose possono ancora fare mostra di sé accanto alle rovine del passato». In Palestina le colline di roccia e deserto gli ricordano i prediletti Iblei, e il lamento delle donne per i guerriglieri morti la tragedia greca. La Casbah di Algeri gli fa pensare al centro storico di Palermo. Di Utica lo colpiscono le rovine e il basilico, ma «tutto il Mediterraneo in qualche modo è Utica».
Come la Sicilia, tutto il Mediterraneo è oggi «una Tauride senza speranza». In Le pietre di Pantalica Beirut è come Palermo. Le macerie di Sarajevo 1997 cancellano la civiltà. La Palestina 2002 è un inferno appena mitigato dalla rugosa matrona di Ramallah che offre nepitella. Ma, come il suo Ulisse è un migrante, il Mediterraneo di Consolo è soprattutto «spazio di migrazioni». Il suo mare «non è di nessuno, non può essere veramente limite, e la terra non reca un marchio di possesso ma molti strati di identità che il tempo e i popoli plasmano, partendo, arrivando». La presenza degli Arabi in Sicilia ha lasciato segni profondi sia nell’ambito agricolo che in quello artistico-culturale. L’antica emigrazione megarese nel versante orientale dell’Isola è piegata, forzando l’anodino referto di Tucidide, a modello di uguaglianza, progresso e raziocinio. Le migrazioni italiane verso il Maghreb e l’emigrazione maghrebina in Italia tradiscono la contiguità dei due mondi. Di qui l’impegno civile di Consolo: la coraggiosa denuncia di episodi di xenofobia e persecuzioni, di leggi disumane, del cinismo politico, della barbarie dei cosiddetti centri di accoglienza, dell’ipocrisia di chi vuole per Lampedusa, prima che un’ospitalità degna di questo nome, il sepolcro imbiancato di un Museo, la beffa di un Monumento.
Terminato il viaggio cartaceo, riposto il voluminoso volume, la ricognizione di Ada Bellanova nell’ideale baedeker di Consolo ci appare a sua volta come una preziosa ‘guida alla guida’, un’appassionata quanto precisa cartografia che registra le concrezioni che vi sono depositate, i fili sotterranei che ne muovono le piste. Fra i suoi esiti, giustamente rivendicati nelle Conclusioni, piace qui rimarcare la esaustiva mappatura dei numerosi rimandi a Omero, Virgilio, Euripide, Tucidide e agli storici greci, svolta con acribia e sulla base di solide competenze: apprendiamo così che le geografie omeriche hanno in Consolo una funzione connotativa, interrogano la natura dei luoghi attraversati; che l’Eneide è adottata come «racconto di migrazione», dove «i simboli dell’epos latino integrano e correggono quelli dell’Odissea omerica nella rappresentazione di uno spazio compromesso con l’esperienza dell’esilio»; che l’Argo di Ifigenia fra i Tauri «concorre a definire i tratti della patria lontana, desiderata», quando la Tauride «è la terra dell’esilio, ovvero dell’estraneità, della perdita culturale, non solo luogo geograficamente definito, ma anche tempo di condanna e di sconfitta».
Ugualmente significative mi sembrano le considerazioni sul ruolo dei termini dialettali (adoperati da Consolo per restituire «un’affettività dello sguardo e testimoniare il legame del ricordo», ma anche per rendere «tratti non altrimenti riferibili con altrettanta precisione»). Ma le notazioni che più mi hanno sorpreso sono quelle che toccano la passione civile di Consolo (rivelata soprattutto dal sistematico spoglio della sua vasta produzione giornalistica), milizia che trasforma il suo baedeker in uno strumento insolito, obliquo (portato com’è all’indignazione e alla protesta), e dove l’invettiva contro la profanazione dei luoghi e della loro identità richiama un plurilinguismo che è anch’esso un ‘gesto politico’: il ricorso al dialetto, a termini greci, bizantini, arabi, normanni, sancisce il rifiuto dell’«im-mondo», il monocorde presente che annulla le differenze, nega le nostre singole storie.
Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021
______________________________________________________________
Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).
Vincenzo Consolo: il dovere di scrivere sulla «mala pianta»
di Laura Pisanello
Settant’anni li ha compiuti nel 2003. Vincenzo Consolo, scrittore raffinato e schivo, nasce infatti, nel 1933, a Sant’Agata di Militello, paese costiero in provincia di Messina. Ma fin da giovane si trasferisce a Milano e cosi, da scrittore meridionale immigrato al Nord, nella memoria e nell’impegno ha trovato le sue principali fonti di ispirazioni. Settant’anni – scrive Consolo – che hanno fatto di me un «testimone, una lastra memoriale di eventi cruciali svoltisi in questo lungo tempo, il Novecento appena tramontato» nel Paese e in particolare in Sicilia. In Sicilia ho visto concludersi la guerra, iniziare la nuova vita civile, l’imporsi della necessità di emigrare al Nord. «Ho visto – scrive ancora nella prefazione a Per Vincenzo Consolo (Piero Manni editore,2004) – la fine del mondo contadino, lo spopolarsi di paesi e di campagne, il nascere di quell’illusione industriale che avrebbe creato i pozzi mefitici di Augusta, di Priolo, di Gela; ho visto, nel vuoto creato dall’esodo della parte più consapevole del popolo, ricrescere e ingigantirsi la mala pianta siciliana della mafia, quell’osceno olivastro che, in simbiosi col potere politico, ha devastato il paesaggio, fisico e umano dell’isola».
Msa. La Sicilia di oggi è molto cambiata rispetto a quella della sua infanzia?
Consolo. Moltissimo. Nessuno pretende che tutto si fermi, si cristallizzi, ma avrei desiderato che lo sviluppo fosse un progresso più armonico nel rispetto della dimensione umana.
Invece, si è costruito selvaggiamente, spesso – lo apprendiamo dalle cronache – eludendo qualsiasi legge e contro le istituzioni. Poi, siccome c’e questo Stato paternalistico che condona, allora tutti osano.
lo ho cercato di esprimere questo mio rammarico, questo dolore per questa mia terra sfigurata, in L’olivo e l’olivastro che racconta un viaggio in Sicilia di uno che se ne era andato via da parecchi anni. E, quando ritorna, trova questo degrado non solo da un punto di vista paesaggistico, ma anche da un punto di vista umano. Un po’ sullo schema omerico del ritorno di Ulisse. E’ un Ulisse che non ritrova più la sua Itaca, che durante la sua assenza è sparita.
Ovviamente questo Ulisse è lei stesso, con i suoi continui allontanamenti e ritorni alla terra natale…
Non posso fame a meno perché e il luogo della memoria, degli affetti. Quando nasciamo veniamo incisi dai segni della cultura e della natura. E la Sicilia ha una grande ricchezza, anche nella stratificazione linguistica e culturale (civiltà greca, latina, araba, spagnola). Nel nostro dialetto ci sono ancora queste matrici di lingue del passato: io scavo da filologo nella lingua, per un bisogno di memoria.
Bisogna avere la consapevolezza dei luoghi dove si è nati, ma questo ci deve servire per aprirci alla conoscenza degli altri, non a chiuderci e a regredire.
foto Mike Palazzotto
Lei ha visto l’esodo dal Sud al Nord negli anni Cinquanta?
Vengo da una terra di immigrazione e di emigrazione (a Tunisi agli inizi del secolo c’erano novantamila italiani). Quando ero studente a Milano, negli anni Cinquanta, ho visto il grande esodo di braccianti meridionali verso il Nord. Ho visto in piazza Sant’Ambrogio il Centro orientamento immigrati, dove arrivavano contadini dalla stazione centrale in quei nebbiosi inverni milanesi e venivano scaricati lì dove c’erano le delegazioni dei Paesi stranieri, del Belgio, della Francia e della Svizzera e da lì venivano avviati o nelle miniere di carbone del Belgio o nelle fabbriche francesi. Capii in quel momento il dramma dell’immigrazione.
Come si comportano oggi gli italiani con gli immigrati?
C’è un sentimento di paura, di xenofobia, verso gli immigrati, che vengono immediatamente «criminalizzati» (anche chiamarli «clandestini» li marchia). Voglio dire che questo è un sentimento cieco perché la storia dell’umanità è fatta di incontri e arricchimenti reciproci, di spostamenti di popolazioni da un luogo all’altro. Oggi il nostro Paese sta invecchiando e questi immigrati sono giovani e portano veramente nuove energie.
Nelle cronache sull’immigrazione Siciliana dell’Ottocento ho letto che i primi passaporti venivano dati ai delinquenti, mentre la gente che non aveva conti in sospeso con la legge veniva sottoposta a visite mediche e spesso veniva scartata. Ci sono anche tra gli immigrati di oggi quelli che delinquono, ma la maggior parte di loro sono persone oneste che scappano da luoghi di violenza, di miseria e vengono a cercare speranza.
Tornando alla Sicilia, in questi ultimi tempi sembra che il problema della mafia non esista più …
Dopo ii 1992, che è stato l’anno dell’impegno, della mobilitazione, è sceso il silenzio. Questo silenzio sulla mafia è un silenzio anche inquietante. L’interesse della mafia è sempre stato quello di stabilire rapporti con il potere politico. Ora, quando la mafia tace evidentemente si desume che questi rapporti sono ben saldi e ben stabiliti. Nel momento delle rotture avvengono le vendette e i fatti eclatanti.
Leonardo Sciascia, dopo aver scritto i primi libri (II Consiglio d’Egitto, Morte dell’Inquisitore) incominciò la serie dei romanzi gialli con II giorno della civetta. Quando lo andavo a trovare, gli comunicavo la mia disapprovazione da lettore per questa svolta. Lui sorrideva perché aveva scelto questa tecnica del romanzo poliziesco per dire altro. Capii, dopo, che lui aveva sentito l’urgenza di affrontare un tema come quello della mafia, servendosi di uno strumento collaudato come ii romanzo poliziesco. Nei suoi romanzi non si arriva mai all’individuazione del colpevole. Sciascia voleva dire che erano delitti politico-mafiosi, erano delitti del potere e li potere non poteva processare e condannare se stesso. Sciascia con questi romanzi ci ha dato il quadro di quella che è stata la storia d’Italia dagli anni Sessanta in poi.
Mi chiedo se sappiamo qualcosa di preciso, per esempio, sul delitto Moro …
Lei seguì anche, come cronista, dei processi di mafia?
Su invito del direttore de «L’Ora» di Palermo, nel 1975 presi aspettativa dalla Rai e andai a Palermo. Avrei dovuto dirigere le pagine culturali, ma non si videro mai: feci molti servizi, inchieste, poi mi mandarono a Trapani a seguire un processo in corte d’Assise. C’era un pubblico ministero che si chiamava Gian Giacomo Ciaccio Montalto, intelligentissimo, preparato. Dietro questo processo c’erano la mafia, il traffico della droga. Una sera Montalto mi invitò a casa sua, a Val d’Erice, sopra Trapani. E alla fine mi disse che riceveva moltissime telefonate e lettere anonime con minacce di morte: «Se mi dovesse succedere qualcosa, lei lo scriva». Gli chiesi perché non lo raccontasse alla polizia e lui rispose: «Dei miei superiori non mi fido». Mi sembrava di vivere in un romanzo giallo. Tornai a Milano e qualche anno dopo Montalto fu ucciso. lo raccontai la vicenda, Sciascia, che allora era deputato a Roma, fece una interrogazione alla Camera; il ministro rispose che a loro non risultava che Ciaccio Montalto avesse ricevuto minacce.
Lei si è laureato in legge ma non ha intrapreso la carriera forense…
Avrei voluto studiare Lettere, ma era considerata una facoltà da donne. Mi laureai in
Giurisprudenza a Milano e poi tornai in Sicilia dove andai a insegnare diritto in scuole agrarie di montagna. Lo feci per cinque anni, ma mi accorsi che il mondo contadino stava finendo e i ragazzi erano destinati anch’essi a emigrare.
Sentivo il desiderio di andarmene via e mi consigliai con Sciascia. Lui mi disse che se fosse stato giovane e senza famiglia se ne sarebbe andato anch’egli perché in Sicilia non c’era più speranza.
Come è finito alla Rai a Milano?
Milano mi sembrava l’unica città dove potevo andare: seppi che c’era un concorso per funzionario in Rai e lo vinsi. Ero l’unico senza ipoteche politiche. Quando mi vidi proiettato nel mondo del lavoro, ebbi subito un rifiuto.
Come è stato il suo rapporto con la Rai?
II mio rapporto con la Rai fu difficile: fui anche sospeso per indisciplina. Sono rimasto sempre ai margini, non ho fatto carriera, sono uscito con la stessa qualifica con cui sono entrato. Dicevo ironicamente: «Lavoro in una fabbrica di armi». Ho tentato tante volte di lasciarla.
Dopo la pubblicazione de II sorriso dell’Ignoto marinaio, Einaudi mi propose di andare a lavorare in casa editrice. Ma dopo una settimana scappai anche da Torino.
A che cosa sta lavorando adesso?
Sto lavorando a un romanzo ambientato ancora una volta in Sicilia, alla fine del Seicento (ho trovato documentazione su un processo nell’archivio centrale di Spagna).
In un mondo che sembra dominato da violenza e caduta dell’etica, quali segni positivi lei ha trovato?
Ci sono delle luci di speranza. i movimenti pacifisti e l’impegno dei giovani a vedere al di là dei confini, in modo globale. Poi ci sono fenomeni poco conosciuti come il volontariato. All’ estero ho incontrato giovani, cattolici e laici che operano nei luoghi più infelici. Si vede che l’essenza umana ancora brilla. In Bosnia, in Libano, in Palestina con Saramago abbiamo incontrato pacifisti che lavorano in modo meraviglioso, ma questo i nostri politici lo ignorano.
Dal Messaggero
di Sant’Antonio
novembre 2014
LEGGERE E SCRIVERE IL MEDITERRANEO

di Ada Bellanova
Fornire una definizione del Mediterraneo non è un compito semplice. Mare – e contesto – in perenne trasformazione, come dimostra la sua storia ecologica, esso resiste ad ogni generalizzazione1 . Si può certamente tentare la strada della determinazione strettamente geografica ma si deve riconoscere che a poco serve dire che si tratta di un mare semichiuso su cui si affacciano vari popoli, diversi tra loro eppure simili per la loro posizione e per la condivisione di problemi e risorse. Si deve poi ammettere che il cosiddetto ecosistema mediterraneo ha subito trasformazioni profonde nel corso dei millenni: eliminazione di boschi e foreste, aumento della popolazione, sfruttamento delle risorse, mutamenti climatici, cambiamenti di fauna e flora2 . Le trasformazioni, tra l’altro, contraddistinguono anche la storia della rappresentazione. L’idealizzazione del passato classico che ha sedotto innumerevoli viaggiatori non esiste più e il Mediterraneo si rivela contesto dalle molte facce, non facilmente assimilabile al solo mondo europeo o occidentale3 . Perciò, come tentare una definizione? Cos’è veramente mediterraneo? Se la politica europea contemporanea ha ridotto la questione al problema della frontiera, al rischio di nuove invasioni barbariche4 , ragion per cui il mare è diventato spazio delle indesiderate migra-
1 La complessità del Mediterraneo è centrale nei recenti studi di Mediterranean ecocriticism. Si veda a proposito S. Iovino, Introduction: Mediterranean ecocriticism, or a Blueprint for Cultural Amphibians, in “Ecozon@”, 4.2, 2013, pp. 1-14, in particolare a p. 4. 2 Ibidem. La Iovino propone il caso dell’importazione di tutta una serie di piante e prodotti nel regno della vitis vinifera e dell’olea europaea, con conseguente profondissime sulla cosiddetta dieta mediterranea (si pensi a pomodoro, riso, caffè ecc.). 3 Ivi, p. 5. 4 Si veda a proposito il saggio di C. Resta, Geofilosofia del Mediterraneo, Mesogea, Messina 2012. Sul Mediterraneo come confine, frontiera anche A. Le-
zioni di masse di disperati, tra cui possono nascondersi pericolosi attentatori, e luogo di inevitabile sepoltura, un vero cimitero, di quanti non arrivano a compiere la traversata a bordo di gommoni e imbarcazioni di fortuna, gli intellettuali hanno mantenuto il Mediterraneo al centro di un vivace dibattito culturale. Dibattito che prova a mettere in discussione gli stereotipi. Rischiose sono infatti le immagini rassicuranti dell’idillio naturalistico e della civiltà dell’accoglienza da una parte oppure, all’estremo opposto, quelle fosche della violenza e della sopraffazione. Da una parte il paradiso turistico a buon mercato, le spiagge seducenti, l’esotismo della porta accanto, dall’altra quello della mafia, dell’estorsione, della corruzione delle classi dirigenti, della mancanza di sicurezza, dell’estremismo. L’una e l’altra immagine non sono che la faccia legale e quella illegale dell’inserimento subalterno del Sud nel mondo dello sviluppo, ai suoi margini, “laddove i modelli seducenti proposti dalle capitali del Nord-ovest si decompongono fino a diventare deformi”5 . Tali riduttive determinazioni trascurano la reale complessità del Mediterraneo, che, non a caso, Braudel tenta di definire nel segno della molteplicità e con l’espressione “crocevia eteroclito”6 . Questo spazio, quindi, non consiste soltanto in una teoria di paesaggi, addirittura non lo si può dire neppure mare unico, perché esso è piuttosto un insieme di mari. Nemmeno si esaurisce nell’elenco di tanti popoli diversi perché essi sono entrati spesso in relazione, avvicendandosi su uno stesso spazio o su spazi confinanti, si sono mescolati, hanno plasmato il territorio, anche come spazio dell’immaginazione, e continuano a farlo, rendendo impossibile una reductio ad unum. Ragion per cui Matvejevic può affermare che non esiste una sola cultura mediterranea, ma ce ne sono invece molte, caratterizzate da tratti simili e da differenze, mai assoluti o costanti7 .
ogrande, La frontiera, Feltrinelli, Milano 2017, che indaga sulla condizione dei migranti. 5 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Bari 1996, pp. 3-4. 6 F. Braudel, Mediterraneo, in Id. (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio la storia gli uomini le tradizioni, trad. it. di E. De Angeli, Bompiani, Milano 1987, pp. 7-8. 7 P. Matvejevic, Il Mediterraneo e l’Europa, Garzanti, Milano 1998, p. 31. Si veda anche Id., Quale Mediterraneo, quale Europa?, in F. Cassano, D. Zolo (a cura di), L’alternativa mediterranea, Feltrinelli Milano, 2007, p. 436:
L’incontro ha sempre comportato delle criticità, in primis una diffusa e pressoché costante conflittualità8 : come scrive Braudel, “in tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato”9 . Ma il contesto mediterraneo non si configura solo come spazio di guerra: nei secoli le civiltà dominanti non hanno potuto cancellare del tutto quelle sottomesse; si sono sempre attivati meccanismi di contaminazione, dialogo, stratificazione. Allora forse la sua “essenza profonda”10 sta nell’esempio che esso può offrire della convivenza tra culture differenti. Solo tale approccio all’alterità può permettere al Mediterraneo, “mare tra le terre”, di essere non confine, limite, ma luogo di relazione e di incontro11. Il problema è anche di politica europea, o dovrebbe esserlo, non solo per il timore della violazione da parte dei migranti. Il legame tra Europa e Mediterraneo infatti esiste, sebbene venga sistematicamente messo in ombra dalla prevalente prospettiva mitteleuropea, ritenuta vincente dal punto di vista economico12. Considerare la “via” mediterranea significa, secondo Franco Cassano, valorizzare le differenze, la varietà che l’ossessione di uno sviluppo a tutti i costi nega. Significa porsi il problema della gestione degli spazi, laddove gli spazi ospitano un patrimonio “verticale”, incredibilmente stratificato, e quello della cura dell’ambiente e del paesaggio, impedendo che questi siano solo preda dell’abusivismo selvaggio. Significa affrontare la questione dello scambio e della convivenza tra vecchi e nuovi abitanti. Ciò va fatto, ed è un’opportunità, non solo per “custodire forme d’esistenza diverse da quella dominante” ma anche per “tutelare la stessa modernità dal suo avvolgimento in una spirale senza ritorno”
13. “l’insieme mediterraneo è composto da molti sottoinsiemi che sfidano o rifiutano le idee unificatrici”. 8 P. Matvejevic, Mediterraneo. Un nuovo breviario, trad. it.di S. Ferrari, Garzanti, Milano 1993, p. 19. 9 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, trad. it. di C. Pischedda, Einaudi, Torino 1976, pp. 921-922. 10 Id., Mediterraneo, cit., p. 9. 11 Ancora Braudel a proposito della definizione del Mediterraneo come grande strada per trasportare uomini e merci (Id., Storia, misura del mondo, cit. p. 105). 12 F. Cassano, Tre modi di vedere il Sud, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 20-24. 13 Id., Il pensiero meridiano, cit., p. 7. Ma si veda anche Id., Paeninsula: l’Italia da ritrovare, Laterza, Roma 1998, pp. 10-11.
1. Lo spazio mediterraneo per Consolo
La scelta di Norma Bouchard e Massimo Lollini di seguire il criterio della mediterraneità nell’antologia del 200614 riflette la centralità dell’interesse di Consolo per la “lettura e la scrittura” dello spazio mediterraneo15. Andando oltre gli stereotipi, la linea interpretativa e rappresentativa dell’autore evidenzia tormento e ricchezza di un contesto complesso, che rifugge qualunque generalizzazione. Parlare della questione e dello spazio mediterraneo significa per Consolo parlare del Sud e, in particolare, della Sicilia. La riflessione sulla complessità del Mediterraneo si innesta dunque sulle considerazioni a proposito della varietà e della molteplicità che caratterizzano la storia, l’ambiente, il patrimonio siciliani. Estremamente significativo appare nell’isola il flusso incessante di energie umane e culturali16, che hanno condizionato e condizionano il paesaggio, accostando e sovrapponendo più identità17. Allo stesso modo l’intero Mediterraneo è amalgama, crocevia di popoli differenti, non solo territorio della conflittualità ma anche patrimonio ricchissimo, possibilità della relazione e dello scambio18: sì scenario di devastazione, dove la tecnologia ha perso la sua funzione antropologica e ha generato mostri che distruggono le antiche città, trasformandole in
14 V. Consolo, Reading and Writing the Mediterranean, a cura di N. Bouchard e M. Lollini, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2006). Si veda il chiarimento nel saggio introduttivo: N. Bouchard, M. Lollini, Introduction: Vincenzo Consolo and His Mediterranean Paradigm, pp. 3-48, a p. 14. Sull’interesse di Consolo per il Mediterraneo si veda anche N. Bouchard, Vincenzo Consolo’s Mediterranean Journeys: From Sicily to the Global South(s), cit. 15 Sul tema anche l’antologia postuma, V. Consolo, Mediterraneo. Viaggiatori e migranti, Edizioni dell’Asino, Roma 2016. 16 C. Gallo, Cultural crossovers in the Sicily of Vincenzo Consolo, in “US-China Foreign Language”, gennaio 2016, vol. 14, n.1, pp. 49-56. 17 Emblematico Uomini e paesi dello zolfo, in Di qua dal faro, pp. 981-982: “Ora qui, per inciso, vogliamo notare che la storia, la storia siciliana, abbia come voluto imitare la natura: un’infinità, un campionario di razze, di civiltà, sono passate per l’isola senza mai trovare tra loro amalgama, fusione, composizione, ma lasciando ognuna i suoi segni”. 18 Tale visione è centrale anche nella riflessione di F. Cassano (i già citati Paeninsula, Il pensiero meridiano, Tre modi di vedere il Sud). Non a caso la scrittura di Consolo e quella di Cassano affiancate espongono il punto di vista italiano per “Rappresentare il Mediterraneo”, collana Mesogea (V. Consolo, F. Cassano, Rappresentare il Mediterraneo, cit.).
moderne metropoli, luoghi di intolleranza politica, religiosa e razziale, ma allo stesso tempo archivio di eredità preziose19. Dunque olivastro e olivo insieme. Ed è per tutelare ‘l’olivo’ che Consolo procede in direzione di un ripensamento dei consolidati effetti della globalizzazione20. L’imposizione dell’economia ritenuta vincente e l’emarginazione dei vari sistemi tradizionali producono inevitabilmente l’aberrante negazione della molteplicità che caratterizza l’identità mediterranea e la rottura degli utili equilibri preesistenti. L’autore dunque riflette sulla gestione degli spazi e della cultura e legge il fenomeno migratorio non come superamento di un limite ma come occasione di scambio che trasforma e vivifica. Nell’ottica di un recupero delle tradizioni e della molteplicità a rischio vanno guardate le scelte linguistiche che recuperano frammenti della Sicilia greca, bizantina, araba, normanna, ovvero le impronte delle lingue parlate un tempo nel Mediterraneo. L’imperativo della salvezza di linguaggi e dialetti dall’oblio si traduce in un plurilinguismo in cui non ci sono parole inventate ma parole scoperte e riscoperte, in un’operazione di riscatto della memoria e, quindi, di ricerca delle radici, dell’identità21. Se la rappresentazione del Mediterraneo risulta ambivalente, anche Ulisse, l’eroe mediterraneo per eccellenza, ha una natura duplice. Il personaggio omerico, associato da Consolo all’uomo contemporaneo, non è l’eroe del ritorno, è piuttosto il migrante: il nóstos gli è costantemente negato, perché nell’approdo all’isola egli scopre il sovvertimento, incontra le macerie di Troia anziché il palazzo di Itaca, ed è condannato perciò ad un esilio senza fine. La sua peregrinazione lo porta a contatto con le varie forme di violenza della modernità nei confronti di piccoli e grandi luoghi, in Sicilia e fuori dalla Sicilia. In ciò il viaggio diventa meditazione sulle proprie responsabilità: insieme all’ansia di scoperta e conoscenza,
è 19 N. Bouchard, M. Lollini, Introduction: Vincenzo Consolo and His Mediterranean Paradigm, cit., pp. 3-48, a p. 18. 20 Si veda l’intervista con A. Prete (Il Mediterraneo oggi: un’intervista, in “Gallo Silvestre”, 1996, p. 63). 21 G. Traina, Vincenzo Consolo, cit., p. 130. F. Cassano in Rappresentare il Mediterraneo parla di recupero da parte di Consolo di un’antica dimensione sacra della lingua, mediante lo scavo nel passato del Mediterraneo (V. Consolo, F. Cassano, Rappresentare il Mediterraneo, cit., p. 57).
evidenziato il senso di colpa e il rimorso per l’abuso della tecnologia che distrugge patrimoni e vite umane22. Le tappe del viaggio cantato da Omero, a loro volta, come già evidenziato, diventano tessere per comporre l’immagine del mondo contemporaneo. Il mito ha avuto un suo innegabile ruolo nella costruzione dell’identità mediterranea23 perché, sorto da una radice geografica, ha a sua volta modificato e condizionato la percezione collettiva dello spazio, confluendo nel patrimonio di tutti, come è accaduto nei casi esemplari di Scilla e Cariddi o dell’Etna. Ma racconti e leggende antichi legati al territorio possono dire qualcosa di nuovo, possono mettere in luce la stortura: questa è l’operazione a cui si dedica Consolo, ribadendo il legame tra la piana delle vacche del Sole e la Milazzo dell’esplosione o evidenziando l’associazione tra regno dei Lestrigoni e area industriale siracusana. Proprio proponendo il mito originale, allora, enfatizzandone alcuni aspetti, l’autore è capace di trasmettere una denuncia che lamenta la profonda metamorfosi subita dai luoghi: riesce cioè a produrre un’immagine critica dello spazio contemporaneo.
1.1 Nel segno della varietà del mare
Consolo si sente figlio della varietà, dei passaggi, degli incroci di popoli che si sono avvicendati sulla sua terra. Perciò, nella straniante Milano, cerca il conforto dell’umanità colorata, varia, di corso Buenos Aires. A Nord egli cerca il suo Mediterraneo e lo trova negli arabi, nei tunisini, negli egiziani, nei marocchini, negli altri africani, lo trova nel “bruno meridionale”: in questa “ondata di mediterraneità” si immerge e si riconcilia, ci si distende come in una spiaggia di sole del Sud24.
22 Sulla figura di Ulisse e il suo rapporto con il Mediterraneo nell’opera di Consolo si vedano alcune riflessioni di M. Lollini (M. Lollini, Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo moderno Odisseo, cit, pp. 24-43 o anche l’introduzione, scritta con N. Bouchard, all’antologia Reading and Writing the Mediterranean, N. Bouchard, M. Lollini, Introduction: Vincenzo Consolo and His Mediterranean Paradigm, cit., pp. 19-21). Ma si vedano anche le affermazioni dello stesso Consolo in Fuga dall’Etna, cit., pp. 50-52. 23 B. Westphal (a cura di), Le rivage des mythes. Une géocritique méditerranéenne. Le lieu et son muthe, Pulim, Limoges 2001. 24 “Io che sono di tante razze e che non appartengo a nessuna razza, frutto dell’estenuazione bizantina, del dissolvimento ebraico, della ritrazione ara-
La similitudine esalta la presenza della varietà umana con tutta la sua gamma di neri e bruni qualificandola come occasione, in una Milano grigia al di là dello stereotipo, di sperimentare la mediterraneità. L’accostamento è significativo perché l’esperienza della “spiaggia al primo tiepido sole” è molto mediterranea, tanto più per Consolo, nato e cresciuto in una località di mare. La vita a Sant’Agata di Militello, “paese marino”, “borgo in antico di pescatori”25 gli ha permesso di avere una precoce familiarità con la spiaggia26. “La visione costante del mare” ha scandito l’infanzia, di giochi, bagni e gite sui gozzi. Sulla riva di una contrada poco nota sono approdati guerra e cadaveri della grande Storia27. Perciò lo spazio mediterraneo non può che configurarsi, sulla base dell’esperienza personale, come “mare”. Il tempo del mito che contraddistingue la percezione del mare delle Eolie viene poi superato nella frequentazione di altre coste, altri porti, altri arcipelaghi: il Mediterraneo non è più quello della giovinezza, non solo perché sono mutati i toponimi, le coordinate, ma anche perché a guardarlo ora è un adulto, con una prospettiva nuova, di cronista e narratore, e perché sempre più ristretto è lo spazio della bellezza, e delusione e amarezza nascono dalla coscienza di un patrimonio a rischio di estinzione, vampirizzato dall’indu,
del seppellimento etiope, io, da una svariata commistione nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie. Mi crogiolavo e distendevo dentro questa umanità come sulla spiaggia al primo, tiepido sole del mattino”, Porta Venezia, in La mia isola è Las Vegas, pp. 112-113. Nello stesso testo (p. 114) gli eritrei che, ai tavoli di un ristorante, mangiano tutti con le mani da uno stesso grande piatto centrale il tipico zichinì gli ricordano l’uso delle famiglie contadine siciliane di una volta. Anche nell’osservazione di questo gesto c’è il conforto del recupero di un’identità, specialmente nel confronto con un Nord tanto diverso. Poco più avanti anche la musica, in un bar egiziano, suggerisce legami, suscita l’evocazione dell’identità mediterranea (Ivi, p. 115). 25 Il mare, in La mia isola è Las Vegas, p. 220. 26 La grande vacanza orientale-occidentale, in La mia isola è Las Vegas, pp. 163-169, a p. 165. Molte le dichiarazioni a proposito di una vita “anfibia”, vissuta cioè a stretto contatto con l’acqua. “Sono stato un bambino anfibio, vissuto più nell’acqua che nella terraferma” (La Musa inquieta, in “L’Espresso”, 15 aprile 1991). 27 Il mare, in La mia isola è Las Vegas, pp. 220-221; La grande vacanza orientale-occidentale, in La mia isola è Las Vegas, pp. 164-165. Nella caratterizzazione del Mediterraneo, a partire dal paese natale, si intrecciano memorie personali e dati della storia ufficiale: lo scorrere del tempo plasma i luoghi, oggettivamente e nella ricezione personale dell’autore.
-strializzazione selvaggia, o dello scenario di nuove guerre, nuove violenze, nuova morte. È negato l’idillio della vita libera e bella con la vista costante delle isole del dio, e risulta stravolto orrendamente anche il lavoro dell’uomo: i pescatori non tirano più nelle reti il pesce azzurro, bensì cadaveri di clandestini28.
1.2 Tra olivo e olivastro: il patrimonio e la violenza
Pur consapevole della varietà e della complessità che lo caratterizzano, Consolo percepisce lo spazio mediterraneo come un mondo unico e vi rintraccia caratteri ricorrenti, corrispondenze e somiglianze. Memoria di paesaggi noti, conoscenze geografiche, storia della rappresentazione si intrecciano nel proporre associazioni relative al patrimonio naturalistico, considerazioni sulle fragilità degli spazi urbani e sui problemi ecologici. A permettere, in Arancio sogno e nostalgia, la definizione del Mediterraneo come regno solare degli aranci, è l’esperienza della pervasività di una coltivazione, che caratterizza fortemente il paesaggio, dalla Sicilia alla Grecia, dal Maghreb alla Spagna. Riconosciuto come traccia artistica, segno di civiltà, ma anche come straordinario catalizzatore di gratificanti percezioni sensoriali – il colore vibrante dei frutti e delle foglie, l’odore e il sapore –, l’arancio è per Consolo, al di là del facile e consolidato stereotipo di un Sud di agrumi e sole capace di attirare i viaggiatori stranieri, sogno di un Eden perduto, simbolo cioè, nel confronto con coordinate geografiche stravolte dall’industrializzazione, come nel caso della Conca d’oro palermitana, di un’integrità ecologica e culturale, di uno spazio sano in cui piante odorose possono ancora fare mostra di sé accanto alle rovine del passato29.
Della tipica vegetazione mediterranea conserva notazioni il diario del viaggio in Jugoslavia: i pini piegati fino al mare, gli ulivi, i fichi, le vigne non segnano solo il paesaggio balcanico, ma anche quello greco, siciliano, turco, e si può inferire che anche il gesto
28 Il mare, in La mia isola è Las Vegas, pp. 221-222. 29 Arancio, sogno e nostalgia, in “Sicilia Magazine”, dicembre 1988, pp. 35-46, ora in La mia isola è Las Vegas, pp. 128-133. La citazione è alle pp. 128-129.
della donna che stende i frutti ad essiccare richiami ricordi di altre geografie più familiari30.
Nel resoconto della visita in Palestina nel 2002 poi Consolo scrive di “un paesaggio […] di colline rocciose e desertiche, che somiglia all’altopiano degli Iblei in Sicilia”31. Ma oltre al profilo fisico del territorio, a suggerire accostamenti sono gestualità e dolore delle donne per i combattenti morti: nei movimenti e nel lamento si colgono i tratti della tragedia greca, la cerimonia funebre di tutto il Mediterraneo32.
Città, anche distanti, sono accomunate dalla difficoltà di reggersi sul proprio passato, dalla fatica nella gestione della verticalità, della stratificazione, dal segno della decadenza a contatto con la modernità. Il paesaggio urbanistico mediterraneo risulta perciò inserito nella riflessione ecologica sullo spazio siciliano. Le case semicrollate nel reticolo delle viuzze della Casbah di Algeri evocano l’immagine del centro storico di Palermo33 e quasi topos diventano la crescita disordinata e veloce, l’invasione dei nuovi palazzi, il traffico, nel paesaggio urbano siracusano o in quello di Salonicco34. In L’olivo e l’olivastro dalla meditazione sulla decadenza della città di Siracusa, già accostata ad altre città del Mediterraneo, Atene, Argo, Costantinopoli, Alessandria35, scaturisce il racconto di
30 Ma questa è Sarajevo o Assisi?, in “L’Espresso”, 30 ottobre 1997. Si tratta del racconto del viaggio fatto a Sarajevo con altri intellettuali italiani per restituire la visita di un anno prima da parte di otto membri del Circolo 99 (di Sarajevo). 31 Madre Coraggio, in La mia isola è Las Vegas, p. 196. Il testo, uscito per la prima volta in italiano in V. Consolo et al., Viaggio in Palestina, Nottetempo, Roma 2003, ma già apparso precedentemente online, anche in francese, è il resoconto del viaggio in Palestina in qualità di membro del Parlamento internazionale degli scrittori. 32 Madre Coraggio, in La mia isola è Las Vegas, p. 197. Consolo si riferisce alla cerimonia funebre mediterranea così com’è codificata in Morte e pianto rituale di E. De Martino che infatti ricorda. Ivi, p. 199. 33 Orgogliosa Algeri tra mitra e coltello, in “Il Messaggero”, 20 settembre 1993. 34 Ne abbiamo già parlato per Siracusa. Si veda invece quello che Consolo scrive di Salonicco in Neró metallicó: “città moderna, piena di luci, di insegne, di manifesti pubblicitari, di quartieri appena costruiti come d’una città che è stata invasa da immigrati, che in poco tempo ha moltiplicato i suoi abitanti. E piena di traffico” (Neró metallicó, in Il corteo di Dioniso, La Lepre edizioni, Roma 2009, p. 9). 35 L’olivo e l’olivastro, p. 820.
una visita lungo la costa africana, a Ustica36. Il ricordo si sofferma in particolare sulle rovine e, a sorpresa, sul basilico profumato che cresce in abbondanza tra le pietre e i mosaici. Quello che è apparentemente un particolare senza importanza serve però a definire un patrimonio di piccole cose, comune a tutto il Mediterraneo37. L’Ustica di Consolo è rovine e basilico. Ma tutto il Mediterraneo in qualche modo è Ustica. Tutto il Mediterraneo è fatto di “piccoli luoghi antichi e obliati” come Ustica, in cui la natura si intreccia con la memoria del passato38. Ma il rischio della dimenticanza è in agguato, l’incuria è già realtà, e il ricordo diventa occasione di meditazione amara: nell’enumerazione di antiche città, nell’anafora del verbo “ricordare”, Consolo si trasforma in un “presbite di mente” tutto rivolto verso il passato, si trasforma in “infimo Casella” tutto proteso verso qualcosa che non c’è più39. Se l’anima del musico appena giunta sulla spiaggia del Purgatorio mostra ancora un grande attaccamento alla vita terrena, tanto da slanciarsi verso Dante, memore dell’antico affetto, e la stessa canzone dantesca da lui intonata è all’insegna della nostalgia, il riferimento evidenzia proprio il legame che Consolo sente con il passato, con ciò che non esiste più, come la vita terrena per le anime purganti. Ma la sovrapposizione non è perfetta: il richiamo alla canzone Amor che ne la mente mi ragiona è immediatamente contraddetto dal “Non più, odia ora” e il canto non ha nulla della dolcezza del regno del Purgatorio, ma piut36 Ivi, p. 836. 37 Ibidem. 38 I mosaici e il basilico di Utica sono già ricordati in un passo di Malophoros, in un elenco di caratteristici e rapidi ritratti di piccoli luoghi carichi di passato, dalla Sicilia alla Grecia al Nord Africa: Malophoros, in Le pietre di Pantalica, pp. 574-575. Dello stesso tono la precedente osservazione sulle “stazioncine solitarie remote, di luoghi antichi, sacri, come quella di Segesta, di Cartaghe-Hannibal, di Pompei o di Olimpia” che sanno essere “commoventi, hanno ormai anche loro qualcosa di antico, di sacro” (p. 574). Omaggio ai “piccoli luoghi antichi e obliati” sono per lo più gli interventi apparsi su “L’Espresso” tra il 1981 e il 1982, dedicati a centri poco noti, come Miraglia, Valverde, Galati o Filosofiana. Il tono di questi articoli è però di solito quasi giocoso, un invito al godimento delle bellezze e delle ricchezze sconosciute, anche gastronomiche. Luogo antico e fuori dai soliti canali turistici (non segnalata sulla “Guide Bleu”) è anche Dion, stesa nella pianura ai piedi del Monte Olimpo a cui sono dedicate alcune pagine in Neró Metallicó (Il corteo di Dioniso, cit., pp. 19-20). 39 L’olivo e l’olivastro, p. 837.
tosto una rabbia infernale, un tono che pretenderebbe “rime aspre e chiocce”:
No, non più. Odia ora. Odia la sua isola terribile, barbarica, la sua terra di massacro, d’assassinio, odia il suo paese piombato nella notte, l’Europa deserta di ragione. Odia questa Costantinopoli saccheggiata, questa Alessandria bruciata, quest’Atene, Tebe, Milano, Orano appestate, questa Messina, Lisbona terremotate, questa Conca d’oro coperta da un sudario di cemento, il giardino delle arance insanguinate. Odia questo teatro dov’è caduta la pietà, questa scena dov’è stata sgozzata Ifigenia, quest’Etna, questa Tauride di squadracce dove si consumano merci e vite, si svende onore, decenza, lingua, cultura, intelligenza…40
Dai toni nostalgici Consolo passa a quelli indignati di un coro antico e professa odio prima nei confronti della sua Sicilia, diventata “terribile, barbarica, terra di massacro”, una Tauride percorsa da “squadracce”, poi verso l’Europa e verso l’intero Mediterraneo. Il dramma in atto ha proporzioni gigantesche e il riferimento ai simboli della tragedia euripidea ne sancisce la gravità: sulla cavea è stata sgozzata Ifigenia, si è prodotto cioè il sacrificio dei sacrifici, la morte della sacerdotessa che Artemide aveva voluto salva, la morte dell’esiliata e, con lei, la morte di ogni forma di giustizia, cultura, rispetto. Il presente è una Tauride senza speranza. All’attentato nei confronti del patrimonio naturalistico e culturale si accompagna la violenza contro la vita umana, in svariate forme: il Mediterraneo è, per Consolo, spazio della conflittualità. La Palermo di Le pietre di Pantalica, in preda alle lotte di mafia, è come Beirut41: le bombe, i kalashnikov, gli efferati omicidi, il sangue sparso dai killer lasciano tra le strade siciliane il disastro dei campi di battaglia e spingono all’associazione con quell’altra violenza, in atto dall’altra parte dello stesso mare, della guerra che porta alla distruzione della capitale libanese. Comiso, poi, coi suoi missili Cruise, rappresenta la minaccia costante della violenza tra popoli a cui neppure le proteste dei pacifisti, bloccate brutalmente, possono opporsi. Nel racconto eponimo di Le pietre di Pantalica, mentre il paese “folgorato dal sole”, quasi fosse “uno di quei vuoti gusci dorati di cicala”, è tutto ripiegato nel suo torpore estivo,
40 Ibidem. 41 Le pietre di Pantalica, in Le pietre di Pantalica, p. 625.
poco più in là l’aeroporto, nella campagna deserta, accoglie i lavori per l’installazione. Alla sola vista del cancello con la scritta “Zona militare-Divieto d’accesso” emerge la tremenda apocalittica considerazione: “Non resterà di noi neanche una vuota, dorata carcassa, come quella della cicala scoppiata nella luce d’agosto. Non resterà compagna, figlio o amico; ricordo, memoria; libro, parola”42. Quasi a dire che troppo in là è andato l’uomo. Nel testo successivo, che porta nel titolo il toponimo, le cicale – ancora loro – che cantano nel sole estivo enfatizzano la pace e la fiacca che prelude alla carica delle forze dell’ordine sui dimostranti43. Di fronte al degrado della violenza – guerra per difendere la possibilità di fare la guerra – e di fronte alla speculazione edilizia e all’inquinamento, l’unica consolazione possibile viene a Consolo dalle rovine immerse nella natura, ovvero dal valore di un patrimonio naturalistico e culturale. Come ad Utica e ancor di più che ad Ustica, negli Iblei a Cava d’Ispica, a poca distanza da Comiso: qui ci sono “le migliaia di grotte scavate dall’uomo, le abitazioni, le chiese, le necropoli della preistoria, della storia più antica dei Siculi, dei Greci, dei Romani, dei Bizantini, di quelli di pochi anni passati”, qui c’è “un cammino bordato dai bastoni fioriti delle agavi, dagli ulivi, dai fichi, dai pistacchi, dai carrubi”44. E fuori dalla Sicilia? Una serie di articoli scritti a partire dagli anni Novanta denuncia una violenza connaturata in numerosi luoghi del Mediterraneo. Teatro del nascente integralismo è il Maghreb, l’Algeria in particolare, dove Consolo nel maggio 1991
42 Ivi, p. 623. 43 Più tardi, nell’atto unico Pio La Torre, Consolo accenna al coinvolgimento della mafia siciliana e americana nell’affare dei missili (Pio La Torre, cit., p. 65) e offre un’immagine amara della nuova Comiso, che contrasta con il passato nell’offesa dell’inquinamento selvaggio e della minaccia di una guerra (Ivi, p. 77). 44 Comiso, in Le pietre di Pantalica, pp. 637-638. Il testo si chiude con una visita alla necropoli bizantina di Cava d’Ispica. C’è la luna e, guardandola, Consolo ricorda la preghiera della Norma belliniana: “Casta diva, che inargenti / queste sacre, antiche piante…”. Dichiara di non sapere il motivo del ricordo. In realtà la memoria ha a che fare, più o meno volutamente, con Zanzotto, nella cui opera la presenza della Norma è significativa: in più di un’occasione il poeta, riferendosi alla luna, allude alle parole della sacerdotessa (un esempio su tutti l’Ipersonetto: “Casta diva” o “sembiante”, A. Zanzotto, Tutte le poesie, cit., p. 571).
scorge il rischio che “il mistico linguaggio della preghiera” si stravolga nel “mortale linguaggio delle armi”45. Uno “scenario apocalittico, sconvolgente”46 caratterizza poi la Sarajevo del 1997. Il “paesaggio di macerie” che si mostra allo sguardo mano a mano che gli italiani in visita si inoltrano nell’entroterra, con la guida di Matvejevic, impressiona ancor di più per il contrasto con il quieto profilo mediterraneo della costa, dove non c’è traccia di guerra e dove Consolo ritrova la vegetazione della sua terra. La città distrutta evoca le dure immagini del Trionfo della morte di Bruegel o quelle di Los desastres de la guerra di Goya47; i suoi resti, accostati a quelli di Assisi appena colpita dal terremoto, si fanno ammonimento, metafora “del nostro scadimento”: “siamo scivolati sul ciglio della voragine paurosa della natura”, ovvero è scomparsa la civiltà. Infernale è infine la Palestina, visitata da Consolo con altri membri del PIE nel 2002 48. Nella descrizione del tragitto che da Tel Aviv conduce a Ramallah, l’accostamento del paesaggio a quello siciliano si rompe all’apparizione dei check point e delle mitragliatrici, e sempre più nel procedere verso la striscia di Gaza si moltiplicano i segni di rovina e lutto, pur nella prorompente vitalità dei “nugoli di bambini dagli occhi neri”49, al punto che il percorso in direzione dei villaggi di Khan Yunus
45 Quei parabolizzati che sognano l’Italia, in “Corriere della sera”, 20 giugno 1991; Orgogliosa Algeri tra mitra e coltello, cit. Si veda anche la prefazione al libro di poesie di Mokthar Sakhri (Poesie, Libro italiano, Ragusa 2000). L’esperienza giornalistica ritorna nel romanzo Lo Spasimo di Palermo (pp. 903-905): Chino Martinez nel giardino della moschea di Parigi ripensa allo sciopero di Algeri, al mitra e al Corano degli integralisti. Sui fondamentalismi nel Mediterraneo si veda anche l’intervista con A. Prete, Il Mediterraneo oggi: un’intervista, cit., pp. 65-66. Sul fondamentalismo di matrice islamica e in particolare sull’attacco alle torri gemelle, Consolo si esprime manifestando un’accesa critica nei confronti di Oriana Fallaci, evidenziando da una parte che non serve reagire con la violenza e che molti sono i vantaggi dell’incrocio tra culture, come insegna la storia siciliana (l’intervista a cura di G. Caldiron, Lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo risponde a Oriana Fallaci “Parole che conducono alla violenza”, in “Liberazione”, 2 ottobre 2001). 46 Ma questa è Sarajevo o Assisi, cit. 47 Sempre a proposito della guerra in Jugoslavia il riferimento all’opera di Goya compare in La morte infinita, in “Il Messaggero”, 6 febbraio 1994. 48 Madre Coraggio, in La mia isola è Las Vegas, pp. 195-200. 49 Ivi, p. 197.
e Rafah pare “una discesa nei gironi infernali”50. L’immagine più forte, quasi un simbolo, è però quella della resistenza eroica di una madre: ad aprire e chiudere il resoconto del viaggio è la figura della donna di Ramallah51, “imponente, dalla faccia indurita”, che vende nepitella raccolta nei luoghi selvatici e che di certo abita nel campo profughi, forse ha figli che combattono.
1.3 Mediterraneo come spazio di migrazioni
Nella rappresentazione offerta da Consolo l’immagine del Mediterraneo come spazio di migrazioni appare fondamentale e questo, oltre che per una chiara consapevolezza storica, per un’attenta lettura della contemporaneità. Divenuto, nei fatti, confine, limite, addirittura cimitero a causa della grande quantità di morti rimasti imprigionati nelle “carrette”, il mare potrebbe essere, invece, occasione di arricchimento in virtù dello scambio tra popoli. È un’immagine ideale, eppure realizzabile, quella che Consolo propone, insistendo su una storia di civiltà, quella siciliana in particolare, che ha la radice della sua grandezza proprio nell’incontro tra le differenze: ora che l’isola è divenuta luogo di approdo dei migranti che provano a sfuggire alla guerra, alla persecuzione o alla povertà, non si deve dimenticare che il progresso, quello vero, è sempre figlio dell’arricchimento che proviene dall’alterità. Lo dimostrano gli straordinari effetti della dominazione araba in Sicilia, a cui Consolo riconosce, sulla base di un ricco corredo di fonti e seguendo l’opinione di Sciascia, addirittura un valore fondante in termini di identità: i tratti tipici della sicilianità, ovvero lingua, letteratura, arte, agricoltura, cucina e persino fisionomia, risentono tutti del passato arabo52. Non
50 Ivi, p. 199. 51 Ivi, p. 195 e 200. 52 Estremamente rappresentativa appare a proposito la sezione Sicilia e oltre in Di qua dal faro e, in particolare, il saggio introduttivo, La Sicilia e la cultura araba. Il saggio si apre con alcune considerazioni sul legame tra la poesia della scuola siciliana e le qaside dei siculo-arabi, ancora attivi nell’isola sotto i Normanni (La Sicilia e la cultura araba, in Di qua dal faro, pp. 1187- 1192, a p. 1187) e riflette poi su diversi aspetti dell’influenza araba, ad esempio sulla rinascita economica e sullo spirito di tolleranza (p. 1189). Significativi nel testo i rimandi a Sciascia (in particolare alle pp. 1188-1189). Ricordo che il rapporto tra Sciascia e il mondo arabo costituisce un ambito ricco di spunti suggestivi. Significativa è la conclusione del saggio di apertura de La corda
a caso l’insistenza sulla presenza degli Arabi nell’isola si traduce nella frequente celebrazione delle innovazioni in ambito agricolo, tecnico, delle trasformazioni in ambito artistico-culturale. Di “rinascimento” parla Consolo, non perdendo occasione per evidenziare i lasciti, le tracce ancora vive nella contemporaneità siciliana. La lussureggiante Palermo, ad esempio, non avrebbe chiese-moschee, castelli, palazzi e giardini seducenti, non avrebbe aranceti se non ci fossero stati gli Arabi. Lo spazio insomma risulta segnato profondamente da questa “migrazione”. Sorprendenti riescono ad essere poi – afferma Consolo – gli incroci della storia, e Mazara, che ridiventa araba nel Novecento per il massiccio arrivo dei tunisini, aveva già nel momento del primo approdo dell’827 l’Africa nel suo nome, Mazar, traccia dell’antica presenza cartaginese. Come a dire che è sempre stato normale per i popoli spostarsi, il mare non è di nessuno, non può essere veramente limite, e la terra non reca un marchio di possesso ma molti strati di identità che il tempo e i popoli plasmano, partendo, arrivando. Se innumerevoli sono le eredità, anche visibili, tangibili, sebbene a rischio, del passato arabo, scomparsa del tutto risulta per Consolo la scelta della tolleranza e della convivenza tra culture, confermata anche dai normanni che non vollero eliminare la civiltà che li aveva preceduti, ma la integrarono e la valorizzarono. Perciò l’immagine del Mediterraneo come spazio di equilibrio e coesistenza tra le alterità non è solo parentesi del passato ma anche un’aspirazione, un esempio positivo da opporre a quanti insistono sui rischi dello scontro tra culture53.
Che l’arrivo di nuovi popoli produca progresso è poi testimoniato per l’autore anche da migrazioni più antiche come dimostra pazza (1970), Sicilia e sicilitudine, in cui l’autore traccia un collegamento ideale tra Salvatore Quasimodo e un poeta arabo di otto secoli precedente, Ibn Hamdis, siciliano di Noto, accomunati dai toni con cui hanno fatto poesia della pena profonda dell’esilio (L. Sciascia, Sicilia e sicilitudine, in Id. La corda pazza, cit., pp. 11-17). Sulla questione particolarmente interessanti risultano anche le osservazioni contenute in uno degli scritti del Canton Ticino, su Tomasi di Lampedusa, apparso su “Libera Stampa” il 27 gennaio 1959, ora raccolto in Troppo poco pazzi (L. Sciascia, Marx Manzoni eccetera e il Gattopardo, in R. Martinoni, a cura di, Leonardo Sciascia nella libera e laica Svizzera, Olschki, Firenze 2011, pp. 102-104 alle pp. 102-103). 53 Nell’ultima intervista Consolo riflette proprio sull’ignoranza di chi solleva lo scontro di civiltà e accosta integralismo e islam (V. Pinello, op. cit.).
l’entusiastica rappresentazione della Sicilia come museo a cielo aperto, che accoglie rovine antiche, città greche, elime, puniche. Ma numerosi sono anche i riferimenti alla nascita delle colonie, a volte molto precisi, con indicazione dell’ecista, del territorio di origine, degli sviluppi della vicenda coloniale54, sulla base dei dati forniti da fonti antiche, come l’opera di Tucidide55, o su testi più recenti che rinviano però alla storiografia greca. E ciò non solo nei testi saggistici: anche le prove narrative offrono una rappresentazione della Sicilia e del Mediterraneo che ne valorizza l’aspetto di crocevia di popoli. Concentrandosi sulle migrazioni dell’antichità, i testi impostano un implicito confronto con gli spostamenti di oggi, riconoscendovi ragioni identiche o simili, ovvero guerra, fame, difficoltà economiche. In particolare, ne L’olivo e l’olivastro56, Consolo si sofferma sull’emigrazione megarese verso la parte orientale dell’isola. La visita ai resti di Megara Hyblaea, oggetto dell’amorevole culto del giovane Salvo e dei suoi, mentre è in corso l’assedio della cannibalica civiltà industriale del polo siracusano, suscita un’entusiastica rievocazione dell’opera dell’ecista Lamis, dell’idea di uguaglianza e progresso dei coloni, della fertilità e della geometria nella suddivisione del terreno in lotti57. All’enfasi sulla fondazione Consolo
54 Ad esempio, Che non consumi tu tempo vorace, cit., p. 12; I muri d’Europa, in L. Restuccia, G.S. Santangelo, Scritture delle migrazioni: passaggi e ospitalità, Palumbo, Palermo 2008, p. 25. 55 L’archaiologhia siceliota del VI libro si apre con una sintesi storica a proposito dei più antichi popoli locali, a partire dai misteriosi Lestrigoni e Ciclopi, cui segue un quadro preciso delle migrazioni dalla Grecia e delle successive fondazioni. Consolo rinvia a Tucidide per la fondazione di Messina, l’antica Zancle (Vedute dallo stretto di Messina, in Di qua dal faro, p. 1045) e infatti il dato è rintracciabile in Tuc. VI 4,5. Ricava probabilmente dallo storico greco anche il dato relativo alla fondazione di Siracusa da parte dell’ecista Archia (Tuc. VI 3), ricordato in La dimora degli Dei (cit., p. 14). Oltre alla fonte tucididea si può riconoscere anche quella di Diodoro Siculo, esplicitata per la colonizzazione greca delle Eolie (Isole dolci del dio, cit., p. 21). 56 L’olivo e l’olivastro, p. 783. 57 Tucidide parla dell’arrivo dei Megaresi (Tuc. VI 4, 1-2) ma non riporta quest’ultimo dato della lottizzazione, che invece si ricava dai rilievi archeologici. A proposito si veda H. Tréziny, De Mégare Hyblaea à Sélinonte, de Syracuse à Camarine: le paysage urbain des colonies et de leurs sous-colonies, in M. Lombardo, F. Frisone (a cura di), Atti del convegno Colonie di colonie: le fondazioni subcoloniali greche tra colonizzazione e colonialismo, Lecce, 22-24 giugno 2006, Congedo editore, Galatina-Martina Franca, 2009,
aggiunge il plauso per le capacità che i Megaresi, scacciati dai Corinzi di Siracusa, dimostrarono, affrontando l’ignoto della Sicilia occidentale dove fondarono Selinunte. Le sue parole trasfigurano il neutro dato storico di Tucidide (VI 4, 2) attribuendo all’opera dei coloni i tratti di una straordinaria epopea58. I resti della civiltà greca di Megara e Selinunte, dunque, risultano monito contro lo straniamento che viene dalla degenerazione economica e culturale. La coscienza dell’identità trascurata dello spazio e della civiltà che l’ha costruita, originariamente straniera, immigrata, ma secondo le fonti storiche “progredita”, costringe l’attenzione sul rischio della perdita in termini di biodiversità culturale, e l’interesse per gli antichi coloni greci diventa traccia ecocritica. Ha a che fare con la volontà di valorizzare il passato greco dell’isola anche il ricorso al mito. Oltre al viaggio di Ulisse, Consolo ama ricordare la vicenda di Demetra, la madre disperata che, in cerca di sua figlia Kore, vaga per il Mediterraneo59, leggenda molto siciliana, in virtù dei luoghi coinvolti: ad Enna c’era l’antica sede della dea60, e proprio lì si svolse il rapimento di Kore, mentre poco più a
pp. 163-164; M. Gras, H. Tréziny, Mégara Hyblaea: le domande e le risposte, in Alle origini della magna Grecia, Mobilità migrazioni e fondazioni, Atti del cinquantesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1-4 ottobre 2010, Stampa Sud, Mottola 2012, pp. 1133-1147. 58 L’olivo e l’olivastro, pp. 783-784, ma anche Retablo, p. 432; La Sicilia passeggiata, pp. 94-95; Malophoros, in Le pietre di Pantalica, p. 578. 59 Più volte Consolo esibisce citazioni dall’Inno a Demetra (nella traduzione di F. Cassola del 1975). In Retablo ad esempio (Retablo, p. 409) i primi due versi (“Demetra dalle belle chiome, dea veneranda, io comincio a cantare, / e con lei la figlia dalle belle caviglie, che Aidoneo / rapì”) sono esempio di suprema poesia per Clerici che sta sperimentando, nell’esperienza sublime dell’accoglienza da parte di Nino Alaimo, tra l’altro dedito al culto di una Grande Madre mediterranea, una sorta di possessione divina. La Sicilia passeggiata (p. 7) si apre con un’epigrafe tratta dall’Inno (Inno a Demetra, vv. 401-403) che pone l’attenzione sull’esito felice della vicenda, ovvero sul momento del ricongiungimento delle dee e sul ritorno della primavera; più avanti nel testo invece (La Sicilia passeggiata, p. 57) leggiamo anche i vv. 305-311 che descrivono l’amarezza di Demetra dopo la perdita della figlia e le conseguenze nefaste per gli uomini. In L’olivo e l’olivastro (p. 843) i versi 40-44 inquadrano i luoghi come scenario del vagabondaggio sofferente di Demetra. 60 La Sicilia passeggiata, p. 58; L’olivo e l’olivastro, p. 822. Al tradizionale luogo del culto di Demetra Consolo si riferisce anche nella prefazione al
Sud, nell’area dello zolfo, la tradizione colloca il regno di Plutone61. La scelta autoriale chiama in causa le dinamiche di rappresentazione del Mediterraneo, ma anche l’identità profonda degli spazi geografici, evidentemente compromessa con il mito. Immaginario collettivo e prospettiva razionalizzante si intrecciano, nell’evidenziare il legame esistente tra Sicilia e Grecia, tra due differenti rive di uno stesso mare. Il culto e il mito, infatti, sarebbero conseguenza della colonizzazione greca62.
Nel mito personale di un mondo antico vivace, fatto di intrecci e incroci alla presenza greca si aggiunge quella cartaginese o quella elima. La vicenda di quest’ultimo popolo, in bilico tra storia e mito, ha a che fare, già secondo Tucidide (VI 2), con l’arrivo in Sicilia dei Troiani: lo storico riferisce che la migrazione, successiva al crollo di Ilio, ebbe come effetto lo stanziamento in territori prossimi a quelli dei Sicani e tale vicinanza portò alla denominazione unica di Elimi per i due popoli; i centri più importanti di questa nuova civiltà furono Segesta e Erice. Consolo, pur conoscendo sicuramente il dato riportato dallo storico, è più sensibile in questo caso alla fonte poetica virgiliana. In La Sicilia passeggiata, ad esempio, il mistero sull’origine di Segesta – o Egesta – richiama i versi 755-758 del V libro dell’Eneide che proprio alla ktisis fanno riferimento63. La quale ktisis si conclude con la fondazione del tempio della dea Venere sulla vetta del monte Erice, com’è ricordato dai vv. 759-760 del V libro virgiliano che Consolo sceglie di citare in La Sicilia passeggiata (“Poi vicino alle stelle, in vetta all’Erice, fondano / un tempio a Venere Idalia”)64, quasi invitando a seguire nell’area occiden
volume di F. Fontana dedicato a Morgantina (V. Consolo, Che non consumi tu tempo vorace, cit., p. 11-13) 61 Consolo ricorda questa associazione tra mito e luogo geografico in La Sicilia passeggiata, p. 62; Uomini e paesi dello zolfo, in Di qua dal faro, p. 985. 62 Molti gli studi sulla questione che evidenziano la difficoltà di definire la reale provenienza del culto di Demetra e Kore. Si veda ad esempio P. Anello, Sicilia terra amata dalle dee, in T. Alfieri Tonini (a cura di), Mythoi siciliani in Diodoro, Atti del seminario di studi, Università degli studi di Milano, 12-13 febbraio 2007 = in “Aristonothos, scritti per il mediterraneo antico”, 2, 2008, pp. 9-24. 63 La Sicilia passeggiata, p. 106. 64 Ivi, p. 108. Consolo precisa il dato poetico aggiungendo che in realtà il tempio è antecedente all’arrivo dei Troiani: parla infatti di un sacello sicano, elimo o fenicio già dedicato al culto della dea dell’amore. Si fa riferimento al tempio anche in Retablo (Retablo, p. 458) e in L’olivo e l’olivastro (L’olivo e l’olivastro, p. 860), dove ritroviamo la citazione dei versi dell’Eneide. In L’olivo e l’olivastro sono ricordati “il bosco e la spiaggia del funerale,
tale dell’isola le orme del passaggio di Enea, sulla base delle indicazioni fornite dall’Eneide: un cammino attento potrebbe permettere di scoprire non solo l’area sacra ericina ma anche il bosco consacrato ad Anchise, la spiaggia dei sacrifici e delle gare65. La scelta di citare proprio i versi del rito di fondazione è interessante perché evidenzia la fusione tra popolazione straniera migrante, i Troiani, e popolazione locale, gli Elimi66. Da tutto ciò risulta evidente per Consolo che gli incontri, gli scambi tra popoli di culture diverse sono stati da sempre causa del cammino della civiltà, e che la chiusura, il rifiuto dell’ignoto che arriva da fuori, è perdita, regressione67. Perciò, egli, servendosi di una frase di Zanzotto, “Ci troviamo oggi tra un mare di catarro e un mare di sperma”, descrive il vecchio continente come perennemente arroccato nelle sue posizioni. “Vecchia” davvero è l’Europa, vecchia l’Italia, non solo per l’età media della popolazione, ma per una cecità di fronte all’arrivo delle masse disperate dei profughi che non riconosce la ricchezza dell’accoglienza e addirittura produce morboso attaccamento ai privilegi, difesi con pericolosi atteggiamenti xenofobi68. All’imperativo dell’accoglienza umanitaria, a cui implicitamente alludono nell’articolo Gli ultimi disperati del canale di Sicilia le immagini tremende del mare-cimitero (“bare di
delle gare in onore d’Anchise” (Ivi, p. 861), menzionati anche in Lo spazio in letteratura (Di qua dal faro, p. 1241). Al mito dell’arrivo dei Troiani in Sicilia si riferisce anche in Retablo l’onomastica relativa al fiume “Criniso o Scamandro” (p. 415). 65 Virgilio narra che Enea, fermatosi presso Drepano – l’attuale Trapani – dopo la parentesi di Cartagine, viene ospitato da Aceste e, con lui e i suoi, celebra gli onori funebri in onore di Anchise, lì seppellito un anno prima. Alla ospitalità già ricevuta da parte di Aceste si riferisce Aen. I 195. La morte di Anchise invece è accennata in Aen. III 707-710. Gli onori funebri in suo onore e i giochi successivi sono al centro del V libro (vv 42-103 e 104-603). 66 Dopo che le donne, istigate da Giunone, hanno dato fuoco alle navi (Aen. V 604-699), l’eroe, ispirato dalla visione di suo padre, decide di fondare una nuova città che sarà abitata da una parte del suo seguito e dai troiani dell’isola. Aceste e i suoi, infatti, che sono già in Sicilia (Aen. V 30 e 35-41) appartengono ad un’antica stirpe troiana. 67 Quando i Lombardi emigrarono in Sicilia, in “Corriere della Sera”, 4 maggio 1991. 68 Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, in “La Repubblica”, 18 settembre 2007. La frase di Zanzotto è ripresa da A. Zanzotto, In questo progresso scorsoio. Conversazione con M. Breda, cit., pp. 68-69. Il poeta la usa per commentare la situazione dell’Italia, sospesa tra “un’Europa invecchiante e le esplosioni demografiche vicine”.
ferro nei fondali del mare”) e dell’orrenda pesca dei morti (“i corpi degli annegati nelle reti dei pescatori siciliani”), si accompagna nella prospettiva autoriale l’invito ad una valutazione delle possibilità economiche e culturali che derivano dai flussi di migranti69. Estremamente significativo nel dibattito risulta per Consolo il caso della doppia migrazione da e verso il Maghreb. C’è stato un tempo lontano in cui il braccio di mare tra la Sicilia e le coste africane non era “frontiera, barriera fra due mondi, ma una via di comunicazione e di scambio”70, un tempo in cui era normale per i lavoratori di Sicilia, di Calabria o di Sardegna cercare fortuna nelle terre degli “infedeli”. Tale familiarità tra i due mondi è stata confermata dall’emigrazione ottocentesca, intellettuale e borghese prima, poi anche di braccianti dell’Italia meridionale, verso le coste nordafricane71. Si tratta di un fenomeno che sta molto a cuore a Consolo72. Non a caso egli lo accoglie nella narrazione di Nottetempo, casa per casa.
69 Negli stimoli offerti dall’emigrazione contemporanea Consolo scorge una possibilità di rinascita anche letteraria: così nell’intervista con A. Bartalucci (A. Bartalucci, op. cit., pp. 201-204, a p. 204). 70 Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, p. 1193. Consolo si è soffermato prima sulla seconda novella della quinta giornata del Decameron di Boccaccio che propone il tranquillo soggiorno di pescatori cristiani, trapanesi, nella musulmana Tunisia. Ma si veda anche in Retablo l’incontro di Clerici, accompagnato dal fido Isidoro e dal brigante, con Spelacchiata e i suoi compagni barbareschi, che si traduce in uno scambio di cerimonie (Retablo, pp. 438-440). L’episodio tiene conto dell’affinità culturale e della consuetudine dei rapporti tra paesi mediterranei. A proposito del valore della “rotta per Cartagine”, ovvero dell’attenzione consoliana per le relazioni storiche di contiguità e vicinanza tra Sicilia e Nord Africa, P. Montefoschi, Vincenzo Consolo: ritorno a Cartagine, in Id., Il mare al di là delle colline. Il viaggio nel Novecento letterario italiano, Carocci, Roma 2012, pp. 54-60; specificamente sull’episodio di Spelacchiata in Retablo, p. 55. 71 A proposito dell’emigrazione italiana in Tunisia si veda lo studio di F. Blandi: F. Blandi Appuntamento a La Goulette, Navarra Editore, Palermo 2012. 72 Del fenomeno Consolo fornisce dati precisi in diverse occasioni. Si veda in particolare Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, pp. 1195-1196; Il Mediterraneo tra illusione e realtà, integrazione e conflitto nella storia e in letteratura, in G. Interlandi (a cura di), La salute mentale nelle terre di mezzo. Per costruire insieme politiche di inclusione nel Mediterraneo, Atti del Convegno di Psichiatria Democratica, Caltagirone, 12-13 marzo 2009, numero monografico di “Fogli di informazione”, terza serie, 13-14, gennaio-giugno 2010, pp. 5-7.
La fuga di Petro, nuovo Enea73, si inserisce proprio nel contesto storico della migrazione verso l’Africa settentrionale. La sua vicenda non è eccezionale, se non forse per le motivazioni, ma rientra nella normalità di un flusso migratorio consolidato74. La stessa presenza del personaggio storico di Paolo Schicchi, con cui Petro ha un breve colloquio sulla nave, obbedisce alla storicità del fenomeno. L’anarchico siciliano, infatti, non fu il solo a cercare rifugio in Tunisia per ragioni politiche: esisteva sulla sponda sud del Mediterraneo una nutrita comunità di antifascisti e addirittura una vera e propria comunità anarchica siciliana a Tunisi75.
Il romanzo si chiude proprio con l’arrivo dall’altra parte del mare: i colori, le architetture, la vegetazione e gli uccelli sanciscono l’approdo ad un nuovo inizio, proprio come accadeva a coloro che emigravano in Tunisia76. Il nuovo spazio su cui si affaccia la nave si carica di attese, di possibilità, innesca un confronto con il passato, con la terra abbandonata, accende speranze, suscita decisioni. Petro lascia significativamente cadere in mare il libro che l’anarchico Schicchi gli ha consegnato durante il viaggio, a sancire il suo rifiuto per ogni forma di violenza, la sua volontà di essere “solo come un emigrante, in cerca di lavoro, casa, di rispetto”77.
La prospettiva di chi guarda e vive il passaggio ad un nuovo spazio definisce e ridefinisce i contorni della realtà, quella che ha lasciato e quella a cui va incontro. La Tunisia non è per Petro un luogo neutro e nemmeno lo è la Sicilia. Allo stesso modo la terra di partenza e la Milano dell’arrivo vengono ridiscusse nell’esperienza
73 Non a caso il capitolo finale reca l’epigrafe virgiliana Longa tibi exilia et vastum maris aequor arandum (Aen. II 780) che permette di associare la Sicilia in preda all’alba fascista ad una Ilio in rovina e Petro in fuga all’eroe costretto a cercare una nuova terra. 74 Nottetempo, casa per casa, p. 752. Nell’intervista con Gambaro (F. Gambaro, V. Consolo, op. cit., p. 102) Consolo evidenzia l’importanza degli scambi tra le due rive del Mediterraneo, proprio a partire della vicenda degli italiani emigrati, perché essi permettono un arricchimento culturale e letterario. 75 Nottetempo, casa per casa, pp. 753-754. A proposito della comunità italiana in Tunisia si veda lo studio di Marinette Pendola (Gli italiani di Tunisia. Storia di una comunità (XIX-XX secolo), Ed. Umbra, “I Quaderni del Museo dell’emigrazione”, Foligno, 2007), curatrice anche del sito www.italianiditunisia.com, denso di informazioni storiche. 76 Nottetempo, casa per casa, p. 755. 77 Ibidem.
di migrazione che conduce i meridionali, negli anni del miracolo economico, alla volta del Nord. Come accade, d’altronde, allo stesso Consolo che, sebbene non si muova per fame ma per realizzazione intellettuale, sperimenta il passaggio, vive una ridefinizione dei luoghi. L’insistenza dell’autore sulla presenza significativa degli italiani in Maghreb e sugli innumerevoli scambi avvenuti tra l’una e l’altra riva del mare fin dal Medioevo va considerata in relazione al suo interesse per quell’emigrazione africana in Italia che ha avuto origine negli anni Sessanta e che non si è più arrestata. Le riflessioni a tal proposito sono estremamente lucide e inquadrano precocemente la questione. I primi lavoratori tunisini, forniti del semplice passaporto con il visto turistico e sprovvisti di quell’autorizzazione che permetteva un regolare contratto di lavoro, giungevano in Sicilia nel 1968. La presenza di questi primi immigrati, costretti a ritornare in patria alla scadenza del visto turistico, rispondeva alla domanda di lavoro a buon mercato da parte di proprietari terrieri e di armatori, per i quali reclutare questa manodopera e sfruttarne la condizione abusiva era senza dubbio un vantaggio. Ai primi immigrati si aggiunsero allora parenti e amici e il fenomeno si allargò78. “L’emigrazione in Italia dei poveri del Terzo Mondo”79 ha inizio a Mazara, proprio lì dove il 17 giugno 827 – ricorda Consolo citando Amari – sbarcavano i musulmani, città splendida e prestigiosa secondo il geografo Idrisi80. A distanza di secoli, scomparsa la bellezza del passato, dopo che miseria e crollo avevano generato quell’altra migrazione, “di pescatori, muratori, artigiani, contadini di là dal mare, a La Goulette di Tunisi, nelle campagne di Soliman, di Sousse, di Biserta”81, il miracolo economico degli anni Sessanta attivava di nuovo la rotta dal Nord Africa82.
78 Sul fenomeno si veda A. Cusumano, Il ritorno infelice, Sellerio, Palermo 1978. Consolo lo cita in diverse occasioni, ad esempio, Il ponte sul canale di Sicilia, Di qua dal faro, p. 1197. 79 L’olivo e l’olivastro, p. 865. 80 Ivi, p. 864. 81 Ivi, p. 865. 82 Ibidem. Si veda anche Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, pp. 1197-1198. Molti gli articoli sul caso di Mazara, ad esempio I guasti del miracolo, cit.; Morte per acqua, cit; “Ci hanno dato la civiltà”, cit. Ancora precedente l’articolo uscito su “Sans frontières” nel 1980 che si sofferma sulla storia di Mazara prima di concentrarsi sulla quarta guerra punica o guerra
L’inversione di rotta, di cui Consolo evidenzia la specularità rispetto a quella italiana, va a riempire i vuoti lasciati dall’altro flusso migratorio, quello dei meridionali verso il Nord, e, anche se il caso di Mazara ha una sua indiscussa esemplarità, il fenomeno, come si è detto, già all’origine riguarda un po’ tutto il trapanese: una terra che ha più di un tratto in comune con la regione di partenza83. Ma mentre, accennando alla somiglianza geografica e culturale delle due rive del Mediterraneo, riporta l’attenzione sulla vicinanza tra i popoli e sui risvolti positivi dello scambio del passato, Consolo lascia emergere la stortura del presente e individua in questa nuova migrazione l’inizio di una lunga serie di episodi di xenofobia e persecuzione84. Gli immigrati maghrebini, infatti, a Mazara in maniera significativa, ma anche altrove, divennero presto oggetto di sfruttamento, divennero strumento di speculazione politica, furono vittime di razzismo, caccia, di rimpatrio coatto. Nel 1999, in Di qua dal faro Consolo già lamenta l’assenza di previsioni, progettazioni, di accordi tra governi85. La vicenda dei tunisini del trapanese e quella di tutti coloro che hanno attraversato e attraversano le acque del Mediterraneo – ma in alcune pagine il discorso si estende al mondo intero – alla ricerca di una nuova vita sono parte di un’unica drammatica storia scandita dalle tragedie quotidiane di corpi senza vita86.
del pesce i cui protagonisti erano proprio i tunisini immigrati della casbah: Quatrième guerre punique, in “Sans frontières”, 30 settembre 1980. 83 Alla somiglianza tra Italia meridionale e Nord Africa Consolo fa riferimento in“Ci hanno dato la civiltà”, cit.. Sulla questione anche un articolo del 1981, Immigration africaine en Italie (“Sans frontières”, 3 gennaio 1981): l’Italia è la prima tappa dei migranti per necessità geografiche ma anche perché è una terra non veramente straniera. 84 L’olivo e l’olivastro, p. 865; Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, p. 1197. Nel precedente I guasti del miracolo (cit.) Consolo rileva lo scandalo del dopo terremoto di Mazara (7 giugno 1981): ai tunisini vengono negate le tende, perché stranieri e perché non votanti e quindi ininfluenti nelle imminenti elezioni regionali. 85 Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, pp. 1197-1198. 86 Uomini sotto il sole, in Di qua dal faro, p. 1202. In particolare l’espressione “d’altri, scoperti, gettati in pasto ai pescecani” allude ad un episodio specifico, già tema del racconto Memoriale di Basilio Archita (Le pietre di Pantalica, pp. 639-646): nel maggio 1984, l’equipaggio della nave Garyfallia, che al comando di Antonis Plytzanopoulos era salpata dal porto di Mombasa da poche ore, si rese colpevole della morte, in mare aperto, proprio in pasto ai
L’ombra del mito antico si affaccia a rappresentare il destino dei migranti: essi ripetono l’esilio di Ulisse, ma soprattutto sono Enea in fuga da una terra in fiamme, oppure sono Troiane, fatte schiave e costrette ad allontanarsi dalla propria patria87.
La condizione degli esseri umani nel mare nostrum sembra così trovare una sintesi nella citazione da Braudel – “in tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato”88–, originariamente riferita all’età di Filippo II. Ma ancor di più i versi eliotiani di Morte per acqua, che ritornano con frequenza sorprendente nei testi giornalistici e nelle prove narrative, riescono a parlare della realtà contemporanea. Già in Retablo l’episodio in cui la statua dell’efebo di Mozia si perde nel mare suscita la riflessione su un’altra perdita, che è ben più grave, quella delle vite umane che in ogni tempo si sono spente e si spengono nell’acqua, “sciolte nelle ossa” come Phlebas il fenicio89. In L’olivo e l’olivastro la citazione si lega esplicitamente alla memoria di un fatto di cronaca: nel 1981 il giovane Bugawi, vittima del naufragio del Ben Hur di Mazara, rimane in fondo al mare e “una corrente sottomarina / gli spolpò le
pescecani, di un gruppo di clandestini. I migranti non vengono sacrificati solo nel Mediterraneo: la vicenda, infatti, come ricorda anche la voce narrante del racconto, il siciliano Basilio Archita, si svolge al largo delle coste del Kenia. I responsabili sono un “manipolo di orribili greci, dai denti guasti e le braccia troppo corte, mostri assetati di sangue e di violenza” (S. Giovanardi, Imbroglio siciliano, in “La Repubblica”, 2 novembre 1988; Id., Le pietre di Pantalica, in S. Zappulla Muscarà, Narratori siciliani del secondo dopoguerra, cit., pp. 179-182), insomma non hanno niente a che fare con i valori dell’antica Grecia. E anche la citazione di Kavafis, in bocca ad uno di loro, stride nel confronto con il terribile delitto. 87 Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, cit., o in I muri d’Europa, cit., p. 25. Entrambi i testi si aprono con citazione dalle Troiane di Euripide (vv. 45-47) e dall’Eneide di Virgilio (II 707-710). 88 Ad esempio a conclusione di Il ponte sul canale di Sicilia, in Di qua dal faro, p. 1198; Il mare, in La mia isola è Las Vegas, p. 222; Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, cit.; I muri d’Europa, cit., p. 30; nel discorso al convegno per Psichiatria democratica, Il Mediterraneo tra illusione e realtà, integrazione e conflitto nella storia e in letteratura, cit. La citazione è tratta da F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, cit., pp. 981-982). 89 Retablo, p. 453.
ossa in sussurri”90. Ma anche i naufraghi di Scoglitti91 sono Phlebas il fenicio, e lo sono tutti i morti del Mediterraneo, tutti quelli che le carrette stracariche e le responsabilità umane hanno lasciato affogare92. Dal 2002 in poi Consolo interviene in maniera decisa e con la consueta indignazione sull’intensificarsi del fenomeno migratorio e sulle responsabilità della politica. Già un testo del ‘90 evidenzia l’ampliamento smisurato del braccio di mare tra Sicilia e Nord Africa, ovvero, la distanza economica creatasi tra i due mondi93. Ancora di più gli articoli successivi, suscitati in particolare dalla legge Bossi Fini, si concentrano sul contrasto evidentissimo, soprattutto a Lampedusa e nelle altre Pelasgie, tra l’opulenza del turismo nella natura incontaminata e la disperazione dell’approdo dei migranti94. Il procedimento antifrastico con cui Consolo si finge sostenitore delle ragioni dei ricchi vacanzieri contro gli sbarchi invadenti degli stranieri evidenzia lo stridere dei due mondi: “Ma lì, a Lampedusa, inopinatamente vi giungono anche, mannaggia, gli emigranti clandestini”95. Così la bella Lampedusa diventa nuovamente scenario di guerra contro l’infedele, come nel poema ariostesco. Se la Lipadusa del Furioso, “piena d’umil mortelle e di ginepri / ioconda solitudi
90 L’episodio è rievocato, con citazione da Eliot, in L’olivo e l’olivastro, pp. 865-866. Nel giugno del 1981 appena dopo il terremoto che aveva colpito Mazara, gli armatori ebbero fretta di rimandare in acqua le navi. Nel naufragio del Ben Hur morirono cinque mazaresi e due tunisini. L’identità di questi rimase ignota per diversi giorni: un indizio della condizione di sfruttamento e illegalità in cui lavoravano gli stranieri. Sullo stesso episodio, sempre con riferimento a Phlebas il fenicio, si veda il già citato Morte per acqua, cit., o “Ci hanno dato la civiltà”, cit. 91 Dedicato ai morti per acqua, in “L’Unità”, 29 settembre 2002. La citazione dei versi di Eliot chiude l’articolo e, che mi risulti, è l’unico caso in cui il passo è riportato per intero. Consolo si riferisce a quanto avvenuto il 24 settembre 2002: uno scafista abbandona a 300 metri dalla spiaggia di Scoglitti il suo carico di migranti; le onde impediscono l’approdo, muoiono 14 persone. 92 Gli ultimi disperati del canale di Sicilia, cit., o in I muri d’Europa, cit., p. 29. Meno esplicito il riferimento a Eliot in Immigrati avanzi del mare, in “L’Unità”, 18 giugno 2003, dove è l’aggettivo “spolpato” (“qualche corpo gonfio o spolpato finisce nelle reti dei pescatori”) che allude a Phlebas il fenicio. 93 Cronache di poveri venditori di strada, cit. 94 Il mondo di Bossi Fini stupido e spietato, in “L’Unità”, 29 agosto 2002. 95 Ibidem.
ne e remota / a cervi, a daini, a caprioli, a lepri”96, ospita il triplice duello di Orlando, Brandimarte e Oliviero contro i saracini Gradasso, Agramante e Sobrino, nel Duemila l’isola, divenuta da “remoto scoglio”, “meta ambitissima del turismo esclusivo”, è luogo d’approdo di pescherecci e gommoni che rovesciano il loro carico di clandestini: “i nuovi turchi, i nuovi invasori saracini”97. E – ancora è dominante l’antifrasi –, se non ci sono gli antichi paladini a combatterli e neppure le navi militari auspicate da Bossi, c’è però il mare “quel fascinoso mare azzurro e trasparente che d’improvviso s’infuria e travolge ogni gommone o peschereccio”98. Tanto più assurde si rivelano le leggi per gestire gli arrivi e, se già prima della Bossi Fini, Consolo lamentava la violazione sistematica dei diritti dell’uomo, dopo il 2002 è ancora più duro. Bersaglio polemico sono le nuove normative, più rigide di quelle previste dalla legge Martelli o dalla Turco-Napolitano: le nuove disposizioni prevedono che le carrette siano bloccate in acque extraterritoriali, “forse anche speronate e affondate. Con tutto il loro carico umano”99. Bersaglio polemico sono i centri di prima accoglienza che – scrive – non meriterebbero questo nome, perché piuttosto di lager si tratta, luoghi atroci, di violenza e umiliazione100. Bersaglio polemico è la diffusione di sentimenti xenofobi, suscitati dalla politica nella mentalità comune, ben rappresentata dall’io narrante del racconto eponimo di La mia isola è Las Vegas che invoca la costruzione di muri d’acciaio per arrestare la marea dei migranti101. In quest’ottica di critica alla nuova legge e all’inadempienza del dovere morale verso i migranti va letta la netta opposizione di Consolo al progetto di un museo della migrazione a Lampedusa, promosso nel 2004 dalla deputata regionale dell’Udc Giusy Savarino. A lei l’autore si rivolge pubblicamente dalle pagine di “La
96 Ariosto, Orlando Furioso, XL 45 vv. 3-4. Il passo è ricordato da Consolo in Lampedusa è l’ora delle iene, “L’Unità”, 28 giugno 2003. Ma si veda anche Isole dolci del dio, cit., pp. 33-35. 97 Lampedusa è l’ora delle iene, cit. 98 Ibidem. 99 Il mondo di Bossi Fini stupido e spietato, cit. 100 Ibidem ma anche Immigrati avanzi del mare, cit. 101 La mia isola è Las Vegas, in La mia isola è Las Vegas, p. 217.
Repubblica”, accusando l’ipocrisia profonda di una tale iniziativa102 e riflettendo su quanto sia irrimediabilmente compromessa l’identità dello spazio mediterraneo. Che cosa rimane del mare di miti e storia? Che cosa della mirabile convivenza tra culture diverse? Il monito dei reperti archeologici, delle narrazioni risulta poca cosa di fronte al mutamento dello sguardo collettivo sancito da leggi xenofobe e lager mascherati da centri di accoglienza: il mare si è fatto frontiera, confine, che gli altri, gli stranieri, non devono superare. Ed è contemporaneamente cimitero, spazio del sacrificio, della tragedia. Perciò il progetto di un museo a Lampedusa, l’isoletta dell’ariostesca lotta contro l’infedele, è, per Consolo, strumento di una retorica ipocrita, che non è giusto appoggiare: che senso avrebbe un monumento all’emigrazione, quando proprio i migranti vengono combattuti, respinti, lasciati morire in mare? Ma, d’altra parte, è il mondo intero ad aver subito una metamorfosi: si è mutato agli occhi dell’autore in un “im-mondo”, ovvero negazione di se stesso, perché preda della follia. La ripetizione dell’aggettivo “nostro”, associato sia allo spazio stravolto che alla massa di cadaveri, assume, nel testo in versi Frammento, toni accusatori, richiamando gli esseri umani alle proprie responsabilità nei confronti della morte di innocenti.
Nostri questi morti dissolti
nelle fiamme celesti,
questi morti sepolti
sotto tumuli infernali,
nostre le carovane d’innocenti
sopra tell di ceneri e di pianti.
Nostro questo mondo di follia.
Quest’im-mondo che s’avvia…103
102 Solo un monumento per gli immigrati, in “La Repubblica”, 21 agosto 2004. Sulla questione Consolo si era già espresso qualche giorno prima: Perché non voglio quel museo, in “La Repubblica”, 19 agosto 2004. 103 Frammento, in Per una Carta “visiva” dei Diritti civili, Viennepierre, Milano 2001, anche in “Microprovincia”, 48, gennaio-dicembre 2010, p. 5.
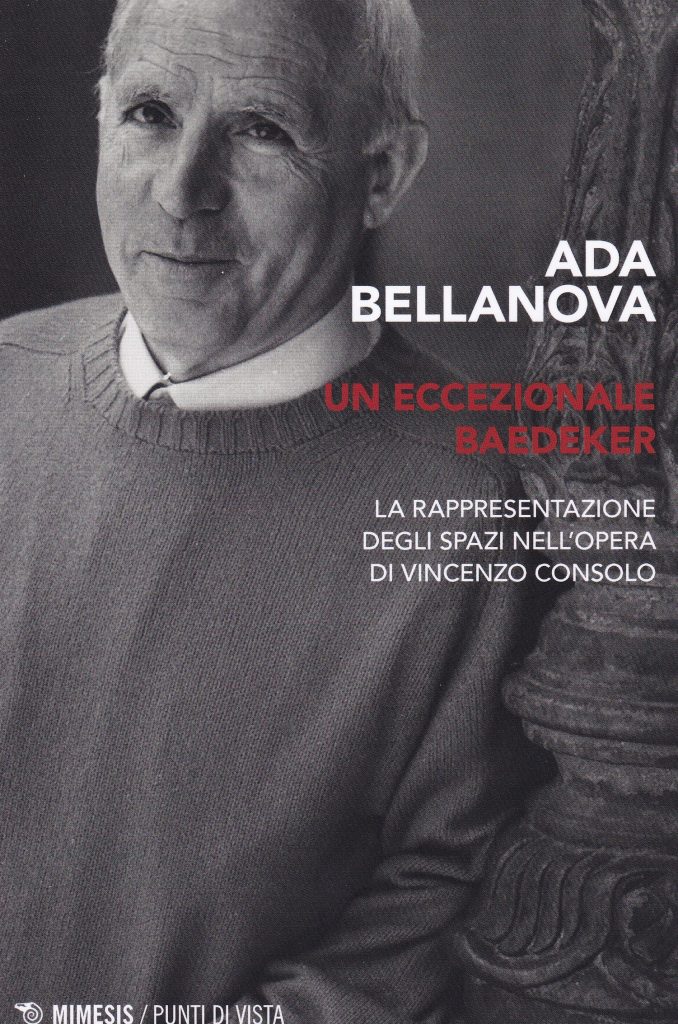
Sant’Agata e oltre
“Un eccezionale baedeker”
La vicenda biografica, il viaggio, l’esplorazione partono da Sant’Agata, un paese sconosciuto ai più, ai piedi dei Nebrodi e affacciato sul mare Tirreno, con le Eolie a vista [1]. Proprio qui Consolo nasce e trascorre i primi anni della sua vita, così che il luogo produce memoria, lo segna «nella carne, nell’anima», diventa ineludibile traccia di un percorso narrativo[2].
Oltre alle ragioni autobiografiche e affettive, a favorire la presenza di Sant’Agata nelle mappe di Consolo è anche la riflessione autoriale sulla posizione geografica del paese che si trova, per così dire, al confine tra un oriente e un occidente, ovvero «alla confluenza di due regni, dove si perdono, si sfumano, si ritraggono in una sommessa risacca le onde lunghe della natura e della storia»[3]. Eppure il toponimo raramente compare nei testi narrativi, anche se i dettagli geografici consentono di rintracciare nello scenario i tratti dello spazio reale. Così ne La ferita dell’aprile, di cui già si è detto, o in La grande vacanza orientale-occidentale, scopertamente autobiografico, dove già la prima immagine – la vista dei Nebrodi alti e rigogliosi – e poi la partecipata descrizione della marina, delle fatiche dei pescatori, del litorale da Cefalù a Capo d’Orlando, delle galleggianti Eolie, di una spiaggia «pietrosa» a cui tornare come si trattasse di Itaca, il cenno veloce al Castello e alla Matrice fanno pensare a Sant’Agata. La grande ricchezza di notazioni affettive e di riferimenti a percezioni sensoriali testimonia l’esperienza e la memoria.
In Alesia al tempo di Li Causi addirittura il luogo è mascherato da un toponimofittizio ma il referente reale dello spazio di invenzione è svelato dal riferimento al castello dei Gallego e dalla vista delle Eolie all’orizzonte[4]. Nella piazza del paese – anonima – Ciccio, il giovane protagonista del racconto, «figlio d’un commerciante di alimentari», assiste agli eventi della Storia: il comizio di Girolamo Li Causi, le lotte dei contadini, gli echi della strage di Portella della Ginestra, la propaganda della Democrazia Cristiana e la vittoria nelle elezioni del 1948. Anche una “contrada” poco nota può essere toccata dai grandi rivolgimenti storici: può capitare che un ragazzino li osservi con «la testa tra i ferri della ringhiera», si chiami Ciccio o Vincenzo. Piazza Vittorio Emanuele, qui solo accennata e invece descritta in maniera precisissima in La testa tra i ferri della ringhiera, con chiari riferimenti al castello, ai palazzi nobiliari, alla bordatura di possenti platani[5], diventa dunque punto di osservazione privilegiato, la radice di una prospettiva nuova sul corso delle cose, e l’esperienza dei grandi eventi registrata dai sensi si fa elemento propulsore fortissimo di un lungo e complesso dialogo tra la letteratura e la Storia.
Il sorriso dell’ignoto marinaio deve la sua riuscita anche alla straordinaria scelta di mappare il castello Gallego di Sant’Agata con le scritte dei prigionieri di Alcara. Un luogo familiare, uno dei più rappresentativi del paese natio, si trasforma in elemento narrativo determinante. Lo spazio reale si traduce in scenario e simbolo: la scala diventa chiocciola, la chiocciola diventa storia, anzi la Storia, che si avvolge su se stessa e si confonde e confonde. E anche la rilettura del Risorgimento, attraverso la valorizzazione di un luogo e di un episodio “senza nome”, trova una sua radice a Sant’Agata, lì dove si sono riversati i ricchi proprietari terrieri in fuga «dopo rivolte contadine di Alcàra, d’Alunzio e di Bronte»[6].
Il toponimo è taciuto anche in L’olivo e l’olivastro, dove sono intimi i dettagli del ritorno doloroso, ad un paese che resta immobile, uguale a se stesso[7], mentre la madre si fa evanescente come Euridice e la casa viene distrutta, spazzata dalle ruspe, sostituita da un palazzo di banche e uffici che nasconde la vista della spiagge e del mare[8].
La vicenda,
chiaramente autobiografica, diventa emblema della rapinosa speculazione
edilizia capace di travolgere anche ciò che è più caro e genera una traccia
narrativa ne Lo Spasimo di Palermo, traducendosinella
distruzione del giardino palermitano di Martinez, nell’apertura del cantiere e
nella costruzione di una nuova casa tra palazzi e casamenti[9].
[1]«Una costa diritta, priva di insenature, cale, ai piedi dei Nèbrodi alti, verdi d’agrumi, grigi d’ulivi. Una spiaggia pietrosa e un mare profondo che a ogni spirare di vento, maestrale, tramontana o scirocco, ingrossava, violento muggiva, coi cavalloni sferzava e invadeva la spiaggia» (La grande vacanza orientale-occidentale, La mia isola è Las Vegas, pp. 163-169, a p. 163).
[2]«Sì, si può cadere su questo mondo per caso, ma non si nasce in un luogo impunemente. Non si nasce, intendo, in un luogo senza essere subito segnati, nella carne, nell’anima da questo stesso luogo. Il quale, con gli anni, con l’inesorabile, crudele procedere del tempo, si fa per noi sempre più sacro. […] Fin dal primo sguardo sul mondo, fin dai primi bagliori dei ricordi – e sono scene isolate, fotogrammi luminosi incorniciati dal nero dell’immemorabile – si è impresso, Sant’Agata, dentro di me per sempre. Hieme et aestate et prope et procul, com’era scritto nella stele fogazzariana, io porto in me questo punto unico del mondo, questo paese […] Mi sono ispirato, narrando, a questo mio paese, mi sono allontanato da lui per narrare altre storie, di altri paesi, di altre forme. Però sempre, in quel poco che ho scritto, ho fatalmente portato con me i segni incancellabili di questo luogo», Memorie, prima “Il Valdemone”, I, 1febbraio 1990, pp. 7-9, ora La mia isola è Las Vegas, pp. 134-138 alle pp. 135-138.
[3]Ivi, p. 137. Sant’Agata assume il ruolo di limen, ago della bilancia tra un’area dell’isola maggiormente segnata dalla natura e un’altra in cui invece hanno la meglio la ragione, la storia. Nel luogo delle sue radici, dunque, Consolo individua la molla della sua aspirazione ad una narrazione che sia «incontro miracoloso, di ragione e passione, di logica e di magico, di prosa e poesia» (Ivi, p. 138).
[4]Alesia al tempo di Li Causi, prima “Il Manifesto”, 19 agosto 2007, ora La mia isola è Las Vegas, pp. 223-227, a p. 223.
[5]La testa tra i ferri della ringhiera, La mia isola è Las Vegas, pp. 201-204, alle pp. 201-202.
[6]Alesia al tempo di Li Causi, La mia isola è Las Vegas, a p. 223.
[7]L’olivo e l’olivastro, pp. 848-849.
[8]Ivi, p. 850.
[9]Lo Spasimo di Palermo, p. 931. Nei dintorni di Sant’Agata è ambientato anche il racconto dell’infanzia di Chino, con indubbio recupero di materiale autobiografico (ad esempio Ivi, p. 981).
Tratto da “Un eccezionale baedeker”
(La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo)
foto di copertina Giuseppe Leone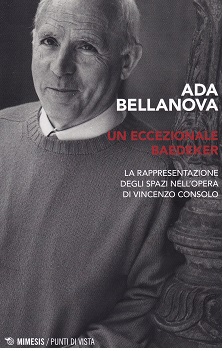
La Sicilia passeggiata Vincenzo Consolo fotografie di Giuseppe Leone
di Gianni Turchetta
Da molti anni speravo di ripubblicare La Sicilia passeggiata. E mi piace ricordare subito come anche Caterina, la compagna di una vita di Vincenzo Consolo, lo desiderasse molto. Benché rimasto appartato, e conosciuto quasi solo dagli specialisti, questo testo, come potrete presto constatare, esercita sul lettore una seduzione intensa, fatta di leggerezza e profondità, dinamismo e erudizione. Queste qualità sono rilanciate e riecheggiate a ogni pagina dalla forza vibrante e dalla fulminea capacità di condensazione visiva e simbolica delle foto di Giuseppe Leone.
In La Sicilia passeggiata narrazione, poeticità e saggismo si fondono felicemente, integrandosi nell’evidenza dinamica degli spostamenti, marcata a ogni passo dai verbi di moto. Si veda l’attacco, tra avventuroso e onirico: “Sospinti dal vento, immaginiamo d’approdare” (p. 17). È una trama lieve e decisa, che quasi sospinge il lettore: “Non sostiamo. Procediamo” (ibidem), “Siamo giunti” (p. 18), “è da qui che vogliamo partire” (ibidem); o ancora: “Abbandoniamo” (p. 46), “Dalla piazza di Scicli voliamo” (p. 48), “Andiamo avanti, avanti” (p. 76), “Salpiamo da Porto Empedocle” (p. 96) e così via. In prima approssimazione, il viaggio attraverso cui Consolo ci guida va da Oriente a Occidente. Si parte dalla necropoli di Pantàlica, per poi raggiungere i Monti Iblei, il Val di Noto, Scicli, e poi Còmiso, Vittoria, Ragusa Ibla, Modica, Siracusa, e ancora Enna, i paesi dello zolfo e quelli del latifondo, fino a immettersi “nell’antica strada che congiungeva Arigento a Catania” (p. 90), arrivare a Gela, Agrigento e la Valle dei Templi, Porto Empedocle, proseguendo per Sciacca, Caltabellotta, Selinunte, Salemi e Calatafimi, e poi Segesta, Trapani, e da qui ancora Èrice e Mozia, le Égadi, fino a Palermo, già punto d’arrivo del viaggio siciliano di Goethe. Ma il movimento fisico è solo l’asse portante di una fitta sequenza di scorribande attraverso il tempo e lo spazio, in un andirivieni senza soste, modulato da continue transizioni tematiche. L’inarrestabile fluidità del discorso è del resto dichiarata apertamente, e coincide con il desiderio di una conoscenza efficace proprio perché pronta a riconoscere un’irriducibile pluralità: “vogliamo partire”, infatti, “per un nostro viaggio, per una nostra ricognizione della Sicilia, per inventarci, liberi come siamo da confini di geografia, da limiti d’epoca storica o da barriere tematiche, un modo, tra infiniti altri, per conoscere quest’isola al centro del Mediterraneo, questo luogo d’incrocio d’ogni vento e assalto, d’ogni dominio e d’ogni civilizzazione.” (p. 18)
Si viaggia, insomma, sotto il segno della molteplicità, caratteristica dell’identità della Sicilia, ma anche del Mediterraneo tutto, come Consolo ha ribadito per una vita intera. Né possiamo dimenticare quanto la pluralità (di lingue, di stili, di generi) sia il cuore della sua ricerca artistica. Il movimento che sospinge La Sicilia passeggiata è incardinato, originalmente, su una prima persona plurale: dove il “noi” è pluralis majestatis, ma piuttosto sobria allusione a una possibile piccola compagnia di viaggiatori. Proprio per questo il “noi” assume una movenza esortativa, come d’invito al lettore a viaggiare insieme all’autore: stabilendo così una sorta di intimità, di vicinanza affettiva oltre che culturale. Non dimentichiamo che questa è una “Sicilia passeggiata”, dove il riferimento alla “passeggiata” non è disimpegno, ma possibilità di conquistare un peculiare regime di leggerezza e libertà, che si fa garanzia di conoscenza, perché capace di accogliere le ragioni della storia insieme a quelle del mito e del sogno, e dunque della poesia. D’altro canto, La Sicilia passeggiata, come è tipico dell’odeporica, della letteratura di viaggio, è sì racconto, ma sempre sorretto da informazioni e spunti lato sensu saggistici: come del resto tutto quello che scrive Consolo. La scelta del titolo è tuttavia segno di differenze profonde rispetto ad altri testi ch’egli scrive in quegli anni. Proviamo a metterle a fuoco.
Quello che poi diventerà La Sicilia passeggiata esce per la prima volta col titolo Kore risorgente. La Sicilia tra mito e storia, in un lussuoso volume hard cover (cm. 29×25), Sicilia teatro del mondo, pubblicato da Nuova ERI / Edizioni RAI nel settembre 1990. Di questo volume costituisce la “metà” letteraria, affiancata, oltre che dalle fotografie di Giuseppe Leone, che già dialogano con il testo consoliano, da un bel saggio di Cesare De Seta, Teatro geografico antico e moderno del Regno di Sicilia, che racconta la storia siciliana a partire dall’omonimo volume uscito a Madrid nel 1686, del cui sontuoso apparato iconografico si riproducono circa cento stampe, su cartoncino. Entrambi i testi sono tradotti in francese (da Nicole Dumoulin) e in inglese (da Richard Kamm). Pochi mesi dopo, nel febbraio 1991, il testo di Consolo e le fotografie di Giuseppe Leone diventano però un volume autonomo, stavolta in un agile formato paperback (cm. 24×14), edito ancora da ERI, con il titolo che qui riproponiamo.
Rispetto alla storia della scrittura di Consolo, La Sicilia passeggiata si colloca fra due opere diversissime, ma che sono entrambe, a loro volta, il racconto di un viaggio in Sicilia. La prima è il romanzo Retablo (1987), ambientato nel 1760-1761, in un Settecento volutamente remoto e irreale, mezzo storico e mezzo fantastico, in opposizione alla deludente realtà storica. La seconda è L’olivo e l’olivastro (1994), viaggio stavolta autobiografico, ancora più apertamente polemico contro il degrado del presente, incardinato sullo schema omerico del nòstos (evocato fin dal titolo, ch’è citazione dall’Odissea). Numerosi spunti odeporici compaiono anche in Le pietre di Pantalica (1988): a prima vista un libro di racconti, ma in realtà frutto della fusione di un originario impianto romanzesco con un pacchetto di narrazioni autobiografiche. Più esili sono invece i rapporti con il romanzo storico Nottetempo casa per casa (1992, Premio Strega)[1]. Proprio il confronto con gli altri due viaggi in Sicilia aiuta a delineare con nettezza, per differentiam, i contorni di La Sicilia passeggiata. Per dirla in pochi cenni, è vistosa anzitutto la distanza rispetto alla fiction di Retablo, con cui pure ci sono non pochi fascinosi elementi di contatto (come i rimandi alla visita goethiana alla grotta di Santa Rosalia, che in Retablo però compare all’inizio, mentre qui è in chiusura). Ma non meno evidente è lo scarto rispetto all’impianto poematico, stilisticamente “alto”, tragico, di L’olivo e l’olivastro, che intreccia il viaggio in Sicilia con la rievocazione delle vicende di personaggi storici rilevanti nella storia dell’isola (Empedocle, Verga, Caravaggio, Maupassant, Saverio Landolina, August von Platen, il giudice Ciaccio Montalto, ucciso dalla mafia, e altri ancora). La copia postillata dall’autore di La Sicilia passeggiata mostra, significativamente, ipotesi di interventi che avrebbero non solo ampliato materialmente il testo, ma anche contribuito a spostarne l’intonazione verso l’alto e i contenuti verso la deprecatio temporis, sospingendolo verso quello che sarà poi L’olivo e l’olivastro. Ma i due libri vanno in realtà in direzioni molto diverse, quasi opposte. Se L’olivo e l’olivastro è infatti tutto teso a sottolineare “i processi di imbarbarimento, di perdita, di orrori”, come dichiarato in un’intervista, La Sicilia passeggiata intende invece valorizzare la ricchezza storica, artistica e naturale dell’Isola, per coglierne l’irriducibile complessità. Come osserva opportunamente Ada Bellanova, “l’attenzione per gli esseri umani e gli intrecci di identità diverse diventa in La Sicilia passeggiata il nodo centrale dello sforzo di dire”[2]. Senza contare l’importanza del rapporto, assai stretto e in qualche misura fondativo, fra il percorso e l’apparato fotografico che lo accompagna, collocandolo in una piccola tradizione di libri dove il testo di Consolo sta accanto a foto dedicate a “luoghi geografici, specialmente siciliani”[3].
Certo anche La Sicilia passeggiata conferma, con la densità dei suoi riferimenti alla classicità greco-latina, l’appartenenza a una stagione di riavvicinamento all’antico, che si fa misura del degrado e della corruzione del presente. Ricordiamo anche la tragedia Catarsi (1989), dedicata alla morte di Empedocle. Consolo si mostra ben consapevole delle differenze tematiche e tonali proprio nel momento in cui, invece che integrare e ampliare La Sicilia passeggiata, decide di scrivere un altro libro, molto più cupo, “alto” e polemico, come L’olivo e l’olivastro. La Sicilia passeggiata va letta, anzitutto, nella chiave della complessità e dell’ambivalenza, che Consolo ritrovava già in Goethe: “Isola dell’esistenza pura e contrastante. Isola dell’infanzia, dei miti e delle favole. Isola della storia. Di storia dei primordi, degli evi di scoperte e di conquiste. Storia di classici equilibri, di decadenze, di crolli, di barbarie. Crogiuolo di civiltà, babele delle razze e delle lingue. Enigma mai risolto è la Sicilia, è archetipo, aleph, geroglifico consunto, alfabeto monco” (p. 18). Dove la contraddizione originaria è anzitutto quella più assoluta e irriducibile: il contrasto fra Vita e Morte, evocato già dal primo titolo, Kore risorgente, che allude alla storia di Persefone, sposa di Ade e regina dell’Oltretomba, che ogni sei mesi torna all’aperto dalla madre Demetra e fa rifiorire la Terra. Non a caso, del resto, questo viaggio siciliano comincia dalla necropoli protostorica di Pantàlica: “vogliamo partire da questo luogo estremo e abissale, da questa soglia per cui si passa dalla scansione della storia all’oscurità del tempo, all’eterno circolare e immoto […]. Poiché Pantàlica è sì un luogo di morte, ma è insieme luogo di resurrezione, di cominciamento: è luogo-simbolo di questa complessa e contrastante terra di Sicilia, della sua storia di ricorrente distruzione e di rinascita” (p. 20). In una direzione analoga vanno molte altre storie evocate: come quella del catastrofico terremoto in Val di Noto del 1693, da cui poi nacquero alcune delle più straordinarie realizzazioni artistiche del barocco siciliano. Ma persino lo spaventoso groviglio di contraddizioni che è Palermo la Rossa, su cui si chiude il libro, riconferma una dinamica analoga. Santa Rosalia, infatti, la “Santa estatica” patrona di Palermo, coincide con “tutte la Sante vergini di Sicilia, Agata Lucia Venera Ninfa, ed è insieme Kore e Persefone”, e si colloca dunque di nuovo sotto il segno della vita che rinasce, di Demetra che torna alla superficie e alla luce: “Come fa l’ape nella primavera, come fa la primavera della storia” (p. 138). Con questa certezza anche noi, dopo tanto buio, ricominciamo il nostro viaggio.
RINGRAZIAMENTI.
Un grazie specialmente sentito va a Giuseppe Leone, che per la presente edizione
ha rivisto e arricchito lo splendido apparato fotografico: così questo libro è
un ritorno, ma anche un libro nuovo. Grazie, di cuore, a Claudio Masetta
Milone, che mi ha rivelato le postille di Consolo al volume, e a Francesca
Adamo, che ha creduto in questo libro e ne ha curato con competenza impaginazione
e redazione.
[1] Per una ricostruzione dettagliata della storia delle opere a cavallo fra fine anni Ottanta a primi anni Novanta mi permetto di rimandare a G. Turchetta, Note e notizie sui testi, in V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di G. Turchetta, e con uno scritto di C. Segre, Mondadori, Milano 2015, pp. 1351-1425.
[2] A. Bellanova, Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2021, p. 28.
[3] Ivi, p. 25n. 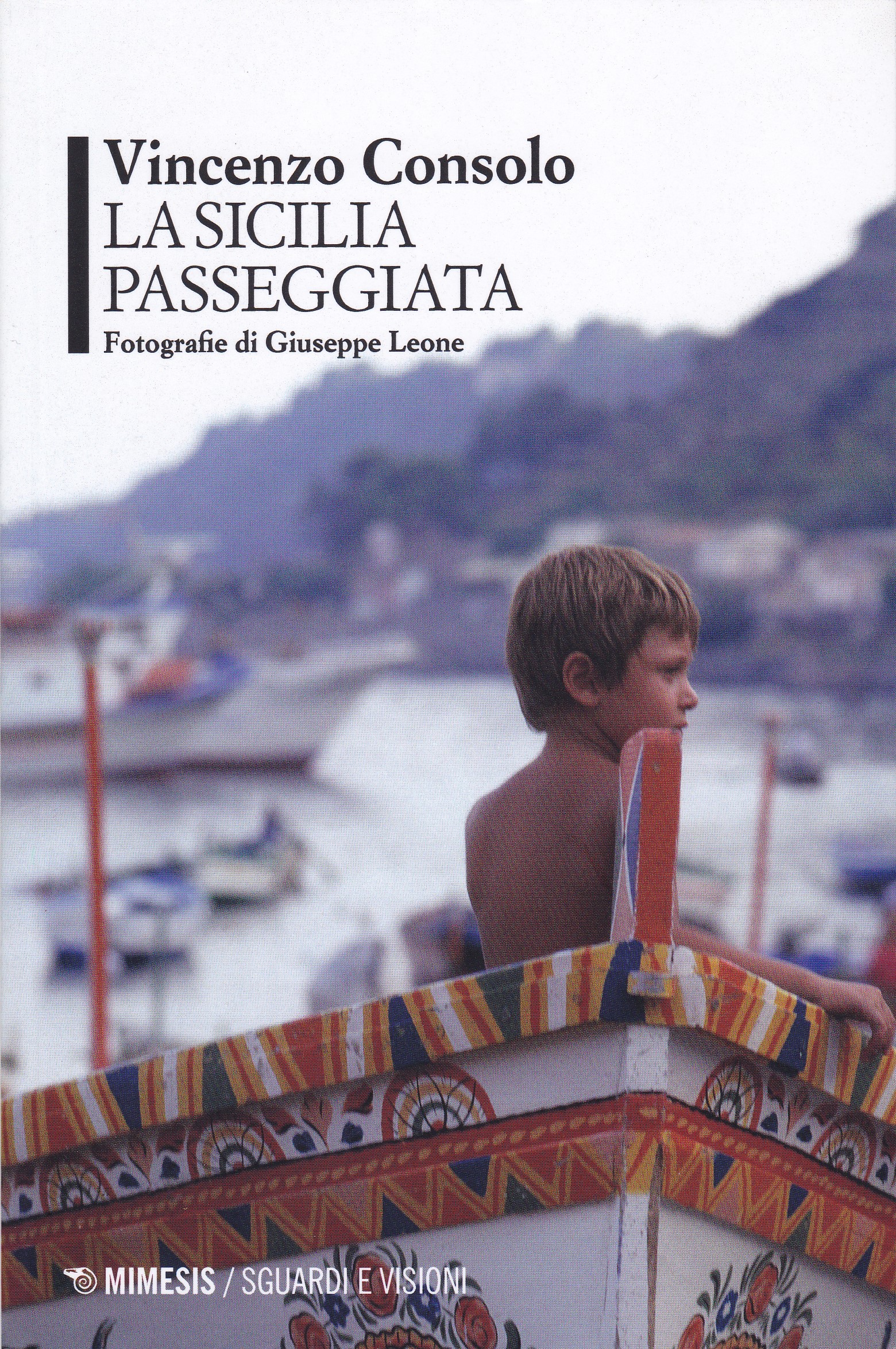
Purché ci resti Itaca: nelle radici una speranza per domani. La voce di Consolo
Ada Bellanova
Purché ci resti Itaca:
nelle radici una speranza per dopodomani.
La voce di Consolo.
1. Ripensare i luoghi in forma di idillio. Il dramma di Ulisse e di Ifigenia.
Senza la letteratura Itaca sarebbe semplicemente una piccola isola greca nel Mediterraneo. Invece Omero, la tradizione, le invenzioni letterarie l’hanno resa il luogo per eccellenza delle radici e della memoria, la patria ritrovata dopo un lungo viaggio: l’hanno trasformata in simbolo[1].
Ulisse in viaggio, intento ad affrontare pericoli, mostri e tempeste, porta con sé l’immagine di Itaca luogo del cuore, patria perfetta, a cui desidera a tutti i costi tornare. Una polarità netta si crea tra il mondo minaccioso – e avventuroso – e il nucleo accogliente e protettivo della patria e della casa. Eppure Ulisse, una volta sbarcato, è costretto a interrogarsi subito sull’identità della terra, sullo scarto tra il sogno che ha cullato durante la lunga distanza e la realtà[2]. Molte cose infatti sono cambiate: lui non è più lo stesso e Itaca è mutata, non solo per i soprusi dei Proci, ma anche perché il tempo ha segnato la sua geografia a tal punto da conferirle un paesaggio nuovo, diverso. Per queste ragioni, e non solo per l’intervento di Atena, Ulisse si guarda intorno e, smarrito, si pone la domanda: «Dove sono capitato?». Sebbene il finale dell’Odissea risulti confortante – l’eroe ottiene di nuovo il suo ruolo di re dopo la sconfitta dei Proci e l’intesa del talamo con Penelope – sorge il dubbio che l’Itaca ritrovata sia un po’ deludente rispetto al sogno e alla nostalgia. Perché altrimenti Ulisse sceglierebbe, come insegna l’altra tradizione, di ripartire? Non dovrebbe godersi la terra tanto amata? Il fatto è che, come scrive Jankelevitch, la nostalgia, per l’esule – per qualunque esule –, è insanabile, inestinguibile[3]. Già nel momento del primo distacco dalla patria ha inizio un cambiamento, nel luogo e nell’individuo, che non permette di colmare la distanza, in alcun modo, neppure nell’opportunità di un ritorno.
Ifigenia a sua volta, la sfortunata figlia di Agamennone, salva ma costretta all’esilio tra i feroci Tauri autori di sacrifici umani, non fa altro che sognare la sua Argo: una reggia preziosa, in cui è stata bambina, principessa, ma ormai, senza che lei lo sappia, luogo insanguinato dagli omicidi, la morte del padre per mano di sua madre, quella di sua madre per mano di suo fratello. La Tauride – anche in questo caso la responsabilità è della letteratura – assume la connotazione di una terra selvaggia, priva di ogni forma di civiltà: la dolente sacerdotessa greca, pur investita dell’autorità religiosa, non può far altro che sciogliere il suo canto d’esilio, insieme alle schiave sue compagne. È la trama dell’Ifigenia in Tauride euripidea: l’autore antico ha composto una tragedia che recita il dramma della nostalgia, la stessa di Ulisse. La città lontana di Argo, nella mente di chi vive l’esilio, ovvero la protagonista e, con lei, il coro, assume i tratti di uno spazio desiderato e armonioso, un territorio caro, in cui rispecchiarsi e ritrovarsi: è emblema della Grecia della civiltà. Eppure, come dicevo, la terra lontana non è affatto così come l’esule se la dipinge e, anche di fronte al lieto fine, mentre Ifigenia e il fratello ritrovato salpano dalla Tauride ostile e si allontanano dai sacrifici, c’è da augurarsi che non ci sia nessun ritorno a casa. Ritrovare Argo infatti non è possibile e il ritorno può essere estremamente traumatico.
Il mito e la letteratura, proponendo una caratteristica veste per certi luoghi reali, li trasformano in simboli, metafore efficaci anche per la contemporaneità e per il nostro modo di vivere gli spazi.
Ne sa qualcosa Vincenzo Consolo che in tutta la sua opera pone l’accento sul suo esilio nel Nord e sull’irredimibile nostalgia per la Sicilia lontana, patria del ricordo, e perciò idealizzata nella distanza, come in un’odissea contemporanea, tra le nebbie di una Milano grigia che ha più di un tratto in comune con la Tauride euripidea. L’olivo e l’olivastro (1994) e poi anche Lo Spasimo di Palermo (1998) descrivono un ritorno doloroso che ha i tratti di un incauto procedere tra le rovine di una patria in fiamme. Nel primo libro, che reca già nel titolo l’omaggio e la simbolizzazione degli spazi omerici – nell’Odissea olivo e olivastro segnano lo spazio del naufragio di Ulisse sulla costa dei Feaci – al giovane migrante siciliano che, fuggito dal terremoto di Gibellina – ecco Enea che abbandona un’Ilio compromessa – prova a ritornare dopo tanti anni, il nóstos è negato: Itaca non c’è più, fuor di metafora, perché la vecchia città è scomparsa sotto il sudario di cemento del Cretto di Burri, e la nuova, con la Stella texana che segna l’ingresso nel Belice, è, per dirla con le parole di Consolo, «costruita dai Proci»[4], non ha insomma molto a che fare con la tanto sospirata patria delle radici. Nel secondo, poi, veramente amaro è il ritorno del protagonista, lo scrittore Chino Martinez, a Palermo: la città degli anni Novanta, già compromessa dalla ferocia della speculazione edilizia, dal sacco che ha cementificato la Conca d’oro, deve fare i conti con la violenza mafiosa, esemplificata dalla drammatica esplosione finale in via d’Astorga che allude in maniera netta alla strage di via d’Amelio. A queste opere possono essere aggiunte moltissime pagine, come il testo eponimo di Le pietre di Pantalica, che piange il degrado – culturale, ambientale – dello scenario della bianca Siracusa, chiamando in causa i simboli della tragedia euripidea[5], tradotta tra l’altro proprio da Consolo con Del Corno[6], che è messa in scena nel teatro antico. L’autore fa del suo vissuto il motore dell’invenzione narrativa: la sua personale prospettiva interpreta gli spazi e li reinventa sul piano letterario. In questo processo Itaca e Argo rimandano a un mondo che non c’è più: un universo intatto, in armonia, cancellato da una modernità incivile e snaturante, e divenuto un perenne labirinto fitto di mostri e pericoli, una Tauride in cui si sacrificano gli innocenti. Nella prospettiva consoliana allora non è solo la Milano affarista ad assumere i tratti di luogo ostile: l’osservazione dell’intero spazio della contemporaneità – l’Italia, il Mediterraneo con i suoi naufraghi e ogni luogo in cui il migrante è perseguitato, ferito, il paesaggio mortificato dagli incendi, dall’industrializzazione, da un turismo becero e superficiale – denuncia una perdita irreparabile in termini di valori e identità[7]. La polarità non è più, o comunque non solo, tra lo spazio fisico dell’esilio e la terra delle radici, ma tra lo spazio del presente, omologante e svilente, e quello del passato, in cui è ancora possibile un equilibrio.
2. Proteggere le radici.
Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi
abbandonati […]
P.P. Pasolini[8]
Eppure, affrontato il rischio della rottura dell’idillio, si può scoprire che Itaca non è del tutto allo sfacelo e che sulle colonne di Argo si può ricostruire. Conviene però prendere coscienza del punto a cui siamo arrivati. Conviene ripartire dalle radici, ritrovare angoli vivi del paesaggio, lasciarsi ispirare da quanto di buono essi comunicano. Il che non vuol dire smettere di vedere le criticità di ciò che è stato: significa valorizzare ciò che può essere valorizzato e trovare una nuova via alternativa all’omologazione e allo sfruttamento.
La vera letteratura ha questo di utile, ci svela a noi stessi, e le pagine di Consolo parlano a tutti e di tutti, toccano le corde del legame doloroso o vivificante che abbiamo con gli spazi e tentano di fare chiarezza su questioni grandi e urgenti: invitano cioè ad una consapevolezza ambientale nel senso più ampio dell’espressione come unica strada non solo per non perdere il luogo, ma anche per non perdere noi stessi.
Trovo illuminante la sua riflessione sulla Sicilia e sul Mediterraneo: nell’amarezza di fronte allo scempio, di fronte ai facili stereotipi che semplificano lo spazio, lo appiattiscono – il seducente paradiso a buon mercato da una parte, il degrado, i sotterfugi dall’altro –, avvallati in maniera semplicistica da un certo tipo di informazione e da un certo tipo di politica, l’autore rivendica il valore della complessità. Lo spazio ha molte facce, molte sfumature, la bellezza ha una sua indubbia fragilità.
Nella sua rappresentazione dello spazio individuiamo la valorizzazione di alcune isole di sopravvivenza: gli Iblei con l’arte intatta degli apicoltori e i Nebrodi coi pascoli verdissimi non sono semplice idillio, Itaca e Argo del ricordo in cui sarebbe meglio non tornare mai, ma un esempio di risposta concreta alla crisi del paesaggio e dell’identità contemporanea. Descrivendo la miracolosa armonia tra uomo e natura, la ricchezza ambientale – piante, animali –, tradizioni gastronomiche e saperi antichi, che caratterizzano queste oasi di sopravvivenza, Consolo valorizza una Sicilia quasi arcaica. In ciò non rifiuta il progresso in sé, piuttosto evidenzia la necessità che esso non faccia perdere all’uomo la sua identità storica e culturale, come è invece accaduto nel caso della violenta industrializzazione dell’isola. Mette cioè in evidenza che i luoghi non sono uno sfondo e che, se smettono di essere quello che sono – fagocitati dall’omologazione, da interessi economici, dalla costruzione di barriere –, inevitabili e funeste sono le conseguenze anche sugli esseri umani. Così strettamente interrelate sono l’identità degli uomini e quella degli spazi.
La sua opera invita dunque – e in ciò risiede, secondo me, la grande attualità del messaggio consoliano – a conservare le radici, a prendercene cura, perché solo nella salvaguardia di ciò che è rimasto possiamo sperare di non perdere noi stessi.
Il passato – come insegnava anche Pasolini nella sua strenua definizione dell’ambiente storico e umano come territorio composito e stratificato nel tempo, insieme universo linguistico, identità dei luoghi, creazione artistica – può non essere un ricordo perduto: può anzi configurarsi come forza a cui attingere.
Mi piace pensare che nei versi di Accordi,con l’ignoto tu, Consolo alluda ad un’identità sua e di tutti i figli del Mediterraneo, un’identità nata da una relazione vecchia di secoli con la terra, le piante, i muri a secco, con i paesaggi: tolto tutto questo, cosa saremmo?
Sei nato dal carrubo
e dalla pietra
da madre ebrea
e da padre saraceno.
S’è indurita la tua carne
alle sabbie tempestose
del deserto,
affilate si sono le tue ossa
sui muri a secco
della masseria
Brillano granatini
sul tuo palmo
per le punture
delle spinesante[9].
Solo se ripartiamo da
questo, allora, da ‘Itaca’, attraverso un cammino, senz’altro faticoso,
difficile, di consapevolezza degli spazi e della nostra relazione con essi, possiamo
avere qualche opportunità di sopravvivere anche noi. Possiamo avere qualche
speranza, se non per domani, almeno per dopodomani.
[1]A. Montandon, Itaque au fil du temps, in B. Westphal (a cura di), Le rivage des mythes. Une géocritique mediterranéenne. Le lieu et son mythe, Pulim, Limoges 2001, pp. 18-36.
[2]Odissea XIII 200-202.
[3]V. Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, Flammarion, Paris 1983, pp. 370-371.
[4]V. Consolo, L’olivo e l’olivastro, in Id., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Mondadori, Milano 2015, p. 869.
[5]V. Consolo, Le pietre di Pantalica, in Id., Le pietre di Pantalica, in Id., L’opera completa, cit., pp. 615-621.
[6]Ifigenia fra i Tauri, trad. di Vincenzo Consolo e Dario Del Corno, Istituto Nazionale del Dramma Antico -XXVII ciclo di spettacoli classici (27 maggio-4 luglio 1982), INDA, Siracusa 1982.
[7]«Non si ritorna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più i luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo», V. Consolo, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli, Roma 1993, p. 69. Dello stesso tono sono le affermazioni di Consolo nell’intervista con D. Calcaterra: «Una volta che si è partiti i ritorni sono impossibili. Qualsiasi ritorno, anche quello di Odisseo, dopo l’allontanamento, non riesce a colmare il distacco […] Nell’assenza si è consumato un duplice mutamento: dell’individuo e del luogo d’origine. Si prova una gran pena quando non riconosci più la tua terra, e la metamorfosi acquista la drammatica cifra dell’inesorabile degrado, della perdita, dello smarrimento. Ogni ritorno è dunque dolore. […] Oggi siamo tutti degli Ulissidi, degli erranti, espropriati del proprio luogo della memoria. Viviamo nell’indefinito, senza sicuri punti di riferimento, senza segni, intorno a noi c’è un mare da cui non s’intravede alcun approdo possibile, e d’altra parte non vediamo più la sponda da cui siamo partiti. Il destino dell’uomo contemporaneo è quello dell’errante, che ha perso la propria identità, la propria patria» (D. Calcaterra, Vincenzo Consolo, le parole, il tono, la cadenza, Prova d’autore, Catania 2007, pp. 20-22).
[8]P.P. Pasolini, 10 giugno 1962, in Poesie mondane, in Poesia in forma di rosa, in Id., Tutte le poesie, a cura di W. Siti, 2 voll., Mondadori, Milano 2003, I, p. 1099.
[9]Accordi. Poesie inedite, a cura di Claudio Masetta Milone e F. Zuccarello , Zuccarello editore, Sant’Agata di Militello 2015.
pubblicato “La macchina sognante” (28 dicembre 2020) 
LO SPASIMO DI PALERMO FRA CRISI E MEMORIA
Cinzia Gallo
Università di Catania
Riassunto Lo Spasimo di Palermo è esempio di una crisi che ha ripercussioni nella forma espressiva: da una parte, emerge la consapevolezza che «sul ciglio dell’abisso la parola si raggela, si fa […] simbolo sfuggente», dall’altra il romanzo appare un «genere scaduto, corrotto, impraticabile». Il conflitto generazionale fra Chino e Mauro rientra pure in quest’ambito. Da qui derivano varie soluzioni che portano al «poema narrativo» di Consolo e testimoniano il disorientamento prevalente: accumuli paratattici, metafore, figure retoriche, figure del discorso. Le suggestioni pittoriche trovano il loro centro nello Spasimo di Sicilia di Raffaello, simbolo di una sofferenza che da Palermo arriva alla Sicilia e a tutto il mondo, mentre gli spazi hanno una grande importanza e mostrano la perdita della memoria storica, responsabile della crisi.
Consolo, crisi, memoria, storia Secondo Ugo Dotti,
Lo Spasimo di Palermo è caratterizzato dal «contrapporsi di storia a memoria, nel vano bisogno di conforto che il . 8 ricordo potrebbe dare e che suscita al contrario un cocente sentimento di patimento, di sconfitta, di spasimo» (Dotti, 2012, 315). Dunque, uno stretto nesso fra storia, crisi e memoria percorre l’intero testo, anche se esso è, innanzitutto, specchio di una crisi, sia collettiva che individuale. Consolo presenta non solo «il fallimento della generazione del dopoguerra nel creare una società più giusta e più civile» (O’Connell, 2008, 173), per cui terrorismo e mafia risultano uniti «in un clima da fine dei tempi, che nega la storia» (Donnarumma, 2011, 446), ma anche la sconfitta di Chino, padre e scrittore. Da ciò l’impossibilità di narrare, cioè di utilizzare i tradizionali mezzi espressivi. Raccontare è però necessario, come attestano le due battute del Prometeo incatenato di Eschilo poste in epigrafe: «Rivela tutto, grida il tuo racconto… / Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore» (Consolo, 1998, 7). Quest’urgenza di dire si realizza subito tramite la letteratura, come nella conclusione di Nottetempo, casa per casa, in cui essa appare «ultima consolazione […] e ultima possibilità di spiegazione del “dolore” del mondo» (Luperini, 1999, 166). Lo stesso Consolo chiarisce: «[…] è caduta la fiducia nella comunicazione, nella possibilità […] della funzione sociale, politica della scrittura. Non rimane […] che l’urlo o il pianto, o l’unica forza oppositiva alla dura e sorda notte, la forza della poesia» (Consolo, 1993, 58). Il gioco citazionistico è, quindi, subito in primo piano: l’iniziale «Allora tu, […] ed io» (Consolo, 1998, 9), con cui il narratore si rivolge a Chino, è stato collegato da O’Connell (2008, 181) al celebre verso di Eliot «Let us go then – you and I», con cui, peraltro, si chiude il quinto capitolo. Un’altra citazione eliotiana («In my beginning is my end» [Consolo, 1998, 9]), rimandando al consueto simbolo consoliano della chiocciola, della spirale, rileva invece l’importanza della memoria, necessaria per recuperare un’identità veicolata dai nomi («il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza» [Consolo, 1998, 9]), di cui Consolo sottolinea spesso l’importanza come segno identitario. Queste citazioni forniscono subito una prima chiave di lettura, in quanto Eliot utilizza termini spesso non uniti fra loro da legami logici, alterna espressioni auliche con altre colloquiali, mescola svariate lingue, rappresentando così la crisi esistenziale dell’uomo: similmente si comporta Consolo. Anche nel nostro testo, comunque, il narrare significa «rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta» (Consolo, 2012, 92), che «assolva la tua pena, il tuo smarrimento» (Consolo, 1998,10). Questi stati d’animo, già nel primo capitolo, sono rapportati da Chino, giunto a Parigi per incontrare il figlio, con la parola che «si fa suono fermo, […] simbolo sfuggente» (Consolo, 1998, 12). Egli, dunque, respinge come false la lingua accademica («Stendono prose piane i professori, […] decorano le accademiche palandre di placche luccicanti» [Consolo, 1998, 12]) e quella giornalistica («Nul n’échappe décidément, au journalisme ou voudrait-il…» [Consolo, 1998, 12]), e nega il potere evocativo del linguaggio: se dapprima, infatti, il prete oppone alla forza delle armi quella delle parole (Giacomo – Marcellesi, 2004, 73-74), quando chiede, all’inizio dei bombardamenti, «di cantare l’aria con parole senza senso» (Consolo, 1998, 14), queste, poi, non servono a disincantare una «trovatura» (Consolo, 1998, 19). Tornano in mente a Chino, invece, termini legati ad epoche passate («Il maggiore parlò in un modo che credeva ancora di quel luogo» [Consolo, 1998, 13]). Per Consolo, difatti, «la vera scrittura […] poggia sulla memoria letteraria soprattutto» (Consolo, 2006, 71 – 72). O’Connell l’ha definita «un ricco mosaico di intertestualità, le cui tessere sono fatte di testi sia antichi sia moderni», in quanto pone accanto «linguaggi e dialetti diversi e spesso stridenti tra di loro», oscillando «tra registro alto e basso» (O’Connell, 2008, 164). Nei primi due capitoli, alcuni termini dialettali o colloquiali («anciove» [Consolo, 1998,15]; «caruso», «scarparo» [Consolo, 1998, 26]; «buatta» [Consolo, 1998, 32]; «a forma di lasagne» [Consolo, 1998, 25]) coesistono, dunque, con altri più elevati, o desueti, formando uno strano impasto linguistico, espressione dello smarrimento in cui vive Chino nel tentativo di superare i fantasmi del passato. Lo stesso Consolo ha dichiarato, in un’intervista: «sono stato […] sperimentatore, senza però arrivare all’estensione linguistica e alla straordinaria polifonia gaddiana, ma operando verticalmente, nel senso di riportare in superficie, […] parole e strutture di lingue sepolte» (Ciccarelli, 2005, 96). Si inserisce in tale ambito il termine «marabutto», di origine araba e perciò legato alla storia della Sicilia, che ritornando varie volte nel nostro testo, ne suggellerà l’andamento circolare svelando il suo carattere di «metafora malinconica» (Traina, 2001, 107). Rientra in questa circolarità anche il rilievo dato alle immagini, in quanto Consolo avverte «Sempre […] l’esigenza di equilibrare la seduzione […] della parola con la visualità, con […] una concretezza visiva» (O’Connell, 2004, 241). . 10 Il primo capitolo, così, accosta, secondo una tecnica cinematografica, parti quasi autonome, corrispondenti alle vicende affiorate alla memoria di Chino. Non a caso l’albergo di Parigi in cui egli soggiorna, oltre a chiamarsi La dixième muse, mostra alle pareti foto di vari divi del cinema, e alla mente di Chino ritorna l’immagine del IUDEX, protagonista del serial cinematografico di Feuillade che adesso egli vede per intero, dopo cinquant’anni, e che sarà richiamato anche alla fine del libro. L’ultimo segmento del capitolo presenta invece il dolore di Chino quale dolore collettivo attraverso il tipico uso consoliano delle figure retoriche, confermando l’orientamento dello scrittore verso il ben noto poema narrativo: Lo strazio fu di tutti, di tutti [anadiplosi] nel tempo il silenzio fermo [allitterazione], la dura pena, il rimorso scuro [chiasmo], come d’ognuno ch’è ragione, […] d’un fatale arresto, d’ognuno che qui resta, o di qua d’un muro, d’una grata, parete di fenolo [metafora], vacuo d’una mente, davanti alla scia in mare, all’arco in cielo che dispare di cherosene [iperbato]. L’esilio è nella perdita, l’assenza, in noi l’oblio, la cieca indifferenza (Consolo, 1998, 24). Un’anastrofe («il tempo suo più avventuroso» [Consolo, 1998, 25]) conclude invece le enumerazioni con cui si esprime lo stato di abbandono di Chino dopo la morte del padre. Analogamente, le enumerazioni indicano il disordine, il caos che contraddistinguono il viaggio di Chino ed Urelia, il loro arrivo a Palermo: Il viaggio fu infinito, nel fumo, nel freddo, raffiche di vento, pioggia, spruzzi delle onde, stretti fra reduci, sbandati, intrallazzisti, donne scasate e di mestiere, ragazzi fuggitivi, frati di questua e ceffi di galera. […] Mai erano stati Urelia e Chino nella città, mai avevano udito tanto chiasso, urla richiami imbonimenti, visto tanto correre e affannarsi tra macerie, travi fili ferri lamiere tufi calcinacci, cantoni in bilico, tappezzerie e maioliche esposte all’aria, giare e bidoni su lastrici crollati, statue riverse, guglie mozzate e cupole sventrate (Consolo, 1998, 31). piccano l’aggettivo dialettale «scasate», il neologismo «intrallazzisti» tra termini più elevati, quali «questua», «fuggitivi», mentre gli aggettivi «riverse», «mozzate», «sventrate» umanizzano gli oggetti, rendendo più forte la sensazione di sofferenza. A Palermo, i «ciechi vaiolosi, storpi, appestati d’ogni sorta che dallo Spasimo si recavano ogni giorno per mangiare alla Dogana» (Consolo, 1998, 32) ricordano l’ «orda di mendichi, ciechi, storpi, nani, malformati» che, in Retablo, si presentano davanti a Clerici, «con lamenti, cantilene e preghiere strazianti» (Consolo, 1992, 51). Con queste autocitazioni, Lo Spasimo di Palermo si conferma, come la critica unanime ha riconosciuto, testo che riassume l’evoluzione artistica ed ideologica di Consolo. Dopo un’ellissi, intanto, tornati nel tempo primo della narrazione, il terzo capitolo inizia, significativamente, con la parola «orrore» (Consolo, 1998, 33): è lo stato d’animo di Chino davanti al suo volto ritratto nello specchio, segno, perciò, quasi, di un’intima dissociazione, che egli descrive, grazie alle enumerazioni, espressionisticamente. Del resto, Norma Bouchard ha riscontrato, ne Lo Spasimo, «[…] an expressionism so radical that it has baffled more than one critic» (Bouchard, 2005, 6). Il pensiero subito rivolto al padre testimonia la persistenza di una lacerante distanza, messa in risalto dall’interrogativa: «Fosse vissuto, sarebbe scaduto così anche suo padre, avrebbe avuto quella faccia, quella sagoma avvilita, si sarebbe piegata la sua testa, il suo orgoglio si sarebbe [chiasmo] con gli anni incenerito [metafora]?» (Consolo, 1998, 33). La stessa incomunicabilità impernia, adesso, il suo rapporto con il figlio Mauro: le parole appaiono infatti «una pazzia recitata, un teatro dell’inganno» (Consolo, 1998, 35) quando i due si incontrano, in un clima di precarietà evidenziato da metafore: «Chi può sapere in questo mulinello di sagome simili e cangianti, questo turbinio di figure, quest’infinito scorrer d’apparenze?» (Consolo, 1998, 34). Se, da una parte, tale incertezza si manifesta, nuovamente, a livello individuale, per cui Chino è consapevole di non essere «riuscito a placare» i suoi «assilli» (Consolo, 1998, 36), «il panico, l’arresto, […] l’impotenza, l’afasia, il disastro» della sua vita, dall’altra lo «scadimento» (Consolo, 1998, 37) è generale, rappresentato dai gusti letterari dei frequentatori della libreria che Daniela ha voluto, per tentare di diffondere romanzi e poesie fra i compagni, «ignari e sprezzanti d’ogni forma letteraria» (Consolo, 12 1998, 37). Responsabile è l’omologazione, lo smarrimento della memoria storica, il predominio delle «mode» (Consolo, 1998, 37): nella vetrina della libreria, antifrasticamente chiamata «La porta d’Ishtar», notiamo allora «la foto d’un giovanotto levigato, riccioletti e occhio vellutato [omoteleuto], ultimo autore di successo, mistico e divo della tivù, […]» (Consolo, 1998, 36). Rafforza questo svilimento della memoria culturale il menu del ristorante Les philosophes: «Cotolette Spinoza – Salade Bergson – Salade Platon – Salade Aristote – Coupe Virgile – Coupe Socrate» (Consolo, 1998, 38). Mauro, poi, che enumera i mali italiani («Sempre nel marasma, nel fascismo inveterato, nell’ingerenza del pretame, nella mafia statuale il paese beneamato?» [Consolo, 1998, 39]), sottolineando le responsabilità del fascismo con l’omoteleuto («inveterato […] beneamato») e l’allitterazione («marasma […] fascismo»), rivolge al padre delle accuse ben precise, rese più incisive dalle metafore, dall’omoteleuto (ornamento-annientamento), dall’anafora, e che coinvolgono tutti i letterati: «tu e i soavi letterati siete le epigrafi d’ornamento, la lapide incongrua e compiaciuta sul muro di quel carcere mentale, quel manicomio d’annientamento» (Consolo, 1998, 39). I riferimenti al romanzo El recurso del método di Carpentier, autore particolarmente caro a Consolo, alla vicenda di Camille Rodin ribadiscono, poi, ancora, la volontà di distacco da una realtà costituita da un «tempo feroce e allucinato» (Consolo, 1998, 42). Il capitolo IV si apre allora con un lungo periodo che accosta immagini metaforiche apparentemente distinte, in realtà accomunate da un senso di negatività, dolore, precarietà, sottolineato dalle enumerazioni miste ad anafore e assonanze: Muro che crolla, interno che si mostra, fuga affannosa, segugio che non molla [assonanza], esito fra ruderi sferzati dalla pioggia, ironiche statue in prospettiva, teschi sui capitelli, maschere sui bordi delle fosse, botteghe incenerite, volumi che in mano si dissolvono, lei al centro d’un quadrivio accovacciata, lei distesa nella stanza che urla e che singhiozza, ritorna dall’estrema soglia, dall’ insulinico terrore, entra ed esce per la porta sull’abisso, il tempo è fisso nel continuo passaggio, nell’assenza, nel fondo sono le sequenze, i nessi saldi e veri (Consolo, 1998, 45). La serie di metafore può apparentarsi al flusso di coscienza di Joyce, il cui Ulisse Consolo definisce «L’odissea dei vinti»[1] (Consolo, 1999, 111). D’altra parte, vedere il film della sua giovinezza non risolve i problemi di Chino ma gli fa capire l’importanza dell’immaginazione e della memoria[2]: «Il tempo, la memoria esalta, abbellisce ogni pochezza, ogni squallore, la realtà più vera. Per la memoria, la poesia, l’umanità si è trasfigurata, è salita sull’Olimpo della bellezza e del valore» (Consolo, 1998, 53). La reazione di Mauro («”Ne hanno combinate i letterati!”» [Consolo, 1998, 53]) conferma che il contrasto generazionale con il padre coinvolge pure la funzione della letteratura e dei letterati, come si chiarirà nella conclusione. L’incomunicabilità fra i due sembra venir meno solo quando Chino dice al padre: «Portale [alla madre, Lucia] per me, quando sarà fiorito, il gelsomino» (Consolo, 1998, 55), mostrando così che, pure per lui, i legami con la Sicilia, di cui quel fiore è simbolo, al pari di quello che avviene ne L’olivo e l’olivastro, sono ineludibili. Per Chino, invece, ritornare in Sicilia significa ripercorrere le vicende della propria vita, che somiglia sempre più ad una fuga, per placare le proprie angosce. Milano e la Sicilia, ovvero i «due poli» entro cui si svolge la vicenda di questo e di molti testi consoliani, si precisano quali simboli «di una condizione di esilio perenne» (Lollini, 2005, 32). Da qui le tantissime «metafore dell’esilio, dell’erranza» (Lollini, 2005, 29), la ricorrenza dei termini ‘esilio-esule’, ‘fuga-fuggire, ‘partire-partenza’, ‘evadere-scappare’, insieme a quelli relativi al campo semantico del dolore. Il quinto capitolo registra questi concetti in modo particolare. Il primo segmento esprime ancora il disagio di Chino con i procedimenti già notati: brevi proposizioni cooordinate per asindeto, enumerazioni. Spicca il chiasmo «lame squame gemini binari» (Consolo, 1998, 57), in cui i due aggettivi aulici (‘squame’, antico; ‘gemini’, latinismo) sono incastonati fra i sostantivi ‘lame, binari’, del registro quotidiano. Segue un’analessi in cui vita e letteratura appaiono strettamente unite, visto che i libri hanno scandito le varie tappe dell’esistenza di Chino. Inverano, intanto, lo spazio: Chino si reca con Lucia, infatti, a visitare la tonnara e il mare descritti nelle [1] Un’allusione all’Ulysses di Joyce e «the re-inauguration of the modern nostos into twentieth-century literary culture», si troverebbe, secondo O’Connell (2012, 246), nel seguente passo: «Ascesero man mano e si dispersero per i vari cieli, entro le celle di quella Sandycove dell’introibo, teca babelica, averno del viaggio» (Consolo, 1998, 46). [2] Secondo O’Connell (Consolo narratore cit., 178), si ha qui un richiamo al saggio Angelus Novus di Benjamin, che peraltro Consolo cita in I ritorni, ed esattamente ai concetti di «rimembranza» e memoria. 14 Osservazioni pratiche intorno la pesca, corso e cammino dei tonni. Quando i poliziotti perquisiscono la sua casa, come si narra anche in Un giorno come gli altri, i suoi libri sparpagliati sembrano «storie perenti, lasche prosodie, tentativi inceneriti, miseri testi della sua illusione, del suo fallimento» (Consolo, 1998, 66), dovuto, comunque, al «tempo feroce, disumano» (Consolo, 1998, 67) in cui vive. Lo testimoniano i procedimenti espressivi. Il «boemo paonazzo», in cui si riconosce Milan Kundera, definisce infatti «merde» gli intellettuali insensibili ai problemi della primavera di Praga nella discussione tra le signore che, con allusione ad Eliot, «in seriche casacche orientali andavano e venivano, […] rivolgevano domande a Saul Bellow» (Consolo, 1998, 66). Il narratore, poi, inserisce la parola antica ‘grascia’ in un’enumerazione («ingombro, grascia, fermento, trionfo di laidume, baccano d’osceno carnevale» [Consolo, 1998, 68]) per raffigurare la disastrosa situazione di Milano. Essa, la «città ignota» è poi descritta con una citazione da Excelsior di Luigi Manzotti («“D’improvviso la scena si trasforma, la Luce e la Civiltà trovansi abbracciate…”» [Consolo, 1998, 69]), menzionato pure in Sopra il vulcano, e una dai Promessi Sposi («“Quel contrapposto di gale e di cenci, di superfluità e di miseria”» [Consolo, 1998, 70]). Il segmento successivo rielabora il brano I barboni, scritto nel 1995 per il catalogo di Ottavio Sgubin, che termina con una citazione dell’Odissea, l’unica di tutto Lo Spasimo («Di’ perché piangi e nel tuo animo gemi / quando odi la sorte…» [Consolo, 1998, 72]), che, non a caso, rimanda ad una condizione di sofferenza. Lo stesso Consolo ne chiarisce, ne Lo spazio in letteratura, il significato, collegando il nostro testo con L’olivo e l’olivastro. Quindi risponde alla richiesta contenuta nella citazione dell’Odissea sostenendo l’impossibilità della narrazione: «“Io sono… no, no, l’aridità, la lingua spessa, l’oblio d’ogni nesso… illuso ancora dell’ascolto, tu procedi”» (Consolo, 1998, 72), affermazione apparentemente in contrasto con il montaliano «varco» che avrebbe condotto Chino, all’inizio del capitolo, «nel passato, nel racconto, in cui […] tutto sembrava decifrabile» (Consolo, 1998, 69). In effetti, nell’analessi in cui il narratore rievoca la vita familiare inizialmente felice di Chino, di Lucia e poi devastata dalle circostanze, la letteratura è dapprima celebrata come depositaria della «verità umana» («“Là si trova” […] “negli assoluti libri, la verità umana”») ma poi, di fronte al precipitare degli eventi, ritenuta inadeguata a riprodurre correttamente la realtà («Ogni parola ora, povera, incapace, riduce quell’incanto, […]» [Consolo, 1998, 73]). Consolo, allora, da un canto adotta una tecnica cinematografica, mostrando i vari eventi (le intimidazioni, la conversazione con il commissario, la vendita della casa) come fotogrammi, dall’altro ritorna alla ‘narrazione poematica’ propria de L’olivo e l’olivastro[3], a confermare la corrispondenza tra i due testi. Così è facile riconoscere degli endecasillabi quando il narratore riferisce la decisione di Chino di lasciare Palermo per andare sulle tracce dell’originaria ed autentica identità siciliana. E il viaggio, vero e proprio topos per Consolo, avviene, significativamente, durante la Pasqua, momento di resurrezione: «S’era fatta smunta, pallida, inquieta /, […] Chino decise di rompere l’assedio, / d’evadere, fuggire dalla casa, / […] Andò con l’infelice per le strade, / […]. Andò in un aprile, nel tempo della Pasqua [due settenari]» (Consolo, 1998, 76-77). Una serie di immagini, combinate con un’anafora e un endecasillabo finale, presenta la Sicilia quale metafora del mondo: «Era là il centro dello spazio, la visione sconfinata, là il cuore della terra, / del mito più oscuro e luminoso» (Consolo, 1998, 77). Il nome di Borges, del resto, rimanda non solo ai «sogni», agli «incubi», agli «specchi», ai «labirinti» (Consolo, 1998, 80), temi presenti nel nostro testo, ma al suo prevalente carattere metaforico. La vicenda di Lucia, con il suo «precipitare nel gorgo medicale, nell’ignoranza, nel dominio, nel cinico interesse di luminari, case di cura, […] rete di sciacalli» (Consolo, 1998, 78) e quella di Chino testimoniano i danni causati dalla perdita della memoria storica: Palermo è, difatti, ormai, una città «stravolta, squallida nell’uniforme volto, nell’anonima sua morsa, nel cieco manto sopra ogni verde luce, nella grigia muraglia avanti a vecchi squarci, immobili macerie, […]» (Consolo, 1998, 79). All’insegna della metafora si svolge, allora, il capitolo settimo. «un re che narra e che governa, elude la metafora, annulla la contraddizione della prosa» (Consolo, 1998, 83) è, intanto, il personaggio principale del racconto letto dal glottologo protagonista de La perquisizione, dietro cui la critica ha scorto Un giorno come gli altri. La metafora si precisa, dunque, quale una necessità, legata a una narrazione in crisi, che tratta di periodi in crisi: appaiono così chiari i rapporti di Consolo con il postmodernismo. Da [3] Esso è l’«apice» di una vera e propria «sperimentazione “poetica”» (Francese, 2015, 70) . 16 una parte vi sembrerebbero rimandare il citazionismo, il plurilinguismo, il tema del complotto; dall’altra, però, Consolo se ne mantiene distante, proprio per l’importanza attribuita alla memoria e alla storia, come Norma Bouchard ha puntualizzato: «it is important to point out that even though Consolo’s novels exhibit many of the rhetorical devices that we have come to associate with postmodern writing practices, they also remain fundamentally distinct from dominant, majoritarian forms of postmodernism» (Bouchard, 2005, 10-11). Una «metafora perenne» giudica poi Chino il romanzo di Manzoni, modello per Consolo di romanzo storico, in quanto allude «alle pesti in ogni tempo di Milano» (Consolo, 1998, 85). Il «lazzaretto più appestato» sembra a Chino «una piazzetta» in cui, avvolti in un’omologazione che cancella ogni identità, «Stavano ragazzi barcollanti o immobili, il busto avanti, piegati sui ginocchi. Sembravano bloccati in quelle pose, pietrificati […]» (Consolo, 1998, 85). Modellato sull’Addio ai monti di Manzoni è, inoltre, l’Addio che Consolo rivolge a Milano, «Città perduta» (Consolo, 1998, 91) non meno della Milano di Berlusconi e della Lega Nord, condannata attraverso la consueta tecnica dell’accumulo: Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, […] scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità (Consolo, 1998, 91). Così, quando Mauro chiede al padre se stia scrivendo, egli risponde negativamente. E se il suo comportamento è differente da quello di altri scrittori (Calvino, Moravia, Sciascia, indicati con delle metafore – «il castoro ligure, il romano indifferente, l’amaro tuo amico siciliano»), ciò accade perché essi hanno «la forza […] della ragione, […] la geometria civile dei francesi» (Consolo, 1998, 88): non vivono cioè una condizione di disorientamento. Costituiscono dunque, queste parole, opinioni dello stesso Consolo (Chino Martinez sarebbe cioè un alter ego dello scrittore), che, proseguendo il suo discorso, una sorta di dichiarazione di poetica, confessa: «mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono…» (Consolo, 1998, 88). La letteratura, però, deve essere, soprattutto, espressione di una società, tant’è che Mauro, in carcere, chiede al padre di portargli I demoni di Dostoevskij, L’affaire Moro di Sciascia, Scritti corsari di Pasolini, Une saison en enfer, Illuminations di Rimbaud. Chino, allora, abbina alla letteratura, che perciò rappresenterebbe un’ancora di salvezza come nella conclusione di Nottetempo (si rifugia nella biblioteca, per esempio), il valore della memoria, delle radici, individuali e collettive. Sul treno per Napoli, infatti, ascoltando parlare dei ragazzi, individua facilmente, e con piacere, «le città e i paesi da cui quei ragazzi provenivano. […] Leggeva in quel concerto la storia d’ogni luogo, i segni […] superstiti delle migrazioni, dei remoti insediamenti» (Consolo, 1998, 95). Egli, pertanto, considera negativamente, al punto da definirla «trucida» (Consolo, 1998, 94), la nuova lingua annunciata da Pasolini, in quanto segno di un’omologazione negatrice della storia. Di questa sono testimonianza i luoghi, lo spazio, che Consolo ritiene, sempre, molto importanti. In prossimità di Palermo Chino scorge, difatti, «il piano di Sant’Erasmo, la foce melmosa dell’Oreto, […] la Porta dei Greci, […] gli antichi palazzi dietro nobiliari, le cupole e i campanili delle chiese, il Càssaro Morto e la Porta Felice, Santa Maria della Catena, la conca stagna affollata d’alberi di lussuose barche della Cala» ma anche «le palazzate nuove del sacco mafioso» (Consolo, 1998, 98). Attraverso lo spazio, cioè, è possibile leggere i cambiamenti della società. Se i luoghi, allora, come la letteratura, manifestano la memoria storica, Chino sente di dover «ricominciare» dai libri, oltre che «dalla chiara geografia» (Consolo, 1998, 102). Si presentano, questi, strettamente uniti, interdipendenti nelle pagine finali dello Spasimo, che, perciò, chiarisce e conclude l’esperienza letteraria di Consolo, rappresentando «al contempo la mediazione verso» quella che Consolo considera una vera e propria «impasse e la risposta ad essa» (O’Connell, 2008, 174). Così, dopo aver raccolto notizie sul musicista D’Astorga, da cui prende nome la strada in cui abita, ed aver scoperto il quartiere intorno, aver collegato il castello della Favara ad alcuni versi del poeta arabo Ab dar-Rahmân, Chino decide di «indagare sulla prigionia in Algeri di Cervantes», su quella di Antonio Veneziano[4] e di scrivere «della [4] Ne L’olivo e l’olivastro (1994, 105), Consolo afferma che, ad Algeri, Cervantes scrive dei versi per Antonio Veneziano. 18 pena vera di due poeti, fuori da ogni invenzione» (Consolo, 1998, 105). Infatti, Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio. Si doleva di non avere il dono della poesia, la sua libertà, la sua purezza, la sua distanza dall’implacabile logica del mondo (Consolo, 1998, 105). Consolo ripropone, in tal modo, le riserve nei confronti del romanzo manifestate in altri testi (Fuga dall’ Etna, Nottetempo, L’olivo e l’olivastro). Un «libro raro» (Consolo, 1998, 106), in spagnolo, trovato in biblioteca, conferma le sue convinzioni. Vi legge di ogni regione d’Italia e del mondo, apprende i vari significati, positivi, del termine ‘marabutto’. È consapevole, anche per questo, di come i tragici eventi che avevano portato alla morte del padre avessero costituito una stortura. Poi, dopo aver vagato per le strade di Palermo ed aver visto, nella «casba di Seralcadio» (Consolo, 1998, 108), un’altra faccia della città, come avvenuto a Milano, si ferma nella chiesa di Santa Maruzza, luogo carico di ricordi, personali e letterari, opposto al drammatico presente. Difatti, «Dentro era l’accesso, racconta il Natoli, alle caverne, alle camere segrete dei processi e delle sentenze dei giustizieri» (Consolo, 1998, 108). Ma al tribunale dei Beati Paoli si lega il vero Palazzo di Giustizia, a cui Chino giunge seguendo un «corteo, fantasmatico» (Consolo, 1998, 109). Il suo pensiero va, allora, al lavoro dei magistrati contro i gruppi mafiosi e, in particolare, al «figlio della sua dirimpettaia» (Consolo, 1998, 109), cioè il giudice Borsellino. L’incontro fra i due avviene nel segno dei libri e conferma come Chino sia alter ego di Consolo «Ho letto i suoi libri… difficili, dicono» (Consolo, 1998, 115), dice il giudice che, dopo aver citato un passo de Le pietre di Pantalica («Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e gelsomino…» [Consolo, 2012, 132]), commenta: «Ma nulla è cambiato, creda. Vedrà, il prossimo luglio sarà uguale… o forse peggio» (Consolo, 1998, 115). Egli legittima, in tal modo, la funzione civile della letteratura, legata anche ad altre arti. Chino trova, infatti, nella «memoria d’un anonimo spagnolo», delle notizie sulla tela che Raffaello dipinge per la chiesa di Santa Maria dello Spasimo, e che intitola «sgomento della Vergine e Spasimo del Mondo» (Consolo, 1998, 112). Giustamente, dunque, la Sicilia è metafora del mondo: la sua crisi, la sua degenerazione sono generali, così come «questo Spasimo, da Palermo» (Consolo, 1998, 112) coinvolge la Sicilia e il mondo tutto. E i luoghi, come la letteratura testimonia, lo confermano: Lesse di Santa Maria dello Spasimo abbandonata dai frati per il nuovo baluardo di difesa che a ridosso il viceré don Ferrante Gonzaga fece costruire. Della magnifica chiesa che divenne poi nel tempo teatro, lazzaretto nella peste, granaio, magazzino, albergo di poveri, sifilicomio, cronicario, luogo di dolore, solitudine, abbandono (Consolo, 1998, 113). Una metafora indica il perdurare di questa condizione, ormai generalizzata, al presente: lo scirocco è un «sudario molle» (Consolo, 1998, 113). Le immagini mettono poi, in parallelo, la peste e il colera, che nel passato hanno oppresso Palermo, con la mafia. Al «paranzello o brigantino» che arrivava a Palermo «con l’infetto» (Consolo, 1998, 113) corrisponde «il corpo sfatto, quasi scheletrico» (Consolo, 1998, 116) rinvenuto dentro il pilastro del portico del palazzo dove abita Chino, il quale ricorda i vv. 10-12 del quarto canto dell’Inferno quale metafora dell’incapacità di trovare una soluzione a questa situazione: «Oscura e profonda era e nebulosa / tanto che, per ficcar lo viso a fondo, / io non vi discernea alcuna cosa» (Consolo, 1998, 118). L’ultimo capitolo si svolge dunque la domenica successiva al Festino di Santa Rosalia, per sottolineare come pure la Santa che aveva salvato Palermo dalla peste, nel 1624, sia adesso impotente. La conformazione della città, con «il fitto ammasso dei palazzi, il cantiere dietro il muro, la corta via d’Astorga [allitterazione]», mostra la perdita di ogni memoria storica, «sepolta sotto il cemento» (Consolo, 1998, 123). Le enumerazioni, mettendo insieme termini di origine araba (‘càssaro’, ‘kalsa’), spagnola (‘criadi’), neologismi (‘villena’), rappresentano questa condizione di disordine, che la metafora conclusiva suggella: «Congiura, contagio e peste in ogni tempo» (Consolo, 1998, 123). 9, 2020. 20 Alla memoria storica, invece, ci riporta il fioraio che in «questa città infernale» (Consolo, 1998, 126), in cui ogni ragionevolezza sembra essere venuta meno, si chiama, non a caso (il riferimento è ad Erasmo da Rotterdam e al suo Elogio della follia), Erasmo, e che, dopo aver donato a Chino dei gelsomini, gli rivolge delle parole, apparentemente oscure, inquietanti, ma che legano il suo passato al suo presente: «Ddiu ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi / chi ti manciunu lu pani. / Ddiu ti scanza di marabutta» (Consolo, 1998, 124). Ciò è evidente nella lettera che Chino scrive al figlio, in cui troviamo insieme i cinque romanzi che Massimo Onofri ha individuato fra le pagine de Lo Spasimo: «un romanzo sul rapporto Italia – Sicilia; un romanzo sul rapporto padre e figlio (il padre di Gioacchino / Chino e Chino); un secondo romanzo padre – figlio (Chino e Mauro); […] un romanzo d’amore (Chino e Lucia); e […] un romanzo di “oblio e dimenticanza”» (Onofri, 2004, 183). Si precisano qui, quando Chino allude all’omicidio del giudice Falcone, le corrispondenze con il passo de Le pietre di Pantalica citato da Borsellino: «Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia, un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo, straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiaccicano membra su alberi e asfalto – ah l’infernale cratere sulla strada per l’aeroporto! – E’ una furia bestiale, uno sterminio»[5] (Consolo, 1998, 128). Ne Le pietre di Pantalica aveva detto: «Questa città è un macello, le strade sono carnazzerie con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. […] La guerra contro la civiltà, la cultura, la decenza» (Consolo, 2012, 132 – 134). E, ne L’olivo e l’olivastro, si indica in modo chiarissimo come responsabile di questa situazione, non limitata a Palermo ma diffusa in tutta Italia, sia la perdita della memoria storica: «Via, via, lontano da quella città che ha disprezzato probità e intelligenza, memoria, eredità di storia, arte, ha ucciso i deboli e i giusti. / Ma è Palermo o è Milano, Bologna, Brescia, Roma, Napoli, Firenze?» (Consolo, 1994, 125). Ne Lo Spasimo, questa situazione di crisi comporta una divaricazione tra letteratura e società. Chino ne matura la consapevolezza: Un paradosso questo del mantello nero in cui si muta qui la toga di chi inquisisce e giudica usando la forza della legge. E per me anche letterario. Voglio dire: oltre che in Inghilterra, nella [5] Da sottolineare come i quattro verbi (sparano-straziano-carbonizzano-spiaccicano) abbiano la stessa finale. Francia dello Stato e del Diritto è fiorita la figura del giustiziere che giudica e sentenzia fuori dalle leggi. Balzac, Dumas, Sue ne sono i padri, con filiazioni vaste, fino al Bernède e al Feuillade di Judex e al Natoli nostro, […]. In questo Paese invece, in quest’accozzaglia di famiglie, questo materno confessionale d’assolvenza, dove lo stato è occupato da cosche o segrete sette di Dévorants, […], dove tutti ci impegniamo, governanti e cittadini, ad eludere le leggi, a delinquere, il giudice che applica le leggi ci appare come un Judex, un giustiziere insopportabile, da escludere, da rimuovere. O da uccidere (Consolo, 1998, 129-130). Il letterato, dunque, l’intellettuale vive in una condizione di esilio, non è adeguatamente apprezzato, tant’è che quando Chino tenta di fermare Borsellino mentre suona al citofono, il giudice si gira ma non lo riconosce. Nell’attentato viene colpito Erasmo che, morendo, recita due versi de La storia di la Baronissa di Carini, ad attestare come, anche se al presente la letteratura non è ascoltata, è da questa, voce della tradizione, della memoria storica, che deve venire la salvezza:
O gran mano di Diu, ca tantu pisi, cala, manu di Diu, fatti palisi!
(Consolo, 1998, 131). 9, 2020. 22 Bibliografia Bouchard, Norma (2005). Vincenzo Consolo and the Postmodern Writing of Melancholy. Italica, 82, (1), 5 – 23. Ciccarelli Andrea (a cura di) (2005). Intervista a Vincenzo Consolo. Italica, 82, (1), 92 – 97. Consolo, Vincenzo (1988). Le pietre di Pantalica. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1992). Retablo. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1993). Fuga dall’Etna. Roma: Donzelli. Consolo, Vincenzo (1994). L’olivo e l’olivastro. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1998). Lo Spasimo di Palermo. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1999). Di qua dal faro. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (2006). «Ma la luna, la luna…». In Pintor Romera I. (a cura di). Lunaria. Vent’anni dopo. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Consolo, Vincenzo (2012). La mia isola è Las Vegas. Milano: Mondadori. Donnarumma, Raffaele (2011). Storia, immaginario, letteratura: il terrorismo nella letteratura italiana (1969 – 2010). In Aa. Vv., Per Romano Luperini. Palermo: Palumbo. Dotti, Ugo (2012). Il senso della storia nell’opera di Vincenzo Consolo. In Ugo Dotti, Gli scrittori e la storia. La narrativa dell’Italia unita e le trasformazioni del romanzo (da Verga a oggi). Torino: Nino Aragno editore. Francese, Joseph (2015). Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità» (1992 – 2012), ovvero la poetica della colpa – espiazione. Firenze: Firenze University Press. Lollini, Massimo (2005). Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo. Italica, 82, (1), 24 – 43. Luperini, Romano (1999). Controtempo. Napoli: Liguori. Marcellesi – Giacomo, Mathée (2004). Vincenzo Consolo: l’alchimie du logos. Croniques italiennes. 2-3, 197 – 214. Onofri, Massimo (2004). Il sospetto della realtà: Saggi e paesaggi italiani novecenteschi, Cava de’ Tirreni: Avagliano. O’Connell, Daragh (2004). Il dovere del racconto: Interview with Vincenzo Consolo. The Italianist. 24: II, 238 – 253. DOI: 10.1179 / ita.2004.24.2.238 O’Connell, Daragh (2008). Consolo narratore e scrittore palincestuoso. Quaderns d’Italià, (13), 161 – 184. O’Connell, Daragh (2012). «Tizzone d’Inferno»: Sciascia on Joyce. Totomodo, 237 – 248. Traina, Giuseppe (2001). Vincenzo Consolo. Fiesole: Cadmo.
Summary
Lo Spasimo di Palermo is example of a crisis that has repercussions on the expressive form: on the one hand, the consciousness that «sul ciglio dell’abisso la parola si raggela, si fa […] simbolo sfuggente» comes out, on the other hand novel seems a «genere scaduto, corrotto, impraticabile». The generational conflict between Chino and Mauro is included in this sphere too. Hence it follows many solutions that lead to Consolo’s «poema narrativo» and testify the prevailing disorientation: paratactic accumulation, metaphors, literary quotations, figures of speech. Pictorial suggestions find its centre in Raphael’s Lo Spasimo di Sicilia, symbol of a pain that from Palermo arrives to Sicily and all world, while the spaces have a great importance and show the loss of historical memory, responsible for crisis. Key words: Consolo, crisis, memory, history