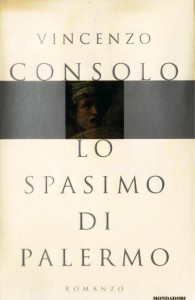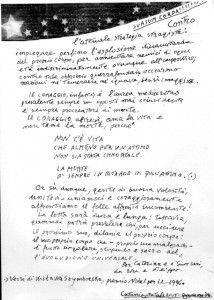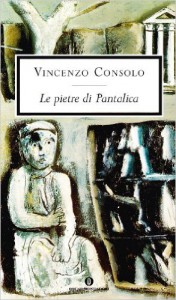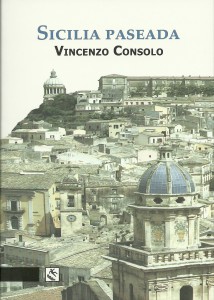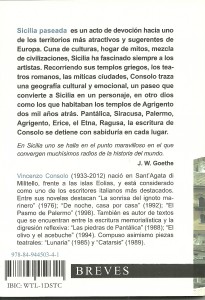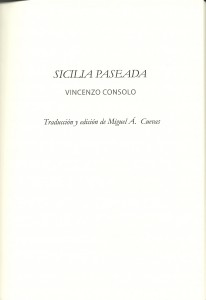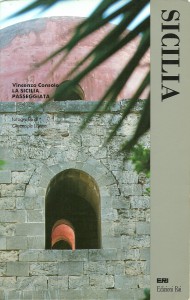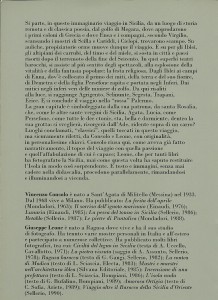Era il settembre 1963 quando il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, pubblicato da Mondadori nella collana “Tornasole”, diretto da Gallo e Sereni , 1963
La ferita dell’aprile
Persone, fatti, luoghi sono immaginari. Reale è il libro
che dedico, con pudore, a mio padre.
Dei primi due anni che passai a viaggiare mi rimane la
strada arrotolata come un nastro, che posso svolgere: rivedere
i tornanti, i fossi, i tumuli di pietrisco incatramato,
la croce di ferro passionista; sentire ancora il sole sulla
coscia, l’odore di beccume, la ruota che s’affloscia, la naftalina
che svapora dai vestiti. La scuola me la ricordo appena.
C’è invece la corriera, la vecchiapregna, come diceva
Bitto, poiché, così scassata, era un miracolo se portava
gente. Del resto, il miglior tempo lo passai per essa: all’alba,
nella piazza del paese, aspettando i passeggeri – malati
col cuscino del letto e la coperta, sbrigafaccende, proprietari
che avevano a che fare col Registro o col Catasto,
gente che si fermava alla marina o partiva col diretto per
Messina – e poi, alla stazione, dove faceva coincidenza con
l’accelerato delle due e mezza.
Non so come cominciai ad aiutare Bitto, fatto sta che
mi vedo salire la scaletta, camminare sopra il tetto per sistemare
i colli, lanciargli, al segnale, il capo della corda
per legare.
Che posso ricordare di quegli anni di scuola e d’Istituto
se li presi controvoglia al primo giorno, se Bitto mi sfotteva
per i libri e lusingava con la guida, la corriera, la vita
in movimento? Chiedevo anche «biglietto» con a tracolla
la borsetta nera, o correvo col cato alla fontana per levare
dai vetri il vomito delle donne e dei bambini.
«Ma che vai all’Istituto, a sfacchinare?» chiedeva ma’
vedendomi le mani lorde, la giacca con le macchie.
Come le cose belle, finì la vita sopra la corriera dopo
che gli cantarono a zio Peppe di come Bitto m’aveva preso
a picciottello. Mi sistemò in una casa ch’affittava e da
quel giorno entrai nell’Istituto.[…]
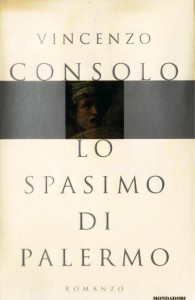
Lo spasimo di Palermo
Lo spasimo di Palermo è un nostos, il racconto di un ritorno
[…] Chiuse il libro, prese la penna e scrisse.
Mauro, figlio mio,
sì, è così che sempre ti ho chiamato e continuo a chiamarti:
figlio mio. Ora più che mai, lontani come siamo, ridotti
in due diversi esili, il tuo forzato e il mio volontario in
questa città infernale, in questa casa… smetto per timore
d’irritarti coi lamenti.
Figlio, anche se da molto tempo tu mi neghi come padre.
So, Mauro, che non neghi me, ma tutti i padri, la mia generazione,
quella che non ha fatto la guerra, ma il dopoguerra,
che avrebbe dovuto ricostruire, dopo il disastro, questo Paese,
formare una nuova società, una civile, giusta convivenza.
Abbiamo fallito, prima di voi e come voi dopo, nel vostro
temerario azzardo.
Ci rinnegate, e a ragione, tu anzi con la lucida ragione
che sempre ha improntato la tua parola, la tua azione. Ragione
che hai negli anni tenacemente acuminato, mentre
in casa nostra dolorosamente rovinava, nell’innocente tua
madre, in me, inerte, murato nel mio impegno, nel folle
azzardo letterario.
In quel modo volevo anch’io rinnegare i padri, e ho compiuto
come te il parricidio. La parola è forte, ma questa è.
Il mio primo, privato parricidio non è, al contrario del
tuo, metaforico, ma forse tremendamente vero, reale.
Tu sai dello sfollamento per la guerra a Rassalèmi, del
marabutto, dell’atroce fine di mio padre, della madre di tua
madre, del contadino e del polacco. Non sono mai riuscito
a ricordare, o non ho voluto, se sono stato io a rivelare
a quei massacratori, a quei tedeschi spietati il luogo dove
era stato appena condotto il disertore. Sono certo ch’io
credevo d’odiare in quel momento mio padre, per la sua
autorità, il suo essere uomo adulto con bisogni e con diritti
dai quali ero escluso, e ne soffrivo, come tutti i fanciulli
che cominciano a sentire nel padre l’avversario.
Quella ferita grave, iniziale per mia fortuna s’è rimarginata
grazie a un padre ulteriore, a un non padre, a quello
scienziato poeta che fu lo zio Mauro. Ma non s’è rimarginata,
ahimè, in tua madre, nella mia Lucia, cresciuta con
l’assenza della madre e con la presenza odiosa di quello
che formalmente era il padre.
Sappi che non per rimorso o pena io l’ho sposata, ma
per profondo sentimento, precoce e inestinguibile. Quella
donna, tua madre, era per me la verità del mondo, la
grazia, l’unica mia luce, e sempre viva.
La mia capacità d’amare una creatura come lei è stato
ancora un dono dello zio.
Al di là di questo, rimaneva in me il bisogno della rivolta
in altro ambito, nella scrittura. Il bisogno di trasferire
sulla carta – come avviene credo a chi è vocato a scrivere
– il mio parricidio, di compierlo con logico progetto, o
metodo nella follia, come dice il grande Tizio, per mezzo
d’una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente
comunicativa, di padri o fratelli – confrères –
più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili
del disastro sociale.
Ho fatto come te, se permetti, la mia lotta, e ho pagato
con la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna.
Compatisci, Mauro, questo lungo dire di me. È debolezza
d’un vecchio, desiderio estremo di confessare finalmente,
di chiarire.
Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia,
un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo,
straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiaccicano
membra su alberi e asfalto – ah l’infernale cratere sulla
strada per l’aeroporto! – È una furia bestiale, uno sterminio.
Si ammazzano tra di loro, i mafiosi, ma il principale
loro obiettivo sono i giudici, questi uomini diversi da
quelli d’appena ieri o ancora attivi, giudici di nuova cultura,
di salda etica e di totale impegno costretti a combat-
tere su due fronti, quello interno delle istituzioni, del corpo
loro stesso giudiziario, asservito al potere o nostalgico
del boia, dei governanti complici e sostenitori dei mafiosi,
da questi sostenuti, e quello esterno delle cosche, che qui
hanno la loro prima linea, ma la cui guerra è contro lo Stato,
gli Stati per il dominio dell’illegalità, il comando dei
più immondi traffici.
Ma ti parlo di fatti noti, diffusi dalle cronache, consegnati
alla più recente storia.
Voglio solo comunicarti le mie impressioni su questa
realtà in cui vivo.
Dopo l’assassinio in maggio del giudice, della moglie
e delle guardie, dopo i tumultuosi funerali, la rabbia, le
urla, il furore della gente, dopo i cortei, le notturne fiaccolate,
i simboli agitati del cordoglio e del rimpianto, in
questo luglio di fervore stagno sopra la conca di cemento,
di luce incandescente che vanisce il mondo, greve di
profumi e di miasmi, tutto sembra assopito, lontano. Sembra
di vivere ora in una strana sospensione, in un’attesa.
Ho conosciuto un giudice, procuratore aggiunto, che
lavorava già con l’altro ucciso, un uomo che sembra aver
celato la sua natura affabile, sentimentale dietro la corazza
del rigore, dell’asprezza. Lo vedo qualche volta dalla
finestra giungere con la scorta in questa via d’Astorga
per far visita all’anziana madre che abita nel palazzo antistante.
Lo vedo sempre più pallido, teso, l’eterna sigaretta
fra le dita. Mi fa pena, credimi, e ogni altro impegnato in
questa lotta. Sono persone che vogliono ripristinare, contro
quello criminale, il potere dello Stato, il rispetto delle
sue leggi. Sembrano figli, loro, di un disfatto padre, minato
da misterioso male, che si ostinano a far vivere, restituirgli
autorità e comando.
Quando esce dalla macchina, attraversa la strada, s’infila
nel portone, vedo allora sulle spalle del mio procuratore
aggiunto il mantello nero di Judex, l’eroe del film
spezzato nella mia lontana infanzia, che ho congiunto, finito
di vedere – ricordi? – alla Gaumont.
Un paradosso questo del mantello nero in cui si muta
qui la toga di chi inquisisce e giudica usando la forza della
legge. E per me anche letterario. Voglio dire: oltre che in
Inghilterra, nella Francia dello Stato e del Diritto è fiorita
la figura del giustiziere che giudica e sentenzia fuori dalle
leggi. Balzac, Dumas, Sue ne sono i padri, con filiazioni
vaste, fino al Bernède e al Feuillade di Judex e al Natoli
nostro, il cui Beati Paoli è stato il vangelo dei picciotti.
In questo Paese invece, in quest’accozzaglia di famiglie,
questo materno confessionale d’assolvenza, dove lo stato
è occupato da cosche o segrete sette di Dévorants, da tenebrosi
e onnipotenti Ferragus o Cagliostri, dove tutti ci
impegniamo, governanti e cittadini, ad eludere le leggi, a
delinquere, il giudice che applica le leggi ci appare come
un Judex, un giustiziere insopportabile, da escludere, rimuovere.
O da uccidere.
Ancora questa mattina, come ogni domenica, sono andato
ai Ròtoli a portare i gelsomini. C’è un fioraio qui,
all’angolo della strada, che me li vende, mastr’ Erasmo,
che ha un pezzetto di terra a Maredolce. È un vecchietto
originale, simpatico, che parla per proverbi. Oggi, nel darmi
i fiori, ne ha detto uno strano, allarmante per una parola,
marabutto, che mi tornava da dolorosa lontananza…
Lo interruppe lo squillo del telefono. Era Michela che
gridava, piangendo:
«Don Gioacchino, presto, esca di casa, scappi subito,
lontano!»
Riattaccò. Gioacchino restò interdetto, smarrito. Sentì
nella strada deserta, silenziosa, i motori forti, lo sgommare
delle auto blindate.
Guardò giù. Erano il giudice e la scorta. Vide improvvi-
samente chiaro. Capì. Si precipitò fuori, corse per le scale,
varcò il portone, fu sulla strada.
«Signor giudice, giudice…» I poliziotti lo fermarono,
gl’impedirono d’accostarsi. Sembrò loro un vecchio pazzo,
un reclamante.
Il giudice si volse appena, non lo riconobbe. Davanti al
portone, premette il campanello.
E fu in quell’istante il gran boato, il ferro e il fuoco, lo
squarcio d’ogni cosa, la rovina, lo strazio, il ludibrio delle
carni, la morte che galoppa trionfante.
Il fioraio, là in fondo, venne scaraventato a terra con il
suo banchetto, coperto di polvere, vetri, calcinacci.
Si sollevò stordito, sanguinante, alzò le braccia, gli occhi
verso il cielo fosco.
Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono.
Implorò muto
O gran mano di Diu, ca tantu pisi,
cala, manu di Diu, fatti palisi!
pubblicato nel 1998