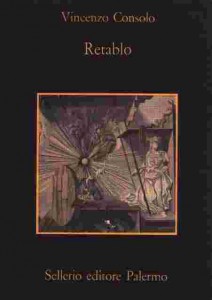ISIDORO, dono dell’ alma e gioia delle carni, spirito di miele, verdello della state, sugello d’ oro, candela della Pasqua, battaglio d’ ogni festa, sposo d’ un giorno e sempre disiato, Rosalia che t’ ha donato il core si squaglia per la brama, col ricordo di te rimane incatenata. Ah, bagascia!, dici, lo so. E sua madre pure! Bagascia, sì, all’ apparenza, ma per il bene nostro, tuo e mio. Bella, la verità. Isidoro, monaco smonacato per amore, uomo sbocciato con tardanza, fiumara turbinosa d’ autunno, foco che sprizza in cima del vulcano, tu, nella volontaria povertate, nella sicurezza del paglione, nel profumo e nel ristoro della chiesa, nella serenitate del convento, tu non capivi la laida miseria, i pericoli mortali di due femmine, una vedova e una vergine, nel vicolo fetoso dove mi vedesti, ed io ti vidi, per la prima volta. D’ acchito non mi piacesti, lo confesso. In primo, perch’ ero presa da un giovine ambulante, biondo e rizzuto come un san Giovanni, ch’ ogni giorno arrivava sopra un asino pantesco adorno di specchietti, di nastri e di cianciàne, e con potente voce, modulata, bandeggiava spàragi, cime, bròccoli e finocchi. E guardi e complimenti e regalìe d’ ortaggi salivano dalla strada alla finestra, dentro il panàro e in volo sopra l’ aere. In secondo, perch’ eri torvo, nero come un san Calogero e chiuso nel nero della barba, storto per le bisacce, incerto nella tonaca d’ albagio che ti ballava sul secco delle ossa. Brutto, eri brutto, Isidoro. Io e mia madre ne ridevamo tanto. Ma la notte che scappasti dal convento, dopo che ti tagliasti quei peli in faccia di porco ragusano, che ti sgrasciasti nella pila e t’ appressasti a me che già dormivo, ah, Isidoro, Dio benedica, io subito m’ accorsi che la bellezza tua stava nascosta. Bella, la verità. La mattina, mentre tu ronfavi, alla finestra, guardando l’ Immacolata dell’ altarino sulla cantonata in faccia, infilando nel dito un anello, che più non tolgo mai, feci giuramento: “Isidoro è l’ unico e vero sposo mio, per l’ eternitate”. E recisi una ciocca di capelli e l’ offrii alla Madonna spargendola nel vento, siccome fanno le monache che si sposano con Dio. E io monaca sono, Isidoro mio, monaca per amore del ricordo più bello e incorrotto, monaca per amore dell’ amore, in clausura d’ anima per te, per te, fino alla morte. Chè mai prima di quella notte io provai il Paradiso, nè mai per l’ innante proverò. Per grazia tua, Isidoro, Dio benedica. Bella, la verità. E dopo quella notte, per un mese e passa non volli più lavarmi, sciogliere l’ essenza, disperdere l’ odore tuo sparso nel mio corpo. Con gran dispetto del signor marchese che, dalla partenza tua per il Vallo di Mazara in compagnia del cavaliere di Milano, ci tolse, me e la madre mia, dal vico malfamato e ci portò in palazzo. “Lavati”, mi diceva “e lavati!”. “No, no e no!” gli rispondevo battendo a terra lo scarpino. E il marchese allora, rassegnato, al momento d’ uscire per la passeggiata, mi spruzzava essenze di bergamotto e di jasmino. Monaca, dicevo, in clausura d’ anima, d’ amore, e il monastero mio è questo gran palazzo in cui dimoro, tenuta al pari d’ un bigiù, nell’ agio e nello sfrazzo, vesti e cibarie sopraffine a tinchitè, ora nel quartierino mio a scrivere questa lettera per te. Lettera, memoria o testamento, prima ch’ io lasci questa citate di Palermo, incontro a un destino che solo Dio sa. ;-3MA NON è la mia mano a far scorrere la penna sulla carta. Io vivo, sento, ascolto il core mio e parlo, e ciò che dico, è la mano innocente di don Gennaro Affronti a calarlo sulla carta, in forma di segni a china, di scrittura. Don Gennariello, artista un tempo molto rinomato, ch’ ha girato per corti e per teatri di tutto questo mondo, s’ è ridotto in Palermo per insegnare il canto. E l’ ha insegnato a me, chè il signor marchese che mi tiene, scoprendomi gran dote nella gola, ha voluto ch’ io divenissi una cantante e così debutterò fra qualche giorno in una capitale, prima donna seria nella Vergine del Sole del Cimarosa. Don Gennariello m’ ha insegnato l’ arte, tutte l’ astuzie del mestiere, ed egli a poco a poco è divenuto per me il padre che non ho, e pure madre, chè quella mia, la naturale, presa nel cortiglio di signore sdillinchiose e dei loro sdillinchiosi cavalieri, non ha più tempo di badare a me. Io sono dunque ormai creatura di don Gennaro. Il quale, meschino, da caruso, fu mutilato della sostanza sua mascolina per esser tramutato in istromento dolcissimo di canto. E ha avuto ricchezza, onori e risonanza, ma gli è mancata la cosa più importante della vita: l’ amore, come quello nostro, Isidoro mio. Mi dice: “Ah, come t’ avrei adorata, Rosalia, se fossi stato uguale come gli altri!”. E ancora, sospirando: “C’ est la vie: chi canta non vive e chi vive non canta”. E mi guarda, alla vigilia del mio inizio, con gran malinconia. “Siamo castrati, figlia mia”, aggiunge, “siamo castrati tutti quanti vogliamo rappresentare questo mondo: il musico, il poeta, lo scrittore, il pintore… Stiamo ai margini, ai bordi della strada, guardiamo, esprimiamo, e talvolta, con invidia, con nostalgia struggente, allunghiamo la mano per toccare la vita che ci scorre per davanti”. Ha ragione, ha ragione don Gennaro! Così fanno, allungano le mani, questi artisti. Così il vecchio abate Meli, che a Villa Giulia, sbucando avanti a me all’ improvviso da un cespuglio, tocca, sospira e va, declamando poesie. Così il cavalier Serpotta, lo scultore plastico, quando il marchese mi portò da lui per farmi fare le pose per la statua della Verità: al posto dello stucco, plasmava me, con insistente mano. Ahuffa, vah. Non voglio dirti, ma i rischi che c’ erano nel vico ci sono pure qua, coi galantomi. Ma io vivo solo nel ricordo di te e per te, Isidoro. Monaca mi feci e monaca resto nel cuore e nelle carni, finchè posso. Il signor marchese, poveretto, già vecchio, affaticato, s’ accontenta ch’ io viva nel palazzo, di guardarmi e di mostrarsi con me in società. Gli altri, cicisbei o babbaluci, li tengo a bada, e come!, non mi chiamassi se no Guarnaccia Rosalia e non avessi avuto un uomo come Cicco Paolo Cricchiò, ai voti tramutato in Isidoro. E così continuo a chiamarlo, perchè nome troppo bello e perchè sotto questo nome lo conobbi. Bella, la verità. Isidoro, io ti vidi folle per Palermo al tuo ritorno dal viaggio, ti vidi alla Marina da dentro la carrozza, ancora qualche volta sulla strada da dietro le gelosie del palazzo. So, so che per tutti i mesi che durò il viaggio, notte e giorno, in tutte l’ avventure, i mali passi, nel rischio della vita, fra gente bona o pure fra briganti, sotto il sole o le stelle, in fondachi o locande, non facevi che sognare, invocare me, la tua Rosalia. E il cavaliere Clerici racconta che sei stato picciotto valoroso, accorto e ingegnoso. Nello scansare ostacoli, sventare trappole, imboscate, ridurre all’ amistà ladri di passo e truci grassatori. Tu che da monaco vendevi bolle dei Luoghi Santi pei viaggi, bolla vivente fosti per il cavaliere, e più efficace. Nel trovare l’ uscita a ogni intoppo. Come a Selinunte, dopo che al cavalier pintore furarono la sacca con dentro carte, pennelli, carboni e acque tinte, nell’ ingegnarti a squagliare sul foco pallettoni a lupara e farne un bastoncino a punta pel disegno. Ma subito, al ritorno, perdesti la ragione. Ossesso ti facesti, cane randagio e questuante di pietà. Perchè la Rosalia tua era scomparsa. E apparecchiasti casotto, spettacolo per i vichi, le strade e le piazze di Palermo. In pianto rotto sul monte Pellegrino davanti all’ alabastro della Santa; in possessione, in furia dell’ Inferno in San Lorenzo alla scoperta che la Verità ignuda del cavalier Serpotta era la copia del sembiante mio. E l’ urla e lo schiamazzo davanti all’ Oratorio, e l’ accorrere del padre Guardiano che riconobbe in te il frat’ Isidoro fuggito dal convento, ladro dell’ onze delle bolle, e che chiamò i gendarmi. E fu la Vicarìa. Povero Isidoro. Non fosse stato pel signore di Milano, pel cavaliere Clerici, amico del marchese e amico mio, che pagò ogni debito e pure pel riscatto, saresti ancora ai ferri. ;-3ORA sei libero, Isidoro, libero, solo e disperato, per l’ assenza di me, pel tradimento e l’ affronto mortale che credi ch’ io ti feci. M’ ammazzeresti, son certa, nel caso mi trovassi. Male faresti, Isidoro, male, ammazzeresti la Rosalia tua che t’ ama e t’ è fedele, che t’ ha lasciato solo per amore. Bella, la verità. Cos’ è l’ amore in dentro la miseria? Un fiore delicato, una pomelia bianca e avorio dentro in un pantano, neve immacolata nel fervore del luglio. Dura un sospiro, un attimo, si corrompe e muore. E il nostro, così breve, intenso e risplendente? Io vidi nel nero vico dove nacqui innumeri fanciulle infiammarsi d’ amore, maritarsi e subito odiare, cariche di figli e strette dagli stenti, l’ uomo tanto amato, ed essere odiate. Avere insulti, fiati di vino, patimenti, colpi di legno e sfregi di coltello. Finire sfatte al Càssero Morto o fora dalle mura della Kalsa e appestate morire a lo spedale dello Spasimo. Ah, io mai, io mai! Far finire nell’ odio e nel dolore il nostro amore. Fu per questo che scappai, ch’ accettai questa parte dell’ amante, questa figura della mantenuta. Bella, la verità. E ora che la sai, la verità, se la capisci, fatti saggio, Isidoro, ritorna virtuoso. Chiedi perdono al padre Guardiano, rientra nel convento. Saperti ancora monaco, mi dona contentezza. Monaco tu e monaca io, nel voto e nel ricordo del nostro grande amore. Addio, Isidoro, io parto, io parto. Addio. E per l’ ultima volta, come quella notte: dolce, sangue mio.
VINCENZO CONSOLO
La Repubblica, 28 luglio 1985