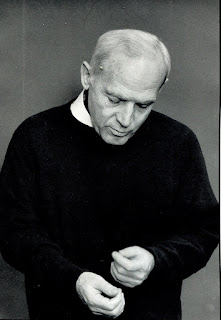La ferita dell’aprile
di Vincenzo Consolo
Einaudi, 1977 (2^ edizione)
pp. 138
Era il settembre 1963 quando il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, fece la sua apparizione nel mondadoriano “Tornasole”, diretto da Gallo e Sereni e fortemente orientato alla ricerca del nuovo. Proprio per la carica sperimentale della collana, il testo ebbe una ricezione alquanto elitaria; perché Consolo s’imponesse all’attenzione della critica e del pubblico si dovettero aspettare gli anni successivi, in particolare il 1976 con Il sorriso dell’ignoto marinaio.
Ma in questo libro d’esordio dell’autore di Sant’Agata di Militello si trovano già in nuce molti elementi, temi, particolarità delle prove narrative più mature.
In quell’anno in cui videro la luce grandi capolavori della nostra storia letteraria, come sottolinea Giulio Ferroni, “Consolo sembra percorrere una strada tutta sua, lontano sia dalle operazioni di tipo formalistico, dalle delibazioni estetizzanti, che dagli stravolgimenti avanguardistici e neoavanguardistici”. Partendo dall’espressionismo verghiano per poi imboccare una direzione originale, l’autore – allora solo trentenne – dava già dimostrazione della sua capacità di analisi e riflessione storica, consegnandoci una prosa narrativa tesa allo scavo nella memoria e nel passato, personale e collettivo.
L’inizio del romanzo, con la splendida similitudine della strada arrotolata come un nastro suggerisce subito l’idea del ricordo che prende forma dalla parola narrata:
Dei primi due anni che passai a viaggiare mi rimane la strada arrotolata come un nastro, che posso avvolgere: rivedere i tornanti, i fossi, i tumuli di pietrisco incatramato, la croce di ferro passionista; sentire ancora il sole sulla coscia, l’odore di beccume, la ruota che s’affloscia, la naftalina che svapora dai vestiti. [p.3]
La ferita dell’aprile può considerarsi la storia di una crescita, il quadro di un periodo particolare dell’esistenza, l’antefatto di una vita che ha da venire. Tutto costruito sul modulo del racconto biografico in prima persona e diviso in dodici brevi capitoli, il romanzo racconta la vita del giovane Scavone in un paese della costa settentrionale della Sicilia, rievocato con un po’ di nostalgia e al lettore regalato con la giusta dose di lirismo:
Questo paese è una grata, i vicoli incrociati, quelli piani trasversali e gli altri che scendono dritti fino a mare [..] laggiù, lo specchio di acqua chiara, un vetro azzurro in fondo al vicoletto. Ma verso l’alto c’è lo schermo della terra, le colline verdegrige con gli ulivi e gli agrumeti. Questo paese sembra posato tra le zampe d’un cane accovacciato, chiuso com’è i in questo rettangolo collinoso in riva al mare. [pp.121-122]
È il secondo dopoguerra e il protagonista, orfano di padre, trascorre un anno all’Istituto religioso del paese, luogo-prospettiva dal quale Scavone i suoi amici osservano il mondo che li circonda. I litigi di cortile e le prove di vera amicizia, i riti religiosi, i rapporti con gli americani e la distribuzione dei pacchi alimentari, la conoscenza di un nuovo frate educatore, l’esplorazione dei primi desideri sessuali, i viaggi in compagnia dello zio Giuseppe, il gioco del Monopoli.. la vita è scandita da attimi di piccoli piaceri, dialoghi ed eventi che segnano la formazione del personaggio. Sullo sfondo dei momenti di vita minuta, si scorgono tra le righe igrandi fatti storici: la strage di Portella della Ginestra, le elezioni amministrative dell’aprile 1947, lo scoppio del colera a Palermo, l’eruzione dell’Etna dello stesso anno e, file rouge di tutta la narrazione, l’anticomunismo clericale che permea l’educazione dei ragazzini, primo segnale di un’incipiente Guerra Fredda.
“Avvenimenti personali di scarsa incidenza e altri di più profondo impatto sono alternati senza essere organizzati su un asse prospettico che consenta di disporli in ordine di importanza”: a Consolo non interessa subordinare il personale al politico.
Il microcosmo raccontatoci dall’autore colpisce per la sua ritualità. Come su un palcoscenico, i personaggi partecipano alle funzioni religiose (particolarmente evocative le scene dell’interruzione della novena di Natale e della processione pasquale) e a quelle “sociali”.
Scavone recita nel salotto della Baronessa e nello studio del Rettore dell’Istituto; sua madre nasconde la relazione con il cognato per poi sposarlo una volta che la cittadinanza glielo impone; i ragazzini fingono di trovare interessanti le prediche della domenica; Filì porta con sé l’amico e lo rende spettatore nascosto di un rapporto sessuale con una donna adulta. Consapevoli degli artifici entro i cui confini si muovono, sanno di essere un po’ attori e partecipano tutti a questo “gioco delle parti”.
Accanto al mondo sociale, ecco la recita in quello familiare. Su tutte le figure spicca quello dello zio Giuseppe Scavone su cui il ragazzino opera una completa proiezione della figura paterna assente. Protagonista indiscusso dello spettacolo familiare, a lui il ragazzino dedica tutto il suo amore filiale:
Era un giorno d’agosto e di calura e tornava di campagna in un bagno di sudore. Mi chiamò dentro e mi disse di sfilargli i borzacchini, di lavargli con l’aceto i piedi sfatti. Mi parve un re, un santo, assiso sul cassone, le mani sulle cosce, lo sguardo sopra di me in ginocchione a sfregargli i piedi immensi nel bacile di rame con l’aceto. [p.34]
Uno degli aspetti più interessanti della struttura del romanzo è la duplicità di funzione del protagonista.Narratore e personaggio, la sua voce ha assoluta centralità: da un lato è impegnato a vivere le dinamiche della vita in paese, dall’altro a raccontarle. Sia nell’agire che nel narrare, però, Scavone è distante dal dare giudizi e dall’attribuire definizioni. Registra quel che vede con l’aridità del catalogatore, non sempre ha piena consapevolezza di quello che succede nel mondo degli adulti, e il percorso di formazione è lontano dal dirsi concluso. Ovunque domina l’instabilità dei momenti di passaggio.
Ci sono due “dati saldamente pre-diegetici” a cui si accenna continuamente nel corso del libro ma che non vengono mai raccontati: la morte del padre e l’abbandono di un paese di cui non si pronuncia mai il nome e nel quale si può facilmente riconoscere San Fratello. Con la sua parlata di derivazione gallo-italica, il paese sui Nebrodi che farà la sua comparsa anche nelle opere successive di Consolo (Lunaria, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Le pietre di Pantalica), è come un marchio sulla figura di Scavone, che tutti chiamano“zanglè” perché parla una lingua speciale, diversa da quella dei suoi coetanei che per questo spesso lo deridono e lo fanno sentire diverso.
Arriviamo a questo punto alla lingua de La ferita dell’aprile, così audacemente costruita sul doppio asse lingua-dialetto, mai contrapposti ma, al contrario, immessi l’uno nell’altro. La lingua di Consolo è intrisa dioralità, si nutre di canti liturgici e popolari, di canzoncine politiche (Quando sarà abolito il capitale/ le piante daran gnocchi con la bagna/ e invece di patate pere e mele/ avremo confettini e pandispagna, p.68) e di scanzonate rime dialettali, interiezioni e modi di dire. Come sottolinea Daniela La Penna, la struttura su cui si costruisce il testo è il pervasivo discorso indiretto libero, “punto di incontro tra diegesi e mimesi” e che non è difficile individuare come una chiara eco verghiana:
La capo ciurma le chiama puttanelle, zoccole, sempre la testa là voi ci avete, e loro cantano a struggimento s’è maritata Rosa Sarina e Peppinella, col canto e controcanto, ed io che sono bella mi voglio maritar. [p.74].
Il testo procede per immagini staccate che hanno il ritmo delle stagioni. Basta leggere queste righe sull’arrivo della primavera in Sicilia per sentire gli odori di una terra, intravederne i colori, intuirne i sapori:
Primavera prescialora che non lascia di dire è cominciata. La conca s’appende nel dammuso tirata oro con cenere e limone. Voglia di insalata sul terrazzo, voglia d’aceto, nespole agrimogne. I vecchi, lo scialle sulle spalle e le coppole sugli occhi, si portano nel sole a scatarrarsi, a togliersi l’inverno dalle ossa, disegnano il terreno col bastone, spaventano l’uccello e la lucertola. Le donne sui balconi, alle finestre, sciolte le crocchie, ripassano i capelli, fino alle spalle, fino alla vita, conservano i batuffoli nelle crepe per le rose di carta, centrini a punto croce, bambole d’organza e falpalà. I pittori, cappelli di giornale, sbarazzano i catoi, trespidi e tavole, testate e materassi sopra il marciapiede; la calce e gli scopini fanno la primavera, bianco e cilestrino, rosa cotto, giallo giudeo. [p.73]
La ferita dell’aprile è un romanzo che non ha nulla da invidiare ai testi del Consolo successivo in quanto a complessità e profondità tematica. Gli studiosi si sono interrogati sul senso della parabola di Scavone, dandone diverse interpretazioni. Giancarlo Ferretti, nella sua preziosa introduzione alla riedizione Mondadori del 1989, legge il libro come un “romanzo sul problema del potere” e sulla “carica liberatoria della diversità”; AlbertoCadioli ha, invece, sottolineato l’aspetto della formazione, sancita dal finale dell’opera e dall’ingresso del protagonista nel mondo degli adulti.
– Ecco, – pensavo, – la vita è un gioco di maretta: avere l’occhio fino a capire il momento per gridare «arripa!» e scivolare col legno sulla cresta. Un po’ prima, un po’ dopo, sbagliare il tempo, per ansie o dubbi o titubanze, significa farsi pigliare sotto, e travolgere, e sbattere nel fondo […] uno che pensa, uno che riflette e vuol capire questo mare grande e pauroso, vien preso per il culo e fatto fesso. E questa storia che m’intestardo a scrivere, questo fermarmi a pensare, a ricordare, non è segno di babbìa? [p.105]
Nel microcosmo siciliano si condensa una riflessione dai toni elegiaci sull’uomo e sulla storia. Come nella Trezza di Verga, nella comunità di Consolo c’è spazio per un’etica, per una filosofia della vita, e non è certo un caso che anche qui sia affidata al mondo del mare.
Claudia Consoli
Edizione di riferimento: Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, Torino, Einaudi, 1977.