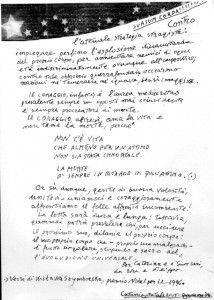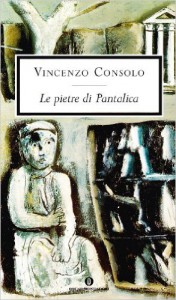Alessandro Dell’Aira
Editor, iberista
Incontrai Consolo per la prima volta a Madrid, nell’autunno del ’95.
Allora dirigevo la rivista “Quaderni” del Liceo Italiano Enrico Fermi,
di cui ero preside. L’Istituto Italiano di Cultura seguiva con interesse
il nostro lavoro e ci autorizzava a pubblicare i testi delle conferenze
che organizzava nella sua sede o patrocinava in Spagna. Certo di
fargli piacere, gli donai una copia della prima edizione italiana della
commedia di Lope sul Santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo,
da me curata, edita qualche mese prima a Palermo.
Consolo, in quell’autunno, lasciò Madrid per Barcelona e Salamanca,
dove tenne una lezione accademica, La retta e la spirale, su temi siciliani
intrecciati con la storia spagnola tra Rinascimento e Barocco. Cedette
generosamente ai “Quaderni” copia del testo che avrebbe poi inserito
in Di qua dal faro,1 che accennava anche alla commedia di Rosambuco
come esempio di legame interculturale nel Siglo de Oro, e si concludeva
con una riflessione amara e attualissima sul “dolore senza catarsi”.
Prima di inviare il dattiloscritto in tipografia mi venne il dubbio che
vi fosse un evidente refuso, perdita anziché perdida, nella trascrizione di
una quartina dalla Galatea di Cervantes incisa sull’arco d’ingresso di una
villa di Bagheria:
Ya la esperanza es perdida
Y un solo bien me consuela
1 “La Retta e la Spirale”, «Quaderni del Liceo Italiano di Madrid», 4 (giugno 1996),pp. 83-84. IL testo è preceduto da parte di un’intervista con Valeria Cioffi. Di qua dal Faro (d’ora in avanti DQF), in L’opera completa (d’ora in avanti OC), a cura di Gianni Turchetta, prefazione di Cesare Segre, Milano, Mondadori, 2015 (I Meridiani), pp.1234-1238.
Que el tiempo que pasa y buela
Llevará presto la vida.2
Chiamai Consolo a Barcelona: mi disse che avrebbe controllato. E infatti mi chiamò la mattina dopo, molto divertito. Mi aveva cercato a scuola qualche ora dopo, e in mia assenza gli aveva risposto Juanita, la custode. Consolo le disse: «Per favore, avvisi il preside che la esperanza es perdida». Juanita si allarmò: «No signore, questa brutta notizia al preside gliela dia lei. Richiami domani». Tutto avrei immaginato, tranne che sarei tornato su questo divertente equivoco ventitré anni dopo, per presentare a Valencia Sfidando L’Ignoto, diario narrato della ricerca condotta da Sandro e Salvatore Varzi e da me sul capolavoro di Antonello oggi nel Museo Mandralisca di Cefalù, celebrato da Consolo ne Il Sorriso dell’Ignoto marinaio. Corredato di note finali rigorose, Sfidando L’Ignoto è un saggio di ‘filologia leggera’, nel senso che non cede di una sillaba all’invenzione e agevola la condivisione di un percorso in cui non mancano fasi di incertezza e di suspense. Consolo, messo sulla pista del marinaio da Lucio Piccolo,3 precisò poi che non aveva mai creduto a quella diceria. Lo rivelò rievocando l’incontro con Roberto Longhi a Milano nel ’69, quando chiese notizie al noto critico d’arte sul primo capitolo del Sorriso che gli aveva inviato qualche tempo prima. Longhi gli rispose bruscamente: «Sì sì, ho letto
2 La villa-fortezza apparteneva a don Giuseppe Branciforti, conte di Mazzarino, capo di una congiura contro Filippo IV di Spagna, scoperta e sventata per tempo. L’iscrizione è del 1658. La quartina è abbinata a un emistichio di Torquato Tasso, O corte a dio. 3 Il sorriso dell’ignoto marinaio, d’ora in avanti SIM, Note e notizie sui testi, in OC, p. 1300. Secondo Consolo, il primo fotografo a riprodurre il quadro fu Domenico Anderson intorno al 1915 (OC, p. 1309). In realtà di trattò del fotografo palermitano Giovanni Fiorenza, autorizzato dalla Soprintendenza di Palermo il 22 giugno 1914, in vista della dichiarazione di rilevante interesse artistico e storico del ritratto, notificata l’11 febbraio 1916. Poiché non vi è traccia della riproduzione presso gli archivi della Fondazione Mandralisca, si suppone che la lastra venne acquistata nel 1930 da Domenico Anderson. Cfr. Sfidando l’Ignoto, Palermo, Ed. Torri del Vento, 2017
(d’ora in avanti SI), pp. 87-88, n. 28.
le sue pagine, ma questa storia del marinaio deve finire».4 Abbiamo inserito questa frase in quarta di copertina, consapevoli che la diceria sarà dura a morire. Il fatto nuovo è che ne abbiamo dimostrato l’infondatezza, partendo da un sigillo mai notato prima, apposto nel Settecento sul retro della tavoletta da un prozio del barone Mandralisca, l’arcidiacono Giuseppe Pirajno, all’epoca vescovo vicario di Cefalù. A
nostro parere, anche in assenza di fonti scritte, questo sigillo e varie altre evidenze iconografiche bastano a identificare il personaggio raffigurato nella tavoletta, misterioso come tutti gli ‘Ignoti’ di Antonello. Tuttavia, è bene che il gap tra Mistero e Ignoto persista: lo svelamento toutcourt toglierebbe al ritratto parte del fascino di cui lo stesso Consolo partecipa.5 Cesare Segre ha osservato che l’Antonello del Mandralisca è divenuto «una specie di doppio di Vincenzo Consolo».6 In ogni caso,
non c’è ricerca in grado di andare oltre quel sorriso-lumaca, «fiore
di ragione»,7 insondabile, condiviso dagli artisti in azione –pittore e
narratore– e dal modello in posa. A nostro parere si tratta di Francesco Vitale da Noja presso Bari, oggi Noicattaro. Dottore alla Sorbona in Teologia e Arti, precettore, segretario e ambasciatore di Ferdinando il Cattolico, valoroso umanista e profondo esperto di Duns Scoto, fu designato vescovo di Cefalù nel 1484, quando tra i diplomatici di Ferdinando e Isabella gli ‘aragonesi’ furono rimpiazzati dai ‘castigliani’. Si fece ritrarre su xilografie e medaglie. In Sicilia sostenne gli interessi della casa d’Aragona. Colto da ictus a Valencia nel 1491, dopo un soggiorno a Siviglia, rientrò a Cefalù
4 SI, p. 7, n. 1 con rinvii a Fuga dall’Etna e a MESSINA, N., “Per una storia di «Il sorriso dell’ignoto marinaio» di Vincenzo Consolo”, «Quaderns d’Italià», 10 (2005), pp. 113-126. 5 SI, pp. 75-76. Consolo non dubitò mai della provenienza ‘precaria’ del ritratto, da lui associato al cratere siceliota con la scena della vendita del tonno, acquistato dal barone a Lipari (La Pesca del Tonno, in DQF, OC, p. 1007). 6 SEGRE, C., “Un profilo di Vincenzo Consolo”, in OC, p. XVI. 7 Così in L’Olivo e l’olivastro (in OC, p. 853) Consolo definisce il sorriso dell’Ignoto, rivolto alla «grande storia di Palermo».
e vi mori in data incerta, comunque anteriore al 14 febbraio 1494.8 Quando il prozio del Mandralisca la fece propria, la tavoletta era molto malridotta. Forse non si sapeva più chi raffigurasse. Consolo si dimostra certo della provenienza liparitana del ritratto. Imposta la narrazione sulla «planimetria metaforica» Lipari-Cefalù- Messina,9 ma sa di non avere a che fare con un marinaio. Lo confermano due sue descrizioni, stilisticamente lontane ma convergenti. Nella prima si accenna alla reazione del barone, che stringe sotto un’ascella la tavoletta avvolta in una tela cerata, a bordo di un veliero stipato di gente e di mercanzie. Consolo descrive il ritratto con gli occhi del barone che scruta il misterioso Giovanni Interdonato, dopo i colpi di tosse che scuotono un vecchio cavatore di pomice:
[…] Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza
8 Vitale, semiparalizzato, il 10 marzo 1492 fece apporre una chiosa da altri sull’ultimo foglio di un incunabolo stampato a Venezia nel 1481, aggiungendo a margine un tremolante manu propria (SI, pp. 50-53). Il 12 febbraio 1494 Ferdinando il Cattolico scrisse di avere appena appreso della morte di Vitale (SI, p. 53, n. 53). Il documento è trascritto da Óscar Perea Rodríguez nella sua tesi di dottorato: «[…] en esta hora es venida aquí nueua que es fallecido maestre Francisco de Noya, obispo de Cefalú; y comoquier que no se sabe muy certificadamente si ello es assí, cordamos de vos preuenir de nuestra voluntat sobre la prouisión del dicho obispado […]» [Las cortes literarias hispánicas delsiglo XV: el entorno histórico del Cancionero general de Hernando del Castillo (1511). Universidad Complutense de Madrid, a.a. 2003-2004, p. 194 n. 587]. Da un documento della Curia cefaludense risulta che la sede di Cefalù fu dichiarata vacante nel febbraio del 1495. 9 Cefalù e l’Ignoto di Antonello sono uno dei vertici del triangolo metaforico. I cavatori di pomice liparitani e i rivoltosi di Alcàra Li Fusi occupano gli altri due. e vi mori in data incerta, comunque anteriore al 14 febbraio 1494.8 Quando il prozio del Mandralisca la fece propria, la tavoletta era molto malridotta. Forse non si sapeva più chi raffigurasse. Consolo si dimostra certo della provenienza liparitana del ritratto. Imposta la narrazione sulla «planimetria metaforica» Lipari-Cefalù- Messina,9 ma sa di non avere a che fare con un marinaio. Lo confermano due sue descrizioni, stilisticamente lontane ma convergenti.
Nella prima si accenna alla reazione del barone, che stringe sotto un’ascella la tavoletta avvolta in una tela cerata, a bordo di un veliero stipato di gente e di mercanzie. Consolo descrive il ritratto con gli occhi del barone che scruta il misterioso Giovanni Interdonato, dopo i colpi di tosse che scuotono un vecchio cavatore di pomice:
[…] Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza
8Vitale, semiparalizzato, il 10 marzo 1492 fece apporre una chiosa da altri sull’ultimo
foglio di un incunabolo stampato a Venezia nel 1481, aggiungendo a margine un tremolante manu propria (SI, pp. 50-53). Il 12 febbraio 1494 Ferdinando il Cattolico
scrisse di avere appena appreso della morte di Vitale (SI, p. 53, n. 53). Il documento
è trascritto da Óscar Perea Rodríguez nella sua tesi di dottorato: «[…] en esta hora
es venida aquí nueua que es fallecido maestre Francisco de Noya, obispo de Cefalú;
y comoquier que no se sabe muy certificadamente si ello es assí, acordamos de vos
preuenir de nuestra voluntat sobre la prouisión del dicho obispado […]» [Las cortes
literarias hispánicas delsiglo XV: el entorno histórico del Cancionero general de Hernando del Castillo (1511). Universidad Complutense de Madrid, a.a. 2003-2004, p. 194 n.587]. Da un documento della Curia cefaludense risulta che la sede di Cefalù fu
dichiarata vacante nel febbraio del 1495. 9 Cefalù e l’Ignoto di Antonello sono uno dei vertici del triangolo metaforico. I cavatori di pomice liparitani e i rivoltosi di Alcàra Li Fusi occupano gli altri due. dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vivuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e alle vicende loro. E, avvertivasi in colui, la grande dignità di un signore […].10
In questa oscillazione tra conoscenza e pietà, Consolo coglie da rabdomante il profilo di un conciliatore di storia e spiritualità, umanesimo e missioni diplomatico-ecclesiastiche. Vitale visse in mezzo agli uomini e alle vicende loro, ancor più di Interdonato, riconosciuto da Mandralisca nell’Ignoto del ritratto, mentre di notte, nel suo studio, si concentra sulla tavoletta appesa a una parete tra gli scaffali. Un’agnizione-insight degna di un romanzo di Dumas. Per quanto ci risulta, tuttavia, il barone non era certo, o ignorava di possedere un Antonello prima che nel gennaio del 1860 Giovan Battista Cavalcaselle, in casa sua, ne ricavasse un geniale bozzetto. Cavalcaselle, garibaldino mazziniano esule a Londra dopo il 1849, critico d’arte e pittore, giunto in Sicilia per ragioni di studio qualche mese prima di Garibaldi, forse con una missione coperta, è una specie di doppio attenuato del democratico Interdonato. Nella seconda descrizione, a tratti impressionistica, risuonano il lessico e i luoghi comuni dei frequentatori di pinacoteche. Ha per sfondo una festa organizzata dal barone in casa sua per presentare il ritratto ad amici e conoscenti. Quando Enrico sfila il panno dal leggìo su cui ha collocato la tavoletta, l’Ignoto si svela e il Mistero, volendo rubare il titolo a un romanzo di Marco Malvaldi, si accentua «negli occhi di chi guarda»:
[…] Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal busto e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta,
10 SIM, in OC, pp. 129-130.
le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini. Il personaggio fissava tutti negli occhi, in qualsiasi parte essi si trovavano, con
i suoi occhi piccoli e puntuti, sorrideva a ognuno di loro, ironicamente, e ognuno si sentì come a disagio […].11
Come nel cambio di scena di un’opera lirica, questa seconda
descrizione è interrotta da colpi di schioppo e abbaiar di cani in
lontananza, equivalenti ai colpi di tosse del cavatore a bordo del veliero.
Dal suo leggìo, l’Ignoto sembra allargare il sorriso in un ghigno. In un
angolo del salone, il cefalutano Salvatore Spinuzza, pressoché ignorato
dagli altri invitati perché ‘facinoroso’ come Giovanni Interdonato,
rabbrividisce.
Di qua dal faro, pubblicato nel ’99, contiene il testo della conferenza
salmantina del ’95, affidato quattro anni prima ai «Quaderni del Liceo
Italiano». Tra gli altri ‘pezzi’, contiene anche un bilancio d’autore sul
Sorriso vent’anni dopo, definito come metafora del superamento dei
«romanzi d’intreccio dispiegati e dominati dall’autore», come approdo
alla pari dignità dialettica dei linguaggi, «compresi quelli marginali».12
Consolo è entrato da anni in una fase nuova. Coglie nel segno Joseph
Francese quando afferma che gli attentati mafiosi dei giudici Falcone e
Borsellino, mesi in atto nel ’92 per conto di raffinati mandanti, segnano
il passaggio definitivo di Consolo dall’aventino sciasciano all’impegno
politico scoperto.13 E quanto al «parricidio» da lui perpetrato, ingrato
e miope è il giudizio di chi lo ha definito «un infelice che voleva essere
11 Ivi, pp. 143-144.
12 CONSOLO, V., “Il «Sorriso» vent’anni dopo”, in DQF, OC, p. 1254.
13 FRANCESE, J., Vincenzo Consolo. Gli anni de «L’Unità» (1992-2012), ovvero la
poetica della colpa-espiazione, Firenze, University Press, 2015.
Sciascia».14 Se Sciascia fu un superbo autore di romanzi e saggista, Consolo fu un artista, un linguista, un «orafo della parola». A tanta distanza da quell’equivoco sulla esperanza perdida, che allarmò la simpatica custode del Liceo Italiano, verrebbe da dire che nulla accade per caso. C’è ancora speranza. Il dibattito in ambito letterario e non solo, che in quei giorni Consolo giudicava «quasi spento»,15 è in agonia, ma il decesso del romanzo non è sopravvenuto. A rantolare, semmai, sono i lettori. Da rappresentazione del reale e dell’esistenziale, da intreccio di storie più o meno rilevanti o defilate, la letteratura di oggi si apre allo svelamento di crimini sommersi (per esempio, in Resto qui, di Marco Balzano, che nel 2015 ha vinto il Campiello con la storia di un giovane del Sud immigrato a Milano). In Italia, in Spagna, in Europa,
la narrativa si è aperta all’epica delle culture migranti e alle voci critiche dai paesi ‘banditi’, quelli che il presidente USA in carica ha definito latrine. Scrittori-migranti e migranti-scrittori,16 protagonisti dell’epica dell’andare e venire viaggiando, narrano storie di emarginazione nelle lingue dell’Unione. Sicché la partita non è persa del tutto. Tra guerre e violenze endemiche, speculazione spietata, politici e amministratori corrotti, vincere l’impotenza si può, sorridere da lumache si può, con
o senza il supporto dell’ideologia, ma senza rinunciare alla speranza e senza bandire l’immaginazione creativa. La speranza, se cade, trova sempre il modo di rialzarsi. Diversamente dal sorriso, non è mai stata quel che si dice una metafora, neppure in letteratura.
14 CARUSO, C., “Vincenzo Consolo: «Un infelice che voleva essere Sciascia». Il ricordo del fotografo Fernando Scianna amico di Vincenzo Consolo, che Mondadori pubblica nella Collana «I Meridiani»”, «Panorama», 9 febbraio 2015. 15 In I ritorni (in DQF, OC, p. 1121) Consolo scrive: «Crediamo che oggi, per la caduta di relazione tra la scrittura letteraria e la relazione sociale, non si possono che adottare, per esorcizzare il silenzio, i moduli stilistici della poesia; ridurre, per rimanere nello spazio letterario, lo spazio comunicativo, logico e dialogico proprio del romanzo». 16 La distinzione è del brasiliano Julio Monteiro Martins, scomparso a Lucca nel 2014.