Rosalba Galvagno
Per quanto le pagine di Vincenzo Consolo siano disseminate di figure femminili, per alcune di esse non è facile delinearne i contorni o il profilo secondo i moduli tradizionali del ritratto o del personaggio a tutto tondo, anche perché spesso tali figure sono metaforizzazioni di oggetti naturali o culturali. La Sicilia ad esempio (e con essa il Mediterraneo tutto), nella sua complessità di «esistenza» e di «storia», di bellezza e di orrore, di attrazione e di repulsione, di natura e di cultura, di storia e di arte, di guerra e di pace, di mafia e di eroi, è sicuramente l’oggetto femminile più emblematico della scrittura di Consolo. Tutti gli altri non sono che degli avatars, dai più
orridi ai più teneri, di questo oggetto fondamentale che egli ha inseguito durante tutto il suo percorso di uomo e di artista, approssimandosi forse di più ad esso e perfino attingendolo (immaginariamente, s’intende) nei resti archeologici, nelle pietre antiche. I personaggi femminili consoliani consistono sovente in semplici nomi di figure mitologiche o di sante, in mere elencazioni caotiche di questi nomi, che si configurano come delle vere e proprie antonomasie. Nomi di divinità o ninfe mitologiche
talvolta accompagnati da un predicato (Afrodite, Artemide, Aretusa, Ciane, Demetra, Persefone, Hera, Athena, Venere celeste, Diana delle cacce, Cerere
delle messi siciliane, Malophòros, Ecate, Medusa, Core, Sfinge, Europa, Scilla, Antigone, Circe, Sirene ecc.); di sante o comunque di figure cristiane (Giovanna d’Arco, Santa Rosalia, Santa Lucia, la Madre, Annunziate, Maddalene, sante Caterine, Immacolate, sante Ninfe o Susanne ecc.).
Ora, queste semplici citazioni onomastiche non sono certo delle eccedenze barocche, dei meri ornamenti retorici, ma sono appunto delle antonomasie
che vanno lette come autentici significanti, cioè nomi. 1 Tutti i romanzi di Consolo sono citati da questa edizione. attraverso i quali il testo veicola ed evoca una pluralità, spesso contraddittoria, del femminile, come accade ad esempio col termine Malophòros al quale è accostato, tra gli altri, il termine mele (miele), che ricorre in altre due pagine dello stesso capitoletto (In Egesta degli Elìmi) del romanzo Retablo, in particolare nel contesto fortemente erotizzato della Confessione di Rosalia Granata: «come fa l’apa sopra la corolla dove al fine s’insinua e suscita il suo mele»1. Questo significante della dolcezza, specie quella erotica e materna, si riverbera anche nel capitoletto successivo (In Selinunte greca), nella mirabile descrizione della dea Malophòros, descrizione generata di fatto dalla prima parte del nome della dea: «e il tempio sacro in fondo e segretissimo in cui nel recesso più interno e proibito era Lei, la Molle, l’Umida, la dèa che porta la mela e che la dona, l’inconoscibile, insondabile padrona» (p. 437), dove a «Molle» si affianca qui il termine «mela», l’attributo proprio della dea, che designa il frutto e connota al contempo la fertilità. Accanto a questi nomi propri femminili appartenenti alla nostra tradizione mitologica e cristiana, incontriamo anche dei nomi comuni di parentela come madre, moglie, sorella, figlia, signora, fidanzata, i nomi cioè dei legami familiari più intimi spesso dolorosamente drammatici, come ad esempio il termine «sorella» riferito all’anonima fanciulla portata in corteo funebre sempre nel capitoletto intitolato In Selinunte greca del romanzo Retablo. O le sorelle di Petro Marano, Lucia e Serafina, intaccate anch’esse dal male catubbo (dalla melanconia) nel capitolo IV, La torre, del romanzo Nottetempo, casa per casa. D’altronde il capitolo VIII, la cui epigrafe è una citazione tratta dalla Nedda di Verga2, si intitola significativamente Le donne, mentre il capitolo X, Pasqua delle rose, introduce la tenera figura di Grazia la Piluchera, l’accogliente amante (prostituta?) di Petro (pag. 731 ss.). Da L’olivo e l’olivastro preme ricordare almeno la Lucia del Seppellimento di Santa Lucia del celebre dipinto di Michelangelo Merisi: Effigiò la santa come una luce che s’è spenta, una Lucia mutata in Euskìa, un puro corpo esanime di fanciulla trafitta o annegata, disposto a terra, riversa la testa, un braccio divergente […]. La luce su Lucia giunge da fuori il quadro, dalla pietà, dall’amore dei fedeli astanti, da quel corpo riverbera e si spande per la catacomba, a cerchi, a onde, parca come fiammella di cera dietro la pergamena. (pp. 828-829) E la stessa madre dello scrittore, toccante e indimenticabile «vecchia Euridice»:
La guardava, ne studiava la faccia, la pelle
sottile e bianca, le venuzze azzurre, il neo sulla
tempia, i capelli fini e lisci fermati dietro con la
crocchia, la bocca a grinze, le orecchie trasparenti,
i buchi allungati dei lobi da cui pendevano gli
orecchini. Ma presto provava imbarazzo, disto-
glieva lo sguardo, gli sembrava di violare l’intimità
indifesa di quella donna ch’era sempre stata
candida, innocente, il suo privato e lento allontanarsi.
[…]
Cosa credeva? Che quella donna, sua madre, fosse rimasta sempre lì, uguale, come il giardino, le barche, le isole, con il ricordo di lui sempre acceso? Il dolore per gli altri figli andati, scomparsi? Aveva mollato pure lei (ma come, quando?) e s’era messa a camminare per la sua strada. Voleva annullare quel tempo, ritornare, lui, al punto della partenza, far tornare lei, vecchia Euridice, di là dall’ombra dell’oblio? (pp. 848-849)
Accanto a queste due ultime figure (Santa Lucia e la madre) delle quali, a differenza delle precedenti antonomasie, lo scrittore ci consegna un ritratto rapido ed essenziale, sono anche presenti nei suoi testi delle metaforizzazioni del femminile, come quella, notissima, della «chiocciola» del Sorriso dell’ignoto marinaio (pp. 233-238), o in Retablo quella dell’«arancio » (p. 427) o del «corallo» (pp. 454 ss.) e persino del tempio: il tempio di Segesta all’occorrenza, nella cui descrizione insistono le «madri» e la gran «Madre» (p. 414). Ma, tra gli oggetti inanimati, o più precisamente cosmici, bisogna annoverare la luna disseminata ovunque nelle pagine consoliane, 20 al centro, segnatamente, della splendida favola teatrale
Lunaria. La luna come figura per eccellenza del femminile («Deh madre, sorella, sposa, guida della notte, méntore, virgilia, dimmi, parlami, insegnami la via») 3 ha una lunga tradizione nella nostra letteratura,
basti qui citare l’esempio massimo del Canto di un pastore errante dell’Asia, e anche delle altre numerose lune di Leopardi, come quella dell’Odi Melisso e del Tramonto della luna letteralmente evocate
in Lunaria. Dopo questa rapida rassegna di figure femminili,
vorrei soffermarmi sul capolavoro di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, che si apre su una interessante figura di donna, Catena Carnevale, un personaggio dal nome altamente simbolico, per
quanto lo scrittore si sia ispirato a una donna reale di Lipari di nome Maria Maggiore. Se il nome proprio Catena rinvia immediatamente
alla scrittura, alla catena significante, il cognome Carnevale non può non evocare una straordinaria eroina popolare immortalata da Carlo Levi in Le parole sono pietre: Francesca Serio madre di Salvatore Carnevale, una donna che non aveva paura di pronunciare, per ottenere giustizia per il sacrificio del figlio ucciso dalla mafia, «parole di pietra»4. Il ritratto di Catena viene presentato dapprima nell’Antefatto del primo capitolo del Sorriso dell’ignoto marinaio, e quindi ripreso e arricchito di ulteriori
tratti, nel secondo capitolo intitolato L’albero delle quattro arance. Di Catena sappiamo che è bella e irraggiungibile, la sua bellezza però non s’incarna in un corpo reale di donna, piuttosto in una sorta di raggio luminoso che al tempo stesso la vela e la svela «al rapido saettar d’occhi traversi […] dei giovani che passano e ripassano per la strada di San Bartolomeo » (p. 127)5. Ricama e sa decifrare la scrittura barocca delle ricette, sicché torna utile al padre speziale in Lipari. È «un’intellettuale»6, nervosa, irritabile, meteoropatica, un mistero quanto all’amore. A tal punto furiosa, da infierire sul ritratto dell’Ignoto perché somigliante al suo fidanzato lontano, con 3 Lunaria, p. 315 4 Cfr. C. Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, Torino, 1955, pp. 138-152. Consolo ha dedicato allo scrittore torinese un denso saggio raccolto nella settima e ultima sezione di Di qua dal faro (Milano, Mondadori, 1999, pp. 251-257) intitolata significativamente Le parole sono pietre. 5 Vincenzo Consolo ha svelato, nel corso di un Convegno a lui dedicato e tenutosi a Capo d’Orlando nell’ottobre del 2006, che l’immagine alla quale questa descrizione di Catena rinvia è quella di una Annunciazione. 6 V. Consolo, Fuga dall’Etna, Donzelli Editore, Roma, 1993, p. 43. 7 Ivi, p. 46. 8 «il povero esclama / al fondo di tanto abisso / terra pane / l’origine è là / la fame senza fine / di libertà» (pp. 250-251). quel sorriso che l’affascina tanto quanto la perseguita, un sorriso inafferrabile che potrà incatenare, lei già incatenata da quel sorriso, solo sfregiandolo
col punteruolo d’agave da ricamo, solo lasciandovi sopra, tale un’erinni, il segno della sua passione assoluta (p. 127). Vorrei ancora, prima di passare a Rosalia, forse la figura princeps della ricca galleria di figure femminili
consoliane, soffermarmi sull’ultimo capitolo (IX) del Sorriso dell’ignoto marinaio, che contiene le famose scritte graffite sui muri del carcere dai rinchiusi colpevoli dell’eccidio di Alcara Li Fusi. Paradossalmente e perfino scandalosamente, questo carcere a forma di chiocciola rappresenta
forse il luogo per eccellenza del ‘femminile’, della scrittura autentica, corale e acefala, «indipendente da un corpo o da una mente» (p. 222), una scrittura capace di tradurre in linguaggio il trauma originario del Soggetto e della Storia. Un trauma che, nel punto finale della riscrittura storico-metaforica degli eventi riportati nel romanzo, si mostra quasi allo stato
puro senza i «colori dell’affresco»7, graffito di carbone e messaggio poetico per chi può leggerlo e intenderlo. L’ultima strofe dell’ultima scritta sul muro è infatti in lingua sanfratellana, incomprensibile per lo stesso Mandralisca e per noi lettori:
U pauvr sclama
Suogn ‘nta u mar
Au Faun di tant abiss
Terra pan
L’originau è daa
La fam sanza fin
Di
Libirtaa 8
Di questa strofe in sanfratellano la prima edizione del romanzo non forniva alcuna traduzione. Ora, proprio gli ultimi cinque, poeticissimi versi rinviano ad una parola mancante (propriamente la parola muta del desiderio), una parola fondamentale perché generatrice dell’intero canto. Si tratta della parola ‘lontananza’ intesa come separazione dall’oggetto
d’amore, vera e propria parola ombelicale che si iscrive nell’ordine silenzioso della lettera, e che coincide con quello che Freud nell’Interpretazione dei sogni chiama ‘ombelico del sogno, kern-punkt, punto opaco e non più decifrabile del desiderio del sogno, ma anche punto di generazione plurima e sovradeterminata della scrittura del sogno. Ma c’è di più. Soggetto di questa ‘lontananza’ è una fanciulla, una figura femminile dunque. È stato possibile risalire a questa parola ombelicale grazie all’eccellente studio di Salvatore Trovato sulla presenza del sanfratellano nel Sorriso. Lo studioso afferma che il verso:
au faun di tant abiss, rigo 28 della scritta, è ripreso dall’ottava num. 19 (dal titolo La lontananza) della raccolta di Luigi Vasi (p. 286), un’ottava d’amore che tratta appunto il tema della lontananza (Suogn ‘nta u mar au faun di tant abiss ‘sono nel mare al fondo di tanto abisso’ piange la fanciulla per la lontananza dell’amato nell’ottava popolare) da cui Consolo sa trarre elementi per la costruzione di un testo che tratta il tema della rabbia sociale, dell’odio di classe e del desiderio di vendetta9. D’altronde l’intera strofe è costruita con versi presi da varie altre ottave del Vasi e abilmente intrecciati dallo Scripteur, al fine di trasmettere un messaggio innanzi tutto etico-sociale, rivoluzionario, rivendicativo. Ma, mi permetto di postillare, questo messaggio è strutturato poeticamente e per di più in una lingua ‘altra’. Inoltre la voce che emana dal fondo dell’abisso, frammento di corpo staccato dal soggetto che la enuncia, è quella di una fanciulla innamorata e separata dal suo amato, la stessa voce profonda, anonima ed enigmatica che modula il canto della strage, del trauma, della separazione, della lontananza.
E passiamo infine alla figura di Rosalia nel romanzo Retablo, un romanzo diviso, com’è noto, in tre parti: due portelli laterali Oratorio e Veritas, e
un portello centrale, Peregrinazione. Esso narra il 9 S. Trovato, Valori e funzioni del sanfratellano nel pastiche linguistico consoliano del «Sorriso dell’ignoto marinaio» e di «Lunaria», in Dialetto e letteratura a cura di Giuseppe Gulino ed Ermanno Scuderi, Pachino 1989 (Atti del 2° Convegno di studi sul dialetto siciliano – Pachino 28/30 aprile 1987), p. 135. 10 «Alzai gli occhi e vidi nel riquadro, ah, la mia sventura!, la donna che teneva la funicella del panaro e accanto una fanciulla di quindici o sedici anni, la
mantellina a lutto sulla testa che lei fermava con graziosa mano sotto il mento. E gli occhi tenea bassi per vergogna, ma da sotto il velario delle ciglia fuggivan lampi d’un fuoco di smeraldo. Mai m’ero immaginato, mai avevo visto in vita mia, in carne o pittato, un angelo, un serafino come lei» (p. 371). viaggio e le peripezie dell’artista milanese Fabrizio Clerici e della sua guida Isidoro, un monaco del convento della Gancia, nella Sicilia del XVIII secolo (1760-1761 circa). Fin dal celebre prologo di Retablo da me chiamato Inno a Rosalia, la figura femminile non si riduce a una mera rappresentazione realistica. Essa soggiace piuttosto a delle figurazioni metamorfiche, che vanno dal ritratto a tutto tondo della protagonista
Rosalia all’«ottuso vortice» (p. 422) del corpo del godimento. Non a caso Rosalia è esattamente definita in due luoghi, e fuori da ogni figurazione possibile, come «la causa di tutto, il motore primo» (p. 372) secondo le parole di Isidoro, e «il motore primo del miracolo» (p. 420) secondo le parole dell’altra Rosalia, perché di «Rosalia» ce ne sono almeno
due in Retablo. Il romanzo non farà che dispiegare dall’inizio alla
fine ciò che il prologo annuncia: la perdita e quindi la quête di Rosalia, cioè dell’oggetto del desiderio e dei suoi avatars, che si incarna nelle figure di Rosalia Guarnaccia, l’amata di Isidoro; Teresa Blasco, l’amata di Fabrizio Clerici; alle quali bisogna aggiungere Rosalia Granata, la donna sedotta da Frate Giacinto da Salemi e salvata da Vito Sammataro, un frate costretto a farsi brigante. O, infine, «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore» (p. 423). Accanto a queste vi sono altre importantissime figure femminili come quelle mitologiche e religiose
già citate all’inizio di questo saggio o altre figure minori come Luzìa o Lucia Barraja (p. 467), che fa parte anch’essa della galleria delle Rosalie.
E se si volesse delineare un ritratto fisico, esteriore (secondo la terminologia dei teorici del Rinascimento italiano) di Rosalia10, è vero che esso consiste soltanto di alcuni tratti quali l’età (ha 15-16 anni),
lo sguardo acceso da lampi d’un fuoco di smeraldo, i capelli colore del rame, i denti di cagnola, mentre il suo ritratto interiore è fissato dall’ossimoro angelo/ diavolo, permanendo inestricabili i tratti angelici e
diabolici. È anche fresca, odorosa, bella di sette bellezze ecc., ma soprattutto ha un bel nome, infatti l’inno inaugurale del romanzo è una variazione attorno 22 al nome di Rosalia. Isidoro, d’altronde, risponderà a
Fabrizio Clerici che Rosalia «È solamente il nome» (p. 386).
Ciò che sembra emergere dall’analisi testuale dell’Inno a Rosalia11 è la scrittura dello slancio di un desiderio verso un oggetto femminile forse del tutto inedito nella tradizione letteraria italiana ed europea. Alle due donne – Venere celeste e Venere terrestre – celebrate da questa tradizione si sostituisce in Retablo una sola donna dalle molte sfaccettature, che è al contempo idealizzata e concupita (sogno o incubo di ciascun uomo forse). Ciò che il lavoro dello stile, della prosodia specialmente, rivela grazie
all’accordo stabilito da un certo ritmo tra elementi verbali appartenenti a ordini linguistici differenti e perfino opposti, è l’ibridazione di queste due figure di donna, ottenuta attraverso la coalescenza della corrente tenera e della corrente sensuale dell’amore, che fa sì che i tratti ideali e i tratti erotici di questo oggetto femminile divengono interscambiabili.
Le figurazioni del corpo di Rosalia vanno dunque dal ritratto della giovane adolescente paragonata per la sua bellezza al corpo della statua di Santa Ro- 11 Per questa analisi dettagliata cfr. Rosalba Galvagno, «Hymne à Rosalia» dans «Le Retable» de Vincenzo Consolo, in «Revue des Études italiennes», dirigée par François Livi et Claudette Perrus, Varia, Tome 63, n. 3-4/2017, pp. 41-53. salia, all’allegoria della Veritas scolpita dal Serpotta,
ad una panòplia di metonimie del corpo (sguardo, capelli, denti, ossa, reliquie, voce), alla ‘lettera’ e, per finire, al corpo del godimento difficilmente rappresentabile: si tratta piuttosto di una figura senza
figura del reale, ma al quale Consolo riesce addirittura a dar voce e nella cui specifica e originalissima articolazione si situa la scrittura dell’eros. La mise en abyme di questa scrittura si situa nel bel mezzo del romanzo, in quell’eccentrico capitoletto intitolato Confessione, voluto in corsivo da Consolo. Ora, la grandezza e l’importanza letteraria di questa Confessione
risiede proprio nella scrittura, difficilissima, dell’estasi mistica e al contempo arditamente sensuale del corpo di Rosalia ridotto qui a puro strumento del godimento, pura voce, pura onomatopea di una «gioia grande e senza nome»: «O bona, o bella, o santa creatura!» dissemi
con quella sua voce flautata stringendo forte nelle sue le mani mie.
«O padre, o padre, per me pietate, vi chiedo abènto!…» riuscii a sospirare, e venni meno. Mi ritrovai, al risveglio, riversa su un giaciglio
dentro un casalino ov’erano gli attrezzi per la selva,
la testa sul grembo del mio frate, che la mano,
ora con forza e ora lievemente, passava sul mio
petto, mentre il core affannoso mi battea come
del coniglio stanato dal furetto. E dal petto quindi
in giuso si moveva, fin su la nicchia ove natura
pose il nocciolo del caldo, il seme, il fomento d’ogni
brama, godimento, levitando, sfiorando tratteggiando,
come fa l’apa sopra la corolla dove al fine
s’insinua e suscita il suo mele, mentre che l’origlier
crescendo s’impetrava. O foco, foco! Foco che in
segreto ardi su la lampa, fiamma che bruci e non
consumi! Foco che avvampi il core, l’ossa, ardi il
midollo, ogni fibra dell’anima, del corpo! […].
Ah il furore, il delirio, l’ottuso vortice, la danza,
da cui sortiva sempre inappagata, sempre anelante
all’amor di lui, di lui che a poco a poco si negava,
di Lui che m’appariva irraggiungibile!
E prona pecora belava, guaiva cagna cana, hau
hau, lamentava, ma’, ma, tata cicia caca, ohu ohu,
nerva rova urìca, ahi ahiahi, mala mele fima… (pp.
416-422) 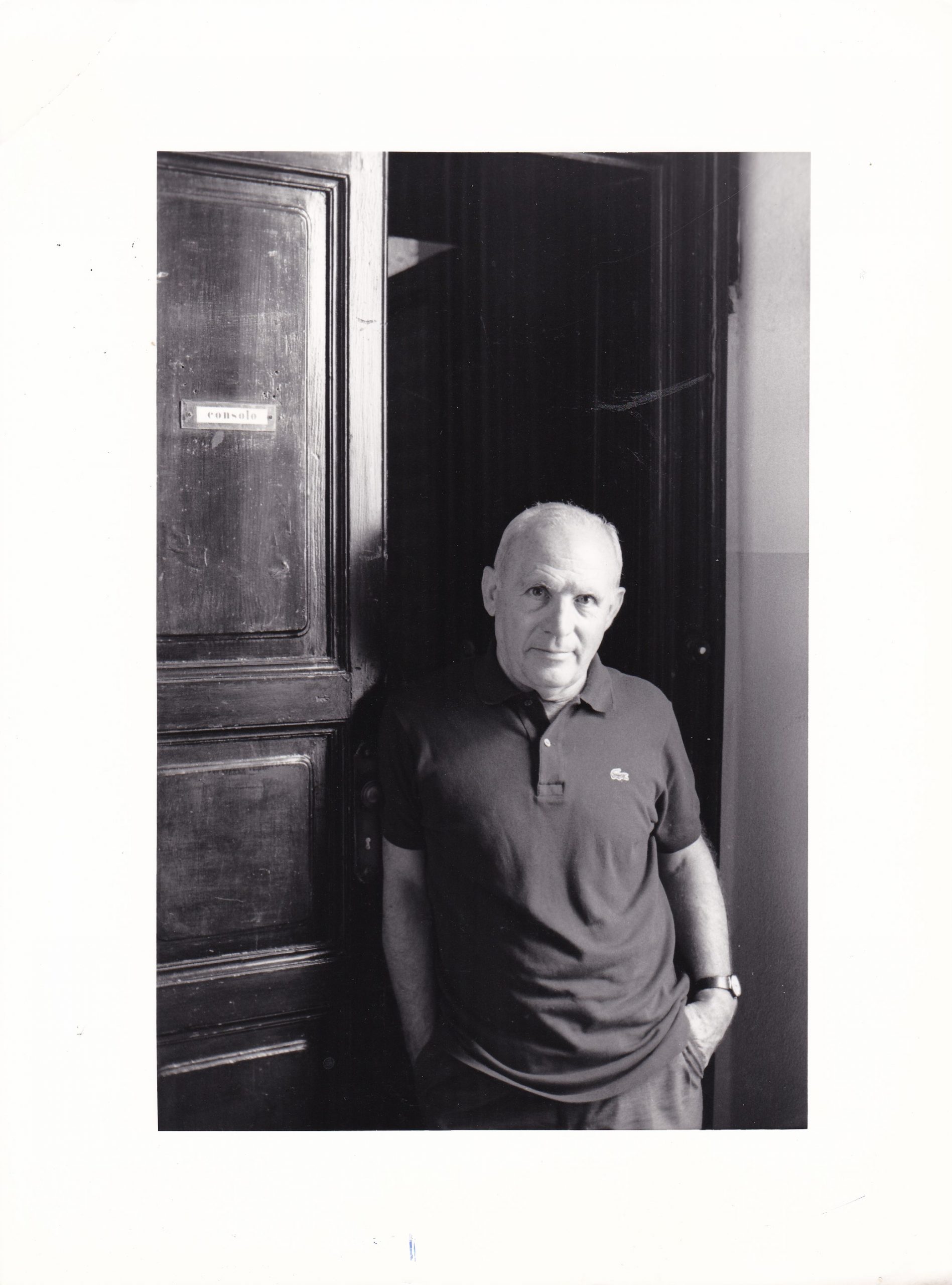
23
1 V. Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e con uno scritto di Cesare Segre, Mondadori («I Meridiani»), Milano, 2015, p. 418.
2«… faceva altri lavori più duri che da quelle parti stimavansi inferiori al compito dell’uomo» (p. 710). 
Tag: Lipari
Ricordi di Vincenzo Consolo
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
A 10 anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, FAAM ricorderà lo scrittore con “Reading – Ricordi di Vincenzo Consolo”, a cura di Paolo Di Stefano e Giovanni Turchetta, in collaborazione con Associazione Amici di Vincenzo Consolo.
Mercoledì 26 gennaio alle ore 18:30 al Laboratorio Formentini verrà data voce ai ricordi di chi ha conosciuto l’autore, con i testi di Maria Attanasio, Maria Rosa Cutrufelli, Nino De Vita, Paolo Di Paolo, Ernesto Ferrero, Corrado Stajano e Nadia Terranova.
***
MARIA ATTANASIO
«Prima viene la vita»
Una fotografia, senza pretese d’arte.
Puramente testimoniale di uno dei tanti momenti di condiviso vissuto: presentazioni, incontri, lunghi conversari di politica, letteratura, o degli eventi del giorno, di cui Vincenzo era attentissimo e severo giudice.
Nel retro della foto, una data: agosto 1993. Sullo sfondo di un’altura di pietre e sterpaglie, una casamatta con due lunghe fessure orizzontali, da cui nel luglio del 1943 i cannoni tedeschi cercavano di fermare lo sbarco alleato. In primo piano Vincenzo e Melo; io tra loro.
Di fronte a noi – sotteso all’immagine – il maldestro fotografo, Giovanni mio marito; e il profilo di Gela in lontananza, la meta privilegiata dell’itinerario di quel giorno per ritrovarne il passato e leggerne il presente. Ma del tutto smemorata -la città di ciminiere e vocianti periferie- del suo costitutivo già stato: le mastodontiche mura di Capo Soprano, i resti archeologici, il Museo.
A concludere la visita fu una lunga sosta sulla tomba di Eschilo, che dal margine ovest della città si affaccia sulla raffineria. Avvolta dai fumi di anidride solforosa e dai malodori di catrame e benzene, la tomba del Grande Tragico apparve allo scrittore come il simbolo “della perdita d’ogni memoria e senso, del gelo della mente e dell’afasia” di una condizione umana, degradata e analfabeta nel consumo mediaticodell’istante.
La fine di un’Atene civile “che nessuno può liberare dall’oltraggio”, scriverà nel lamento-invettiva che conclude la straniante e drammatica scrittura de L’olivo e l’olivastro; l’amaro nostos di un contemporaneo Ulisse che, ritornando nell’Itaca-Sicilia, si ritrova un’isola di kalashnikof e omologazione, di tritolo e globalizzazione, senza scampo devastata dai proci.
Un viaggio, durante il quale, per un breve tratto, gli sono stata compagna.
Tante volte era venuto -e verrà- a Caltagirone, da solo o insieme a Caterina Pilenga, sua moglie.
Caterina è rimasta a Milano, mi disse invece, quando nell’agosto del 1993 – durante la fase compositiva di quel libro – mi telefonò per annunciarmi che sarebbe arrivato con suo fratello Melo: voleva rivisitare Caltagirone e i paesi vicini. E io fargli da guida.
Nonostante Vincenzo già conoscesse la medioevale topografia araba del centro storico della mia città, tornò a interrogare chiese, conventi, scalinate, proletari carruggi e nobili palazzi; i luoghi per lui non essendo pura definizione di spazi, ma verticalità di tempi, storie, linguaggi, oscuramente vibranti dietro ogni casa, ogni muro, ogni piazza.
Più forte di ogni altra cosa fu però il malioso richiamo dell’antica civiltà del tornio e dell’argilla; nelle botteghe dei vasai, nella scintillante bellezza di forme e smalti dei loro manufatti, ritrovando l’essenza connotativa di ogni esistenza: fusione di vivo presente e remoto vissuto.
E da Caltagirone in tanti altri luoghi – non visibili nel testo ma esperienzialmente costitutivi di esso – tra cui un piccolo villaggio rurale distante una ventina di chilometri. Una laboriosa comunità contadina lo abita, in prevalenza proprietari di piccoli fondi, che coltivano la terra in economia, o l’aiuto di immigrati: tunisini e -in quegli anni di bombe umanitarie- anche albanesi. Non era ancora arrivata in Occidente l’ondata subsahariana e medio-orientale, che oggi invece ne è respinto ed errante nucleo.
Ritenendo che non ci fosse nulla di interessante per il suo libro in fieri, cercai di dissuaderlo. Inutilmente.
Andammo.
Vigneti, serre, ortaggi, uliveti, e dignitose case a un piano con i catoi a pianoterra aperti sulla strada, nel cui buioso dentro si intravedevano botti, attrezzi agricoli, gente indaffarata. Da uno di essi uscì un uomo -il padre di un mio alunno- che ci invitò ad entrare, offrendoci vino e frutta secca; insieme a lui, Amedeo, in realtà l’italianizzato nome di Ahmed, un tunisino di pochissime parole.
Seduti su cassette che facevano da improvvisate sedie, iniziò un’indolente conversazione su coltivazione e cicli produttivi di olio e vino, a cui Vincenzo, senza prosopopea di superiorità intellettuale, con vivo interesse partecipava: ascoltava, chiedeva, precisava, intervenendo con competenza su vigneti ad alberello o a spalliera, su frantoi a freddo o a caldo.
Durante la visita al Museo di Gela, mi aveva sbalordito la sua immediata individuazione di conii e figurazioni della ricchissima raccolta numismatica, ma mi lasciò senza parole il suo puntuale sapere di campagna e agricoltura; una sconfinata passione conoscitiva, senza soluzione di continuità tra esperienza di vita e scrittura, ne muoveva il passo e la parola, rispettosamente in ascolto di ogni fare umano, e del linguaggio di quel fare!
Ad un certo punto la conversazione sviò sulla scuola e sul figlio, che -disse il padre alludendo alle sue difficoltà scolastiche in latino e greco- andava male perché non aveva i p(i)ramenti (un termine dialettale per indicare l’invisibile basamento su cui poggia una casa, che altrimenti crolla) convenendo entrambi, Vincenzo e quell’uomo, sull’assoluta necessità dei p(i)ramenti, per costruire case e saperi.
E la scrittura, aggiunse durante il viaggio di ritorno, ripetendo, ilare e ammirato, quella parola: metafora e senso della sua ricerca espressiva.
Risalendo dal fondo del già scritto e del già vissuto, la metrica della memoria, in tutte le sue operesi fa infatti visionaria poesia in forma di narrazione; sovversiva scrittura della presenza per “dare ragione e nome” all’umano dolore; che ne è sempre presupposto ed essenza: “Prima viene la vita, – scrive in Retablo – quella umana, sacra, inoffendibile, e quindi ogni altro: filosofia, scienza, arte, poesia, bellezza.”
In ogni tempo, in ogni spazio. Qui, adesso.
Continuo perciò a chiedermi oggi -a distanza di dieci anni dalla sua morte- quale sarebbe la sua reazione di fronte alla realpolitik di un’Europa, che finanzia spudorati sovranismi, per difendere i confini e respingere i migranti in fuga da guerre, fame, dittature; lasciandoli morire nel gelo della rotta balcanica, o annegare nel tentativo di attraversare la Manica, o il Canale di Sicilia.
Solitamente calmo nell’interloquire, Vincenzo però si accendeva di sdegno, esplodeva davanti a un’ingiustizia sociale o all’indifferenza dell’obeso Occidente, concludendo furente: “No. Tutta quest’ingiustizia non può durare.!
Hasta la vista, Vincenzo, poeta e profeta!
***
MARIA ROSA CUTRUFELLI
«Mai contro l’uomo»
“Siracusa, il tempio di Apollo è allagato e le idrovore non possono intervenire. Potrebbero distruggere i reperti.”
Il 30 ottobre scorso, quando ho letto questa notizia sui giornali, ho immediatamente, inevitabilmente, pensato a Vincenzo e al dolore che ne avrebbe avuto. Di colpo, mi è tornato in mente il piccolo appartamento che aveva comprato a Ortigia. Piccolo, ma con un grande terrazzo che si allungava proprio sul tempio dorico e le sue pietre millenarie: una visione estraniante, che ti faceva precipitare in un punto misterioso del tempo, là dove la storia incontra il mito. Era questa visione, era quel terrazzo ad affascinare Vincenzo. Non gli importava che l’appartamento fosse scomodo, con molte scale e pochi servizi. O che l’intero edificio fosse fatiscente. Caterina, con il suo buonsenso nordico, se ne lamentava, ma lui non le dava ascolto. Li ricordo così: lei pragmatica, adorante e critica nella stessa misura, lui tutto preso dalla nostalgia per l’isola e dal “dovere di scrivere in difesa dell’uomo, mai contro l’uomo” (come disse in una bella intervista che gli fece Rosaria Guacci per il nostro bimestrale, Tuttestorie).
Molto uniti e solidali, Caterina e Vincenzo si compensavano a vicenda. Lei ribelle, ma con un forte senso pratico. Lui convinto che, per recuperare la speranza, bisognasse abbandonare il codice razionalistico, cioè la Francia, e andare verso la Spagna, verso la “dolce follia,
simbolica e metaforica” di Don Chisciotte. Lei intransigente, lui mite. Ma se qualcuno peccava d’indifferenza sociale, Vincenzo sapeva essere molto duro nei suoi confronti, ed era lei, la ribelle pragmatica, a sgridarlo quando si mostrava troppo rigido. Cosa che gli capitava abbastanza di frequente. Una volta l’ho visto nascondere le mani dietro la schiena per non ricambiare il saluto di un assessore, reo di non so più quale sopruso.
E Caterina, sottovoce: “Smettila di fare il Pierino dispettoso!” La prima volta che l’ho incontrato di persona, è stato a Torino, a un salone del libro. Avevo appena pubblicato un romanzo ambientato in Sicilia, a Gela, la città del petrolchimico, e Vincenzo volle conoscermi: tutto ciò che riguardava la Sicilia lo riguardava personalmente. Era un uomo schivo e io, da parte mia, ero intimidita dalla sua presenza: lui non poteva saperlo, ma lo consideravo il ‘mio’ maestro. Non solo per ammirazione verso la sua scrittura (questo non basta, a mio parere, per fare di qualcuno un ‘maestro’). Ciò che mi entusiasmava era la sua concezione della lingua, così innovativa, straordinariamente moderna. Mi piaceva il suo interesse per le voci ‘altre’, voci che possiedono ritmi e accenti diversi dai nostri, e che tuttavia si mescolano alle nostre voci producendo un effetto che lui chiamava ‘mistilinguismo’.
Era più che un interesse, a dire il vero: era una ricerca letteraria e, al tempo stesso, una presa di posizione etica e politica. Che si concretizzava in un sostegno particolare a certi libri e a certe scritture. Per esempio, quando al premio Vittorini arrivò “Madre piccola”, il primo romanzo di Cristina Ali Farah, scrittrice italiana di padre somalo, ricordo che disse a noi della giuria: “Ecco un caso di mistilinguismo.” Ecco un romanzo degno della sua e della nostra attenzione.
Vincenzo era sedotto dalla commistione delle lingue, da quel loro sovrapporsi che produce scritture nuove. Tanto più nuove in quanto arrivano da paesi dove scrivere non è mai un ‘atto neutro’, perché la lingua stessa – lingua d’importazione, lingua nemica – ha bisogno di essere re-inventata per poter diventare strumento di speranza.
Più volte Vincenzo Consolo ha rivendicato la sua scelta, il suo situarsi “in una linea sperimentalista in cui è forte l’implicazione del mistilinguismo”. Implicazione evidente, sosteneva, fin dal suo primo libro, “La ferita dell’aprile”. Era il respiro ampio, era lo sguardo che andava oltre, superando confini e barriere, a dare senso morale alla sua narrazione, a unire la ricerca formale all’impegno etico in letteratura. Un azzardo che mi lasciava senza fiato.
Per farla breve, Vincenzo Consolo era il ‘mio’ maestro e quel giorno, a Torino, ero paralizzata dalla timidezza. Non rammento cosa gli dissi, come risposi alle sue domande, ma non devo essergli dispiaciuta, considerando che da quel primo incontro è poi nata una lunga amicizia.
Fu lui a volermi nella giuria del premio Vittorini (di cui era presidente) e gliene sono ancora grata per molti e svariati motivi. Ma soprattutto perché mi ha permesso di scoprire cosa si prova a stare sopra un palco millenario. Infatti, in quegli anni ormai lontani, il premio si teneva al teatro greco di Siracusa e la giuria, per l’appunto, prendeva posto sul palcoscenico. Be’, vi assicuro che vedere il panorama da lì, dal cuore del teatro, poter guardare la cavea da quella prospettiva e risalire su con lo sguardo, su lungo i gradini a semicerchio, è un’emozione indimenticabile. Invidio gli attori che possono godere di quello spettacolo quando vogliono. Finita la cerimonia, spesso prendevamo la stessa macchina per recarci in visita alle rispettive famiglie. Io mi fermavo a Graniti, lui proseguiva per Sant’Agata di Militello. Durante il viaggio, Vincenzo mi parlava di sua sorella, che aveva cresciuto lui e tutti gli altri fratelli. Io gli parlavo di mia madre, fiorentina trapiantata in Sicilia.
Mi dava anche consigli, naturalmente. Non è questo che fanno i maestri? Così quando, nel 2010, gli comunicai che me ne andavo per un anno in Africa, in Senegal, si affrettò a dirmi: “Scrivi un diario!” Un suggerimento che ho seguito solo in parte, dato che provo un’avversione invincibile nei confronti dei diari (dei ‘miei’ diari, quelli degli altri mi piacciono, li leggo avidamente e guai se non ci fossero!). Però, con quell’esortazione di Vincenzo che mi girava sempre per la testa, quella volta ho cercato un compromesso. E dunque ho preso appunti (talmente brevi, purtroppo, che a rileggerli oggi non capisco più a cosa si riferiscono) e ho fatto foto e raccolto ritagli di giornale. Ma temo che Vincenzo non intendesse questo… Comunque, al mio ritorno, lo trovai già malato. La malattia non aveva spento la sua voglia di conoscere il mondo, era curioso come sempre e dunque gli parlai dell’Africa e del mio lungo soggiorno a Dakar, città ricca di cultura, di musica e di gioventù. In ogni caso, evitai accuratamente l’argomento ‘diari’.
D’altronde le nostre telefonate erano sempre più brevi e, per me, sempre più tormentose. Per fortuna c’era Caterina, che, con la solita efficienza, gli organizzava la vita e gli incontri con gli amici. Dopo, quando Vincenzo non ha più avuto bisogno del suo aiuto per vivere, Caterina si è dedicata ai suoi scritti. Riordinava le carte, cercava in ogni modo possibile di curare la sua memoria. Un giorno mi disse: “Non m’importa di morire, ma non posso farlo finché le sue cose non sono a posto”.
E così è stato.
***
NINO DE VITA
Questo racconto in versi dialettali di Nino De Vita (avete il testo in fotocopia con traduzione) richiede una breve premessa che lo stesso poeta di Marsala ci ha pregato di lettere:
Io e Vincenzo Consolo ci siamo incontrati per la prima volta in una stanza dell’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Non ricordo di preciso in quale anno, di sicuro eravamo in uno dei primissimi anni Settanta. Era estate. Lui si trovava in quei giorni in vacanza a Pantelleria, lì si era sentito male (aveva contratto l’epatite) ed era stato trasferito a Trapani. Una sua cara amica che lo accompagnava mi aveva, su consiglio di Consolo, telefonato per avvisarmi e così io raggiunsi quella mattina Vincenzo. C’era stato fino ad allora solo uno scambio epistolare fra di noi. È tutto dentro il mio racconto in versi: non c’è di inventato, come si suol dire, nemmeno una virgola. Da quel giorno (e fino a qualche mese prima della sua scomparsa) io e Vincenzo non ci siamo più lasciati.
Trasu nno strurimentu
(Entro nel mio tormento)
I.
S’attrova sutta ô Munti, nno ’na timpa
– ed è rranni – ’u spitali
ri Sant’Antoniu Abbati.
Ri finistruna Trapani si gori
stinnigghiata, ch’allonga,
trasi, turciuta, rintra
ô mari.
Summu p’i scali, summu, allarmatizzu
pi stu ncontru, stu fattu
chi ntravinni a Vicenzu
Consulu. E comu fu,
com’èni chi successi.
A pperi summu, allentu,
cu ’a vuci ri sta fìmmina
chi chiamannu, vogghiardi,
mi fici sapituri.
Ora è mezziornu.
’A luci,
nne strati, quasi, annorva.
’U ventu manca e cc’è
scarmazzu.
I. É sotto il monte, su un’altura/ – ed è grande – l’ospedale/ di Sant’Antonio Abate./ Dalle vetrate Trapani si ammira/ distesa, che si allunga,/ penetra, a falce, dentro/ il mare.// Salgo le scale, salgo, intimorito/ per questo incontro, questo fatto/ che è successo a Vincenzo/ Consolo. E come fu,/ com’è potuto accadere.// A piedi salgo, a lento,/ con la voce di questa donna/ che chiamando, di mattina presto,/ mi fece sapere.// Ora è mezzogiorno./ La luce,/ nelle strade, quasi, acceca./ Il vento manca, stagna/ la calura.
II
É nno lettu, curcatu,
c’u cozzu nno chiumazzu
aisatu nna spaddera.
“Vicè” cci ricu, appena
m’apprisentu, nna porta,
e ’u canusciu. “Vicè…”
“Ninuzzu” rici “Ninu…”
E subbitaniu, aisannu
’u vrazzu “Arresta ddocu,
accura, ’un ti ncustari”.
Avi ’a facci ggiannuffa, comu ’u bbiancu
ri l’occhi, comu ’i manu.
“Vicè” cci fazzu “e cch’èni: nni ncuntramu
e ’unn’i putemu rari
’a manu!”.
Nno lettu allattu cc’èsti,
misu mpizzu, un bbonentu
mmicchiutu, allignamatu,
ch’assisti: s’arricogghi
tuttu, ciatìa, lampia
’i vavareddi.
’A fìmmina, chi mi
chiamau, èsti a tuccari
a mmia, additta, ’a viu
pigghiata ri cileri.
“Sta zzàfara m’a portu ri Milanu”
va cuntannu Vicenzu. “M’a sintia
sbissata sta pirsuna
mia…
’U tempu ri pusari
peri a Pantiddiria,
nzèmmula a idda” e cci
rriri nnamentri ch’a
talia “e sugnu cca…”
Ora talia a mmia.
Mi rici, rrisulenti:
“Sì propriu propriu ntìficu
comu t’avia nnall’occhi”.
“A to’ fiura ammeci eu l’hâ vistu
nne libbra, nne ggiurnala,
Vicenzu”.
E trovu appoiu
cu ’a spadda nna facciola
ra porta.
“Stu malannu” mi batti, cu ’a ncasciata
“parsi una puvirenzia:
nn’aviamu a canùsciri ô rritornu
ri l’ìsula e accurzamu”.
’A fìmmina è nnirvusa,
s’assistema i capiddi,
tira un’arricialata.
Rrutuliu cu Vicenzu
ri niatri, ra Sicilia,
l’amici chi cci avemu,
ri Sciascia, chi ora â gghiri
a truvari…
’U vecchiu nni talia,
senti, tistia, pari
ri sti cosi ntrissatu,
sta comu ’un alluccutu.
Trasi un nfirmeri, posa
nna culunnetta ’un sacciu
soccu, un agghiummareddu.
Sarrani chi ci sunnu
bbadduzzi ri pigghiari.
E sgangusu, nnamentri
chi nnesci: “Chi facemu,
chi faciti, ah, ’un scuffamu?”.
“Penzu ch’è avura, Ninu,
ri jiritinni” mi rici
Vicenzu.
“Chi torni a Cutusìu?”
“ ’A Cutusìu. Poi vegnu
a truvàriri, arrè,
ddumani.
’A juta a Rracarmutu,
â Nuci, ddà, nni Sciascia,
’a straportu”.
“No” iddu rici “ ’un strapurtalla, vacci,
’un ddàriti pinzeri.
Ri Sant’Ágata agghica me’ niputi
Rrinu…Vacci, tu vacci,
va ttròvalu a Nanà.
E sai soccu ti rico: ti priparu
una littra e cci ’a porti”.
Nesci ra bbuzza, misa
ô capizzu, un mazzettu
ri fogghi, ’a pinna, mentri
ch’a fìmmina, pigghiànnumi p’un ùvitu,
mi tira nno passettu
e mi rici, appagnata:
“Talìami nna facci,
nnall’occhi: chi ti paru
ggiannuffa? M’a pigghiai,
sta zzàfara â pigghiai!”
’Un sacciu chi cci ’a ddiri…
“ Ti ricu ch’è accussia”
idda accorna. “ ’A pigghiai,
mi l’ammiscau”.
E trimannu
’a testa s’accummogghia
l’occhi.
’A luci, fora, a ppicu,
misi comu una negghia
nne casi e puru a mmari.
Si viri sulu ’u curmu
ri Favugnana e Lèvanzu.
Marèttimu ’un si viri…
Penzu a sti jorna mei,
a mmia, sta sulità
chi ci haiu, a cu è chi persi,
trasu nno strurimentu…
“Ninu” sentu Vincenzo
chi mi chiama. E arrisagghiu,
tornu nnarrè. “Cci ’a scrissi”
rici appena chi spuntu
“è pronta”.
M’avvicinu.
Mi poiu pi pigghiari
’a bbusta e s’arritira
’u vrazzu.
“ ’U sai chi staiu pinzannu?”
mi rici, cu ’a timenza
“sta littra a Sciascia tu
è megghiu ch’un cci ’a porti.
Mi scantu chi maniannula,
chi nni sacciu, a viatri, a tutti rui
v’ammisca”.
II. É nel letto, disteso,/ con la nuca sul cuscino/ poggiato alla testiera./ “Vicè” gli dico, appena/ mi affaccio sulla porta/ e lo riconosco. “Vicè…”/ “Ninuzzo” dice “Nino…” / E di colpo, alzando / il braccio “Resta lì,/ attento, non ti accostare”./ Ha la faccia giallastra, come il bianco/ degli occhi, come le mani./ “Vicè” gli faccio “ e ch’è: ci incontriamo/ e non possiamo darci/ la mano!”/ Nel letto accanto al suo c’è,/ in punta, sul bordo, seduto, un uomo/ vecchio, smagrito,/ che ci ascolta: si stringe/ nelle spalle, sospira, batte/ le palpebre./ La donna, che mi/ chiamò per avvisarmi, è accanto/ a me, all’impiedi, la vedo/ turbata./ “Quest’epatite me la porto da Milano”/ racconta Vincenzo. “La sentivo/ spossata questa persona/ mia…/ Il tempo di posare/ piede a Pantelleria,/ assieme a lei” e le/ sorride intanto che la/ guarda “e sono qua…”/ Ora guarda me./ Mi dice, sorridente:/ “Sei proprio proprio come / ti immaginavo”./ “Il tuo volto invece io l’ho visto/ nei libri, sui giornali,/ Vincenzo”./ E trovo appoggio/ con la spalla allo stipite/ della porta./ “Questo malanno”/ ribatte, ironico/ “ è parso una provvidenza:/ dovevamo conoscerci al mio ritorno/ dall’isola e accorciammo”./ La donna è nervosa,/ si aggiusta i capelli,/ tira un sospiro lungo.// Parlo con Vincenzo/ di noi, della Sicilia,/ degli amici che abbiamo,/ di Sciascia, che devo andare/ a trovare…/ Il vecchio ci guarda,/ ascolta, fa sì con la testa, sembra/ di queste cose interessato,/ sta come un allocchito./ Entra un infermiere, poggia/ sul comodino non so/ cosa, un involto piccolo./ Forse ci sono dentro/ le pillole da prendere./ E canzonante, mentre/ che sta per uscire: “Che facciamo,/ cosa fate, ah, non smammiamo?”./ “Penso che è l’ora, Nino,/ di dovere andare” mi dice/ Vincenzo./ “Che torni a Cutusìo?”./ “A Cutusìo. Poi vengo/ a trovarti, di nuovo,/ domani./ L’andata a Racalmuto,/ alla Noce, da Sciascia,/ la sposto”./ “No” lui dice “non rinviarla, vacci,/ di me non preoccuparti./ Da Sant’Agata arriva mio nipote/ Rino… Vacci, tu vacci,/ vai a trovarlo a Leonardo./ E sai cosa ti dico: preparo/ una lettera e gliela porti”./ Esce dalla borsa, che tiene/ vicino al letto, un mazzetto/ di fogli, la penna, mentre/ la donna, prendendomi per un gomito,/ mi tira nel corridoio/ e mi dice, spaventata:/ “Guardami la faccia,/ gli occhi: che ti sembro/ gialla? L’ho presa,/ l’ho presa st’epatite!”/ Non so che cosa dirle…/ “Ti dico che è così”/ insiste. “L’ho presa,/ mi ha infettato”./ E scuotendo/ la testa si nasconde/ gli occhi./ La luce, fuori, a picco,/ ha steso come una nebbia/ sopra le case e a mare./ Si scorge solo la punta/ di Favignana e Levanzo./ Marettimo non si vede…/ Penso a questi giorni miei,/ a me, questa solitudine/ che vivo, a chi è che ho perso,/ entro nel mio tormento…/ “Nino” sento Vincenzo/ chiamare. E mi riscuoto,/ torno indietro. “Gliel’ho scritta”/ dice appena mi affaccio/ “è pronta”./ Mi avvicino./ Mi sporgo per prendere/ la busta e ritrae/ il braccio./ “Lo sai cosa sto pensando?”/ mi dice, pieno di temenza/ “questa lettera a Sciascia tu/ è meglio che non la porti./ Ho paura che toccandola,/ che so, a voi, a tutti e due/ vi infetti”.
***
PAOLO DI PAOLO
Un immenso giacimento
È una mattina di novembre, è il 2001. Vincenzo Consolo si racconta agli studenti di un liceo non lontano da Roma. Io avevo diciott’anni: provai a invitarlo; lui fu cortese in un modo che non mi aspettavo. Subito paterno, curioso. Sono andato a ripescare la vecchia videocassetta in cui è rimasta traccia delle sue parole, della sobrietà con cui le pronunciava. “Sono uno dei pochi (o dei tanti?) che non predilige le memorie erotiche, gli schizzi di sangue, gli intrighi internazionali. La lettura è un mondo infinito dal quale trarre linfa vitale per l’immaginazione, per una continua ricerca di verità e di conoscenza”. Ne Lo Spasimo di Palermo appare uno scrittore di cui si dice che “aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile” e che ha scelto “una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio”.
Non è un’opera facile, immediatamente accessibile la sua – con quell’affollarsi sulla pagina di parole remote, preziose, sonore come note di una musica distante –, e per gli studenti che lo ascoltavano provò a semplificare, a descrivere la sua scelta letteraria con estrema chiarezza. Ho provato a trascrivere parte del suo intervento, con maggiore fedeltà possibile, perché credo somigli a un tentativo di autodefinizione preciso e appunto trasparente. Disse tra l’altro:
«La tradizionale gerarchia mette in una posizione prevalente la parte comunicativa. Io ho cercato di rompere questa gerarchia, strutturando le frasi secondo un particolare ritmo, secondo un’autentica armonia sonora che avesse una valenza di significante forte quanto quella di significato; e attingendo all’immenso giacimento linguistico della mia terra, la Sicilia, attraversata da tutte le grandi civiltà, dalla fenicia alla greca, a quella romana, a quelle araba, francese e spagnola. Ho scavato in questo giacimento come un archeologo, trovandomi per le mani una ricchezza impensabile, con lo stesso stupore provato venendo qui stamattina e percorrendo un tratto di Appia antica: con tutta la meraviglia e il rapimento di passare in un istante dalla modernità a un passato remoto e viceversa. Ho innestato sulla lingua italiana i reperti di altre lingue, anche scomparse, e non l’ho fatto per via di un gioco formale. Per me è stato un bisogno, un’urgenza di allargare i significati della parola, sottraendola alla convenzione linguistica, che ci spinge ad accettare e fare nostro un solo significato. Ma le parole esistono davvero in una dimensione più complessa, che comprende il loro suono, la radice da cui nascono. Sono come biglie chiuse con un mistero dentro: bisogna aprirle».
Dietro alla gentilezza dello sguardo si notava come un allarme: per una realtà politica, civile – non solo italiana – in cui gli era difficile riconoscersi:
“Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità” (ancora da Lo Spasimo di Palermo).
Quando già allora parlava di “potere economico che diventa potere politico” era profetico? No, era uno scrittore: capace di osservare, e di aspettare. Come nelle parole con cui si chiude il romanzo Nottetempo, casa per casa: “Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore”.
Una delle scene più belle e commoventi dell’intera opera narrativa di Consolo sta forse in un libro che, ancora più degli altri, si sottrae alle definizioni, L’olivo e l’olivastro, sospeso tra divagazione, saggio, racconto lirico. Ci appare a un tratto un Verga ormai vecchio e distante da tutto, chiuso in un impenetrabile e risentito silenzio. È investito da continue richieste di presenza a pubbliche onoranze e le rifiuta una a una. Ma il primo giorno di settembre del 1920 – ottantesimo compleanno dell’autore dei Malavoglia – a Catania è arrivato Luigi Pirandello. Che osserva lo scrittore più anziano, si specchia in quel volto più vecchio del suo di quasi trent’anni riconoscendolo padre, “superbo e ostinato come il padre suo”, e in qualche modo sente di ricevere un’eredità.
Ma voglio lasciare ancora la parola a Consolo, che a sua volta immagina e dà voce al sentire di Pirandello, in una giornata di un secolo fa:
«Pensò che, al di là dell’esterna ricorrenza, delle formali onoranze, in quel tempo di lacerazioni, di violenza, di menzogna, in quel tramonto, in quella notte della pietà e dell’intelligenza, il paese, il mondo, avrebbe ancora e più ignorato, offeso la verità, la poesia dello scrittore. Pensò che quel presente burrascoso e incerto, sordo alla ritrazione, alla castità della parola, ebbro d’eloquio osceno, poteva essere rappresentato solo col sorriso desolato, con l’umorismo straziante, con la parola che incalza e che tortura, la rottura delle forme, delle strutture, la frantumazione delle coscienze, con l’angoscioso smarrimento, il naufragio, la perdita dell’io. Pensò che la sua Antonietta, la suor Agata della Capinera, la povera madre, il fratello suicida di San Secondo, ogni pura fragile creatura che s’allontana, che sparisce, non è che barlume persistente, segno di un’estrema sanità nella malattia generale, nella follia del presente».
***
ERNESTO FERRERO
«L’oscuro segreto delle parole»
Nel 1963 Vincenzo Consolo pubblica da Mondadori il suo primo libro, La ferita dell’aprile, un romanzo di formazione che racconta un’educazione cattolica. Ha scelto per il titolo un verso di un amico fraterno, il poeta Basilio Reale. L’aprile vuole simboleggiare la stagione dell’adolescenza, quella scontentezza di sé che i romanzi di Cesare Pavese, una delle letture fondative del giovane Consolo, hanno raccontato così bene. Ma molte sono le ferite che l’esordiente si porta dietro, tutte dissimulate e risolte nella scrittura.
È nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, a metà strada tra Messina e Palermo, da una famiglia che gestisce un commercio di olio e granaglie. È un bambino gracile e biondiccio. Molti anni dopo, a Milano, in presenza della gran mole di Riccardo Bacchelli dice a se stesso che lui, così piccolo, non potrà mai diventare uno scrittore, gli manca il physique du rôle. Il padre ripeteva scherzosamente che, diverso com’era dagli altri figli, era un trovatello. Lo aveva ritrovato sulla vicina strada per San Fratello, antica colonia d’origine lombarda, in cui si parlava un dialetto incomprensibile, che per i siciliani della zona, raccontava Vincenzo, era diventato la cifra stessa della diversità, dunque motivo di scherno, di dileggio. Lui invece si sentiva a proprio agio, in quell’identità di sanfratellano. Lo faceva sentire in battaglia contro ogni autorità costituita, contro il codice linguistico dominante.
Cresce in una casa senza libri, ma a scuola è bravissimo. Quando dopo la licenza liceale si lascia scappare che vorrebbe fare lettere classiche, i suoi gli dicono che per carità, quella è materia da femmine. Per compiacerli, si laurea in Legge e si adatta persino a fare l’apprendista nello studio notarile di un cognato, a Lipari. Poi insegna diritto in un istituto superiore, ma si sente mancare l’aria.
È afflitto da una timidezza patologica. Scrivere per lui è una ragione di vita, ma si chiede se rifugiarsi nella letteratura non sia un “segno di babbìa”, di sciocca ingenuità, un modo per evadere dalla realtà. Ama la sua terra, tra le colline e il mare, con una adesione panica, e tuttavia avverte l’isola come una gabbia. Si chiede se “uscendo da questo pozzo scuro di Sicilia, riuscirei a sbloccare ogni cosa”. La ferita dell’aprile passa quasi inosservato, apre una stagione di crisi e dubbi crescenti. Cerca e trova maestri, come Leonardo Sciascia, avvolto nel fumo delle sue Chesterfield, e il poeta Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, “il barone magico” che lo invita spesso nella sua villa di Capo d’Orlando, dove lo gratifica di monologhi ammalianti. Intanto matura una coscienza politica che resterà sempre vigile e risentita perché offesa. Ha sperimentato le prepotenze mafiose, assistito alle lotte contadine e alle repressioni poliziesche, è rimasto sconvolto dalla strage di Portella della Ginestra.
Nel 1967 la grande occasione: vince un affollatissimo concorso in Rai. Viene assunto come funzionario addetto ai programmi culturali e si trasferisce a Milano. Non è un’esperienza felice. Non sopporta le regole troppo rigide, le gabbie burocratiche, le imposizioni dall’alto. Ha duri scontri con la Direzione centrale, sperimenta sulla sua pelle quello che oggi si chiama mobbing.
Lo salva il giornalismo. Vittorio Nisticò lo invita a collaborare al battagliero quotidiano palermitano che dirige, “L’Ora”, che ha già al suo attivo tante battaglie civili, in primis contro la mafia trionfante di quegli anni. Nel 1975 si trasferisce a Palermo, fa il cronista con umiltà e dedizione, convinto che quello sarà il suo vero mestiere. Intanto fermenta, lentamente e tortuosamente, il progetto di romanzo che diventerà Il sorriso dell’ignoto marinaio: una rilettura delle vicende risorgimentali in una Sicilia squassata da tentativi rivoluzionari e rivolte contadine, molto lontana dall’agiografia tradizionale, che si interroga sull’uso mistificatorio della Storia, scritta troppo spesso dalle classi dominanti.
Ne è protagonista Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, liberale illuminato, erudito, collezionista, appassionato studioso di scienze naturali, cultore di chiocciole e molluschi, che ha reso pubbliche le sue raccolte trasformando la sua casa di Cefalù in museo, quello stesso dove ancora oggi si conserva il meraviglioso ritratto di ignoto di Antonello da Messina da lui acquistato a Lipari.
A superare le incertezze di una stesura tanto travagliata è la moglie di Consolo, Caterina, che di nascosto da lui porta al libraio-editore Gaetano Manusé i primi due capitoli del romanzo, per una edizione d’arte arricchita da un’acquaforte di Renato Guttuso. Corrado Stajano ne scrive entusiasta su “il Giorno”: è più sottile e intenso del Gattopardo, è uno Sciascia poetico. Da Einaudi ci precipitiamo a scrivere a Consolo che ci interessa molto.
A questo punto l’uomo dei dubbi è obbligato a vincere le sue titubanze. In tre mesi finisce il lavoro, di getto. Stajano ha visto giusto. Il sorriso dell’ignoto marinaio si rivela un romanzo stupefacente, un poema in prosa sostenuto da una scrittura potente, musicale, fortemente ritmata, che fonde in una polifonia di voci un italiano “alto” e i dialetti, tradizione colta e materiali popolari. Ne nasce una vertiginosa pluralità di lessici, registri e toni, dove la parola è spinta verso un massimo di sonorità e splendore. Consolo ha lo stesso vorace enciclopedismo del suo amato Gadda, incrocia invenzione e documenti autentici, si abbandona alla vertigine della lista. Gode nel nominare le cose, la natura di casa che conosce così bene. Così avverrà negli altri suoi libri, come la malinconica favola teatrale Lunaria, in cui la Luna cade su una contrada di una Palermo settecentesca, a simboleggiare la fine di tante cose. O in un altro romanzo corale e musicale, Nottetempo, casa per casa, Premio Strega 1992, in cui l’avvento del fascismo in Sicilia è colto attraverso l’arrivo a Cefalù di una stravagante comunità di cultori di riti esoterici, capeggiata da un moderno superuomo, l’inglese Aleister Crowley, profeta di una religione satanica, tra sesso e droga.
L’uomo che nel 1976 arriva nella redazione di Einaudi ha lo stesso mezzo sorriso dell’ignoto di Antonello: “ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà”. Lo scrittore che vuole dare voce agli oppressi e ai diseredati non ha nulla del tribuno, non è uomo di invettive. Al contrario, racconta a bassa voce, senza scatti o soprassalti, senza aiutarsi con i gesti, con una sorta di doloroso stupore, tra orgoglio e lampi di sarcasmo, come se raccogliesse le conferme di qualcosa che ha sempre saputo. Parla di sé solo per quello che può coincidere con il “noi” di una collettività offesa e in cerca di riscatto. La sua apparente mitezza nasconde la tensione di un continuo sospetto. Sta sempre sulla difensiva, come i suoi contadini e i suoi pescatori. Bisogna quasi insistere per cavargli qualche avara notizia sul suo privato. Non ama gli aneddoti personali. Gli sembrano futili.
In una delle sue ultime pagine, Vincenzo Consolo si dice figlio di una terra flagellata, oltreché dalle violenze della Storia, da eruzioni di vulcani e terremoti distruttivi. “E allora, – scrive – di fronte alle macerie, alla polvere dell’esistenza e della storia, privi come siamo di speranze e conforti di ordine metafisico, non resterebbe che lo sconforto, il pianto. Ma solamente i poeti, ancora, posseggono l’oscuro segreto delle parole per dire, con la più alta dignità e più alta bellezza, della grande avventura dell’esistere, della vita; dei suoi dolori, delle malattie, della morte; dire delle sue consolazioni; dell’amore, dell’arte, di un fiore (sia pure una ginestra), del sorgere del sole, del tramonto della luna, della grazia di una donna”.
***
CORRADO STAJANO
Eterno migrante del ritorno
Questo ricordo dedicato da Corrado Stajano all’amico Vincenzo uscì sul «Corriere della sera» il 22 gennaio 2012, il giorno dopo la morte di Consolo.
Che dolore grande vederlo sdraiato su quel divano del soggiorno di casa, con un plaid addosso, il volto sempre più segnato, la voce sempre più flebile. Agitare il braccio smagrito e la mano, addio, addio. Chissà se quel gesto era l’ultimo saluto, il segno amorevole della vita che si stava allontanando.
Il vecchio sofferente era il ragazzetto che nel suo primo libro — autobiografico — La ferita dell’aprile, sprizzava allegria beffarda, un grillo saltellante dalla marina alla montagna siciliana, tra le piazze, i vicoletti, i bagli, l’oratorio, in mezzo ai carusi, ai bastasi, ai preti, alle vocianti donne di paese, alla baronessa secca e bianca, narrazione di un vivere che non può finire mai?
Vincenzo Consolo è morto in corso Plebisciti a Milano, dove abitava, dopo un travaglio di mesi. «Mi sto riprendendo», diceva immancabilmente, e non si capiva se in quelle parole c’era soltanto la sua antica ironia o anche un pizzico di speranza. Perché Vincenzo ha intensamente amato la vita, anche nei momenti più difficili di dramma e sofferenza. E Caterina, sua moglie, come quelle solide figure della mitologia greca che gli piaceva tanto, gli ha sempre dato la forza e il coraggio di cui aveva bisogno.
È nato a Sant’Agata di Militello, nella piazza del paese, non lontano dal mare, tra San Fratello e Capo d’Orlando. Da bambino, ricorda, era piccolo e magro, «con un toracino d’uccello. Zigaga era il soprannome che mi avevano appioppato i fratelli: zirlo, pìspola». La sua è una famiglia di commercianti, la ditta vendeva olio, zucchero, lenticchie, fave, cereali. Suo padre, su un camion Fiat 6211, consegnava la merce ai grossisti. Qualche volta il piccolo Vincenzo lo accompagnava. Studi in paese, il liceo Valla a Barcellona Pozzo di Gotto: dopo la maturità, è Milano ad attirarlo. La cultura industriale, in quegli anni Cinquanta, gli sembra tutto ciò che c’è di nuovo. Elio Vittorini e Vittorio Sereni stanno riscoprendo il rapporto tra letteratura e industria, Ottiero Ottieri e Paolo Volponi lavorano in fabbrica, i nomi delle grandi aziende, la Pirelli, l’Alfa Romeo, la Breda, affascinano, la città è ricca di energie intellettuali, vi abitano Quasimodo, Montale, gli scrittori, gli scienziati, gli editori.
Consolo studia legge all’Università Cattolica, non per ragioni religiose o ideologiche, semplicemente perché l’aveva preceduto un compaesano. Entra nel convitto universitario di via Necchi, vicino a Sant’Ambrogio, capisce in fretta. Ricorda padre Gemelli, il frate fondatore e rettore della Cattolica, già vicino ai fascisti e avversario accanito del Modernismo e di tutto ciò che è nuovo: aveva la testa grossa e gli occhi fulminanti.
Ricorda anche il cardinale Schuster, «etereo e magico come una figura onirica, con il suo viso gotico e diafano ricamato di venuzze». Ricorda soprattutto i poliziotti del suo paese, nella vicina caserma della Celere, e gli zolfatari siciliani che al Centro orientamento immigrati venivano equipaggiati di casco, lanterna e mantelline e fatti partire per le miniere del Belgio dove molti di loro, a Marcinelle e altrove, troveranno la morte.
Vincenzo ha deciso di diventare scrittore.
Ma Milano non è il suo mondo, non ne possiede la lingua, per lui essenziale, non ha memoria dell’immaginato mondo industriale. Come raccontarlo? Torna in Sicilia, pensa di diventare uno scrittore di realtà viste e vissute, di tipo sociologico. Ma non fa i conti con la sua natura fantastica da archeologo delle parole. La ferita dell’aprile esce nel 1963 in una bella collana, «Il Tornasole», diretta da Niccolò Gallo e da Vittorio Sereni. Con i «Gettoni» di Vittorini è l’iniziativa editoriale più coraggiosa e aperta al futuro. Vincenzo è affascinato dal mondo visionario del coltissimo Lucio Piccolo, il barone di Calanovella, poeta scoperto da Montale, che viveva in una villa di Capo d’Orlando come un uomo del Settecento. Nel salone della villa — con il cimitero dei cani accanto — nel buio più assoluto recitava urlando le sue poesie esoteriche, tra vasi Ming, statuette orientali, cassettoni Luigi XVI, ritratti di viceré e di capitani dell’Inquisizione.
Ma è Leonardo Sciascia il vero maestro. È lui a far da contrappeso al fantasioso mondo di Lucio Piccolo. Consolo ritrova con la sua razionalità e i suoi saperi storici, critici, politici, quella strada civile annusata nella prima avventura milanese. La Sicilia contadina così amata si è nel frattempo disgregata, la mafia ha riconquistato un potere assoluto, il candore dell’isola è stato macchiato dalla corruzione, dall’ossessione del denaro, più sporco che pulito, dagli assassini. Il lavoro manca.
Quando decide di partire di nuovo, nel ’68, Milano è incandescente, ricca di fervori. Dal ’63 al ’76 Consolo non pubblica nulla, sta rimuginando, pensando, studiando. È convinto che la letteratura deve essere nemica del potere. Vuole legare la Sicilia alle idee di progresso sociale e civile della Milano di allora. Ma il linguaggio, come trovare il linguaggio adatto che sente gorgogliare nella testa? Legge Gadda, ma il suo amore per la metafora non lo accomuna allo scrittore dell’Adalgisa. È Manzoni, piuttosto: trova paternità e sostegno «nel Manzoni dei Promessi sposi e della Colonna infame, quello della necessità della metafora. (…) L’Italia del Manzoni – scrive – sembra davvero eterna, inestinguibile».
Come spunta l’idea di un libro nella mente di uno scrittore? Il Ritratto di ignoto di Antonello da Messina, del museo di Cefalù, fa da scintilla. Ma sono il fallimento del Risorgimento, la speranza tradita dei contadini di avere le terre dei feudatari, la povertà dei cavatori di pomice ammalati di silicosi — storia e società — ad accumularsi informi nella testa di Vincenzo. Nel 1976, con Il sorriso dell’ignoto marinaio, capolavoro di folgorante bellezza, nasce, si può dire, Vincenzo Consolo, il Vicè dei compagni di giochi, uno dei più grandi scrittori del Novecento, tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, conosciuto forse più in Europa che in Italia.
Vincenzo non era mai in pace, inquieto, sempre. Nel 1993 disse pubblicamente che se alle elezioni di quell’anno avesse vinto a Milano la Lega Nord, come poi accadde, se ne sarebbe andato dalla città per protesta contro la barbarie della «padania» inesistente. Non partì, fu criticato, accusato di esibizionismo, di presunzione. Un provocatore. La Sicilia nel sangue. Consolo non ha di certo avuto bisogno di quella nota di diario che Goethe scrisse nel suo Viaggio in Italia, il 13 aprile 1787: «L’Italia, senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell’anima: è qui la chiave di tutto».
Appena poteva, eterno migrante del ritorno, partiva. Non ha mai tradito la sua isola. Andava per vedere un’altra volta quel che aveva nel cuore. Non lo ritrovava. Ferito tornava al Nord, a Parigi, a Madrid. E poco dopo riprendeva la strada dell’eterno viaggio, riandava in Sicilia. È morto nella Milano della sua giovinezza. Nella grande stanza foderata dai libri degli scrittori amati di laggiù. Alle pareti un dipinto con una smisurata macchia arancione, il disegno di due ragazzi di Casarsa, di Pasolini, l’Ignoto marinaio di Guttuso, incisioni secentesche, ritratti, carte geografiche dell’isola stampate all’insù e all’ingiù. Tutto qui sa di Sicilia.
***
NADIA TERRANOVA
L’uomo dello Stretto
La prima volta che ho visto Vincenzo Consolo me lo sono andato a cercare. Fu a Torino, al Salone del libro, però forse, siccome sono messinese come lui, vi aspetterete che il nostro legame risalga a prima della mia età adulta, alle mie origini.
Sarebbe bello oggi poter raccontare un’amicizia atavica, un comune legame che viene da qualcosa di diverso dall’esser nati entrambi sulla sponda più a sud dello Stretto, nella stessa provincia della Sicilia, la meno narrata e tuttavia la più ricca di narrazioni, quella, per intenderci, che compare per la prima volta nel dodicesimo canto dell’Odissea, quando Omero canta di Scilla e Cariddi e della distruzione della nave di Ulisse per via della loro furia. Mi piacerebbe dire che quella storia fu proprio lui a raccontarmela, magari quando ero piccola, e che da lui venne la contezza di potere, anzi dovere, raccontare quella lingua di mare che bagna città e paesi per poi allargarsi e perdersi nel Mediterraneo. Perché, in effetti, è così che è andata: non solo tutto questo io, messinese, l’ho imparato anche da Vincenzo Consolo, ma è stato lui a sussurrarmi all’orecchio tutto ciò che serve per scrivere, ovvero: guarda il mare e fallo, tu puoi. Ovviamente, non sa di averlo detto, perché la sua voce mi è arrivata nel modo più nobile e giusto in cui deve arrivare la voce di uno scrittore: attraverso i suoi libri.
Per primo fu un suo romanzo a dirmi della nostra Messina, che soffre la ferita dell’identità perché i terremoti ne hanno distrutto la forza e la potenza, soprattutto l’ultimo, quello del 1908. Con una pagina mormorò a me, solo a me, che Messina, non esistendo più, continuava a esistere.
“Città di luce e d’acqua, aerea e fuggente, riflessione e inganno, fatamorgana e sogno, ricordo e nostalgia. Messina non esiste. Esistono miti e leggende, Saturno, Orione, Cariddi, Mata e Grifone, Colapesce. Ma forse vi fu una città con questo nome perché disegni e piante riportano la falce di un porto con dentro velieri che si dondolano, e mura, colli scanditi da torrenti e coronati da forti, e case palazzi chiese orti… “
Queste parole di Vincenzo Consolo, tratte da L’olivo e l’olivastro, costituiscono la radice dei miei tre romanzi e del mio libro Omero è stato qui, in cui ho raccolto le storie e le leggende dello Stretto. Messina, ho pensato spesso, è viva solo per i messinesi, per chi ci è nato e cresciuto. Oppure no: è viva solo per chi ne ha letto, perché i luoghi esistono solo se c’è qualcuno che li sa raccontare, anzi a volte penso che esistano solo dentro un racconto, dentro le parole che li salvano e li traghettano da una storia all’altra.
Solo dopo averne divorato i libri ho scoperto che, in realtà, un legame originario tra me e Vincenzo Consolo esisteva, e riguardava in effetti Messina. La sorella di mia madre, la poetessa Marietta Salvo, per qualche tempo aveva collaborato alle pagine culturali dello storico giornale siciliano L’Ora. Solo dopo la pubblicazione del mio primo romanzo scoprii che lo aveva intervistato: mi mostrò la doppia pagina dell’articolo e mi raccontò delle loro conversazioni, degli scambi che avevano avuto, delle lunghe conversazioni su poesia e letteratura.
Il mio incontro dal vivo con lui, invece, avvenne in una città aliena a entrambi: Torino. E forse solo nella capitale del libro potevano incontrarsi una messinese che aveva scelto Roma e un messinese che aveva scelto Milano.
Erano i primi anni duemila e Vincenzo Consolo teneva un incontro al Lingotto, nei giorni del Salone. Io ero lì da lettrice, non avevo ancora pubblicato nulla se non dei racconti in qualche antologia e rivista, stavo lavorando al mio primo romanzo ma l’editoria mi incuteva timore, non sapevo se qualcuno mi avrebbe presa in considerazione e, nel frattempo, mi rifugiavo in ciò che non mi ha mai tradito: le pagine degli scrittori che amo. Insieme a un’amica che avevo contagiato con la mia “consolite”, la febbre dei suoi libri, aspettammo Vincenzo Consolo per poter avere con lui un contatto diretto poco prima dell’incontro. Lui si sorprese di trovare due lettrici entusiaste e così giovani, e allora mi sorpresi io: per me la letteratura è sempre stata androgina, senza età, senza tempo. Gli dicemmo che i suoi libri ci piacevano tantissimo anche se qualche volta erano difficili da trovare, e si incupì: ditelo al mio editore, rispose, e in quella sola frase, in quell’espressione di disappunto previdi quello che poi sarebbe toccato a me come a tutti gli scrittori, il difficile rapporto tra chi scrive e chi pubblica, una forma di poliamore fatta anche di incomprensioni e delusioni. Allora fu un lampo, ma adesso lo so bene, lo so per esperienza. Con la sua lingua magnifica, ricercata ed elegante, Vincenzo Consolo mi ha insegnato vocaboli e rime, musicalità della prosa e accuratezza storica, ma soprattutto mi ha insegnato due cose su cui ho imparato a piangere e sorridere, una altissima e una quotidiana: che lo Stretto è un luogo mitico da raccontare, e che gli editori sono sempre un po’ canaglie. 
foto Giovanna Borgese
Citazioni pittoriche e strategie ecfrastiche nell’opera di Vincenzo Consolo
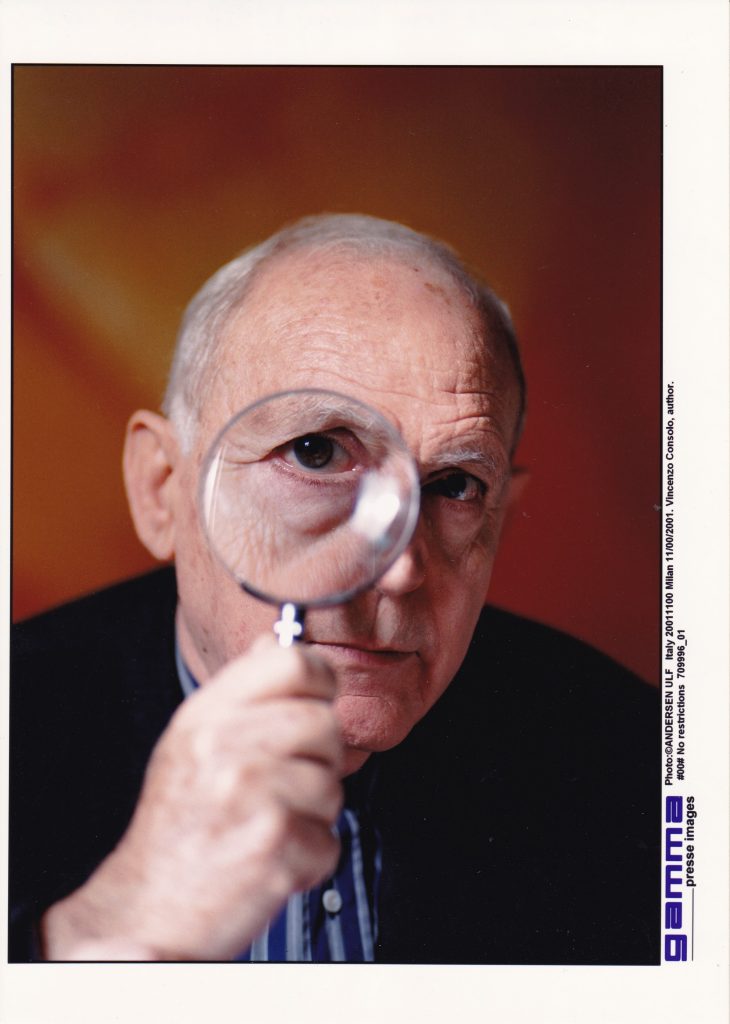
L’articolo indaga l’intenso dialogo tra i romanzi consoliani e le arti figurative, in particolare la pittura. Un dialogo che si avvale di strategie molteplici, le icone autoriali annunciate spesso dai titoli tematici dei romanzi, il ricorso all’ekphrasis nascosta, gli inserti critici riferiti alle opere d’arte. Con particolare riferimento a Il sorriso dell’ignoto marinaio ed a Retablo prende in esame, per altro, l’uso che lo scrittore fa dell’ekphrasis, il suo valore metanarrativo e metadiegetico.
L’opera di Consolo riserva ampio spazio alle citazioni figurative.[1] Lo scrittore, intervistato da Giuseppe Traina, ha dato una spiegazione della ricchezza dei riferimenti pittorici riscontrabili nei suoi romanzi ricorrendo ad un assunto semiologico, affermando la volontà di superare la contrapposizione tra lo svolgimento temporale del linguaggio verbale e lo svolgimento spaziale dell’opera figurativa. Per Consolo la continua evocazione dell’immagine riscontrabile nella sua scrittura risponde all’esigenza di equilibrio tra temporalità e spazialità:
Credo ci sia bisogno di equilibrio tra suono e immagine, come una sorta di compenso, perché il suono vive nel tempo, invece la visualità vive nello spazio. Cerco di riequilibrare il tempo con lo spazio, il suono con l’immagine. Poi sono stati motivi d’ispirazione, di guida, le citazioni iconografiche di Antonello da Messina o di Raffaello. In Retablo c’è l’esplicitazione dell’esigenza della citazione iconografica: il “retablo” appartiene alla pittura ma è anche “teatro”, come nell’intermezzo di Cervantes.[2]
La stessa perigrafia dei romanzi consoliani rinvia spesso a suggestioni figurative o a palesi citazioni pittoriche, evidenti fin dai titoli: com’è noto Il sorriso dell’ignoto marinaio fa riferimento al dipinto di Antonello da Messina, il ritratto virile d’ignoto custodito nel Museo Mandralisca di Cefalù. Anche Retablo, romanzo pubblicato nel 1987 per i tipi Sellerio, evoca la pittura fin dal titolo. Il termine catalano retablo indica infatti una pala d’altare inquadrata architettonicamente: essa può articolarsi in diversi scomparti formando un dittico, un trittico o un polittico costituito da tavole dipinte, talvolta da sculture o dall’alternanza di dipinti e bassorilievi, tenendo insieme, in quest’ultimo caso, imagines pictae e fictae. Il titolo scelto da Consolo, facendo riferimento ai polittici iberici, denunzia in primo luogo la vocazione pittorica del libro. Ma retablo è inteso dall’autore come un significante polisemico, come un lessema evocativo di rara e remota sonorità che contiene, ad un tempo, riferimenti figurativi, teatrali e letterari: «La parola retablo (parola oscura e sonora, che forse ci viene dal latino retrotàbulum: il senso, per me, dietro o oltre le parole, vale a dire metafora) l’ho assunta nelle varie accezioni: pittorica, shahrazadiana, cervantesiana».[3] Tra l’altro il lemma spagnolo rinvia alla memoria del Retablo de las meravillas di Miguel de Cervantes. L’evocazione cervantesiana può essere intesa anche come un riferimento al tratto illusorio dell’arte, motivo a cui il romanzo dedica più di una riflessione. Attraverso la scelta di un titolo di carattere tematico[4] l’autore allude, infine, all’organizzazione narrativa del libro, articolato per scene e quadri successivi che potrebbero essere considerati come delle tavole sovrapposte, pur mantenendo la loro autonomia narrativa. Il testo consoliano si configura dunque come un polittico, come una successione di quadri narrativi al centro dei quali sta il motivo odeporico, ovvero il viaggio del cavaliere Fabrizio Clerici nella Sicilia del XVIII secolo, e una tarsia di citazioni che ne fanno uno dei romanzi più complessi e levigati della letteratura italiana del secondo Novecento.

Per dare un titolo all’ampia intervista concessa all’IMES nel 1993, lo scrittore, ancora una volta, ha usato un riferimento pittorico evocando Fuga dall’Etna di Guttuso.[5] Consolo ha riproposto il nome che il pittore siciliano ha dato ad una tela di vaste dimensioni realizzata tra il 1938 e il 1939, la sua prima composizione corale, lungamente meditata e preparata attraverso studi, ritratti e paesaggi realizzati tra la Sicilia e la Sila.[6] Nel dipinto un’eruzione etnea assume un più ampio significato sociale e diventa l’occasione per rappresentare masse di contadini in fuga concitata, arditi scorci di cavalli che negli stilemi e nell’esemplificazione formale rivelano la memoria di Guernica di Picasso: un’allusione alla sofferenza del mondo contadino e al dramma della migrazione, anch’esso un vulnus iscritto nella storia del Novecento. Non è un caso che Consolo si sia ricordato del telero guttusiano: nell’intervista, infatti, l’autore ripercorre il suo itinerario biografico e intellettuale, parla dell’allontanamento dall’isola natale, della condizione di erranza, della metafora odissiaca che attraversa i suoi romanzi, del nostos impossibile e del trasferimento giovanile a Milano. La citazione di Fuga dall’Etna testimonia, tra l’altro, dell’amicizia tra lo scrittore e Guttuso che si traduce nelle argute allusioni presenti in diversi romanzi. Si veda, ad esempio, il cenno, incastonato nelle pagine di Retablo, al «pittore celebrato […] della Bagarìa», anacronisticamente collocato in un elenco di artisti siciliani d’epoca manierista o barocca: «Siete meglio del Monrealese, meglio dello Zoppo di Ganci, del Monocolo di Racalmuto, meglio di quel pittore celebrato (non ricordo il nome) della Bagarìa».[7] L’allusione consoliana, che qui assume le connotazioni di un ammiccante gioco a nascondere, non è dissimile dalla scelta di fare dell’amico Clerici, pittore lombardo inquieto e surreale, il protagonista del libro.

Anche l’ultimo romanzo di Consolo, Lo Spasimo di Palermo, fa riferimento a un’opera pittorica, il dipinto di Raffaello un tempo custodito nella chiesa palermitana di Santa Maria dello Spasimo e oggi esposto nelle sale del Museo del Prado. Secondo la narrazione del Vasari la tavola dell’Urbinate sarebbe giunta in Sicilia per mare, attraverso fortunosi accadimenti.[8] La citazione dello Spasimo (ovvero della raffaellesca Andata al Calvario di Cristo) è usata per conferire una connotazione martirologica alla narrazione. Il romanzo, infatti, si confronta col tema dell’impotentia scribendi, con lo smarrimento del protagonista e, nelle pagine conclusive, allude alla strage di via D’Amelio, all’attentato che determinò la morte di Paolo Borsellino. Il simbolismo sotteso dal riferimento pittorico è intensificato dalla riproduzione di una pagina dello spartito del Dies irae del compositore augustese Manuele d’Astorga.[9] La citazione pittorica, il ricercato recupero di un testo musicale d’epoca barocca, i riferimenti cinematografici portano al massimo grado l’orchestrazione plurima dei codici, facendo culminare la narrazione in una successione di suggestioni sinestetiche che conferiscono forza al tragico explicit.
Oltre alla perigrafia, alle tarsie intertestuali ed alle note icone autoriali di Consolo, ovvero alle esplicite costruzioni ecfrastiche dedicate al ritratto virile di Antonello da Messina nel Sorriso dell’ignoto marinaio, all’oratorio serpottiano di San Lorenzo in Retablo, al caravaggesco Seppellimento di Santa Lucia ne L’olivo e l’olivastro ed alla tavola raffaellesca nello Spasimo, Miguel Ángel Cuevas ha messo in evidenza il ricorso, da parte dello scrittore, alla strategia dell’«ekphrasis nascosta».[10] Cuevas, attraverso lo studio variantistico delle opere consoliane, ha sottolineato come l’autore tenda all’occultamento dell’originario costrutto ecfrastico, restituendo al lettore non la descrizione di un’immagine, ma la sua immediatezza:
L’occultamento della dimensione ecfrastica del testo finisce per far diventare l’immagine un’alterità senza equivalenze, senza punto di riferimento: un’alterità assoluta; le figure si palesano in una loro ambiguità atopica, all’interno della quale la persistenza di segni elocutivi descrittivi potrebbe essere interpretata – non solo, ma almeno anche – come indizio del flusso di coscienza, come l’apparire, in ogni caso, di una diversa voce narrante: che paradossalmente provoca effetti di denarrativizzazione.[11]
Se l’ekphrasis, figura di pensiero per aggiunzione che la retorica ha considerato da sempre il mediumtra la letteratura e le arti, è la descrizione verbale di una rappresentazione visuale, se, come ha affermato Mengaldo, la «descrizione verbale non mima l’opera, ma lo sguardo che percorre l’opera»,[12] la strategia di opacizzazione referenziale adottata da Consolo rende ancora più complessi i rapporti intercorrenti tra testo e immagine. Il ricercato equilibrio tra temporalità e spazialità, di cui lo scrittore ha parlato nell’intervista concessa a Traina, rivela risvolti assai complessi considerando che spesso, nelle narrazioni consoliane, la visività verbale si pone come controfigura di un’immagine non dichiarata: «rapporti, in definitiva, basati su convergenze o parallelismi che incrinano, mostrandone l’obsolescenza, le tradizionali ed escludenti collocazioni delle immagini su un asse spaziale in rapporto al logos che si svolge sulla temporalità».[13]
In sintesi il rapporto tra i romanzi di Consolo e la pittura si avvale di strategie molteplici: la retorica della citazione e le icone autoriali che spesso sono preannunciate dal titolo tematico dell’opera; le ekphrasis nascoste, incastonate in una scrittura sempre caratterizzata da forte pittorialità; inserti critici e metadiegetici riferiti alle opere d’arte che testimoniano la raffinata formazione dell’autore e contribuiscono ad accentuare l’antinarratività delle sue opere dalla densa struttura ‘palinsestica’.[14] Un’ulteriore riflessione, sulla scorta degli studi di Michele Cometa dedicati alla retorica visuale, si impone in rapporto alle diverse forme di integrazione dell’ekphrasis nelle opere consoliane.
1. Il sorriso dell’ignoto marinaio: la funzione metapoetica e metanarrativa dell’ekphrasis
Si è già notato che Il sorriso dell’ignoto marinaio fa riferimento, fin dal titolo, ad un dipinto antonelliano, il ritratto virile custodito al Museo Mandralisca di Cefalù. La tavola quattrocentesca, che una tradizione suggestiva ma infondata indicava come il ritratto di un marinaio, è alla base dell’ordine delle somiglianze che attraversa il romanzo. Fin dall’incipit il protagonista, barone Enrico Pirajno di Mandralisca, tiene la tavola dipinta sotto braccio, riportandola da Lipari, dove l’ha fortunosamente scoperta, al suo palazzo cefaludese. L’antefatto del primo capitolo fa da sintesi del viaggio dell’aristocratico collezionista e vi dà un’esatta collocazione cronotopica, datandolo 12 settembre 1852: «Viaggio in mare di Enrico Pirajno barone di Mandralisca da Lipari a Cefalù con la tavoletta del ritratto d’ignoto di Antonello recuperata da un riquadro dello stipo della bottega dello speziale Carnevale».[15]
Leggendo il romanzo si scopre che il volto effigiato nel dipinto è somigliante a quello del patriota Giovanni Interdonato, l’uomo che il barone ha scorto, travestito da marinaio per sfuggire alle rappresaglie borboniche, nell’imbarcazione che lo riportava alla sua dimora. L’Interdonato avrà un ruolo essenziale nel determinare la presa di coscienza politica del Mandralisca. Otto anni dopo il viaggio alle Eolie, infatti, nel crinale storico del 1860, il Pirajno abbandonerà i suoi studi eruditi, la passione per la malacologia, il suo interesse per il collezionismo di mirabilia naturalia et antiquaria perseguito secondo l’habitus aristocratico e, essendosi rispecchiato nel volto dell’amico, muoverà da un generico liberalismo ad una più profonda comprensione della questione sociale.
Incastonata nel primo capitolo del Sorriso è la celebre ekphrasis del quadro di Antonello, ospitato tra le collezioni del Mandralisca:
Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. […] L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diventerà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini.[16]
La descrizione del ritratto è anche una sua interpretazione oscillante tra etopea e prosopografia, ricca di connotazioni fisiognomiche che verranno riproposte per stabilire il complesso gioco di rifrazioni e proiezioni identificative tra i personaggi del romanzo.

La giusta età della ragione, l’ironia che si pone come tertium tra l’eccesso di severità e il riso aperto, sarcastico o spietato, anticipa il percorso di maturazione politica ed esistenziale del protagonista. Consolo piega così a particolare partitura quella vocazione fisiognomica presente nei romanzi di molti scrittori siciliani, da De Roberto a Tomasi di Lampedusa, da Sciascia ad Addamo. Del resto a indirizzare il lettore verso un’attenta interpretazione del testo è la citazione in esergo, tratta dall’Ordine delle somiglianze di Sciascia: «Il giuoco delle somiglianze è in Sicilia uno scandaglio delicato e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza […]. I ritratti di Antonello “somigliano”; sono l’idea stessa, l’arché della somiglianza […]. A chi somiglia l’ignoto del Museo Mandralisca?».[17] Nell’economia narrativa del Sorriso sono diverse le ipostasi del riconoscimento e del rispecchiamento che stabiliscono la tensione speculare tra i personaggi principali. Significativamente il momento in cui l’aristocratico individua nell’Interdonato il marinaio già scorto nel viaggio del 1852 è anche il momento in cui egli si accorge della straordinaria somiglianza tra il patriota e l’uomo effigiato nella tavola antonelliana.[18]
Il ritratto di Antonello, nella Memoria che il Mandralisca invia all’Interdonato sui fatti di Alcàra Li Fusi, vero e proprio nucleo ideologico del romanzo, diventa anche l’emblema di una ragione distaccata, condizionata dalla nascita, dalla posizione di casta o dalle necessità di carriera. Rispecchiandosi nel ritratto antonelliano, in altre parole, il Mandralisca pone una spietata critica a se stesso, alla sua classe sociale, alle sue «imposture»,[19] alla stessa intellettualità progressista che concepisce comodi ideologemi e interessate teleologie, a partire dalla stessa retorica risorgimentale.
Cuore di molteplici tensioni narrative, simboliche e proiettive, la tavola di Antonello assolve dunque ad un ruolo capitale nel romanzo, ben lontana dall’essere una semplice citazione iconica. Usando il linguaggio di Cometa è utile indagare, in quest’opera consoliana, l’«integrazione per trasposizione»[20] dell’ekphrasis.La riflessione dello studioso, sulla scorta della rilettura di un testo classico come le Immagini di Filostrato, categorizza diverse forme di integrazione ecfrastica, da intendersi come integrazione da parte del lettore nel suo repertorio.[21] Scrive Cometa: «Il lettore è dunque invitato non solo a penetrare con lo sguardo nell’immagine ma anche a integrarla con le proprie preconoscenze e con la propria esperienza pregressa».[22] Naturalmente nel Sorriso si possono riconoscere forme molteplici di integrazione dell’ekphrasis, e tra esse l’«integrazione ermeneutica»,[23] forse il procedimento più ricercato alla base del patto ecfrastico: nel Sorriso la descrizione dell’opera d’arte si avvale delle consapevolezze critiche, iconografiche e iconologiche di Consolo, in dialogo con quel lettore colto che le possieda e le sappia intendere. Come vedremo in seguito gli inserti critici e metadiscorsivi hanno una parte significativa nel Sorriso. Ma il romanzo del 1976 rimane un caso esemplare in cui l’opera d’arte assume un vero e proprio ruolo genetico, al punto che l’intero plot è stato concepito attraverso costanti rinvii ad essa. È parimenti evidente che la descrizione del ritratto antonelliano assolve alle funzioni metapoetica e metanarrativa, nel senso postulato da Cometa che ha recuperato motivi propri della poetologia schlegeliana e romantica, secondo cui l’ekphrasis permette di prefigurare ed anticipare il senso di un romanzo, costituendo un dispositivo in cui l’opera letteraria si «rispecchia», una lente in cui si scorge un’«immagine unitaria della narrazione».[24]
Oltre al caso dell’icona antonelliana, si possono individuare nel Sorriso molteplici esempi di ekphrasis nascosta; per tutti la descrizione, incastonata nel primo capitolo, di un cavatore di pomice liparitano sofferente, osservato dal Mandralisca durante il viaggio da Lipari a Cefalù. Come ha messo in evidenza Cuevas, nella descrizione dell’uomo si riconosce un dettaglio della Crocefissione di Anversa, una tavola antonelliana in cui il ladrone di sinistra si attorce in un ultimo spasimo che precede la morte.[25] Vi è nel Sorriso un’essenziale e ben nota triangolazione di riferimenti figurativi: il ritratto antonelliano, la Crocefissione di Anversa e Los desastres de la Guerra di Goya, i cui titoli scandiscono la narrazione del settimo capitolo, dedicato alla sanguinosa rivolta contadina di Alcàra Li Fusi ed alla sua repressione.[26] Come ha sottolineato Rosalba Galvagno alcune ekphrasis del Sorriso possono essere ricondotte alle incisioni de Los desastres.[27] Ma il novero dei rinvii meno evidenti alle arti plastiche e figurative è molto ampio. Non manca chi ha individuato nella rappresentazione dello studiolo del Mandralisca un probabile riferimento al San Gerolamo di Vittore Carpaccio, alle opere di Filippino Lippi o a quelle del ceroplasta siracusano Matteo Durante.[28]
Tra i tanti riferimenti espliciti alle arti sono riscontrabili cenni alla statuaria ed alla produzione ceramica greca, all’icona marmorea del Giovane con la tunica del Museo Whitaker di Mozia ed al cratere del Pittore di Lipari rappresentante la vendita del tonno. Altri riferimenti evocano il Trionfo della morte di Palermo (l’affresco tardogotico di Palazzo Sclafani che ha ispirato Guernica di Picasso, citato spesso anche da Sciascia e Bufalino), le sculture rinascimentali di Francesco Laurana ed Antonello Gagini, le tele del secentista Pietro Novelli. La descrizione delle collezioni messe insieme dal Mandralisca restituisce una fitta successione di citazioni pittoriche:
Venne il momento della visita al museo. Guidati dal barone Mandralisca, fecero il giro della quadreria disposta in doppia fila alle pareti. Sentirono distratti elogiare la luce dell’Alba a Cefalù del Bevelacqua, l’espressione intensa della Sant’Anna del Novelli, la sapienza prospettica dell’Ultima Cena della scuola del Ruzzolone, dove le figure erano così tonde e grosse, così sazie, che sembrava quella sì un’ultima cena, ma il cui inizio non si conosceva, con portate continue di maccheroni al sugo. E così avanti, per le tavole bizantine, per ignoti siciliani, per i napoletani e gli spagnoli, fino a quello della giovane formosa che offre alle labbra di un vecchio rinsecchito il capezzolo rosa d’una mammella bianca che sbuca dallo scuro in piena luce.[29]
Nella rappresentazione dei dipinti non mancano increspature ironiche, come nel rapporto che viene stabilito, con un improvviso abbassamento del tono della narrazione, tra il motivo iconografico dell’Ultima cena e le «portate continue di maccheroni al sugo»: un’allusione al succulento banchetto che è probabilmente l’unico motivo per cui gli ospiti hanno accettato l’invito del barone a recarsi nella sua dimora e «godere la visione di una nuova opera unitasi alla loro collezione».[30] La stessa capacità rovesciante è rivelata nella descrizione di un dipinto che fa riferimento alla lactatio, tradizionale emblema di una delle Virtù Teologali, la Carità. Lo statuto iconografico che, nella tradizione figurativa barocca era l’occasione per rappresentare la nudità e la procacità femminili, esplicita qui il suo sottointeso erotico e diventa un’allusione alla ben poco edificante brama di un «vecchio rinsecchito»,[31] con un evidente riferimento alle Sette opere di Misericordia di Caravaggio.
Consolo, nel Sorriso, recupera un motivo letterario e parodico, quello dell’antiquario, della sua greve erudizione, della sua mania collezionistica che ha un archetipo nella goldoniana Famiglia dell’antiquario e conosce significative riprese anche nei romanzi di Capuana e De Roberto.[32] Non è un caso che, scorgendo una statua classica tra i marmi accatastati in un’imbarcazione, immaginando di accaparrarsela, il Pirajno si ponga in fantasiosa competizione con altri aristocratici dediti alla raccolta di nobilia opera del passato. Rappresentando la brama del Mandralisca, lo scrittore incastona nella narrazione un elenco dei maggiori collezionisti siciliani realmente esistiti ed attivi tra il XVIII e il XIX secolo:
Uh, ah, cazzo, le bellezze! Ma dove si dirigeva quella ladra speronara, alla volta di Siracusa, bianca, euriala e petrosa, o di Palermo, rossa, ràisa e palmosa? Pirata, pirata avrebbe voluto essere il barone, e assaltare con ciurma grifagna quella barca, tirarsela fino all’amato porto sotto alla rocca […]. Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale, il Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina.[33]
L’ironia consoliana raggiunge il culmine nella descrizione dei crateri attici radunati nella collezione Mandralisca, con le loro scene erotiche ed altre raffigurazioni ispirate ai baccanalia, certamente non confacenti alla morale del XIX secolo:
Oltre al Venditore di tonno, oltre a matrone languide, sdraiate, con ancelle attorno che le aiutavano a fare toilette, i vasi neri e rossi mostravano fauni impudichi e sporcaccioni, con tutta l’evidenza dritta della infoiatura, che abbrancavano per la vita, per le reni ninfe sgambettanti per portarsele, poverette, chissà dove; altre scene di fughe e rapimenti, altre di ragazze estatiche davanti a giovanotti inghirlandati e con bordoni in mano di cui non si capivano le intenzioni. Gli uomini si davano gomitate, facevano ammiccamenti, azzardavano sottovoce interpretazioni, mentre il barone li informava sull’epoca e sul luogo della provenienza di quelle antichità.[34]
Concependo il suo romanzo come un «antiromanzo storico»,[35] sullo sfondo di un Risorgimento gramscianamente inteso come mancata rivoluzione, Consolo ha usato la sua conoscenza della storia dell’arte per fare il verso al barone collezionista, per rappresentare la vacuità della sua classe sociale. L’integrazione ermeneutica dei costrutti ecfrastici vuole il concorso esegetico del lettore, la sua comprensione dei passaggi ironici. La «plurivocità» del Sorriso,[36] oltre che nei processi parodici, è ravvisabile nella stessa contraddittorietà e complessità di un personaggio come il Mandralisca che, in ultimo, riuscirà ad allontanarsi dalla concezione erudita ed esornativa della cultura propria della sua classe sociale, destinata ad un ineluttabile declino, acquisendo un’acuta e demistificante consapevolezza politica.
2. Retablo, o delle rifrazioni ad infinitum
Consolo ha fatto del pittore milanese Clerici il protagonista di Retablo. Le allusioni a Clerici e Guttuso non sono casuali. Ad ispirare il romanzo, infatti, è stato un viaggio in compagnia dei due artisti nella Sicilia orientale, un’occasione in cui lo scrittore ha rivisto i templi dorici di Segesta, Selinunte e Agrigento percorrendo alcune delle tappe canoniche del Grand Tour d’Italie.[37] Consolo, dunque, ispirandosi ad un fatto realmente accaduto, ha dato un doppio letterario al suo amico. A complicare il gioco di allusioni vi è la perigrafia, la scelta di illustrare la prima di copertina della prima edizione del libro con un dettaglio di un dipinto di Clerici,[38] ed ancora la scelta di incastonare nel testo diverse ekphrasis ispirate all’opera dello stesso artista. Non sembra un caso che il pittore milanese sia stato anche il protagonista di un romanzo di Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, ed abbia fatto conoscere a Sciascia La tentazione di Sant’Antonio, la tela del manierista Rutilio Manetti in cui è effigiato il diavolo con gli occhiali, investito di forti valori simbolici nel romanzo Todo modo.[39]Le vertiginose rifrazioni del libro consoliano sono degne della teoria di rispecchiamenti de Las Meninas di Velázquez, dipinto emblematico della temperie barocca.
La rappresentazione di un viaggio in Sicilia nel XVIII secolo, la ricchezza di riferimenti figurativi e la diffusa retorica dello sguardo fanno di Retablo l’opera consoliana in cui il rapporto tra letteratura e pittura si fa più intenso e insistito.[40] I rimandi figurativi, per altro, agiscono in profondità, fino a dare forma alla stessa architettura ed alla focalizzazione del racconto. Il romanzo, infatti, è ripartito in tre capitoli o tavole: Oratorio, Peregrinazione e Veritas. A ciascuna di queste parti corrisponde una diversa voce narrante, quella di Isidoro in Oratorio, quella di Clerici in Peregrinazione e quella di Rosalia in Veritas. Un intreccio di voci che restituisce al lettore gli stessi accadimenti osservati da angolazioni diverse, moltiplicando prismaticamente le visioni e le possibili interpretazioni della realtà.
Ad incipitdi Oratorio è posto il celebre inno che Isidoro innalza a Rosalia: una petitio amorosa, una laica preghiera, una litania o un delirio in cui la scomposizione del nome dell’amata in Rosa e Lia, il moltiplicarsi delle figure fonetiche ed etimologiche, l’intertestualità non priva di echi danteschi e petrarcheschi, l’investimento ambiguo ed ambivalente della donna si spingono ad un parossistico virtuosismo. Subito dopo Isidoro, dedito alla questua e alla vendita delle bolle, narra in prima persona l’amore concepito per la giovane che, quotidianamente, gli appariva alla finestra insieme alla madre. Le due donne hanno ordito il raggiro dell’inesperto questuante facendogli credere di poter sposare la ragazza e, fattesi consegnare il denaro delle bolle, sono scomparse nel nulla. Cacciato dunque dal convento, il fraticello è ridotto alla condizione di facchino alla Cala di Palermo. Qui, finalmente, gli appare il cavaliere Clerici, sceso da una nave che ha il nome simbolico di Aurora.[41] L’aristocratico viaggiatore prende con sé Isidoro, lo allontana dalla vita dura ed ambigua del porto e ne fa il suo accompagnatore nel viaggio in Sicilia volto all’osservazione e alla riproduzione dei monumenti antichi. Quando Clerici fa conoscere al fraticello il cavaliere Serpotta e gli mostra l’oratorio palermitano di San Lorenzo, questi scorge nella statua della Veritas il sembiante dell’amata Rosalia, va in escandescenze e sviene.
Come si vede da questa veloce sintesi il primo capitolo di Retablo consegna subito al lettore una pluralità di toni: l’incipitlirico, la seduzione e il raggiro di Isidoro che rinvia all’archetipo novellistico di Boccaccio, la rappresentazione della baraonda della Cala, non priva di dettagli bassi, spuri e scatologici, la descrizione dettagliata dell’oratorio serpottiano. Il primo apparire di Rosalia tra i vicoli di Palermo è una delle tante ekphrasis nascoste che costellano la narrazione, annunciata da un preciso riferimento al «riquadro», ovvero alla finestra da cui si sporge la ragazza in compagnia della madre:
Alzai gli occhi e vidi nel riquadro, ah, la mia sventura!, la donna che teneva la funicella del panaro e accanto una fanciulla di quindici o sedici anni, la mantellina a lutto sulla testa che lei fermava con graziosa mano sotto il mento. E gli occhi tenea bassi per vergogna, ma da sotto il velario delle ciglia fuggivan lampi d’un fuoco di smeraldo. Mai m’ero immaginato, mai avevo visto in vita mia, in carne o pittato, un angelo, un serafino come lei.[42]
La scena, più che un generico riferimento all’Annunciata antonelliana di palazzo Abatellis, rinvia ad un’opera di Bartolomé Esteban Murillo, Las Gallegas, ovvero Due donne galiziane alla finestra, custodita alla National Gallery di Londra: un riferimento fino ad oggi non evidenziato dalla letteratura critica, tuttavia ricco di impliciti che contribuiscono a connotare la figura di Rosalia. Nel dipinto appaiono due donne, una giovane e una matura, che affacciandosi alla finestra ammiccano al passante-spettatore: un espediente che, attraverso lo sguardo muliebre, tende ad oltrepassare lo spazio della tela, come spesso accade nelle opere del secentista spagnolo. Si tratta di un dipinto di genere popolaresco, una scena di seduzione in cui è forse raffigurata una giovane prostituta con la sua mezzana. Il dettaglio della mantellina fermata con la mano sotto il mento è puntualmente riscontrabile nella descrizione di Retablo e si fa indice dell’esatta referenzialità del testo consoliano. L’ekphrasis delinea dunque l’immagine ambivalente della giovane, il cui atteggiamento, in apparenza pudico, dissimula una capacità seduttiva rivelata dallo sguardo che, «sotto il velario delle ciglia», emana, secondo una significativa sinestesia, «lampi d’un fuoco di smeraldo».[43]

Fin dalla prima apparizione, dunque, Rosalia è rappresentata secondo le valenze ambigue della donna levatrice e sprofondatrice, una duplicità iscritta nel suo stesso nome composto che rinvia alla patrona palermitana, quella Santa Rosalia nella cui iconografia, inventata nei primi decenni del Seicento, confluiscono non pochi statuti rappresentativi della Maddalena.[44] Un percorso iconografico certo non ignoto a Consolo che, nell’inno di Isidoro, si avvale dell’oscillazione tra la figura laica e quella profana di Rosalia, facendo riferimento alla statua marmorea della santa venerata nel santuario di Monte Pellegrino.[45]
Già in Oratorio, dunque, la giovane donna appare ad una finestra, tecnema della visione non dissimile dalla cornice di un dipinto,[46] viene ricordata attraverso il simulacro marmoreo della santa, la si immagina rappresentata in una delle figure in stucco dell’oratorio serpottiano, è evocata ripetutamente nelle catene paronomastiche e nella dimensione ecoica dell’inno incipitario che scompone e richiama ripetutamente il suo nome: tutti simulacra del sentimento amoroso concepito da Isidoro, espressione dell’ossessione del fraticello e dell’intangibilità di uno sfuggente oggetto del desiderio.[47] Per altro, nella rappresentazione laico-profana di Rosalia e nelle reduplicazioni della sua immagine, è facile scorgere la suggestione de Gli elisir del diavolo di Hoffmann.
Tra le statue che ritraggono Rosalia vi è l’allegoria serpottiana della Verità che, secondo lo statuto iconografico, è rappresentata come Nuda Veritas. La descrizione del teatro plastico settecentesco è una delle più note icone autoriali incastonate nel libro che nasconde, nella stessa rappresentazione degli stucchi rischiarati da un raggio di sole, l’ekphrasis di un dipinto di Clerici. Il raggio che penetra nell’aula, che colpisce una ninfa di cristallo e, rifrangendosi, illumina le statue, è lo stesso che si può scorgere in una tela del pittore milanese, La grande confessione palermitana: il chiarore diffuso dal raggio solare, consustanziale al «bianco puro»[48] dell’oratorio, rivela nel dipinto una natura luttuosa che lega le candide statue all’immagine funerea dei corpi imbalsamati delle catacombe dei Cappuccini di Palermo. Ecco che il testo consoliano, in una vertiginosa sovrapposizione, include in una descriptio un’altra ekphrasis. Come ha rilevato Maria Rizzarelli: «L’ordine delle somiglianze che nel Sorriso costituiva il principio gnoseologico della conversione ideologico-sociale del Mandralisca, diviene qui ordine delle apparenze, da fondamento conoscitivo si trasforma, attraverso l’esasperante trionfo della figura del doppio, in ordine dell’illusione con cui s’identifica l’arte».[49]
La rappresentazione dell’oratorio è il punto culminante del capitolo iniziale di Retablo. Se in questa prima parte del romanzo si incontrano alcuni grandi pittori e artisti (un rapido cenno è dedicato anche al dipinto palermitano di Caravaggio, la Natività), il secondo capitolo, Peregrinazione, è totalmente incentrato sulla figura di Clerici che, accompagnato da Isidoro, intraprende il suo viaggio e la sua esplorazione della Sicilia.

Anche Clerici viaggia per l’isola con l’intento di dimenticare la donna amata, Teresa Blasco, futura sposa di Cesare Beccaria e dunque futura nonna di Alessandro Manzoni.[50] Alla nobildonna milanese, il cui padre ha origine spagnola e la madre siciliana, il cavaliere dedica il suo diario di viaggio. Fin dalla Dedicatoria, indirizzata a Teresa, Clerici si dice intenzionato a illustrare e a narrare la patria materna della donna, rivelando così l’intenzione di avvalersi sia della parola che dell’immagine, di usare entrambi i codici per rappresentare la Sicilia.[51] Del resto, già in Oratorio, l’aristocratico viaggiatore è stato presentato da Isidoro in virtù della sua abilità di disegnatore: «Quel don Fabrizio che sbarcò in Palermo, con la fortuna mia, per viaggiare l’Isola, scoprire l’anticaglie e disegnar su pergamene con chine e acque tinte templi e colonne e statue di cittate ultrapassate».[52] Lo stesso cavaliere, ben presto, sente l’esigenza di porre sotto gli occhi di donna Teresa non solo le immagini del mondo classico, i monumenti antichi, ma anche le brutture della società contemporanea. Clerici si rivela, dunque, un viaggiatore assai lontano da compiacimenti arcadici e vagheggiamenti idilliaci, dall’eterno archetipo della pastorale teocritea e dalle sue riprese settecentesche. Le sue intenzioni e il suo sguardo disilluso preannunciano un motivo che diventerà dominante nei successivi romanzi consoliani, il contrasto tra la memoria del passato e un presente di rovina, immemore e degradato.
Il percorso di Clerici ricalca parzialmente quello del Grand Tour nella Sicilia occidentale: Palermo, la vicina Monreale, Alcamo, Segesta, Selinunte, Mozia e Trapani. Retablo rimodula dunque, attraverso una complessa trama intertestuale, temi e motivi propri dell’odeporica settecentesca, configurandosi come un Voyage pittoresque, un Conte philosophique e un romanzo picaresco. Lo sguardo di Clerici è quello straniante del pittore, aduso a scrutare le fisionomie, a indovinare l’animo di chi gli sta di fronte. La sua visione è arguta e disincantata, in altre parole è quella di uno smaliziato e inquieto viaggiatore novecentesco, anche se le illusioni, gli apparati effimeri, le rifrazioni, le quinte teatrali e i retabli ingannevoli appaiono ad ogni passo del suo viaggio, adatte a rappresentare le oltranze immaginative di pittori, scultori e architetti della Sicilia barocca o tardobarocca. Il trionfo della teatralità e la voglia di destare meraviglia trovano il culmine nella descrizione di Alcamo, la patria del Soldano Lodovico, il luogo dove si riunisce l’Accademia de’ Ciulli Ardenti che, con la sua poesia edulcorata e pretenziosa, non rende onore all’autore del Contrasto. È qui che, in occasione della festa del paese, appare il Retablo de las meravillas, un apparato aniconico e illusorio in cui ogni spettatore può proiettare e scorgere i suoi fantasmi.
Nell’ultimo capitolo di Retablo, Veritas, Rosalia racconta finalmente la sua verità: realmente innamorata di Isidoro, è divenuta una cantante che si appresta a debuttare in una rappresentazione della Vergine del Sole di Cimarosa. Ospite nel palazzo di un munifico marchese, è stata educata al bel canto da don Gennaro Affronti, un artista castrato che le ha fatto da «padre» e da «madre».[53] Rosalia si è dunque mantenuta fedele ad Isidoro, convinta che per preservare un amore sia necessaria la sua cristallizzazione. Per questo esorta l’amato a ritornare alla vita passata ed alla sicurezza claustrale.
Ogni aspetto della vita e dell’arte, in Retablo, si rivela illusorio: l’amore di Isidoro e Rosalia verrà preservato solo a costo di una monacazione spirituale; l’amore concepito da Clerici per donna Teresa Blasco non è ricambiato. Frequenti sono i dubbi, espressi dallo stesso Clerici, sulla possibilità di rappresentare quant’egli ha osservato nel suo viaggio: l’impotenza dell’arte è metaforizzata dalla condizione del castrato don Gennaro, ovvero dalla sua impotentia generandi. L’uso sapiente dei costrutti ecfrastici e delle rifrazioni che sembrano riproporsi ad infinitum allude all’intangibilità della realtà. Motivi che percorrono in modo insistito l’opera di Consolo e, dopo essersi affacciati in Retablo, passando per un testo capitale come Catarsi, giungono alle pagine intensamente patemiche dello Spasimo. Ma anche per viam negationis l’autore, col vertiginoso spessore palinsestico della sua opera, ha riaffermato la necessità dell’arte e della scrittura, del nesso intimo tra parola e immagine, del loro irrinunciabile valore tetico.
1 Cfr. M. Á. Cuevas, ‘Ut Pictura: El imaginario iconográfico en la obra de Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10, 2005, pp. 63-77.
2 G. Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole (FI), Cadmo, 2001, p. 130.
3 La citazione è tratta da S. Puglisi, Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla scrittura di Vincenzo Consolo, Acireale-Roma, Bonanno, 2008, p. 207.
4 Cfr. G. Genette, I titoli, in Id., Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1989, pp. 55-101.
5 V. Consolo, Fuga dall’Etna, Roma, Donzelli, 1993.
6 Per le immagini di Fuga dall’Etna e dei suoi bozzetti cfr. F. Carapezza Guttuso (a cura di), Guttuso. Capolavori dai musei, Milano, Mondadori Electa, 2005, pp. 60-61.
7 V. Consolo, Retablo, Palermo, Sellerio, 1987, ora in Id., L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2015, p. 417. Tutte le successive citazioni saranno tratte da questa edizione.
8 Cfr. G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, Torino, Einaudi, 1991, pp. 630-631.
9 Per uno studio della fitta intertestualità de Lo Spasimo di Palermo mi permetto di rinviare a D. Stazzone, ‘Testi e intertesti in Vincenzo Consolo: Lo Spasimo di Palermo’, in F. Cattani, D. Meneghelli (a cura di), La rappresentazione allo specchio. Testo letterario e testo pittorico, premessa di S. Albertazzi, M. Cometa, M. Fusillo, Roma, Meltemi, 2008, pp. 185-201.
10 Adotto qui le definizioni di «icona autoriale» ed «ekphrasis nascosta» proposte in M. Á. Cuevas, ‘L’arte a parole. Intertesti figurativi nella scrittura di Vincenzo Consolo’, in R. Galvagno (a cura di), «Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, introduzione di A. Di Grado, Avellino, Biblioteca di Sinestesie, 2015, pp. 17-37. Di notevole valore teorico è l’introduzione alla raccolta degli scritti per artisti di Consolo: M. Á. Cuevas, ‘L’arte a parole’, in V. Consolo, L’ora sospesa ed altri scritti per artisti, Valverde (CT), Le Farfalle, 2018, pp. 9-16.
11 M. Á. Cuevas, L’arte a parole, p. 29.
12 P. V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, Torino, Bollati Boringhieri, 2005, p. 38.
13 M. Á. Cuevas, L’arte a parole, p. 30.
14 Quanto al palinsesto consoliano cfr. D. O’ Connell, ‘Consolo narratore e scrittore palincestuoso’, Quaderns d’Italià, 13, 2008, pp. 161-185; D. O’ Connell, ‘Furor melancholicus: poetica pittorica nella narrativa di Vincenzo Consolo’, in D. Perrone, N. Tedesco (a cura di), Letteratura, musica e arti figurative tra Settecento e Novecento, Firenze, Franco Cesati, 2014, pp. 147-160.
15 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1976, ora in Id., L’opera completa, p. 127. Tutte le successive citazioni saranno tratte da questa edizione. Per una storia critico-genetica ed alcune valutazioni filologiche sul Sorriso cfr. N. Messina, ‘«Il sorriso dell’ignoto marinaio» di Vincenzo Consolo. Un approccio a III Morti sacrata’, in J. Eynaud (a cura di), Interferenze di sistemi linguistici e culturali nell’italiano, Atti del X Congresso AIPI (Università di Malta, La Valletta, 3-6 settembre 1992), Zabbar (Malta), Gutemberg Press, 1993, pp. 141-163; N. Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo «Il sorriso dell’ignoto marinaio», tesi di Dottorato, Universitad Complutense, Madrid, 2007, [accessed 17 February 2020]; D. O’ Connell, ‘“And he a face still forming”: Genesis Gestation and Variation in Vincenzo Consolo’s Il sorriso dell’ignoto marinaio’, Italian Studies, 1, 2008, pp. 119-140.
16 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, p. 143-144.
17 Sul rapporto tra Consolo e Sciascia cfr. C. Madrignani, ‘Dopo Sciascia’, La rivista dei libri, novembre 2001, pp. 26-29; M. Á. Cuevas, ‘Parole incrociate: Sciascia e Consolo’, in L. Trapassi, Leonardo Sciascia, un testimone del secolo XIX, Acireale-Roma, Bonnanno, 2012, pp. 195-206. Quanto alla funzione delle epigrafi nell’opera consoliana mi permetto di citare D. Stazzone, ‘Tra palinsesto e paratesto: le epigrafi di Consolo’, Quaderns d’Italià, 21, 2016, pp. 183-192.
18 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, p. 161.
19 Ivi, p. 219.
20 M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 2012, p. 135.
21 Si fa cenno alla nozione di «repertorio» elaborata da W. Iser, L’atto di lettura. Una teoria della risposta estetica, Bologna, il Mulino, 1987.
22 M. Cometa, La scrittura delle immagini,p. 116.
23 Ivi, p. 121. 24 Ivi, p. 140.
25 La Crocefissione, custodita al Koninklijk Museum voor Schone Kunstern di Anversa, è un olio su tavola realizzato da Antonello nel 1475, durante la sua permanenza a Venezia. Cfr. M. Lucco (a cura di), Antonello da Messina. L’opera completa, Cinisiello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2006, pp. 216-221.
26 Cfr. M. Á. Cuevas, ‘Ancora su Antonello’, Testo, 59, 2010, pp. 117-124.
27 Cfr. R. Galvagno, ‘«Bella la verità». Figure della verità in alcuni testi di Vincenzo Consolo’, in Ead. (a cura di), «Diverso è lo scrivere»,pp. 39-64.
28 Cfr. S. Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del «Sorriso dell’ignoto marinaio», Palermo, Sellerio, 2011, p. 44. Per l’iconografia di San Gerolamo cfr. H. Friedmann, A Bestiary for Saint Jerome. Animal Symbolism in European Religious Art, Washington D.C., Smithsonian Institution Press, 1980, pp. 291-293. Per l’iconografia di San Gerolamo nelle opere consoliane cfr. S. S. Nigro, ‘Gerolamo e Agrippino’, La Sicilia, 15 novembre 1988.
29 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 141-142.
30 Ivi, p. 135. 31 Ivi, p. 142.
32 Si pensi al don Eugenio Uzeda dei Vicerè di De Roberto o al don Tindaro del Marchese di Roccaverdina di Capuana.
33 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 134-135.
34 Ivi, p. 142. 35 V. Consolo, Fuga dall’Etna, p. 45.
36 C. Segre, ‘La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo’, in Id., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi,1991, p. 83.
37 Cfr. V. Consolo, Conversazione a Siviglia, a cura di M. Á. Cuevas, Caltagirone (CT), Lettera da Qalat, 2016, pp. 45-46.
38 Si tratta di un dettaglio de La grande confessione palermitana, riprodotto nella prima copertina di V. Consolo, Retablo, Torino, Sellerio, 1987.
39 Il racconto della scoperta sciasciana del dipinto di Manetti è in F. Clerici, ‘L’eremo, l’abate e il diavolo’, in Id., Di profilo, a cura di M. Carapezza, Milano, Novecento, 1989, pp. 267-271.
40 Per alcune valutazioni complessive su Retablo cfr. N. Zago, ‘C’era una volta la Sicilia. Su «Retablo» e altre cose di Consolo…’, in Id., L’ombra del moderno, da Leopardi a Sciascia, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1992; G. Turchetta, ‘Il luogo della vita: una lettura di «Retablo»’, in M. Lanzillotta, G. Lo Castro, E. Porciani, C. Verbaro (a cura di), Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola, Pisa, 2014, ETS, pp. 647-656.
41 È evidente il simbolismo onomastico adottato da Consolo: il cavaliere Clerici, infatti, approdando a Palermo, salva Isidoro, lo trae dall’abisso in cui era sprofondato e gli permette di rinascere a nuova vita. Ma il nome del «pacchetto Aurora», nel continuo gioco di allusioni che caratterizza la scrittura consoliana, rinvia anche all’incrociatore russo che, nel dicembre 1908, portò soccorso alla popolazione di Messina dopo il terremoto che aveva raso al suolo la città siciliana e Reggio Calabria. L’Aurora, per altro, ebbe un ruolo di primo piano nella rivoluzione d’Ottobre, sparando il primo colpo d’arma da fuoco dal castello di prua, segnale dell’inizio della rivoluzione.
42 V. Consolo, Retablo, p. 371. 43 Ibidem.
44 Per l’iconografia della patrona palermitana Santa Rosalia cfr. M. Cometa, Descrizione e desiderio. I quadri viventi di E. T. A. Hoffmann, Roma, Meltemi, 2005.
45 V. Consolo, Retablo, p. 369.
46 Quanto alla finestra, alla sua funzione di tecnema della visione e al suo ruolo nelle descrizioni letterarie cfr. P. Hamon, Imagerie. Littérature et imageau XIX e siècle, Paris, Édition José Corti, 2001.
47 Cfr. il saggio di R. Galvagno, «Bella la verità», pp. 39-64.
48Ibidem.
49 M. Rizzarelli, ‘Un Retablo come uno specchio. Le voyage pittoresque del cavaliere Fabrizio Clerici’, in A. Ottieri (a cura di), Ai margini della letteratura. Le “scritture contaminate”, Sinestesie, IV, 2006, p. 92.
50 Per i rapporti tra Retablo e l’Illuminismo lombardo cfr. G. Albertocchi, ‘Dietro il Retablo. «Addio Teresa Blasco, addio marchesina Beccaria». Leggere Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10, 2005, pp. 95-111, ora in G. Albertocchi, «Non vedo l’ora di vederti». Legami, affetti, ritrosie nei carteggi di Porta, Grossi e Manzoni, Firenze, Clinamen, 2011, pp. 141-159.
51 Cfr. V. Consolo, Retablo, p. 379. 52 Ivi, p. 370. 53 Ivi, p. 473.
da Arabeschi n. 15
La lumaca, l’andamento a spirale e la sfida al labirinto
La lumaca, l’andamento a spirale e la sfida al labirinto: una lettura di Vincenzo Consolo,
di George Popescu Literatura Italiana
Prima di leggere i libri di Vincenzo Consolo, ho letto qualche recensione e soprattutto alcune sue interviste che tra l’altro sono vere e proprie arti poetiche, manifesti letterari e civili di una grande e acuta profondità del pensiero, capaci da se’ di far crescere l’interesse e la curiosità per la sua opera. E tutto questo devo dire, per quella straordinaria disponibilità con la quale si mette direttamente al centro della problematica e, poi, per la sincerità confermata da ogni frase, da ogni parola a parlare apertamente del suo lavoro, delle sue ossessioni estetiche e non solo. Mi ha sconvolto innanzi tutto la riflessione acutissima con la quale discute aspetti controversi di poetica narrativa in un momento in cui questi problemi sono diventati così complicati, fino a generare lunghe e spesso faticose, orgogliose dispute che finiscono per complicare ancor di più le cose. O amor, Jacopo Tintoretto – Museu de Colônia Quella disponibilità, quella chiarezza e sopratutto quella sincerità, la franchezza, il suo modo di dire le cose senza nessuna intenzione di lusingare oppure di offendere la sensibilità del lettore costituiscono alcune delle qualità portanti del suo profilo letterario, capaci di configurare un modello di scrittore impegnato con la sua vita, con la vocazione e l’ardore nella propria scrittura e nel destino assunto, e assunto fino in fondo. Se la letteratura è ancora come dev’essere un problema di carattere, oltre il talento, oltre la vocazione vera, allora si può sostenere senza nessun rischio di approssimazione convenzionale che Vincenzo Consolo, a parte la dimensione particolare della sua scrittura, appartiene, a mio avviso, a quella tradizione di artisti per i quali il binomio arte e vita rappresenta un punto fermo di partenza e un punto fermo di arrivo; un progetto che fa coincidere il fuori e il dentro, realtà e coscienza, il destino, parola e cosa, società e individuo. La ricchezza del suo lavoro, in tutti gli aspetti che riguardano il rapporto io-mondo, io-reale, e in particolar modo le scelte stilistiche, il problema linguistico così essenziale per uno scrittore italiano offrono una moltitudine di prospettive dalle quali si può partire nella valutazione della sua opera. Si è parlato ad un certo momento di un carattere “intellettuale” della sua scrittura; ho già usato le virgolette per questo aggettivo, perché in effetti ogni costrutto che assume l’intento di un prodotto artistico non lo può escludere, non lo può evitare. Tra l’altro perché – si sa bene oggi forse meglio di ieri – che purtroppo esiste una allucinante arte di consumo che si rivolge prevalentemente ad un fruitore pigro, andando sempre verso le sue aspettative più facili, verso la sua comodità. Da questo punto di vista Consolo procede in una maniera tutta contraria: perché ha scelto di scrivere alla realtà, di affrontarla, forse non per cambiarla – sarebbe soltanto un sogno da sempre – ma per portarla sul piano della coscienza per destare nel lettore la curiosità, il coraggio di assumere la realtà integrale con tutte le sue insidie, e le sue deformazioni. Detto questo, vorrei iniziare, sfogliando alcune mie pagine di appunti raccolti in presa diretta dai testi del Nostro. Sempre aperture di prospettive, di letture, di percezioni senza la preoccupazione, almeno per adesso, di articolare un discorso lineare dotato di quella coerenza che deve restare come prima condizione di una interpretazione, per dire così, organica. Con la pubblicazione del suo primo libro, l’autore afferma di aver avuto già la consapevolezza di cosa sarebbero stati gli argomenti della sua scrittura e cosa gli interessava di più: Mi interessava – afferma lui – il mondo storico sociale, non mi interessavano i problemi personali o le indagini psicologiche. Mi interessava raccontare la Storia, la Sicilia e quindi ho proseguito su questa scelta di argomenti privilegiando quelli che erano i temi storico-sociali. Mi collocavo anche come stile, come tipo di espressione, su una linea sperimentale e di tipo espressivo. C’è già tutto qui: la scelta della “tematica” e l’opzione stilistica, i due pilastri di ogni lavoro letterario. Ebbene, la Storia, ma quale Storia, della Sicilia, però la storia è già qualcosa di infinito, non solo per la durata, ma anche per la sua dialettica interna, per il modo in cui viene vissuta e, poi, scritta-descritta, da chi, per chi e di chi assunta e con tante sofferenze, con delle conseguenze purtroppo irreversibili e via discorrendo. E proprio qui che sento il bisogno di chiamare in causa la metafora ormai famosa che è quella beniaminiana dell’Angelus Novus. Ricordiamola.: …un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che chiamiamo progresso, è questa bufera. Una metafora, questa beniaminiana, dell’angelus novus, che tra l’altro non identifica un angelo nuovo, bensì ci può ricordare anche la figura della Medusa con il suo sguardo mortale per chi cerca di affrontarla in faccia; possiamo poi evocare anche la metafora del labirinto ove anche se non vi sono delle macerie – oppure non si fanno vedere – c’è sempre lo sguardo impegnatissimo nel trovare quel punto debole del percorso da dove sperare a trovare la via d’uscita o meglio una via d’uscita… Ritorniamo all’opera di Vincenzo Consolo, cercando di trovare un punto di riferimento in grado di farci avvisare su qualche via (non di uscita, ma di entrata nel suo mondo, nel suo labirinto) possiamo contare. Operazione assai difficile; innanzitutto perché ce ne sono molti, voglio dire, molti punti di riferimento, nuclei semantici, nodi referenziali che possono diventare vere e proprie chiavi di lettura e di approccio; e, poi, in un secondo luogo, operazione difficile perché, proprio nel caso speciale di uno scrittore che ignora, rifiuta, addirittura respinge qualsiasi metodo prestabilito, assumere un punto di partenza o un altro come una specie di filo conduttore nella esegesi della sua opera sarebbe ancor una volta una scelta in limine, ugualmente rischiosa. Apriamo un’altra strada: Ecco, prese casualmente, altre alcune citazioni dalle quali si potrebbe iniziare un percorso esegetico. Procediamo, questa volta noi, in maniera metodica così da identificare una linea, diciamo così, tematica: Quando io ho pubblicato il mio primo libro, La ferita dell’aprile, ero consapevole di cosa fossero gli argomenti della mia scrittura e cosa mi interessava. Mi interessava il mondo storico sociale, non mi interessavano i problemi personali o le indagini psicologiche. Mi interessava raccontare la Storia, la Sicilia e quindi ho proseguito su questa scelta di argomenti, privilegiando quelli che erano i temi storico-sociali…. Allora, la scelta tematica era già identificata, e anche assunta: raccontare la Storia e propriamente una Storia, non solo quella della Sicilia, ma anche una sua parte, alcune pagine scelte tra tante ma poi, vedremo qual era il criterio impegnato in quella scelta. Invece molto significativo mi pare qui far interferire questo orientamento tematico dello scrittore con la metafora di Beniamino: qui interviene per darci una conferma l’autore stesso quando afferma che ha cercato “di scrivere delle narrazioni nel modo in cui intende questo genere Walter Benjamin, un tipo di scrittura o di racconto che appartiene ancora a una società pre-borghese”. Cosa significherebbe pre-borghese non mi pare così difficile da capire ma solo riducendo il discorso, sempre in base alle affermazioni dell’autore, a quella tipologia sociale per la quale Storia non ha alcun senso di progresso e tantomeno una base giustificatoria. Quel mondo quindi situato tra una civiltà ancora contadina nei suoi aspetti superficiali, formali, apparenti e che ha perso la sua coerenza di una volta, quella parte di sapienza di cui parla ancora la letteratura orale, e il mondo borghese, che forse, se non sbagliamo noi, ha attraversato quello del sottoproletariato, nel senso che si è fatto sfruttare, abbandonandolo per poi strumentalizzarlo con il preciso scopo di approfittare del suo lavoro. In tutte queste due categorie si ritrova un punto comune: la povertà, è da essa che poi scatena sempre il tentativo di opposizione, di confronto, di lotta, con l’intera scenografia che si conosce: speranza, attesa, fede e diffidenza, l’impegno diretto, il tradimento da alcune parti, e, alla fine, le sconfitte; ma sconfitte che conferiscono sostanza alla storia, le danno la propria consistenza, nel bene e nel male… Esiste poi un altro punto di riferimento (e di partenza), quello che ci porta all’idea di labirinto.Ecco, parlando vent’anni dopo, su Il sorriso dell’ignoto marinaio, Consolo avverte: I tre elementi allora, la rivolta contadina di Alcàra, i cavatori di pomice di Lipari e il Ritratto d’Antonello reclamavano una disposizione su uno spazio di rispondenze e di senso, in cui il Ritratto stesso, nel suo presumibile percorso da una Messina, già di forte connessione storica, cancellata dai terremoti, a Lipari, isola-regno d’esistenza, di mito, a Cefalù, approdo nella storia e nella cultura, disegnava un triangolo e un movimento da un mare d’incertezza e rassegnato destino (…), a una terra di consapevolezza e di dialettica. Questa planimetria metaforica verticalizzavo poi con un simbolo offertomi dal malacologo Mandralisca, quello della conchiglia, del suo movimento a spirale * . A proposito di Eliade, si può riflettere ad un’idea che potrebbe servire nell’operazione di decriptare alcuni significati portanti della letteratura consoliana e cioè quella indicata dal grande scienziato romeno con la formula l’incentramento del margine, o meglio il centrare del margine; come un massimo compito che Consolo assume così come intendiamo noi il suo operare sulla storia e sul reale e cioè quello riguardante strettamente la Sicilia, si potrebbe indicare almeno sul piano di un’ideologia letteraria, questo tentativo di far andare al centro (dell’interesse e della preoccupazione del lettore e non solo) ciò che si è chiamato il problema della Sicilia, la Sicilianità come quel modo di vivere difficile. Sempre con riferimento a Eliade, si deve invocare qui la sua metafora dell’eterno ritorno, che per l’altro è anche una metafora di estrazione romantica e, poi, in particolar modo, nietzscheana; tuttavia, in Eliade, la metafora si colloca puntualmente nel discorso sull’origine e sul dovere (quasi un segno di destino e di fatalità) di ritornare sempre nel punto di partenza, e così si genera, inculcata nella nostra vera e propria identità, una circolarità che alimenta, intrattiene, potenzializza la sofferenza, il dolore, una specie di pendant a quel male di vivere montaliano. Ecco come si colloca Consolo in funzione del motivo del ritorno all’origine, che infatti è un altro motivo ricorrente nelle sue meditazioni-riflessioni. Parlando del suo libro L’ulivo e l’olivastro, l’autore propone un aspetto particolare della sua Sicilia presente, ma sempre col riferimento al mito ulissiano e al tema del ritorno come un dovere antico, come destino. In Sicilia [afferma l’autore] si ritorna, non si può fare a meno. Così come Ulisse lascia la dolce terra dei Feaci per ritornare nella sua pietrosa Itaca. Non si può prescindere dai luoghi dove si è nati, dove si è cresciuti, dove si sono sentite le prime voci, dove si sono viste le prime luci. Sono luoghi che non si possono eliminare dalla nostra memoria. Si sente il sogno di tornare, malgrado tutto. E di qui che si va verso la metafora della lumaca, collocata anch’essa nel labirinto, vista come una rappresentazione di una’ascensione dal basso verso l’alto, e che può significare anche lo sprofondare e il perdersi all’apice di questa stessa spirale. E di nuovo la parola dell’autore: Ed è anche il simbolo, per studiosi di etnologia e di storia delle religioni, …il simbolo del labirinto. Ecco, dal labirinto, con intelligenza, si può uscire, oppure si può rimanere prigionieri. Ecco, quel simbolo io l’ho preso come il simbolo della storia, per cui i popoli, le popolazioni che si trovano in una infelicità sociale, possono rimanere prigionieri dentro questo labirinto a forma di spirale, oppure, seguendo il labirinto, possono uscire verso la realtà della storia e prendere consapevolezza della loro condizione sociale… Conclusione, una fra tante, emblematica, direi, per il lavoro del Nostro. Inutile evocare a questo punto una parola-concetto, una parola spia della scrittura di Consolo e appunto la parola greca nostos, che vuol dire proprio l’origine, quel ipogeo come il dovere di partire sempre dalle radici, che non per caso si trovano nel sottosuolo, nel sottoterra, quel luogo che fa da controcanto, da contropartita alla Storia nella visione e nella rappresentazione di Vincenzo Consolo. E di cui le immagini (di questi luoghi sotterranei, di queste caverne), sono un po’ il corrispettivo, della profondità della lingua e della profondità della storia è già un altro punto di partenza nell’approfondire l’opera consoliana. Ma si può continuare con l’idea di labirinto come una metafora così produttiva nel campo esegetico. Oltre il suo vastissimo e diversissimo campo semantico, mi pare opportuno sottolineare un fatto della poetica narrativa di Consolo: il rapporto che stabilisce tra l’idea di viaggio come esplorazione dello spazio, più quello del mare che della terra, il viaggio come anche ritorno, di un Ulisse che si trasforma così in un prototipo dell’eroe universale, un archetipo della sapienza, del conoscere, un navigatore ideale e insieme singolare. Pare superfluo ricordare che per Consolo, come per Dante, per Pirandello, la vicenda dell’eroe omerico con la sua intera disperazione, riguarda lo spazio siciliano, e anche quello terribile e insieme affascinante Stretto di Messina che diventa anch’esso ricorrente nell’opera del Nostro. Il tentativo di Ulisse, sommariamente indicato qui, punta sullo spazio cosicché, attraversarlo per conoscerlo equivale ad assumerlo. Un tentativo compiuto col sacrificio liminare, non di una sua possibile fine, morte, ma, con l’allontanamento dalla sua Itaca, coll’affrontare il rischio di perdere tutto ciò che aveva prima, regno e soprattutto l’amore incorporato nella figura di Penelope. Qui interviene un altro possibile punto di partenza nell’interpretare l’opera di Consolo: quello che potrebbe omologare la sua scrittura sullo stesso piano con la tela su cui Penelope sta ricamando, non qualcosa di utile, ma proprio l’attesa stessa che subentra così nel destino, suo, di Ulisse, di tutti noi. La scrittura come ricamo non mi risulta fuori del progetto scritturale dell’autore di Le pietre di Pantalica. La invoca anche, se mi ricordo bene. Invece sul piano stilistico, espressivo, poetico, il labirinto si presenta davvero come un riferimento preciso, assolutamente non casuale, legato ad una scelta che Consolo identifica in Calvino. Ed è per questo che si può chiamare in causa, per la sua specificità di poetica, la famosa formula calviniana La sfida del labirinto; ma il riferimento non significa altro che un possibile percorso della critica nella ricerca di altre chiavi di lettura per poter dare effettivamente, se questo fosse possibile e plausibile, un senso al mondo che ci propone un autore che resta – in quanto deve restare – ancora un mondo da interrogare, tramite un confronto sempre aperto alla coscienza del lettore… Ma quale sarà a questo punto l’offerta indicata, più adatta, della ricca e lunga semantica del labirinto? Quel gioco che ha, come ricorda Kerenyi, un significato rituale e che come tale serve a scongiurare – rappresentandola – la paura della morte, l’angoscia dell’uomo di fronte alla nullificazione di tutte le cose? Rifacciamo in breve lo scenario di questo gioco che si presenta in due tempi, in due fasi: l’entrata nel labirinto e il faccia a faccia col mistero, in cui gli attori sperimentano la perdita di se’; poi, il ritorno alla luce che rappresenti, diciamo, una nuova nascita, attestando la continuità della vita che di generazione in generazione rinnova se stessa. Fin qui, Kerenyi. Sono intervenute poi tante altre interpretazioni-soluzioni, come quella di Tagliaferri per il quale il labirinto potrebbe essere preso come una metafora di un utero materno e il filo di Arianna sarebbe allora un cordone ombelicale, il Minotauro diviene un embrione, un germoglio, un’ ombra inquietante con cui dobbiamo confrontarci. Per Calvino, si sa, si pone un altro tipo di richiesta, di interrogativo, di soluzione, tramite un’idea che l’abbiamo incontrata anche in Consolo, a proposito di un altro argomento, ma non così staccata, l’idea voglio dire, da questa prospettiva, torno a ripetere, di natura poetica e, se si vuole, di poiesis, come il far poetico. Per l’autore delle Cosmi-comiche, l’operatore interpretativo diventa un rapporto cartografico che include una distanza rispetto al labirinto: così, è facile trovare la via d’uscita quando il labirinto si osserva dall’esterno, quindi quando si dispone di una mappa totalizzante; invece, dal dentro e allorquando le mappe sono parziali e contraddittorie, succede che non solo sia possibile la salvezza, ma si va in una grave confusione, una specie di sostituzione dei topos, delle isole, appunto, perche’ coll’avvicinarsi il topos, l’isola cambia il nome, vuol dire anche l’identità. Ci fermiamo qui con la storia esegetica di un motivo-mito così complicato e insieme incitante. Ma non prima di focalizzare almeno una suggestione per la scrittura di Consolo: il labirinto per lui si presenta in veste di Storia, o meglio una sua pagina sempre della storia siciliana, identificata in alcuni momenti di rottura, di confusione, di sconvolgimento, e perciò necessitante di non una giustificazione, ma di una giusta ricostruzione in base alla quale sarà poi possibile denunciare quelle tracce, e quelle insidie, che ci provocano nel e dal presente. Angelus novusi, Paul Klee – The Israel Museum, Jerusalém Ed è per questo che rientra in scena proprio adesso la metafora beniaminiana dell’angelus novus; il quale, ricordiamoci, si trova fissato, prigioniero tra un passato per cui non basta la sua nostalgia a compiere il ritorno, ma non è possibile nemmeno andare avanti, nel futuro, per quella bufera che lo sconfigge. Ma il presente dov’è? Il presente non esiste, sulla linea di una dialettica elementare, è soltanto un passaggio, un passeggio, un limbo, quel purgatorio dantesco dove Virgilio ha quasi perso tutti i poteri e dove a Dante, come a tutti noi, è rimasto solo l’interrogarsi come la soluzione di orientamento. Ma l’idea di labirinto è un motivo di riflessione per il Nostro. Per Vincenzo Consolo, creatore di un’opera che non si impone ne’ per la quantità (dimensione, diversità di motivi, di argomenti), ne’ per l’imprudenza di lusingare i gusti, in gran parte pervertiti, corrotti dal consumismo, del lettore (un lettore che lo vuole, come sostiene, un po’ simile a se stesso), quindi per Vincenzo Consolo, la letteratura mi pare che sia una scommessa; e un riscatto: una scommessa con la Storia così come è sempre stata scritta-descritta, ma non vissuta; e un riscatto come tentativo di recupero per la mediazione della parola, diventata pietra, capace invece di esorcizzare il reale vero, quello vissuto, e mai tradito. In questa prospettiva, poetica, sento il bisogno di identificare la formula paradigmatica per il suo intero lavoro e che si può chiamare la testualizzazione del reale e che vuol dire un tentativo di trasmutazione, nel logos, quel ontos che possa essere preso come topos, ipogeo, nostos che dir si voglia.
19 maggio 2020 George Popescu Poeta, tradutor e professor de Literatura Italiana da Universidade de Craiova * Archetipo biologico e origine di percezione, conoscenza e costruzione, com’è nella Spirale delle calviniane Cosmi-comiche; arcaico segno centrifugo e centripeto di monocentrico labirinto, com’è in Kérenyi e in Eliade.

La Metafora del Sorriso. Vincenzo Consolo e l’Antonello del Mandralisca
Alessandro Dell’Aira
Editor, iberista
Incontrai Consolo per la prima volta a Madrid, nell’autunno del ’95.
Allora dirigevo la rivista “Quaderni” del Liceo Italiano Enrico Fermi,
di cui ero preside. L’Istituto Italiano di Cultura seguiva con interesse
il nostro lavoro e ci autorizzava a pubblicare i testi delle conferenze
che organizzava nella sua sede o patrocinava in Spagna. Certo di
fargli piacere, gli donai una copia della prima edizione italiana della
commedia di Lope sul Santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo,
da me curata, edita qualche mese prima a Palermo.
Consolo, in quell’autunno, lasciò Madrid per Barcelona e Salamanca,
dove tenne una lezione accademica, La retta e la spirale, su temi siciliani
intrecciati con la storia spagnola tra Rinascimento e Barocco. Cedette
generosamente ai “Quaderni” copia del testo che avrebbe poi inserito
in Di qua dal faro,1 che accennava anche alla commedia di Rosambuco
come esempio di legame interculturale nel Siglo de Oro, e si concludeva
con una riflessione amara e attualissima sul “dolore senza catarsi”.
Prima di inviare il dattiloscritto in tipografia mi venne il dubbio che
vi fosse un evidente refuso, perdita anziché perdida, nella trascrizione di
una quartina dalla Galatea di Cervantes incisa sull’arco d’ingresso di una
villa di Bagheria:
Ya la esperanza es perdida
Y un solo bien me consuela
1 “La Retta e la Spirale”, «Quaderni del Liceo Italiano di Madrid», 4 (giugno 1996),pp. 83-84. IL testo è preceduto da parte di un’intervista con Valeria Cioffi. Di qua dal Faro (d’ora in avanti DQF), in L’opera completa (d’ora in avanti OC), a cura di Gianni Turchetta, prefazione di Cesare Segre, Milano, Mondadori, 2015 (I Meridiani), pp.1234-1238.
Que el tiempo que pasa y buela
Llevará presto la vida.2
Chiamai Consolo a Barcelona: mi disse che avrebbe controllato. E infatti mi chiamò la mattina dopo, molto divertito. Mi aveva cercato a scuola qualche ora dopo, e in mia assenza gli aveva risposto Juanita, la custode. Consolo le disse: «Per favore, avvisi il preside che la esperanza es perdida». Juanita si allarmò: «No signore, questa brutta notizia al preside gliela dia lei. Richiami domani». Tutto avrei immaginato, tranne che sarei tornato su questo divertente equivoco ventitré anni dopo, per presentare a Valencia Sfidando L’Ignoto, diario narrato della ricerca condotta da Sandro e Salvatore Varzi e da me sul capolavoro di Antonello oggi nel Museo Mandralisca di Cefalù, celebrato da Consolo ne Il Sorriso dell’Ignoto marinaio. Corredato di note finali rigorose, Sfidando L’Ignoto è un saggio di ‘filologia leggera’, nel senso che non cede di una sillaba all’invenzione e agevola la condivisione di un percorso in cui non mancano fasi di incertezza e di suspense. Consolo, messo sulla pista del marinaio da Lucio Piccolo,3 precisò poi che non aveva mai creduto a quella diceria. Lo rivelò rievocando l’incontro con Roberto Longhi a Milano nel ’69, quando chiese notizie al noto critico d’arte sul primo capitolo del Sorriso che gli aveva inviato qualche tempo prima. Longhi gli rispose bruscamente: «Sì sì, ho letto
2 La villa-fortezza apparteneva a don Giuseppe Branciforti, conte di Mazzarino, capo di una congiura contro Filippo IV di Spagna, scoperta e sventata per tempo. L’iscrizione è del 1658. La quartina è abbinata a un emistichio di Torquato Tasso, O corte a dio. 3 Il sorriso dell’ignoto marinaio, d’ora in avanti SIM, Note e notizie sui testi, in OC, p. 1300. Secondo Consolo, il primo fotografo a riprodurre il quadro fu Domenico Anderson intorno al 1915 (OC, p. 1309). In realtà di trattò del fotografo palermitano Giovanni Fiorenza, autorizzato dalla Soprintendenza di Palermo il 22 giugno 1914, in vista della dichiarazione di rilevante interesse artistico e storico del ritratto, notificata l’11 febbraio 1916. Poiché non vi è traccia della riproduzione presso gli archivi della Fondazione Mandralisca, si suppone che la lastra venne acquistata nel 1930 da Domenico Anderson. Cfr. Sfidando l’Ignoto, Palermo, Ed. Torri del Vento, 2017
(d’ora in avanti SI), pp. 87-88, n. 28.
le sue pagine, ma questa storia del marinaio deve finire».4 Abbiamo inserito questa frase in quarta di copertina, consapevoli che la diceria sarà dura a morire. Il fatto nuovo è che ne abbiamo dimostrato l’infondatezza, partendo da un sigillo mai notato prima, apposto nel Settecento sul retro della tavoletta da un prozio del barone Mandralisca, l’arcidiacono Giuseppe Pirajno, all’epoca vescovo vicario di Cefalù. A
nostro parere, anche in assenza di fonti scritte, questo sigillo e varie altre evidenze iconografiche bastano a identificare il personaggio raffigurato nella tavoletta, misterioso come tutti gli ‘Ignoti’ di Antonello. Tuttavia, è bene che il gap tra Mistero e Ignoto persista: lo svelamento toutcourt toglierebbe al ritratto parte del fascino di cui lo stesso Consolo partecipa.5 Cesare Segre ha osservato che l’Antonello del Mandralisca è divenuto «una specie di doppio di Vincenzo Consolo».6 In ogni caso,
non c’è ricerca in grado di andare oltre quel sorriso-lumaca, «fiore
di ragione»,7 insondabile, condiviso dagli artisti in azione –pittore e
narratore– e dal modello in posa. A nostro parere si tratta di Francesco Vitale da Noja presso Bari, oggi Noicattaro. Dottore alla Sorbona in Teologia e Arti, precettore, segretario e ambasciatore di Ferdinando il Cattolico, valoroso umanista e profondo esperto di Duns Scoto, fu designato vescovo di Cefalù nel 1484, quando tra i diplomatici di Ferdinando e Isabella gli ‘aragonesi’ furono rimpiazzati dai ‘castigliani’. Si fece ritrarre su xilografie e medaglie. In Sicilia sostenne gli interessi della casa d’Aragona. Colto da ictus a Valencia nel 1491, dopo un soggiorno a Siviglia, rientrò a Cefalù
4 SI, p. 7, n. 1 con rinvii a Fuga dall’Etna e a MESSINA, N., “Per una storia di «Il sorriso dell’ignoto marinaio» di Vincenzo Consolo”, «Quaderns d’Italià», 10 (2005), pp. 113-126. 5 SI, pp. 75-76. Consolo non dubitò mai della provenienza ‘precaria’ del ritratto, da lui associato al cratere siceliota con la scena della vendita del tonno, acquistato dal barone a Lipari (La Pesca del Tonno, in DQF, OC, p. 1007). 6 SEGRE, C., “Un profilo di Vincenzo Consolo”, in OC, p. XVI. 7 Così in L’Olivo e l’olivastro (in OC, p. 853) Consolo definisce il sorriso dell’Ignoto, rivolto alla «grande storia di Palermo».
e vi mori in data incerta, comunque anteriore al 14 febbraio 1494.8 Quando il prozio del Mandralisca la fece propria, la tavoletta era molto malridotta. Forse non si sapeva più chi raffigurasse. Consolo si dimostra certo della provenienza liparitana del ritratto. Imposta la narrazione sulla «planimetria metaforica» Lipari-Cefalù- Messina,9 ma sa di non avere a che fare con un marinaio. Lo confermano due sue descrizioni, stilisticamente lontane ma convergenti. Nella prima si accenna alla reazione del barone, che stringe sotto un’ascella la tavoletta avvolta in una tela cerata, a bordo di un veliero stipato di gente e di mercanzie. Consolo descrive il ritratto con gli occhi del barone che scruta il misterioso Giovanni Interdonato, dopo i colpi di tosse che scuotono un vecchio cavatore di pomice:
[…] Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza
8 Vitale, semiparalizzato, il 10 marzo 1492 fece apporre una chiosa da altri sull’ultimo foglio di un incunabolo stampato a Venezia nel 1481, aggiungendo a margine un tremolante manu propria (SI, pp. 50-53). Il 12 febbraio 1494 Ferdinando il Cattolico scrisse di avere appena appreso della morte di Vitale (SI, p. 53, n. 53). Il documento è trascritto da Óscar Perea Rodríguez nella sua tesi di dottorato: «[…] en esta hora es venida aquí nueua que es fallecido maestre Francisco de Noya, obispo de Cefalú; y comoquier que no se sabe muy certificadamente si ello es assí, cordamos de vos preuenir de nuestra voluntat sobre la prouisión del dicho obispado […]» [Las cortes literarias hispánicas delsiglo XV: el entorno histórico del Cancionero general de Hernando del Castillo (1511). Universidad Complutense de Madrid, a.a. 2003-2004, p. 194 n. 587]. Da un documento della Curia cefaludense risulta che la sede di Cefalù fu dichiarata vacante nel febbraio del 1495. 9 Cefalù e l’Ignoto di Antonello sono uno dei vertici del triangolo metaforico. I cavatori di pomice liparitani e i rivoltosi di Alcàra Li Fusi occupano gli altri due. e vi mori in data incerta, comunque anteriore al 14 febbraio 1494.8 Quando il prozio del Mandralisca la fece propria, la tavoletta era molto malridotta. Forse non si sapeva più chi raffigurasse. Consolo si dimostra certo della provenienza liparitana del ritratto. Imposta la narrazione sulla «planimetria metaforica» Lipari-Cefalù- Messina,9 ma sa di non avere a che fare con un marinaio. Lo confermano due sue descrizioni, stilisticamente lontane ma convergenti.
Nella prima si accenna alla reazione del barone, che stringe sotto un’ascella la tavoletta avvolta in una tela cerata, a bordo di un veliero stipato di gente e di mercanzie. Consolo descrive il ritratto con gli occhi del barone che scruta il misterioso Giovanni Interdonato, dopo i colpi di tosse che scuotono un vecchio cavatore di pomice:
[…] Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza
8Vitale, semiparalizzato, il 10 marzo 1492 fece apporre una chiosa da altri sull’ultimo
foglio di un incunabolo stampato a Venezia nel 1481, aggiungendo a margine un tremolante manu propria (SI, pp. 50-53). Il 12 febbraio 1494 Ferdinando il Cattolico
scrisse di avere appena appreso della morte di Vitale (SI, p. 53, n. 53). Il documento
è trascritto da Óscar Perea Rodríguez nella sua tesi di dottorato: «[…] en esta hora
es venida aquí nueua que es fallecido maestre Francisco de Noya, obispo de Cefalú;
y comoquier que no se sabe muy certificadamente si ello es assí, acordamos de vos
preuenir de nuestra voluntat sobre la prouisión del dicho obispado […]» [Las cortes
literarias hispánicas delsiglo XV: el entorno histórico del Cancionero general de Hernando del Castillo (1511). Universidad Complutense de Madrid, a.a. 2003-2004, p. 194 n.587]. Da un documento della Curia cefaludense risulta che la sede di Cefalù fu
dichiarata vacante nel febbraio del 1495. 9 Cefalù e l’Ignoto di Antonello sono uno dei vertici del triangolo metaforico. I cavatori di pomice liparitani e i rivoltosi di Alcàra Li Fusi occupano gli altri due. dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vivuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e alle vicende loro. E, avvertivasi in colui, la grande dignità di un signore […].10
In questa oscillazione tra conoscenza e pietà, Consolo coglie da rabdomante il profilo di un conciliatore di storia e spiritualità, umanesimo e missioni diplomatico-ecclesiastiche. Vitale visse in mezzo agli uomini e alle vicende loro, ancor più di Interdonato, riconosciuto da Mandralisca nell’Ignoto del ritratto, mentre di notte, nel suo studio, si concentra sulla tavoletta appesa a una parete tra gli scaffali. Un’agnizione-insight degna di un romanzo di Dumas. Per quanto ci risulta, tuttavia, il barone non era certo, o ignorava di possedere un Antonello prima che nel gennaio del 1860 Giovan Battista Cavalcaselle, in casa sua, ne ricavasse un geniale bozzetto. Cavalcaselle, garibaldino mazziniano esule a Londra dopo il 1849, critico d’arte e pittore, giunto in Sicilia per ragioni di studio qualche mese prima di Garibaldi, forse con una missione coperta, è una specie di doppio attenuato del democratico Interdonato. Nella seconda descrizione, a tratti impressionistica, risuonano il lessico e i luoghi comuni dei frequentatori di pinacoteche. Ha per sfondo una festa organizzata dal barone in casa sua per presentare il ritratto ad amici e conoscenti. Quando Enrico sfila il panno dal leggìo su cui ha collocato la tavoletta, l’Ignoto si svela e il Mistero, volendo rubare il titolo a un romanzo di Marco Malvaldi, si accentua «negli occhi di chi guarda»:
[…] Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal busto e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta,
10 SIM, in OC, pp. 129-130.
le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini. Il personaggio fissava tutti negli occhi, in qualsiasi parte essi si trovavano, con
i suoi occhi piccoli e puntuti, sorrideva a ognuno di loro, ironicamente, e ognuno si sentì come a disagio […].11
Come nel cambio di scena di un’opera lirica, questa seconda
descrizione è interrotta da colpi di schioppo e abbaiar di cani in
lontananza, equivalenti ai colpi di tosse del cavatore a bordo del veliero.
Dal suo leggìo, l’Ignoto sembra allargare il sorriso in un ghigno. In un
angolo del salone, il cefalutano Salvatore Spinuzza, pressoché ignorato
dagli altri invitati perché ‘facinoroso’ come Giovanni Interdonato,
rabbrividisce.
Di qua dal faro, pubblicato nel ’99, contiene il testo della conferenza
salmantina del ’95, affidato quattro anni prima ai «Quaderni del Liceo
Italiano». Tra gli altri ‘pezzi’, contiene anche un bilancio d’autore sul
Sorriso vent’anni dopo, definito come metafora del superamento dei
«romanzi d’intreccio dispiegati e dominati dall’autore», come approdo
alla pari dignità dialettica dei linguaggi, «compresi quelli marginali».12
Consolo è entrato da anni in una fase nuova. Coglie nel segno Joseph
Francese quando afferma che gli attentati mafiosi dei giudici Falcone e
Borsellino, mesi in atto nel ’92 per conto di raffinati mandanti, segnano
il passaggio definitivo di Consolo dall’aventino sciasciano all’impegno
politico scoperto.13 E quanto al «parricidio» da lui perpetrato, ingrato
e miope è il giudizio di chi lo ha definito «un infelice che voleva essere
11 Ivi, pp. 143-144.
12 CONSOLO, V., “Il «Sorriso» vent’anni dopo”, in DQF, OC, p. 1254.
13 FRANCESE, J., Vincenzo Consolo. Gli anni de «L’Unità» (1992-2012), ovvero la
poetica della colpa-espiazione, Firenze, University Press, 2015.
Sciascia».14 Se Sciascia fu un superbo autore di romanzi e saggista, Consolo fu un artista, un linguista, un «orafo della parola». A tanta distanza da quell’equivoco sulla esperanza perdida, che allarmò la simpatica custode del Liceo Italiano, verrebbe da dire che nulla accade per caso. C’è ancora speranza. Il dibattito in ambito letterario e non solo, che in quei giorni Consolo giudicava «quasi spento»,15 è in agonia, ma il decesso del romanzo non è sopravvenuto. A rantolare, semmai, sono i lettori. Da rappresentazione del reale e dell’esistenziale, da intreccio di storie più o meno rilevanti o defilate, la letteratura di oggi si apre allo svelamento di crimini sommersi (per esempio, in Resto qui, di Marco Balzano, che nel 2015 ha vinto il Campiello con la storia di un giovane del Sud immigrato a Milano). In Italia, in Spagna, in Europa,
la narrativa si è aperta all’epica delle culture migranti e alle voci critiche dai paesi ‘banditi’, quelli che il presidente USA in carica ha definito latrine. Scrittori-migranti e migranti-scrittori,16 protagonisti dell’epica dell’andare e venire viaggiando, narrano storie di emarginazione nelle lingue dell’Unione. Sicché la partita non è persa del tutto. Tra guerre e violenze endemiche, speculazione spietata, politici e amministratori corrotti, vincere l’impotenza si può, sorridere da lumache si può, con
o senza il supporto dell’ideologia, ma senza rinunciare alla speranza e senza bandire l’immaginazione creativa. La speranza, se cade, trova sempre il modo di rialzarsi. Diversamente dal sorriso, non è mai stata quel che si dice una metafora, neppure in letteratura.
14 CARUSO, C., “Vincenzo Consolo: «Un infelice che voleva essere Sciascia». Il ricordo del fotografo Fernando Scianna amico di Vincenzo Consolo, che Mondadori pubblica nella Collana «I Meridiani»”, «Panorama», 9 febbraio 2015. 15 In I ritorni (in DQF, OC, p. 1121) Consolo scrive: «Crediamo che oggi, per la caduta di relazione tra la scrittura letteraria e la relazione sociale, non si possono che adottare, per esorcizzare il silenzio, i moduli stilistici della poesia; ridurre, per rimanere nello spazio letterario, lo spazio comunicativo, logico e dialogico proprio del romanzo». 16 La distinzione è del brasiliano Julio Monteiro Martins, scomparso a Lucca nel 2014.

Il punto scritto: genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio
DARAGH O’CONNELL
In un’intervista fatta a Vincenzo Consolo parecchi anni fa, lo scrittore siciliano ha parlato della “fantasia creatrice” come di un elemento femminile con il quale si può uscire dal cerchio della ragione, un cerchio simboleggiato dalla metafora della “chiocciola” nel Sorriso dell’ignoto marinaio (O’Connell, 2004: 238-253). Questa fantasia creatrice nel romanzo, si muove nei panni del personaggio Catena Carnevale la fidanzata che sfregia il sorriso ironico e pungente del ritratto e, in seguito, ricama la tovaglia di seta intitolata «L’albero delle quattro arance «. La descrizione nel libro di questa tovaglia e fondamentale e assomiglia per certi versi proprio allo stile della scrittura consoliana, ed e in realtà una metafora per il testo stesso, se non l’intero progetto letterario di Consolo. Leggiamo: Sembrava, quella, una tovaglia stramba, cucita a fantasia e senza disciplina. Aveva sì, tutt’attorno una bordura di sfilato, ma il ricamo al centro era una mescolanza dei punti più disparati: il punto erba si mischiava col punto in croce, questo scivolava nel punto ombra e diradava fino al punto scritto. E i colori! Dalle tinte più tenui e sfumate, si passava d’improvviso ai verdi accesi e ai rossi più sfacciati. Sembrava, quella tovaglia, – penso la baronessa, – ricamata da una invasa dalla furia, che con intenzione ha trascurato regole numeri misure e armonia, fino a sembrare che la ragione le fosse andata a spasso. (Consolo, 2015: 167-168) Questa analogia tra la scrittura letteraria e il ricamo e lo sfregio di Catena, richiama proprio la poetica distintiva di Consolo: una poetica palinsestica che prevede l’accumulo e l’elisione di vari testi di provenienza diversa, siano essi di stampo giornalistico, creativo o saggistico, in uno spazio di singolare gestazione autoriale fra polifonia e palinsesto (O’Connell, 2008: 161-184). Queste pagine intendono analizzare, da diversi punti di vista, il primo capitolo del longseller di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), delineando l’evoluzione del romanzo dalla sua forma primigenia fino alle più recenti rielaborazioni. Saranno messe a fuoco alcune varianti testuali (Messina, 2009: 143-202) e dichiarate le fonti, letterarie e non, sottese all’intero capitolo. Il primo capitolo e in effetti, a mio avviso, un grande palinsesto, e molte delle procedure adottatevi da Consolo richiamano una polifonia e una concezione alla Bachtin ell’enciclopedismo, la sua definizione di romanzo di Seconda linea. In più, il capitolo I sancisce in realtà molti aspetti della nuova poetica di Consolo, che in definitiva rappresenta lo spazio letterario in cui il passaggio da riso a sorriso e più evidente. Consolo conclude cosi la Nota dell’autore, vent’anni dopo aggiunta come postfazione dell’edizione Mondadori del 1997: […] che senso ha la riproposta di questo Sorriso? E la risposta che posso ora darmi e che un senso il romanzo possa ancora trovarlo nella sua metafora. Metafora che sempre, quando s’irradia da un libro di verità ideativa ed emozionale, allarga il suo spettro con l’allargarsi del tempo. (Consolo, 1997: 183)2 Sono passati vent’anni da queste enunciazioni, e oggi il testo sfaccettato di Consolo ha cominciato a ricevere il trattamento critico che merita. Abbiamo avuto oltre quarant’anni per metabolizzare e situare un romanzo della sua importanza, non solo nel contesto della narrativa italiana del ventesimo secolo, ma anche in quello dell’evoluzione poetica di Consolo. Si dovrebbe, pertanto, entrare nel cuore del dibattito su questo allargarsi del tempo, contribuire attivamente alla crescita di questo corpus critico-accademico con al centro la poetica di Consolo. Tuttavia, in questo approccio al capitolo I, ciò che più ci preme non e tanto il suo allargarsi nel tempo, quanto il suo restringervisi, cercando di individuare con esattezza i momenti cardine della composizione del testo. Sarebbe erroneo, in tanti sensi interconnessi, dire che Il sorriso e un testo nel fiore dei suoi quarant’anni. Quando leggiamo le mini-biografie sulle copertine dei libri di Consolo, siamo portati a credere che Il sorriso sia un prodotto testuale della metà degli anni ’70 e perfettamente inserito nel suo tempo. In realtà, va sottolineato che Il sorriso e un testo mutevole, «un lavoro perennemente mobile e non finibile», per dirla con Contini (1970: 5), la cui genesi può essere collocata intorno alla metà degli anni ’60 e le cui più recenti articolazioni possono essere datate al 1997. Questo saggio intende dimostrare che Il sorriso si può considerare come un atto letterario il cui incipit – non solo testuale, ma anche concettuale – e retrodatabile a cinquant’anni fa. Fuori dalla storia del testo in quanto tale, alcune delle tematiche e delle metafore de Il sorriso sono apparse in diverse guise, in altre narrazioni più tarde di Consolo. Sia Nottetempo, casa per casa sia L’olivo e l’olivastro si riferiscono esplicitamente al Ritratto d’uomo di Antonello (Consolo, 1992a: 138-139 [Consolo, 2015: 142-143]; Consolo, 1994: 124-125 [Consolo, 2015: 852- 853]). Per cui si può dire che Il sorriso, dal suo livello ipertestuale originario, 2 La Nota dell’autore, vent’anni dopo e successivamente riapparsa come saggio di chiusura in Consolo, 1999a, p. 276-282, con il titolo «Il sorriso», vent’anni dopo. 57 e diventato un ipotesto per le opere successive di Consolo3. Per di più, Il sorriso e il primo capitolo di una trilogia di romanzi che prendono le mosse da importanti momenti della storia siciliana e italiana: l’insorgere del fascismo nei primi anni ’20 e la sua correlazione in tempi più recenti con la nuova destra italiana, in Nottetempo, casa per casa (1992); e il fallimento del tentativo di creare una società giusta da parte della comunemente definita “generazione del dopoguerra”, simbolizzato dall’assassinio del giudice Paolo Borsellino, in Lo spasimo di Palermo (1998). Tralasciando queste considerazioni, la focalizzazione esclusiva su Il sorriso e, in particolare, sul capitolo iniziale del romanzo, si basa su alcune valide ragioni: anzitutto, il capitolo I risulta il più negletto di tutti, dato che la critica ha preferito studiare e interpretare i cosiddetti “capitoli caldi” della seconda meta del romanzo; poi, perché e il capitolo con la storia testuale più lunga, e dunque la sua gestazione dovrebbe apparire più evidente ad un’attenta analisi; infine, il capitolo inaugura una nuova poetica per Consolo dopo La ferita dell’aprile (1963): gli elementi di solito associati al romanzo – il significato del sorriso, la chiocciola, la compresenza di poesia e prosa, le forme metriche, gli stilemi, l’uso dell’elencazione, di forme dialettali e parodistiche, l’impegno dell’autore, e un’abbondante messe di intertesti, in breve, una polifonia – sono già tutti presenti nel loro insieme in questo capitolo. Certo i commenti dell’autore facilitano la lettura del primo capitolo del romanzo, e le riflessioni sono molto rilevanti, non solo per ciò che nascondono, ma anche per ciò che rivelano. Forse, quella più significativa riguardo al Sorriso appare nella Nota dell’autore chiamata in causa all’inizio, in cui, pur a distanza di venti anni, Consolo delinea i tre elementi fondamentali da cui la struttura del romanzo ha preso forma: I tre elementi allora, la rivolta contadina di Alcara, i cavatori di pomice di Lipari e il Ritratto d’Antonello reclamavano una disposizione su uno spazio di rispondenze e di senso, in cui il Ritratto stesso, nel suo presumibile percorso da una Messina, già di forte connessione storica, cancellata dai terremoti, a Lipari, isola-regno d’esistenza, di mito, a Cefalù, approdo nella storia e nella cultura, disegnava un triangolo e un movimento da un mare d’incertezze […] a una terra di consapevolezza e di dialettica. (Consolo, 1997: 177-178) Dei tre punti sopraelencati, solo il primo e notoriamente escluso, e di là da venire. Inoltre, questo movimento ad assetto triangolare, emanante dai brani d’apertura del capitolo, e illuminante riguardo alla poetica di Consolo e a come (e dove) egli si vede situato all’interno della tradizione letteraria siciliana: in una posizione intermedia tra quella occidentale e quella orientale, che e come dire, tra 3 Seguo le categorizzazioni e classificazioni genettiane della “transtestualità”, vale a dire la trascendenza testuale del testo, rilevate da Gérard Genette (1997: 7-8): «si tratta appunto di quella che chiamerò d’ora in poi ipertestualità. Designo con questo termine ogni relazione che unisca un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo anteriore A (che chiamerò, naturalmente, ipotesto) sul quale esso si innesta in una maniera che non è quella del commento». storia e mito. I movimenti spaziali da est a ovest nel primo capitolo del romanzo, e la decisione dell’autore di abbracciare le tradizioni storiche occidentali degli scrittori dell’isola, si scorgono nello stesso incipit4. Nel libro-intervista Fuga dall’Etna, riferendosi proprio alla prima parte del romanzo, Consolo afferma: Il libro e scritto nella prima parte in forma parodistica, mimetica, sarcastica se si vuole, quindi in negativo: faccio il verso a un erudito dell’Ottocento recluso nella sua mania antiquaria, che scrive i suoi saggi scientifici, che si occupa di malacologia, una materia quanto mai curiosa, eccentrica. (Consolo, 1993: 45) Se gli elementi parodistici, mimetici e sarcastici sono davvero presenti, e in abbondanza, nella prima parte del romanzo, Consolo pero non evidenzia tutti gli altri che danno “forma” a questo capitolo: un’angoscia delle influenze di altri scrittori, la ricerca di una nuova poetica, una concezione totalmente alterata di quello che è il genere del romanzo. L’analisi s’incentrerà proprio su questi elementi nascosti o impliciti, peraltro parzialmente rivelati dall’esame del graduale crescere del testo, gli inizi del quale si possono far risalire a un momento circostanziato della vita dell’autore, un evento che e l’emblema degli obiettivi dichiarati della sua poetica, vale a dire, la fusione dei due filoni, orientale e occidentale, della letteratura siciliana. E mia ferma convinzione, che l’incontro organizzato da Consolo tra i suoi due mentori, il poeta Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia, e il più chiaro esempio possibile del punto di partenza del futuro romanzo. Né Le pietre di Pantalica, Consolo racconta l’evento tenutosi il 7 marzo 1965, una data degna di nota, perché coincidente con la prima messa officiata in lingua italiana dopo il Concilio Vaticano Secondo: Sciascia arrivo da Caltanissetta al mio paese e assieme andammo da Piccolo. Al congedo, sulla porta, Piccolo solennemente disse allo scrittore, indicando con la mano su per le colline: «Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali». Avevo deciso di lasciare la Sicilia e di trasferirmi a Milano. «Non parta, non vada via» mi diceva Piccolo. «A Milano con tutti gli altri, rischia di annullarsi. La lontananza, l’isolamento danno più fascino suscitano interesse e curiosità.» Non potevo rispondergli che non ero ricco, che dovevo guadagnarmi la vita. Non potevo dirgli, soprattutto, che lì in Sicilia mi sembrava tutto finito, senza speranza, che a Milano, al Nord avevo la sensazione che tante cose si muovessero, che stesse per iniziare una nuova storia. (Consolo, 1988: 142-143 [Consolo, 2015: 599])5 Ad un primo sguardo, nel brano sono proprio pochi gli accenni riferibili alla futura opera Il sorriso, perché Consolo taglia corto con la storia dell’incontro raccontando di altre esperienze con Piccolo. Invece nella Fuga dall’Etna riprende il racconto con un’interessante coda: 4 Per le discussioni sulla mappatura della letteratura siciliana del luogo, cfr. il mio saggio: O’Connell, (2005: 29-48); e O’Rawe (2007: 79-94). 5 La più antica traccia si trova in due quaderni autografi (Ms 3, Ms 4), per cui cfr. Messina (2009: 58 e n. 53). Questo uno dei ricordi più belli, che riprendo da Le pietre di Pantalica: «[…] “Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali.” “C’e qui Consolo,” rispose Sciascia. “Consolo e ancora giovinetto,” replico Piccolo sarcasticamente (avevo trentatré anni!). Ma io presi quella frase come impegno verso Sciascia e come una sfida verso il barone.» Sciascia era rimasto affascinato da quel poeta, da quel gran personaggio che era Piccolo. Erano, i due scrittori, quanto di più diverso, di più lontano si potesse immaginare, eppure nutrivano, l’uno per l’altro, stima e ammirazione. (Consolo, 1993: 23-24)6 Non è da ritenere una coincidenza il fatto che siano esattamente queste nostre terre, quei paesi medievali a costituire il contenuto o retroscena del primo capitolo del futuro romanzo. La sfida sottaciuta di Consolo a Piccolo diventa poi col tempo anche sfida a tutta la letteratura siciliana, e il romanzo che ne risulta e un romanzo i cui antenati sono certo Verga, De Roberto, Pirandello, Vittorini e Tomasi di Lampedusa, ma i cui “istigatori” potrebbero considerarsi Piccolo e Sciascia: sia detto per inciso, richiamati rispettivamente dal protagonista Enrico Pirajno Barone di Mandralisca (Piccolo) e del deuteragonista Giovanni Interdonato (Sciascia). Tredici anni di silenzio separano il primo romanzo di Consolo La ferita dell’aprile datato 1963 e Il sorriso. La concezione originale de Il sorriso, comunque, prende le mosse negli anni ’60 ed e connessa, almeno dal punto di vista ideologico, al periodo di “acuta storia”. Inoltre, e un romanzo siciliano in senso stretto, non solo perché tratta di storia siciliana, ma anche perché la sua nascita e il suo sviluppo sono databili al periodo 1963-1968, ovvero gli anni in cui Consolo visse in Sicilia prima di spostarsi a Milano definitivamente nel gennaio 1968. Ma Consolo, e chiaro, non smise di scrivere a meta anni ’60 per riprendere la penna in mano soltanto a metà degli anni ’70. Rimase attivo, sia sul piano creativo sia su quello giornalistico, durante gli anni che separano le date di pubblicazione dei due romanzi7. Tuttavia, ciò che si commenta e la preistoria effettiva del libro, ovvero come arrivo alla sua versione definitiva nel 1976. Quanto segue e la storia tracciata sulla fortuna di pubblicazione de Il sorriso dell’ignoto marinaio, dalle prime apparizioni fino ad oggi. Testo e testi: variazioni e varianti. Nel numero luglio-settembre di «Nuovi Argomenti» del 1969, diretto da Alberto Carocci, Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, appare per la prima 6 Le virgolette evidenzierebbero il passaggio citato da Le pietre di Pantalica fino a «una sfida verso il barone». In realtà, il passo da «C’e qui Consolo» a «una sfida verso il barone» non appaiono, come si è visto, in Le pietre di Pantalica. 7 Per la scrittura creativa, cfr. i racconti di quegli anni ora in La mia isola è Las Vegas (Consolo, 2012). Per quella giornalistica, anche se ne dà solo una visione parziale, Esercizi di cronaca (Consolo, 2013). Da non escludere sono anche gli articoli raccolti in Cosa loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010, (Consolo, 2017). Ed altri ancora, di vario argomento, risulta che ne siano conservati nell’Archivio Consolo. Volta un racconto dal titolo Il sorriso dell’ignoto marinaio. A tutti gli effetti e ciò che diventerà il primo capitolo del futuro romanzo omonimo (Consolo, 1969: 161-174). Il racconto non presenta alcun antefatto o appendici. E di poco successivo, del 1975, un libro dallo stesso titolo con un’acquaforte di Renato Guttuso del famoso Ritratto d’uomo (edizione limitata in 150 copie). Il volume contiene i primi due capitoli di quello che sarà il romanzo che conosciamo (Consolo, 1975a). Corrado Stajano, amico di Consolo, avvalendosi di una celebre metafora pirandelliana, ha scritto un pezzo per Il Giorno per segnalare questa pubblicazione: Adesso Manusé ha esaudito il gran sogno della vita, e diventato editore e c’è la possibilità, dicono gli uomini di penna, che questo libro che ha stampato, […] possa creare un nuovo caso letterario. Perché qui si sono incontrate due corde pazze siciliane, quella di Manusé e quella dello scrittore del libro, o meglio dei primi due capitoli del libro pubblicato in questo volume, che gli editori, quando il romanzo sarà finito, certo si contenderanno, perché Il sorriso dell’ignoto marinaio e un nuovo Gattopardo, ma più sottile, più intenso del romanzo di Tomasi di Lampedusa, uno Sciascia poetico, di venosa lava sanguigna e insieme razionalmente freddo nei suoi teoremi dell’intelligenza. (Stajano, 1975) La motivazione dell’articolo di Stajano sembra essere quella di voler forzare la mano di Consolo, spingendolo verso il completamento del romanzo. E anche notevole l’intento di fare pubblicità al romanzo futuro. Tuttavia, Stajano risulta anche molto ben informato del contenuto dei capitoli inediti e ciò suggerisce che al momento della pubblicazione della versione di Manusé la maggior parte del romanzo era già stata completata, o già comunque concettualmente concepita, e che Consolo ne stava discutendo apertamente con gli amici più fidati. Il romanzo completo, l’editio princeps, venne pubblicato l’anno successivo da Einaudi e fu accolto dagli elogi della critica (Consolo, 1976). Nel 1987 la Mondadori ne stampo un’edizione economica includendo una Introduzione firmata da Cesare Segre (Consolo, 1987). Nel 1991 Mursia pubblico una seconda edizione aggiornata dell’antologia di Leonardo Sciascia e Salvatore Guglielmino Narratori di Sicilia, che accoglie, con annotazioni, la prima sezione del capitolo I de Il sorriso (Consolo, 1991). Nel 1992 Einaudi ripubblico il romanzo (Consolo, 1992b) e nel 1995 ne apparve un’edizione scolastica, edita e annotata da Giovanni Tesio (Consolo, 1995).
Nel 1997 Mondadori ha pubblicato ancora una volta il romanzo insieme alla Nota dell’autore, vent’anni dopo (Consolo, 1997). Due successive riedizioni del romanzo sono state pubblicate sempre da Mondadori: la prima, nella collana Oscar scrittori del Novecento (Consolo, 2002); la seconda, in quella Oscar classici moderni (Consolo, 2004). Come si può intuire dalle date di pubblicazione, il periodo di gestazione de Il sorriso e stato decisamente lungo e in più va considerato che la versione originariamente pubblicata in «Nuovi Argomenti» differisce molto da quelle successive con una divisione in capitoli, anche perché parziale. Le varianti testuali tra le dieci versioni, edizioni e ristampe, databili dal 1969 al 1997, rivelano che Consolo ha rielaborato di continuo il suo testo. Che la maggior parte di esse siano quelle tra la versione di «Nuovi argomenti» e l’edizione del 1997, significa inoltre che Consolo ha ritoccato il testo dopo il 19768. Le varianti si diversificano per tipologia e importanza, partono dai più banali errori di battitura per arrivare alle sostituzioni e alle rielaborazioni di interi paragrafi. Questo di per sé suggerisce che il capitolo I e una sorta di workinprogress, un testo sempre compulsato dall’autore e completato da una serie di aggiunte accorpate nel corso degli anni. Lasciando da parte le fonti pubblicate, il cosiddetto emerso9, si può andare indietro fino al livello delle fonti precedenti alla pubblicazione e paratestuali che vanno a toccare il punto cruciale della genesi e gestazione del romanzo. Ho deciso di chiamarli pre-testi, nel senso che essi variano in tipologia, importanza e stato. Alcuni sono stati pubblicati e quindi dovrebbero rientrare nella categoria del paratesto, venendo così ad aumentare il nostro attuale bagaglio di nozioni sul romanzo. Pre-testi: genesi e gestazione Lo stato di incertezza che caratterizza i manoscritti autografi, i testi scritti a macchina, i saggi e gli altri “interventi autoriali”, con particolare attenzione alla gestazione del testo, sono noti. Anche il problema di datare il materiale presenta non poche difficolta. La tentazione, quando si ha a che fare con manoscritti e varianti testuali, e quella di sviluppare un approccio unilineare alla poetica dell’autore considerato; ascrivere a quell’autore certi presupposti fondamentali che tuttavia non sono facilmente verificabili. Nel caso di Consolo, al di là delle suddette edizioni del testo in forma di racconto e romanzo e dell’allettante realizzazione di varianti che intercorrono fra esse, esiste anche un ricco patrimonio di documenti non pubblicati. Nicolo Messina ha suggerito che sarebbe stato «illuminante, oltre che un’entusiasmante avventura, il poter penetrare grazie a un’edizione critica genetica all’interno della sua officina» (Messina, 1994: 40). Da allora, Messina si e imbarcato in questa avventura con una serie di articoli ispirati a un approccio filologico critico-genetico alle opere di Consolo, specialmente Il sorriso (Messina, 2005: 113-126). Oltre a ciò, Messina ha completato l’edizione critica del romanzo di cui si sentiva l’assoluta necessita e che è in sé stessa un vero capolavoro di critica-genetica10. Poiché Messina ha lavorato sui manoscritti e dattiloscritti, non mi ci soffermerò. 8 L’edizione del 1997 e il testo tenuto come base per lo studio di tutti gli altri, essendo la versione che ha ricevuto l’ultimo ne varietur dell’autore. Concordo in questo con Messina (2005: 121-124). 9 Ricorro alla denominazione di Messina (2005: 117-121). 10 Messina (2009). L’approccio critico-genetico di Messina e basato sui seguenti studi: Hay (1979), Degala (1988), Gresillon (1994), Tavani (1996) e Contat e Ferrer (1998). Ai fini del nostro discorso, pero, risulta assai significativo un dattiloscritto denominato Ds 2, o piuttosto le pagine che l’accompagnano (Ds 20), perché contengono una sorta di resoconto del futuro romanzo. In particolare, l’asserzione nella scheda Ds 20 che «sono due capitoli di un romanzo (capitoli o racconti autonomi, perché, nelle intenzioni dell’autore, intercambiabili e combinatori come carte da giuoco)», pone una serie di questioni che sono rilevanti per la genesi e la gestazione del testo. Ci sono numerose sovrapposizioni, intrecci tematici e corrispondenze lessicali tra i capitoli I e II del romanzo. Dal punto di vista strutturale, la narrazione di entrambi i testi e in parte focalizzata attraverso Mandralisca (capitolo I) e Interdonato (capitolo II) con corrispondenze tra i due. Il fatto che i capitoli I e II siano intercambiabili e combinatori, postula un’influenza di Italo Calvino sul metodo strutturale di Consolo, in particolare del saggio Appunti sulla narrativa come processo combinatorio (Calvino, 1995: 199-219). Nella spiegazione di Calvino dell’ars combinatoria tanti elementi avrebbero potuto colpire Consolo, non ultimi le citazioni da Strutture topologiche nella letteratura moderna di Hans Magnus Enzensberger11, Calvino tra l’altro afferma anche: La battaglia della letteratura e appunto uno sforzo per uscire fuori dai confini del linguaggio; e dall’orlo estremo del dicibile che essa si protende; e il richiamo di ciò che è fuori dal vocabolario che muove la letteratura. (1995: 211) E che Calvino nel saggio ritorni sul simbolo del labirinto dopo l’analisi fattane nel precedente La sfida al labirinto (1962), non avrà lasciato indifferente Consolo tutto preso dalla sua curiosa, personale concezione siciliana del labirinto in Il sorriso: cioè la chiocciola12. La questione della genesi del romanzo si può far risalire ancora più indietro, all’attività giornalistica di Consolo da metà degli anni Sessanta in poi. Al riguardo ci si può anche chiedere quale influenza abbia potuto esercitare il giornalismo sui suoi sforzi creativi. Per tanti aspetti il giornalismo consoliano e come un’istantanea dei multiformi interessi nutriti in quel tempo: letterari, artistici, politici e civili; e quando tutto ciò viene visto attraverso la lente de Il sorriso, ci si apre un’intrigante entrée nel mondo della sua attività creativa e poetica ancora in via di sviluppo. Consolo ha scritto per Tempo illustrato e, durante il suo primo periodo a Milano, ebbe una regolare rubrica intitolata Fuori casa nel giornale palermitano L’Ora13. Tuttavia, il suo rapporto con L’Ora 11 Avrà una diretta influenza su Consolo, si sa, il saggio di Hans Magnus Enzensberger (1966: 7-22). 12 Calvino (1995: 99-117) dove (116) si sostiene: «Quel che la letteratura può fare e definire l’atteggiamento migliore per trovare la via d’uscita, anche se questa via d’uscita non sarà altro che passaggio da un labirinto all’altro. E la sfida al labirinto che vogliamo salvare, e una letteratura della sfida al labirinto che vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al labirinto». Consolo mette in scena la sua sfida al labirinto attraverso il personaggio secondario di Catena Carnevale in Il sorriso. 13 La rubrica, pubblicata dal dicembre 1968 al maggio 1969, e definita un piccolo gioiello» da Nisticò (2001: 113); e si può rileggere in Consolo (2013: 179-223). precede il suo trasferimento a Milano ed e indissolubilmente legata con le sue attività in Sicilia14. Nel 1965 e negli anni immediatamente adiacenti, un gruppo di intellettuali e scrittori cominciarono a frequentare il giornale, tra questi Sciascia, il fotografo Enzo Sellerio, lo scrittore Michele Perriera e Consolo stesso. Vittorio Nisticò, direttore de L’Ora nel periodo 1955-1975, ricorda con affetto la presenza e il contributo di Consolo in quegli anni 15. Nel 1966, a seguito dell’omicidio per mano mafiosa del leader sindacale socialista Carmine Battaglia a Tusa (provincia di Messina), Consolo scrisse un breve racconto ispirato all’uccisione, Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, pubblicato ne L’Ora (16 aprile) un mese dopo l’evento 16. Anche se non può facilmente e strettamente rientrare nella categoria del giornalismo, il racconto, come sostiene Sciascia, e «una sorta di reportage giornalistico» (Consolo, 1967b: 429), ed e forse la prova più significativa della scrittura creativa di Consolo dopo La ferita dell’aprile, perché presenta in forma embrionale alcuni elementi linguistici, strutturali e tematici che saranno precipui de Il sorriso. Consolo, senza dubbio, ebbe come modello Le parole sono pietre di Carlo Levi, in particolare la terza sezione in cui si narra la sua visita a Francesca Serio, la madre del sindacalista socialista Salvatore Carnevale, assassinato anch’egli dalla mafia (Levi, [1955] 1979). Non e una coincidenza che Consolo abbia firmato in seguito l’introduzione per una nuova edizione del “libro-indagine”, (Levi, 1979; Consolo, 1999a, 251-257) in cui scrive tra l’altro: A Sciara, Levi ha trovato, sul filo sottile che inseguiva della nuova coscienza contadina, il punto più vero e più alto della realtà siciliana di quegli anni. E più vero e più alto si fa allora il tono del libro: le pagine su Francesca Serio di commozione rattenuta dal pudore, di parole scarne e risonanti. (Consolo, 1999a, 256) Lo stesso senso di ingiustizia e indignazione permea Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, anche se nella storia di Consolo la figura della madre e abbattuta dal dolore e il compito di parlare viene lasciato alla figlia, «una giovane bellissima». All’inizio la incontriamo impegnata in un’attività che fa seriamente presagire le preoccupazioni testuali e metaforiche del futuro romanzo: «dietro i vetri di una piccola finestra, ricamava» (Consolo, 1967b: 432; Consolo, 2012: 20). Come personaggio, la figlia anticipa la figura liminale, altamente metaforica, 14 La prima collaborazione risalirebbe esattamente al 4 febbraio 1964, una recensione di Menabò, 6. Cfr. Salvatore Grassia, in Consolo (2013: 229-230). 15 Nisticò (2001: 113): «Amavamo di lui il garbo, la modestia, il senso di amicizia, gli accenni di sorridente ironia, non meno di quanto ci affascinassero i ricami della sua scrittura, la sua totale mediterraneità, quei fuochi improvvisi della sua passione letteraria e civile.» Il memoriale di Nisticò e senz’altro un affascinante resoconto di un giornale di sinistra in prima linea nella lotta contro la mafia in uno dei più difficili periodi storici. 16 Il racconto fu poi ripreso da Narratori di Sicilia, cit. [ed. 19671], (Consolo, 1967b: 429- 434); ora, col titolo Un filo d’erba al margine del feudo (Consolo, 2012: 18-22; 239). Sul caso Battaglia, cfr. Ovazza (1967) e Santino (2000: 232-233). della venticinquenne Catena del Sorriso, che nell’Antefatto il padre si augura di vedere «serena dietro il banco a ricamare» (Consolo, 1997: 11)17. Anche il cognome di Catena e intrigante: si chiama, infatti, Carnevale, nome che rafforza il legame con il “giovane”, ventiduenne, Salvatore del racconto e con la famiglia di Le parole sono pietre. La presentazione della giovane ragazza da parte di Consolo suggerisce a Traina «sviluppi successivi della narrativa consoliana», come «l’insistenza sul dettaglio cromatico e sull’immagine “rubata” dal passante, che si fa quasi, emblematicamente, quadro o fotografia». (Traina, 2001: 16). Questa tecnica di sospensione della realtà tramite l’immagine fissa, una forma di ipotiposi, e un aspetto prevalente della narrativa più tarda di Consolo. Il racconto di Consolo contiene inoltre una serie di espedienti e scelte lessicali che saranno ulteriormente ampliati nel romanzo. Ecco esempi di emergenza di scrittura “consoliana”, quale poi impronterà il romanzo: «Il sole batteva […] sulle pietre di via Murorotto e sul portale d’arenaria ricamata del Palazzo»; «[…] col suo castello sull’acqua smagliante e triangoli di vele sui merli» (Consolo, 1867b: 429 2 431; Consolo, 2012: 18-19). E successivamente, nel capitolo I de Il sorriso, leggiamo: «Vorticare di giorni e soli e acque, venti a raffiche, a spirali, muro d’arenaria che si sfalda […]»; «Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollano i lor merli di cinque canne sugli scogli» (Consolo, 1997: 12; Consolo, 2015: 132). Inoltre, va sottolineato che la predilezione di Consolo per la catalogazione o inserzione, soprattutto di toponimi, e presente in maniera decisa nel racconto. Entrando nella citta di Tusa, il narratore si mette a conversare con un «vecchio con lo scialle», che indica le montagne circostanti: «Motta» […]. E poi «Pettineo, Castelluzzo, Mistretta, San Mauro…» […]. Stesi io il braccio nel vuoto oltre la ringhiera e indicai il mare. «Quelle macchie azzurre sono isole, Alicudi, Filicudi, Salina… Più in là c’è Napoli, il Continente, Roma…» «Roma» ripeté il vecchio. Volse le spalle al mare e continuo a indicare verso le montagne, ora con un breve cenno del capo: «Cozzo San Pietro, Cozzo Favara, Fulla, Foieri…». (Consolo, 1967b: 430; Consolo, 2012: 18) Il nome di Roma non dice niente al «vecchio», egli ripete meccanicamente ed elenca rapidamente i toponimi del suo mondo, toponimi non registrati sulle mappe ufficiali, come se la loro enunciazione andasse a evocare una realtà diversa. Questo senso di “urgenza toponimica” e la sua sospensione sono ripetuti nel capitolo I del romanzo, dove ancora una volta l’elenco dei toponimi della costa tirrenica della Sicilia e predominante: «Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo…» (Consolo, 1997: 12; Consolo 2015: 128). L’antico passato greco di Tusa e evocato in una breve parentesi del racconto e anticipa il Consolo de Il sorriso: La valle declinava dolce fino alla balza d’Alesa (le sue mura massicce, l’agora, i cocci d’anfora e i rocchi di colonna affioranti tra gli ulivi, la bianca Demetra dal velo incollato sul ventre abbondante). (Consolo, 1967b, 431; Consolo, 2012: 19) 17 Il ricamo di Catena e una chiara metafora tessile del testo. Per ulteriori approfondimenti di questo aspetto consoliano, cfr. il mio saggio: O’Connell, (2003, 85-105). Genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio 65 Il nome di Tusa deriva dall’arabo “Alesa al-tusah” (“Alesa la nuova”), quando l’antica città greca di Alesa perse il primato nella zona nella seconda meta del ix secolo, e il centro fu spostato verso il sito dell’odierna Tusa (Ingrilli, 2000: 56). Nel romanzo, Consolo sancisce una sorta di nostalgia antico-archeologica tramite l’esposizione di ulteriori elenchi toponimici: Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Calacte, Alesa… Citta nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. (Consolo, 1997: 13; Consolo, 2015: 128- 129) Oltre a manifestare le preoccupazioni più importanti del Mandralisca per l’archeologia e il suo rifiuto di affrontare la realtà contemporanea, nella fattispecie quel che si rivelerà essere un cavatore di pomice ammalato di silicosi, la frase si riferisce agli antichi toponimi greci della regione dei Nebrodi sulla costa tirrenica, alcuni dei quali erano già stati citati da Cicerone tra le città della Sicilia vittime di Verre: Tyndaritanam, nobilissimam civitatem, Cephaloeditanam, Haluntinam [Alunzio], Apolloniensem, Enguinam, Capitinam perditas esse hac iniquitate decumarum intellegetis. (Verrine, II.3, 103) Tuttavia nell’edizione del 1997 c’è una variante del testo: «Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Apollonia, Alesa…». Consolo ha chiaramente sostituito la diade Alunzio e Calacte con l’altra Alunzio e Apollonia con l’evidente intenzione di migliorare l’allitterazione della frase e ottenere un elenco alfabetico pressoché perfetto, e in tal modo ha rivelato che alcune rielaborazioni de facto hanno avuto luogo tra le due edizioni cronologicamente estreme dell’intero romanzo. Consolo suggerisce il motivo della sostituzione in un saggio celebrativo di Cefalù pubblicato nel 1999: «Nascere dov’erano soltanto echi d’antiche città scomparse, Alunzio Alesa Agatirno Apollonia, che con la loro iniziale in A facevano pensare agli inizi della civiltà» (Consolo, 1999b: 17). Le somiglianze sono evidenti e ci permettono di visualizzare i processi che hanno delineato la creazione di questo capitolo. Non e un caso, quindi, che questa invocazione alla lettera A, alla storia antica, alla storia seppellita sotto i toponimi odierni dovesse avvenire nella fase iniziale di un romanzo intimamente connesso tanto con ciò che la storia nasconde quanto con ciò che essa rivela. Apollonia, inoltre, si ritiene che fosse l’antico toponimo dell’odierna San Fratello, un paese che ha una funzione estremamente metaforica in gran parte delle opere di Consolo, non ultima Il sorriso18. Consolo sta, quindi, mettendo uno dei suoi marker, o 18 La citta e evocata, in vario grado, in La ferita dell’aprile (1963), Lunaria (1985) e nel racconto «I linguaggi del bosco», in Le pietre di Pantalica (1988). In particolare il sanfratellano, usato o semplicemente citato da Consolo a più riprese, sembra attirare l’attenzione dello scrittore per la natura e ricchezza di lingua “periferica”, voce di una cultura particolare in netto contrasto con la lingua omologata “centrale” cui ricorre la cultura dominante. Segnali, alludendo a qualcosa che acquisisce via via importanza con il procedere del racconto. L’evocazione di antichi toponimi era riapparsa invero in Le pietre di Pantalica, in quel Il barone magico che si avvale ancora una volta della toponomastica poetica e suggerisce con gli stessi toponimi (e qualcuno nuovo) non solamente una topografia autoriale personalizzata, ma anche la loro contiguità con l’atto di scrittura e gli inizi della parola: Qui era un tempo la città antica d’Agatirno, una delle città lungo questa costa che, coi loro nomi comincianti in A (Abacena, Alunzio, Apollonia, Amestrata, Alesa…) fanno pensare ai primordi, alle origini della civiltà. (Consolo, 1988: 147; Consolo, 2015: 603) Il passo tratto da Il sorriso condivide anche somiglianze con un’altra opera d’impostazione storica parallela, I vecchi e i giovani di Pirandello: Via Atenea, Rupe Atenea, Empedocle… – nomi: luci di nomi, che rendeva più triste la miseria e la bruttezza delle cose e dei luoghi. L’Akragas dei Greci, l’Agrigentum dei Romani, eran finiti nella Kerkent dei Musulmani, e il marchio degli Arabi era rimasto indelebile negli anni e nei costumi della gente. (Pirandello, 1973: 163) Il suo stato di intertesto e ulteriormente rafforzato appena più avanti, nello stesso quarto paragrafo, quando Consolo sostiene: «Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni» (Consolo, 1997: 13; Consolo, 2015: 129). Le affinità tra il pirandelliano nome: luci di nomi e il consoliano nomi […], suoni, sogni sono degne di nota. Forse sarà più significativo che Per un po’ d’erba ai limiti del feudo anticipi la tendenza di Consolo a usare documenti storici come discorsi compensativi all’interno delle proprie narrazioni, una pratica più pienamente realizzata ne Il sorriso dell’ignoto marinaio19. Sul portone del municipio era scolpito lo stemma della citta: un grosso cane muscoloso sopra una torre, le zampe posteriori contratte, sul punto d’avventarsi, i denti scoperti. (1860: «In più luoghi, come a Bronte, a Tusa e altrove, i Consigli municipali, costituiti dai Governatori distrettuali, erano composti di elementi della grossa borghesia o dell’aristocrazia di proprietari terrieri, avversi alle rivendicazioni contadine e ai fautori e capi del movimento per la divisione delle terre demaniali»). (Consolo, 1967b: 432; Consolo, 2012: 20) La parte del passo in corsivo e tratta da un documento contemporaneo allo sbarco di Garibaldi in Sicilia e sottolinea un fondamentale fattore storico del Risorgimento in Sicilia: l’opposizione delle classi dominanti in Sicilia al decreto del 2 giugno 1860 «col quale Garibaldi ordinava la divisione delle terre demaniali mediante sorteggio a tutti i capi di famiglia sprovvisti di terra, riservando una quota certa ai combattenti della guerra di liberazione ed ai loro eredi» (Romano, 1952: 139). 19 Segre esamina la funzione narrativa di tale pratica consoliana, anche se l’attenzione del saggio e incentrata esclusivamente sui documenti storici riprodotti in appendice e non su quelli incorporati nel testo stesso (Segre, 2005: 129-138). L’amara ironia che scaturisce dall’inclusione del documento sottolinea il fatto che in 106 anni poco era cambiato nella vita e nelle aspirazioni dei diseredati. E, forse, per questa ragione che Sciascia nella storia scorge il «gioco gattopardesco delle forze della conservazione» (Consolo, 1967b: 429). Da parte sua, di fronte alla staticità del corso degli eventi, Onofri sottolinea che l’immobilita storica, sancita dal documento legislativo, «trova finale suggello nella letteratura, testimonianza abbastanza precoce di quello che possiamo definire il circolo ermeneutico consoliano» (Onofri, 1995: 232). Tuttavia, a permeare queste pagine e soprattutto l’impegno di Consolo a favore della giustizia sociale. Nel racconto, dunque, si possono ritrovare le tracce evidenti del suo primo tentativo di scrivere qualcosa sui paesi medievali additati da Piccolo, pero attraverso il filtro dell’impegno di matrice sciasciana, cioè della sua stessa volontà di abbracciare i temi della giustizia sociale e politica. Sulla questione dell’inserimento di documenti storici nel narrato, il primo capitolo del Sorriso offre un accattivante esempio del metodo di Consolo. E riscontrabile nel diciannovesimo paragrafo e da nell’occhio proprio per quel che rivela delle procedure narrative impiegate dallo scrittore nei suoi testi multiformi. Il paragrafo, presentato per la sua maggior parte in corsivo, suggerisce una citazione o, almeno, una condizione narrante alternativa, una voce o un punto di vista diversi. Nel romanzo, l’unico altro luogo in cui una vasta porzione di testo e riportata in corsivo e nel Capitolo v, Il Vespero, in cui il passo incastonato non in tondo e mutuato direttamente da I promessi Sposi di Alessandro Manzoni: e la descrizione del momento della conversione dell’Innominato piegata da Consolo a tratteggiare il “tempo” e le sensazioni del personaggio Peppe Sirna (Consolo, 1997: 106; Consolo, 2015: 204-205; Manzoni, 2002: 409). Tranne il corsivo non c’è nel testo nessuna indicazione che si tratti di una citazione manzoniana. Nessuna indicazione, né note a piè di pagina né richiami all’autore, soccorre il lettore, il quale non può far altro che accettare la stranezza del passo ed andare avanti con la narrazione. Il brano e interrotto dall’improvviso cambiamento di registro impresso da Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, che esclama: «Uh, ah, cazzo, le bellezze!» (Consolo, 1997: 20; Consolo, 2015, 134), poiché la sua immaginazione prende il sopravvento sul resto del paragrafo. Ciò che precedeva in corsivo, pero, non è un parto dei rimuginii del protagonista del Sorriso, ma un qualcosa di abbastanza strano ed estraneo, e il frutto del pensare altrui, benché sia la mente del barone Mandralisca a rievocarlo. Si ha un indizio nella frase finale del paragrafo: Avrebbe fottuto il Biscari, l’Asmundo Zappala, l’Alessi canonico, magari il cardinale, il Pepoli, il Bellomo e forse il Landolina. Questo forse il Landolina e l’unica allusione, nel testo, ad una possibile fonte, anche se il lettore medio non ha modo né e in grado di saperlo. La parte in corsivo del brano, cioè i tre quinti del paragrafo, e, in effetti, una citazione diretta da una fonte che non sarebbe stata familiare per il Mandralisca, sebbene Consolo la abbia consultata come campione di stile di prosa degli intellettuali siciliani del tardo Settecento e del primo Ottocento. La fonte e proprio il Cavalier Saverio Landolina (1753-1814), figura dominante dell’archeologia siciliana all’inizio del xix secolo. La sua fama e la sua posizione di rilievo si dovevano alla scoperta della famosa Venere Anadiomene, fatta nel 1803 (Dizionario dei Siciliani illustri, 1939). Il testo in questione e da ricercare in una lettera datata 29 gennaio 1807 e indirizzata all’allora «Sopraintendente generale alle antichità», un certo Soratti Agnello, 1972: 218-219; Consolo, 1997: 19-20; Consolo, 2015: 134): Passando a visitare li monumenti del Tindaro ebbi il dispiacere di non ritrovare il più bel pezzo, che l’altra volta vi avevo ammirato. Erano due piedi con le gambe fino alle cosce di un giovane ignudo di elegantissimo greco lavoro, con un’ara dal lato sinistro ben ornata, di marmo alabastro bianco. Osservai ancora due grossi pezzi di marmo statuario, che insieme formavano il busto di un uomo di statura gigantesca; in uno dei detti pezzi si vede la corazza ornata di bassi rilievi, tra i quali si distinguano una bulla pendente sul petto con una testa molto crinita come si osserva in molte nostre medaglie. Dalla spalla destra era pendente sopra la mammella una fettuccia lavorata. Su la spalla sinistra era elegantemente rilevato il gruppo del pallio che doveva coprire le spalle. Sopra il ventre erano due ippogrifi. L’altro pezzo di marmo era il rimanente della corazza, cioè le fibule e le bulle pendenti sopra il sago che copriva le cosce le quali si vedono tagliate. Le bulle erano tutte figurate con varie teste di animali e qualcuna umana. L’esistenza di questi pezzi nel Tìndaro mi fa sospettare che potevano appartenere ad una statua dei Dioscuri, descritti sempre dai poeti in abito militare. Il brano di Landolina e citato pressoché alla lettera e le sole inter/estrapolazioni eseguite da Consolo vanno individuate nei tempi verbali e in quei segmenti del brano che si riferiscono al Landolina stesso. Questo tipo di intertestualità e abbastanza sconcertante per il lettore e, una volta rilevato, mostra il modo in cui si forgia lo stile di Consolo: testi dentro testi, siano essi citazioni poetiche di scrittori canonici o citazioni dirette da oscuri testi archeologici del xix secolo. La citazione letteraria diretta si può considerare ammissibile, se accettiamo che il punto di vista narrativo e qui quello del Mandralisca, com’e peraltro accertabile nel resto di questo capitolo iniziale, ma la citazione diretta da lettere di argomento archeologico e più problematica. Segre scrive che Consolo condivide con Gadda «la voracità linguistica, la capacita di organizzare un’orchestra di voci, il risultato espressionistico» e, assecondando le riflessioni di Bachtin, aggiunge che il plurilinguismo di Consolo e anche «nettamente plurivocità» (Segre, 1991: 83-85). Al riguardo i commenti bachtiniani sull’enciclopedismo nel genere del romanzo sono rilevanti, specialmente in quelli da lui definiti romanzi della seconda linea. Questo tipo di romanzo tende all’enciclopedicità dei generi, e si avvale anche dei generi inseriti. Il fine principale e introdurre nel romanzo la pluridiscorsività, la varietà delle lingue di un’epoca. Scrive Bachtin che i generi extraletterari sono introdotti non per “nobilitarli” e “letteraturizzarli” ma proprio perché sono extraletterari, perché era possibile introdurre nel romanzo una lingua extraletteraria (persino un dialetto). La molteplicità delle lingue dell’epoca deve essere rappresentata nel romanzo (Bachtin, 2001: 218). L’uso sapiente di Consolo di mescolare generi letterari ed extraletterari contrassegna Il sorriso come un complesso romanzo polifonico. Tuttavia, la funzione di memoria qui e profondamente testuale e quindi comparabile a un palinsesto. Un altro brano altamente significativo di Consolo in questi anni Sessanta appare ne L’Ora ed e un pezzo dedicato a Lucio Piccolo. L’articolo intitolato Il barone magico celebra in apparenza l’impresa poetica di Piccolo (Consolo, 1967a)20. Il testo di Consolo sarebbe un pretesto per la presentazione di tre poesie inedite di Piccolo e un frammento della sua prosa Balletto in tre tempi: L’esequie della luna21. Come nel caso di Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, Il barone magico anticipa molto del futuro Sorriso, ma se l’attenzione nel racconto era imperniata sull’indignazione civile dell’autore, il pezzo su Piccolo vede un Consolo lontano dalle questioni politiche e, invece, fortemente immerso nelle potenzialità magiche della parola, radicate nella seduzione del testo poetico. Se il primo era sciasciano nei presupposti e risultati, il secondo e, in gran parte, piccoliano nella sua espressività. Queste tendenze conflittuali dovevano risolversi nell’intensa fusione della scrittura de Il sorriso, in cui Consolo stesso divenne, per Stajano, uno «Sciascia poetico» (Stajano, 1975). E – si potrebbe forse aggiungere – anche un “Piccolo impegnato”. Questi, poi, sono gli scritti di Consolo fino al momento del trasferimento a Milano nel 1968, scritti che rivelano chiaramente che egli aveva già in mente le coordinate del futuro romanzo. Non che il suo rapporto con il giornale palermitano si fosse concluso con la decisione di lasciare la Sicilia, anzi le collaborazioni di Consolo con L’Ora s’intensificarono e divennero più “tradizionalmente” giornalistiche. I temi affrontati per il quotidiano erano abbastanza diversificati e variavano dalla politica, alla cronaca, alla critica d’arte, alle interviste e recensioni, come anche ad alcuni saggi di produzione creativa. Nel 1975 Consolo torno in Sicilia a lavorare al romanzo e ricomincio a frequentare L’Ora. La testimonianza di Nisticò e interessante per l’attenzione prestata agli interessi poliedrici di Consolo e alle attività da lui svolte contemporaneamente alla scrittura de Il sorriso: Nei primi mesi del ’75 Consolo si trasferì per un po’ di tempo a Palermo. […] si butto con manifesta gioia in un intenso lavoro giornalistico. […] Insomma, un bel bagno mediterraneo di umile giornalismo, mentre tra un servizio e l’altro trovava il luogo e il silenzio dove ripararsi per dare gli ultimi ritocchi a Il sorriso dell’ignoto marinaio: il capolavoro che da li a qualche mese lo avrebbe consacrato tra gli eredi della grande letteratura che la Sicilia ha dato alla nazione. A dicembre ne pubblicammo in anteprima un capitolo: la festa in casa del barone Mandralisca. (Nisticò 2001: 113-114) 20 La maggior parte del materiale dell’articolo costituisce la prima sezione del suo successivo «Il barone magico» (Consolo, 1988: 133-135). 21 Le poesie erano Plumelia, L’andito e quella che sarà poi intitolata Non fu come credesti per lo scatto. Un altro esercizio giornalistico con attinenza diretta alla formazione del capitolo i e un articolo, datato al 1970, fremente d’indignazione civile per le deplorevoli condizioni di lavoro dei cavatori di pomice dell’isola di Lipari. Originariamente intitolato «Il paese dei vivi pietrificati», fu pubblicato su Tempo illustrato, ma sotto altro titolo e solo dopo aver subito pesanti interventi modificatori (Consolo, 1970)22. Ancora una volta, affiora il primo capitolo del romanzo che si occupa del destino dei cavatori di pomice di Lipari e della strana malattia da cui sono affetti: la silicosi, popolarmente conosciuta come Male di pietra. L’articolo di Consolo e degno di nota, in quanto mette in risalto un misto di strategie del discorso significative anche per la sua poetica narrativa (Consolo, 1997: 177). Le preoccupazioni di Consolo sono molteplici, ma ciò che dà forza all’articolo e nel fondo la messa a fuoco della percentuale insolitamente alta a Lipari di malati di silicosi e della loro breve aspettativa di vita. Come chiarisce l’ignoto marinaio del romanzo, a provocare la malattia e l’estrazione della pietra pomice senza rispettare le più elementari misure di sicurezza. Consolo definisce le cave «un kafkiano teatro di vita penale dove si aspetta da sempre il messaggio dell’imperatore»23. E una sorta di altra controversia liparitana, ma diversa da quella della Recitazione sciasciana, in quanto lo sfondo non e settecentesco e Consolo vi delinea una storia dei cavatori di pietra pomice sull’isola a partire dal 1838, quando il monopolio e dato in appalto ad un francese di nome Gabriel Barthe. Lo scrittore si addentra nella battaglia giudiziaria tra questi e il vescovo di Lipari Giovampietro Natoli per il controllo delle miniere: il vescovo ottenne la proprietà delle terre, rifacendosi a un decreto del re Roberto I d’Altavilla datato 108424! E non mancano accenni alla moglie del Guiscardo ovvero Adelasia di Monferrato, evocata nel primo capitolo del romanzo e sepolta a Patti. Questa serie di informazioni a prima vista insignificanti permette a Consolo di presentare l’effettivo proprietario delle cave di pietra pomice al momento della redazione dell’articolo: la mafia, legata al finanziere Michele Sindona, nato a Patti 25. Tuttavia, che le condizioni di lavoro dei cavatori non fossero cambiate 22 Sono grato a Caterina Consolo per avermi fornito una copia dell’originale Il paese dei vivi pietrificati, composto da 5 cartelle battute a macchina con annotazioni e correzioni di mano dell’autore, e aggiunte vergate da Caterina Consolo: il toponimo «Lipari» (indicante il tema), la data di redazione: «settembre», e il futuro del testo: «[pubblicato non integralmente]». La cartella finale e datata: «3 settembre 1970». 23 «Il paese dei vivi pietrificati», cit., c. 3. Omesso nella versione apparsa in Tempo illustrato. 24 Consolo cita dal documento storico riportandolo ne «Il paese dei vivi pietrificati», ma il passaggio non compare in «Cosi la pomice si mangia Lipari». 25 Il banchiere Sindona fu una figura di spicco che ebbe contatti stretti con la mafia, leader politici italiani e la Loggia Massonica di Licio Gelli: la P2 (ben nota per gli scandali in cui fu coinvolta). Cfr. Renda (1998: 400-404); Lupo (1996: 262-271). L’editore di Tempo Illustrato soppresse evidentemente ogni riferimento a Sindona e al fatto che il manager dell’impianto Italpomice, Gebhart Raisch, era presumibilmente un ex Maggiore delle SS. dal 1852, anno dell’azione del primo capitolo de Il sorriso, e ben descritto nel pezzo che segue: Alle spalle di Canneto e il monte Pelato, il monte grigio-bianco con pomice con tra le gole radi cespugli verdastri. […] Gli operai sono dentro le gallerie sparsi qua e là per il costone. Con solo le mutande addosso, sotto questo sole di agosto, sono neri, piccoli e neri contro il bianco abbagliante. Sembrano ragni o scarafaggi che si muovono sopra una parete di calce o di sale. Dall’altra parte della strada vi è il burrone che precipita fino al mare. Dalla costa sì partono e vanno fino al largo snelli pontili neri, geometrici, sui quali scorrono i nastri trasportatori che riempiono le stive delle navi attraccate all’altro capo26. Il passo ha notevoli affinità con un altro del capitolo I de Il sorriso in cui Mandralisca svia il minuzioso esame di Interdonato permettendo alla sua immaginazione di proteggerlo dalla vista di uno di questi ‘cavatori’ e rivelando cosi che Consolo sta visualizzando la scena attraverso il filtro del suo testo: Al di là di Canneto, verso il ponente, s’erge dal mare un monte bianco, abbagliante che chiama si Pelato. Quivi copiosa schiera d’uomini, brulichio nero di tarantole e scarafaggi, sotto un sole di foco che pare di Marocco, gratta la pietra porosa col piccone; curva sotto le ceste esce da buche, da grotte, gallerie; scivola sopra pontili esili di tavole che s’allungano nel mare fino ai velieri. Sotto queste immagini il Mandralisca cercava di nascondere, di rimandare indietro altre che in quel momento (frecce di volatili nel cielo di tempesta migranti verso l’Africa, verdi chiocciole segnanti sulla pietra strie d’argento, alte flessuose palme schiudenti le vulve delle spate con le bianche pasquali inflorescenze…)27 Il paese dei vivi pietrificati e poi un esempio di come i processi creativi di Consolo abbiano chiaramente influenzato la sua scrittura giornalistica, in un’inversione di tendenza rispetto agli scritti per L’Ora fin qui considerati. Questi articoli dimostrano che Consolo stava riconsiderando i temi Risorgimentali da tanti punti di vista e in differenti prospettive. Un ultimo punto da trattare, attinente alla gestazione del romanzo, e quello degli scritti consoliani relativi, ovvero ispirati, all’arte figurativa. Questa scrittura differisce considerevolmente da quella della produzione giornalistica ed e fatta principalmente di presentazioni per mostre di artisti contemporanei. Una in particolare, manifestando l’innata vocazione di Consolo a usare forme metriche nella prosa, esercito una diretta influenza sulla gestazione del capitolo i. Il testo, intitolato Marina a Tindari, fu scritto per la mostra personale di Michele Spadaro tenutasi a Como presso la Galleria Giovio il 15-30 aprile 1972. Un centinaio di copie del testo della presentazione di Consolo venne pubblicato 26 «Il paese dei vivi pietrificati», cc. 2-3. La parte di testo in corsivo e stata omessa nell’articolo di Tempo illustrato. 27 Consolo (1969) e Consolo (1975a) presentano entrambi la variante precedente «sotto un sole di foco che pare di Morea». Consolo ha scritto un altro pezzo per Tempo illustrato (2 ottobre 1971) con il titolo «C’era Mussolini e il diavolo si fermo a Cefalù». L’articolo porta avanti un’indagine sulla residenza di Aleister Crowley a Cefalù nei primi anni venti del Novecento ed e il primo indizio del futuro Nottetempo, casa per casa (1992). nello stesso anno dal fratello dell’artista, Sergio Spadaro, insieme a un breve saggio (Consolo, 1972)28. In Marina a Tindari, dopo un’introduzione di prosa prelevata direttamente da Consolo (1969), seguono ventiquattro versi: Quindi
Adelasia, regina d’alabastro,
ferme le trine sullo sbuffo,
impassibile attese che il convento si sfacesse.
— Chi e, in nome di Dio? — di solitaria
badessa centenaria in clausura
domanda che si perde per le celle,
i vani enormi, gli anditi vacanti.
— Vi manda l’arcivescovo? —
E fuori era il vuoto.
Vorticare di giorni e soli e acque,
venti a raffi che, a spirali, muro
d’arenaria che si sfalda, duna
che si spiana, collina,
scivolio di pietra, consumo.
Il cardo emerge, si torce,
offre all’estremo il fiore tremulo,
diafano per l’occhio cavo
dell’asino bianco.
Luce che brucia, morde, divora
lati spigoli contorni,
stempera toni macchie, scolora.
Impasta cespi, sbianca le ramaglie,
oltre la piana mobile di scaglie
orizzonti vanifica, rimescola le masse.
(Consolo, 1972: 15-16)
Nel primo capitolo di Consolo (1975a) il paragrafo 14 e un chiaro esempio delle numerose aggiunte testuali di questa edizione. Il paragrafo e costituito proprio da questo testo in versi di Marina a Tindari, ricondotto, per così dire, all’originaria prosa del catalogo, e in questa forma interpolato tale e quale da Consolo in nell’edizione di 1975a29. Echi di T. S. Eliot, Salvatore Quasimodo e Piccolo sono evidenti sin da una lettura iniziale. Il dato significativo, pero, e che la poetica di Consolo comporti anche l’innesto di altri testi nel romanzo. Questo accorpamento non è solo una forma di autocitazione, ma un radicale spostamento di materiali testuali e potenzialità poetiche: cioè la nuova poetica 28 Consolo scrisse anche per la personale di un altro pittore: Luciano Gussoni, Villa Reale di Monza, 10-30 novembre 1971. Il titolo della presentazione era, nota interessante, Nottetempo, casa per casa. Secondo Messina (2005: 123), il testo scritto per la mostra avrebbe avuto una diretta ripercussione nella costruzione del capitolo vii de Il sorriso, dove sarebbe stato rifuso. Cfr. Messina (2009: 390-393); e inoltre p. 592-621 e 623-627, con le anastatiche del catalogo di Spadaro e di Marina a Tindari, seguite da quella del catalogo di Gussoni. 29 La disposizione in versi e opera del curatore del libretto, Sergio Spadaro, che ha inteso cosi visualizzare i metri intravisti nella prosa consoliana per il catalogo originario. Per un’analisi delle forme metriche nella prosa di Consolo, cfr. Finzi e Finzi (1978: 121-135). di Consolo comporta l’accumulo di diversi testi di varia provenienza, siano essi giornalistici, creativi o di ambito saggistico, in uno spazio a meta fra il polifonico e il palinsesto di singolare gestazione autoriale. Inoltre, in questo particolare esempio, lo spostamento di materiali testuali investe il rapporto di Consolo con l’arte figurativa e le potenzialità proteiformi di parola e immagine. Altrove lo scrittore ha dichiarato: [.,.] io non ho mai scritto una recensione di tipo logico critico dei pittori. I pittori mi interessavano quando mi davano lo spunto per scrivere delle pagine di tipo lirico narrativo, ed allora poi utilizzavo queste presentazioni per scrivere quelli che io chiamo gli ‘a parte’, la parte del coro quando s’interrompe la narrazione. Queste digressioni di tipo lirico espressivo che i latini chiamavano ‘cantica’. (Consolo, 2006: 235) Questo tipo di poetici a parte o di elementi lirico-narrativi a carattere digressivo, sono presenti con maggior frequenza nell’opera più tarda di Consolo e vi assolvono una funzione decisamente corale. L’esempio dedotto dal capitolo i de Il sorriso rappresenta la prima apparizione di questa procedura unica nell’opera di Consolo, una procedura che suggerisce anche il suo ruolo epifanico all’interno della prosa. Non si tratta di un’ekphrasis nel senso stretto del termine, ma la fonte prima svolge una funzione ecfrastica nel suo accentuare l’articolazione del campo visivo. Cosi, queste fonti testuali, giornalistiche, saggistiche e creative, insieme alle varianti testuali, offrono un aiuto inestimabile per la ricostruzione del capitolo i de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Esse evidenziano i momenti salienti della gestazione e forniscono spunti di approfondimento delle preoccupazioni dell’autore; sono parte integrante dei processi creativi del romanzo e ampliano la nostra conoscenza degli aspetti oscuri dell’intero testo; soprattutto, ci permettono di vedere Il sorriso come un prodotto testuale degli anni attorno al 1960, periodo intimamente collegato agli anni di Consolo in Sicilia. Una volta a Milano, lo scrittore inizio l’arduo cammino di tracciare la forma del suo romanzo, di riunirvi tutti i disparati elementi di questo testo mutevole.

Daragh O’Connel
Bibliografia
AA.VV., 1939, Dizionario dei Siciliani illustri, ristampa anastatica, Palermo, F. Ciuni Libraio Editore. Agnello G. (a cura di), 1972, «Le antichità di Tindari nel carteggio inedito di Saverio e Mario Landolina», Estratto dall’Archivio Storico Siciliano Serie iii – Vol. xx, Palermo, La Società Siciliana per la Storia Patria, p. 218-219. Bachtin M., 2001, Estetica e romanzo, trad. Clara Strada Janovič, Torino, Einaudi. Calvino I., 1995, Una pietra sopra, Milano, Mondadori. Consolo V., 1967a, «Il barone magico: Lucio Piccolo», L’Ora, 17 febbraio. Consolo V., 1967b, «Per un po’ d’erba ai limiti del feudo», in: Narratori di Sicilia, a cura di Leonardo Sciascia & Salvatore Guglielmino, Milano, Mursia, p. 429-434. Consolo V., 1969, «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Nuovi Argomenti, 15 (luglio settembre), p. 161-174. Consolo V., 1970, «Cosi la pomice si mangia Lipari», Tempo illustrato, 17 ottobre. Consolo V., 1971, «C’era Mussolini e il diavolo si fermo a Cefalù», Tempo illustrato, 2 ottobre. Consolo V., 1972, Marina a Tindari, a cura di Sergio Spadaro, Vercelli, Arti grafiche Cav. Piero De Marchi. Consolo V., 1975a, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Gaetano Manusé. Consolo V., 1975b, «Un suggestivo anticipo del nuovo romanzo di Vincenzo Consolo. Festa in casa del barone Mandralisca», L’Ora, 9 dicembre. Consolo V., 1976, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Torino, Einaudi. Consolo V., 1985, Lunaria, Torino, Einaudi. Consolo V., 1987, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 1988, Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori. Consolo V., 1991, «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Narratori di Sicilia, a cura di Leonardo Sciascia e Salvatore Guglielmino, Milano, Mursia, p. 387-395. Consolo V., 1992a, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori. Consolo V., 1992b, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Torino, Einaudi. Consolo V., 1993, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli. Consolo V., 1994, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori. Consolo V., 1995, Il sorriso dell’ignoto marinaio, a cura di Giovanni Tesio, Milano, Elemond Scuola. Consolo V., 1997, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 1999a, Di qua dal faro, Milano, Mondadori. Consolo V., 1999b, «La scoperta di Cefalù (come un racconto)», in: Vincenzo Consolo, Giuseppe Leone, Cefalù, Palermo, Bruno Leopardi. Consolo V., 2002, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 2004, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 2006, «Clausura de las jornadas», Lunaria vent’anni dopo, a cura di Irene Romera Pintor, Valencia, Generalitat Valenciana, p. 235-237. Consolo V., 2012, La mia isola è Las Vegas, Milano, Mondadori. Consolo V., 2013, Esercizi di cronaca, Palermo, Sellerio. Consolo V., 2015, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani». Consolo V., 2017, Cosa loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010, Milano, Bompiani. Contat M., Ferrer, D. (a cura di), 1998, Pourquoi la critique génétique ? Méthodes, théories, Paris, CNRS Éditions. Contini G., 1970, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi. Enzensberger H. M., 1966, «Letteratura come storiografia», Il menabò, 9, p. 7-22. Genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio 75 Finzi A., Finzi, M., 1978, «Strutture metriche della prosa di Consolo», Linguistica e letteratura, 3: 2, p. 121-135 Genette G., 1997, Palinsesti: la letteratura al secondo grado, Torino, Einaudi. Gresillon A, 1994, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, Paris, P.U.F. Hay L. (a cura di), 1979, Essais de critique génétique, Paris, Flammarion. Ingrilli F., 2000, Paesi e paesaggi dei Nebrodi, Brolo, Ermes dei Parchi. Levi C., [1955] 1979, Le parole sono pietre, Torino, Einaudi. Lupo S., 1996, Storia della mafia: dalle origini ai nostri giorni, Roma, Donzelli. Manzoni A., 2002, I promessi sposi (1840), a cura di Salvatore S. Nigro, Milano, Mondadori. Messina N., 1994, «Due contributi alla lettura di Vincenzo Consolo tra ecdotica e “Quellenforschung”», Cuadernos de Filología Italiana, 1, 39-46 Messina N., 2005, «Per una storia di “Il sorriso dell’ignoto marinaio” di Vincenzo Consolo», Quaderns d’Italia, 10, p. 113-126 Messina N., 2009, Per un’edizione critico-genetica di Vincenzo Consolo. «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Madrid, Universidad Complutense de Madrid, «E-Prints Complutense», <http://eprints.ucm.es/8090/> Nisticò V., 2001, Accadeva in Sicilia. Gli anni ruggenti dell’«Ora» di Palermo, Palermo, Sellerio. O’Connell D., 2003, «‘Trista conca’: Dantean Anagnorisis and Echo in “Il sorriso dell’ignoto marinaio”», Echi danteschi/ Dantean Echoes, a cura di Roberto Bertoni, Torino, Trauben, p. 85-105. O’Connell D., 2004, «Il dovere del racconto: Interview with Vincenzo Consolo», The Italianist, 24 (2), p. 238-253. O’Connell D., 2005, «Zu Luigi: Pirandello and the Sicilian Literary Tradition», Pirandello Studies, 25, p. 29-48. O’Connell D., 2008, «Consolo narratore e scrittore ‘palincestuoso’», Quaderns d’Italia, 13, p. 161-184. Onofri M., 1995, Tutti a cena da Don Mariano. Letteratura e mafia nella Sicilia della nuova Italia, Milano, Bompiani. O’rawe C., 2007, «Mapping Sicilian Literature: Place and Text in Bufalino and Consolo», Italian Studies, 62, p. 79-94. Ovazza M., 1967, Il caso Battaglia. Pascoli e mafia sui Nebrodi, Palermo, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre. Pirandello L., 1973, I vecchi e i giovani, in Tutti i romanzi, II, a cura di Giovanni Macchia e Mario Costanzo, Milano, Mondadori. Renda F., 1998, Storia della mafia, Palermo, Sigma Edizioni. Romano S. F., 1952, Momenti del Risorgimento in Sicilia, Firenze, D’Anna. Santino U., 2000, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Roma, Editori Riuniti. 76 Daragh O’Connell Segala A. (a cura di), 1988, Littérature Latino-américaine et des Caraïbes du xxE siècle. Théorie et pratique de l’édition critique, Roma, Bulzoni. Segre C., 1991, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi. Segre C., 2005, Tempo di bilanci. La fine del Novecento, Torino, Einaudi. Stajano C., 1975, «Il sorriso dell’ignoto marinaio. Due siciliani pazzi per un libro ‘unico’», Il Giorno, 30/11/1975. Tavani G., 1996, «Filologia e genetica», Cuadernos de Filología Italiana, 3, p. 63-90. Traina G., 2001, Vincenzo Consolo, Fiesole, Cadmo.
Vincenzo Consolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio.
Il sorriso dell’ignoto marinaio viene pubblicato nel 1976 per l’Einaudi ed è il primo vero successo di Vincenzo Consolo. È un’opera percorsa da una forte tensione civile, un romanzo storico che riporta nella Sicilia dei moti rivoluzionari del 1860 ed ha al centro una sommossa contadina che si scatena in un piccolo paese (Alcara li Fusi ) all’arrivo delle truppe di Garibaldi. Questa sommossa è l’occasione per una presa di coscienza del protagonista, il barone filantropo Mandralisca di Cefalù (che riceve in dono a Lipari il celebre Ritratto d’ignoto marinaio ritratto che Antonello da Messina dipinse tra il 1460 e il 1470 su una tavola di piccole dimensioni). È attraverso quest’ultimo quadro che l’autore si interroga su grandi temi come la posizione dell’intellettuale dinanzi alla storia, il valore e le possibilità della scrittura letteraria, gli eventi cruciali della storia civile italiana, del passato e del presente. Consolo, attraverso la figura di Mandralisca si fa portavoce del malessere delle genti siciliane e dello spirito popolare tradito dalle strutture politiche. Egli inserisce nel racconto documenti dell’epoca, spesso manipolati; importante è perciò, in questo romanzo, la commistione tra arte e narrativa, tra storia e attualità.
Tra ricamo e labirinto: l’opera e la scrittura di Vincenzo Consolo
Tra ricamo e labirinto: l’opera e la scrittura di Vincenzo Consolo
 Prima di leggere i libri di Vincenzo Consolo, ho letto qualche recensione e soprattutto alcune sue interviste che delineano una vera e propria ars poetica, presentandosi come manifesti letterari e civili di una grande e acuta profondità di pensiero, capaci da soli di far crescere l’interesse e la curiosità per la sua opera. E tutto questo, devo dire, per quella straordinaria disponibilità con la quale si mette direttamente al centro della problematica e, poi, per la sincerità confermata da ogni frase nel parlare apertamente del suo lavoro, delle sue ossessioni estetiche e non solo. Mi ha sconvolto innanzitutto la riflessione acutissima con la quale discute aspetti controversi di poetica narrativa in un momento in cui questi problemi sono diventati così complicati, fino a generare lunghe e spesso faticose, orgogliose dispute che finiscono per complicare ancor di più le cose.
Prima di leggere i libri di Vincenzo Consolo, ho letto qualche recensione e soprattutto alcune sue interviste che delineano una vera e propria ars poetica, presentandosi come manifesti letterari e civili di una grande e acuta profondità di pensiero, capaci da soli di far crescere l’interesse e la curiosità per la sua opera. E tutto questo, devo dire, per quella straordinaria disponibilità con la quale si mette direttamente al centro della problematica e, poi, per la sincerità confermata da ogni frase nel parlare apertamente del suo lavoro, delle sue ossessioni estetiche e non solo. Mi ha sconvolto innanzitutto la riflessione acutissima con la quale discute aspetti controversi di poetica narrativa in un momento in cui questi problemi sono diventati così complicati, fino a generare lunghe e spesso faticose, orgogliose dispute che finiscono per complicare ancor di più le cose.
Quella disponibilità, quella chiarezza e soprattutto quella sincerità, la franchezza, il suo modo di dire le cose senza nessuna intenzione di lusingare oppure di offendere la sensibilità del lettore costituiscono alcune delle qualità portanti del suo profilo letterario, capaci di configurare un modello di scrittore impegnato con la sua vita, con la vocazione e l’ardore nella propria scrittura e nel destino assunto, e assunto fino in fondo. Se la letteratura è ancora come dev’essere un problema di carattere, oltre il talento, oltre la vocazione vera, allora si può sostenere senza nessun rischio di approssimazione convenzionale che Vincenzo Consolo, a parte la dimensione particolare della sua scrittura, appartiene, a mio avviso, a quella tradizione di artisti per i quali il binomio arte e vita rappresenta un punto fermo di partenza e un punto fermo di arrivo; un progetto che fa coincidere il fuori e il dentro, realtà e coscienza, il destino, parola e cosa, società e individuo.
La ricchezza del suo lavoro, in tutti gli aspetti che riguardono il rapporto io-mondo, io-reale, e in particolar modo le scelte stilistiche, il problema linguistico così essenziale per uno scrittore italiano offrono una moltitudine di prospettive dalle quali si può partire nella valutazione della sua opera. Si è parlato a un certo momento di un carattere «intellettuale» della sua scrittura; ho già usato le virgolette per questo aggettivo, perché in effetti ogni costrutto che assume l’intento di un prodotto artistico non lo può escludere, non lo può evitare. Anche perché – si sa bene oggi forse meglio di ieri – esiste purtroppo una allucinante arte del consumo rivolta prevalentemente a un fruitore pigro, che va incontro alle sue aspettative più facili, alla sua comodità. Da questo punto di vista Consolo procede in una maniera tutta contraria: perché ha scelto di scrivere sulla realtà, di affrontarla, forse non per cambiarla – sarebbe soltanto un sogno da sempre – ma per portarla sul piano della coscienza per destare nel lettore la curiosità, il coraggio di assumere la realtà integrale con tutte le sue insidie, e le sue deformazioni.
Appunti di lettura. La metafora dell’«angelus novus»
Detto questo, vorrei iniziare sfogliando alcune mie pagine di appunti raccolti in presa diretta dai testi del Nostro. Sempre aperture di prospettive, di letture, di percezioni senza la preoccupazione, almeno per adesso, di articolare un discorso lineare dotato di quella coerenza che deve restare come prima condizione di una interpretazione, per dire così, organica.
Con la pubblicazione del suo primo libro, l’autore afferma di aver avuto già la consapevolezza di cosa sarebbero stati gli argomenti della sua scrittura e cosa gli interessava di più: «Mi interessava – afferma lo scrittore – il mondo storico sociale, non mi interessavano i problemi personali o le indagini psicologiche. Mi interessava raccontare la Storia, la Sicilia, e quindi ho proseguito su questa scelta di argomenti privilegiando quelli che erano i temi storico-sociali. Mi collocavo anche come stile, come tipo di espressione, su una linea sperimentale e di tipo espressivo». C’è già tutto qui: la scelta della ʻtematicaʼ e l’opzione stilistica, i due pilastri di ogni lavoro letterario.
Ebbene, la Storia, ma quale Storia, della Sicilia, però la storia è già qualcosa di infinito, non solo per la durata, ma anche per la sua dialettica interna, per il modo in cui viene vissuta e, poi, scritta-descritta, di chi, per chi e da chi assunta e con tante sofferenze, con delle conseguenze purtroppo irreversibili e così via. È proprio qui che sento il bisogno di chiamare in causa la metafora ormai famosa che è quella benjaminiana dell’Angelus Novus. Ricordiamola: «… un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che chiamiamo progresso, è questa bufera».
Una metafora, questa benjaminiana, dell’angelus novus, che tra l’altro non identifica un angelo nuovo, bensì ci può ricordare anche la figura della Medusa con il suo sguardo mortale per chi cerca di affrontarla a viso scoperto; possiamo poi evocare anche la metafora del labirinto dove, anche se non vi sono delle macerie – oppure non si fanno vedere – c’è sempre lo sguardo impegnatissimo nel trovare quel punto debole del percorso da dove sperare di trovare la via d’uscita o meglio una via d’uscita…
Ritorniamo all’opera di Vincenzo Consolo, cercando di trovare un punto di riferimento in grado di indicarci quale via (non di uscita, ma di entrata nel suo mondo, nel suo labirinto) possiamo seguire. Operazione assai difficile; innanzitutto perché ce ne sono molte, voglio dire, ci sono molti punti di riferimento, nuclei semantici, nodi referenziali che possono diventare vere e proprie chiavi di lettura e di approccio; e, poi, in secondo luogo, operazione difficile proprio perché, specie in uno scrittore come Consolo che ignora, rifiuta, addirittura respinge qualsiasi metodo prestabilito, assumere un punto di partenza o un altro come una sorta di filo conduttore nell’esegesi della sua opera sarebbe ancora una volta una scelta in limine, ugualmente rischiosa.
Percorriamo un’altra strada. Ecco, citiamo alcune sue considerazioni prese qua e là dalle quali si potrebbe iniziare un percorso esegetico. Procediamo, questa volta noi, in maniera metodica così da identificare una linea, diciamo così, tematica: «Quando io ho pubblicato il mio primo libro, La ferita dell’aprile, ero consapevole di cosa fossero gli argomenti della mia scrittura e cosa mi interessava. Mi interessava il mondo storico sociale, non mi interessavano i problemi personali o le indagini psicologiche. Mi interessava raccontare la Storia, la Sicilia e quindi ho proseguito su questa scelta di argomenti, privilegiando quelli che erano i temi storico-sociali…»
Allora, la scelta tematica era già identificata, e anche assunta: raccontare la Storia e propriamente una Storia, non solo quella della Sicilia, ma anche una sua parte, alcune pagine scelte fra le tante, e poi vedremo qual era il criterio insito in quella scelta.
Invece, molto significativo mi pare qui far interferire questo orientamento tematico dello scrittore con la metafora di Benjamin: qui interviene per darci una conferma l’autore stesso quando afferma che ha cercato «di scrivere delle narrazioni nel modo in cui intende questo genere Walter Benjamin, un tipo di scrittura o di racconto che appartiene ancora a una società pre-borghese». Che cosa significhi pre-borghese non mi pare così difficile da capire ma solo riducendo il discorso, sempre in base alle affermazioni dell’autore, a quella tipologia sociale per la quale la Storia non ha alcun senso di progresso e tantomeno una base giustificatrice. Quel mondo, quindi, situato tra una civiltà ancora contadina nei suoi aspetti superficiali, formali, apparenti, e che ha perso la sua coerenza di una volta, quella parte di sapienza di cui parla ancora la letteratura orale, e il mondo borghese, che forse, se non sbagliamo noi, ha attraversato quello del sottoproletariato, nel senso che si è fatto sfruttare, abbandonandolo per poi strumentalizzarlo con il preciso scopo di approfittare del suo lavoro. In tutte queste due categorie si ritrova un punto comune: la povertà, è da essa che poi scaturisce sempre il tentativo di opposizione, di confronto, di lotta, con l’intera scenografia che si conosce: speranza, attesa, fede e diffidenza, l’impegno diretto, il tradimento da alcune parti, e, alla fine, le sconfitte; ma sconfitte che conferiscono sostanza alla storia, le danno la propria consistenza, nel bene e nel male…
L’idea di labirinto
Esiste poi un altro punto di riferimento (e di partenza), quello che ci porta all’idea di labirinto. Ecco, parlando vent’anni dopo, su Il sorriso dell’ignoto marinaio, Consolo avverte: «I tre elementi allora, la rivolta contadina di Alcàra, i cavatori di pomice di Lipari e il Ritratto d’Antonello reclamavano una disposizione su uno spazio di rispondenze e di senso, in cui il Ritratto stesso, nel suo presumibile percorso da una Messina, già di forte connessione storica, cancellata dai terremoti, a Lipari, isola-regno d’esistenza, di mito, a Cefalù, approdo nella storia e nella cultura, disegnava un triangolo e un movimento da un mare d’incertezza e rassegnato destino (…), a una terra di consapevolezza e di dialettica. Questa planimetria metaforica verticalizzavo poi con un simbolo offertomi dal malacologo Mandralisca, quello della conchiglia, del suo movimento a spirale»*.
A proposito di Eliade, si può riflettere intorno a un’idea che potrebbe servire nell’operazione di decriptazione di alcuni significati portanti della letteratura consoliana e cioè quella indicata dal grande scienziato romeno con la formula l’incentramento del margine, o meglio centrare il margine; quell’arduo compito che Consolo assume così come intendiamo noi il suo operare sulla storia e sul reale e cioè quello riguardante strettamente la Sicilia, si potrebbe indicare almeno sul piano di un’ideologia letteraria, questo tentativo di porre al centro (dell’interesse e della preoccupazione del lettore e non solo) ciò che si è chiamato il problema della Sicilia, la Sicilianità come quel modo di vivere nella difficoltà.
Sempre con riferimento a Eliade, si deve invocare qui la sua metafora dell’eterno ritorno, che per altro è anche una metafora di estrazione romantica e, in particolar modo, nietzschana; tuttavia, in Eliade, la metafora si colloca puntualmente nel discorso sull’origine e sul dovere (quasi un segno di destino e di fatalità) di ritornare sempre al punto di partenza, e così si genera, inculcata nella nostra vera e propria identità, una circolarità che alimenta, intrattiene, potenzia la sofferenza, il dolore, una specie di pendant a quel male di vivere montaliano.
Ecco come si colloca Consolo in funzione del motivo del ritorno all’origine, che infatti è un altro motivo ricorrente nelle sue meditazioni-riflessioni.
Parlando del suo libro L’ulivo e l’olivastro, l’autore propone un aspetto particolare della sua Sicilia presente, ma sempre col riferimento al mito ulissiano e al tema del ritorno come un dovere ontico, come destino. «In Sicilia – afferma l’autore – si ritorna, non si può fare a meno. Così come Ulisse lascia la dolce terra dei Feaci per ritornare nella sua pietrosa Itaca. Non si può prescindere dai luoghi dove si è nati, dove si è cresciuti, dove si sono sentite le prime voci, dove si sono viste le prime luci. Sono luoghi che non si possono eliminare dalla nostra memoria. Si sente il sogno di tornare, malgrado tutto».
E di qui che si va verso la metafora della lumaca, collocata anch’essa nel labirinto, vista come una rappresentazione di un’ascensione dal basso verso l’alto, e che può significare anche lo sprofondare e il perdersi all’apice di questa stessa spirale. Diamo di nuovo la parola all’autore: «Ed è anche il simbolo, per studiosi di etnologia e di storia delle religioni, …il simbolo del labirinto. Ecco, dal labirinto, con intelligenza, si può uscire, oppure si può rimanere prigionieri. Ecco, quel simbolo io l’ho preso come il simbolo della storia, per cui i popoli, le popolazioni che si trovano in una infelicità sociale, possono rimanere prigionieri dentro questo labirinto a forma di spirale, oppure, seguendo il labirinto, possono uscire verso la realtà della storia e prendere consapevolezza della loro condizione sociale…». Conclusione, una fra le tante, emblematica, direi, per il lavoro del Nostro.
Inutile evocare a questo punto una parola-concetto, una parola spia della scrittura di Consolo e appunto la parola greca nostos, che vuol dire proprio l’origine, quell’ipogeo come il dovere di partire sempre dalle radici, che non per caso si trovano nel sottosuolo, nel sottoterra, quel luogo che fa da controcanto, da contropartita alla Storia nella visione e nella rappresentazione di Vincenzo Consolo. E le cui immagini (di questi luoghi sotterranei, di queste caverne) sono un po’ il corrispettivo della profondità della lingua e della profondità della storia; è già un altro punto di partenza per addentrarci nell’opera consoliana.
La scrittura come ricamo
Ma si può continuare con l’idea di labirinto come una metafora così produttiva nel campo esegetico. Oltre il suo vastissimo e diversissimo campo semantico, mi pare opportuno sottolineare un fatto della poetica narrativa di Consolo: il rapporto che stabilisce tra l’idea di viaggio come esplorazione dello spazio, più quello del mare che della terra, il viaggio come anche ritorno, di un Ulisse che si trasforma così in un prototipo dell’eroe universale, un archetipo della sapienza, del conoscere, un navigatore ideale e insieme singolare. Pare superfluo ricordare che per Consolo, come per Dante, per Pirandello, la vicenda dell’eroe omerico con la sua intera disperazione riguarda lo spazio siciliano, e anche quello terribile e insieme affascinante Stretto di Messina che diventa anch’esso ricorrente nell’opera del Nostro.
Il tentativo di Ulisse, sommariamente indicato qui, punta sullo spazio cosicché, attraversarlo per conoscerlo equivale ad assumerlo. Un tentativo compiuto col sacrificio liminare, non di una sua possibile fine, morte, ma, con l’allontanamento dalla sua Itaca, coll’affrontare il rischio di perdere tutto ciò che aveva prima, regno e soprattutto l’amore incorporato nella figura di Penelope. Qui interviene un altro possibile punto di partenza per interpretare l’opera di Consolo: quello che potrebbe omologare la sua scrittura sullo stesso piano con la tela su cui Penelope sta ricamando, non qualcosa di utile, ma proprio l’attesa stessa che subentra così nel destino, suo, di Ulisse, di tutti noi.
La scrittura come ricamo non mi risulta fuori del progetto scritturale dell’autore di Le pietre di Pantalica. La invoca anche, se mi ricordo bene. Invece sul piano stilistico, espressivo, poetico, il labirinto si presenta davvero come un riferimento preciso, assolutamente non casuale, legato a una scelta che Consolo identifica in Calvino. Ed è per questo che si può chiamare in causa, per la sua specificità poetica, la famosa formula calviniana La sfida del labirinto; ma il riferimento non significa altro che un possibile percorso della critica nella ricerca di altre chiavi di lettura per poter dare effettivamente, se questo fosse possibile e plausibile, un senso al mondo che ci propone un autore che rimane – poiché così deve rimanere – ancora un mondo da interrogare, in un confronto sempre aperto con la coscienza del lettore…
La semantica del labirinto
Ma quale sarà a questo punto l’offerta indicata, più adatta, della ricca e lunga semantica del labirinto? Quel gioco che ha, come ricorda Kerenyi, un significato rituale e che come tale serve a scongiurare – rappresentandola – la paura della morte, l’angoscia dell’uomo di fronte alla nullificazione di tutte le cose? Rifacciamo in breve lo scenario di questo gioco che si presenta in due tempi, in due fasi: l’entrata nel labirinto e il faccia a faccia col mistero, in cui gli attori sperimentano la perdita di sé; poi, il ritorno alla luce che rappresenti, diciamo, una nuova nascita, attestando la continuità della vita che di generazione in generazione rinnova se stessa. Fin qui, Kerenyi. Sono intervenute poi tante altre interpretazioni-soluzioni, come quella di Tagliaferri per il quale il labirinto potrebbe essere preso come una metafora di un utero materno e il filo di Arianna sarebbe allora un cordone ombelicale, il Minotauro diviene un embrione, un germoglio, un’ombra inquietante con cui dobbiamo confrontarci.
Per Calvino, si sa, si pone un altro tipo di richiesta, di interrogativo, di soluzione, attraverso un’idea – che abbiamo incontrato anche in Consolo, a proposito di un altro argomento –, ma non così distante da questa prospettiva, torno a ripetere, di natura poetica e, se si vuole, di poiesis, come il far poetico.
Per l’autore delle Cosmi-comiche, l’operatore interpretativo diventa un rapporto cartografico che include una distanza rispetto al labirinto: così, è facile trovare la via d’uscita quando il labirinto si osserva dall’esterno, quindi quando si dispone di una mappa totalizzante; invece, dal di dentro e allorquando le mappe sono parziali e contraddittorie, succede che non solo sia possibile la salvezza, ma si entra in una grave confusione, una specie di sostituzione dei topos, delle isole, appunto, perché avvicinandosi, il topos, l’isola cambia nome, ossia anche l’identità.
Ci fermiamo qui con la storia esegetica di un motivo-mito così complicato e insieme stimolante. Ma non prima di focalizzare almeno una suggestione per la scrittura di Consolo: il labirinto per lui si presenta in veste di Storia, o meglio una sua pagina sempre della storia siciliana, identificata in alcuni momenti di rottura, di confusione, di sconvolgimento, e perciò bisognosa non di una giustificazione, ma di una giusta ricostruzione in base alla quale sarà poi possibile denunciare quelle tracce, e quelle insidie, che ci provocano nel e dal presente.
Ed è per questo che rientra in scena proprio adesso la metafora benjaminiana dell’angelus novus; il quale, ricordiamoci, si trova fissato, prigioniero tra un passato per cui non basta la sua nostalgia a compiere il ritorno, ma non è possibile nemmeno andare avanti, nel futuro, per via di quella bufera che lo sconfigge.
Ma il presente dov’è? Il presente non esiste, sulla linea di una dialettica elementare, è soltanto un passaggio, un momento di transito, un limbo, quel purgatorio dantesco dove Virgilio ha quasi perso tutti i poteri e dove a Dante, come a tutti noi, è rimasto solo porsi degli interrogativi come soluzione di orientamento. Ma l’idea di labirinto è un motivo di riflessione per il Nostro.
Per Vincenzo Consolo, creatore di un’opera che non si impone né per la quantità (dimensione, diversità di motivi, di argomenti), né per l’imprudenza di lusingare i gusti, in gran parte pervertiti, corrotti dal consumismo, del lettore (un lettore che lo vuole, come sostiene, un po’ simile a se stesso), quindi per Vincenzo Consolo, la letteratura mi pare che sia una scommessa; e un riscatto: una scommessa con la Storia così come è sempre stata scritta-descritta, ma non vissuta; e un riscatto come tentativo di recupero per la mediazione della parola, diventata pietra, capace invece di esorcizzare il reale vero, quello vissuto, e mai tradito.
In questa prospettiva, poetica, sento il bisogno di identificare la formula paradigmatica per l’insieme della sua opera e che si può definire come testualizzazione del reale, ossia un tentativo di trasmutazione, nel logos, di quell’ontos inteso come topos, ipogeo o nostos che dir si voglia.
NOTA
* Archetipo biologico e origine di percezione, conoscenza e costruzione, com’è nella Spirale delle calviniane Cosmi-comiche; arcaico segno centrifugo e centripeto di monocentrico labirinto, com’è in Kérenyi e in Eliade.
George Popescu
(n. 11, novembre 2012, anno II)
Isole dolci del Dio.
*
Quasimodo le chiama “Le isole dolci del Dio” e le guarda dal Tindari nella bellissima lirica intitolata “Vento a Tindari”. Per noi siciliani dell’isola grande, queste isole che avevamo di fronte, soprattutto per noi che abitavamo sulla costa settentrionale, erano delle isole da una parte fantasmatiche perché apparivano e sparivano a seconda del tempo, le nebbie o le calure estive, a volte sembravano vicinissime e dalla zona dove io abitavo si vedeva finanche il faro di Vulcano. Però d’altra parte era un mondo “maledetto” per noi isolani perché quelle erano le isole dei coatti e poi anche dei confinati politici quindi quando la mia sorellina andò a Lipari e incontrò il suo fidanzato, io l’andai a prendere al molo di Milazzo poi l’accompagnai a casa in treno, perché le signorine da sole non viaggiavano, lei in treno mi raccontò questo suo incontro e mi disse tutta felice che poi questo ragazzo sarebbe venuto a casa per chiedere la mano di mia sorella come si usava allora. Io le dissi “vedrai papà cosa dirà…”. Infatti la sera a cena lei disse “sai papà ho incontrato un giovane, ci siamo parlati e mi ha detto che verrà a chiederti la mia mano.” Mio padre, che era molto rigoroso soprattutto con le figlie femmine, le diede uno schiaffo e disse “e io ti ho mandato a Lipari per cercare un fidanzato?”. Poi si sono sposati nel ’60. Allora ero studente a Barcellona e quando potevo andavo da mia sorella e scoprii questo Paradiso che sono le isole Eolie. Quando avevo tempo libero mi imbarcavo a Milazzo sulla “Luigi Rizzo” che allora era l’unica nave e man mano scoprii prima Lipari poi le altre isole, Salina, Alicudi e Filicudi, Stromboli. Una volta ebbi anche un naufragio su un aliscafo: tornavo da Stromboli, era estate e c’erano tantissimi turisti, a Panarea avevano caricato molte persone per cui questo aliscafo cominciò a imbarcare acqua e quasi affonda, spararono i razzi per chiedere aiuto, arrivarono i pescherecci, ci portarono su questi pescherecci e poi ci abbandonarono su una spiaggia di Panarea tutti bagnati. L’indomani finalmente ho potuto raggiungere Lipari. Un altro ricordo alle Eolie: nel ’62 ero lì e arrivò la colonia romana di Moravia, Pasolini con tutti i suoi ragazzetti e Dacia Maraini con la madre Topazia Alliata: io li vedevo, li osservavo, sapevo chi erano. Andavano a fare il bagno a Vulcano alle sabbie nere e io mi mettevo vicino ad ascoltare i loro discorsi. Un giorno sulla spiaggia dopo aver fatto il bagno mi sono seduto accanto a Moravia con nonchalance; Moravia era paralitico da una gamba e zoppicava e arriva una persona che gli racconta che un subacqueo aveva raggiunto una profondità di non so quanti metri ed egli sentenziò “io mi contento di scendere nella profondità dell’animo umano”. Nasceva proprio quell’estate il nuovo amore fra lui e Dacia Maraini. Al Centro Studi Eoliano ho avuto un incontro per l’anniversario del Constitutum, la costituzione democratica che si erano dati gli eoliani. C’era anche un altro personaggio straordinario che ho frequentato a Lipari, Leonida Buongiorno, che mi raccontava le sue vicende personali e non, di cui ero molto amico era una specie di biblioteca delle isole Eolie. Ho conosciuto anche il prof. Giuseppe Iacolino, un altro studioso delle isole Eolie. Pirandello dice che “noi siamo i primi 9 anni della nostra vita” nel senso che da quando nasciamo cominciamo a guardare quindi questi segni esterni ce li portiamo dentro per tutta la vita, sia i segni visuali che i segni orali – questo lo dice anche Dante nel “De vulgari eloquentia”: noi impariamo la prima lingua, la lingua volgare, dalle persone che ci stanno intorno nei primi anni della nostra vita. Nascere in una grande città come Palermo, Catania o ad Agrigento dove è nato Pirandello o nascere alle Eolie è assolutamente diverso perché i segni sono diversi, per cui un eoliano ha un carattere diverso dall’abitante dell’isola grande. Per la vita così dura e aspra l’eoliano era un tipo parsimonioso e laborioso, sull’isola non c’era il latifondo quindi non c’era la mafia e quindi il lavoro per gli eoliani era senza nessun tipo di compromissione e di cedimento ai poteri. C’è un libro di un confinato politico a Lipari che racconta degli altri confinati: quelli che potevano affittavano una casa a Lipari, gli altri invece erano relegati nel castello, una sorta di prigione, però c’era molta solidarietà da parte degli eoliani, c’era aiuto nei confronti di questi confinati. Quindi gli eoliani erano anche persone generose. Oggi non so se è ancora così. Vedere un mondo “altro” anche primigenio, che cos’è la vita nella sua elementarità e nelle sue leggi fondamentali. I turisti spesso vengono dal nord industriale, da luoghi più abbienti e devono capire cosa significa vivere in una piccola isola. L’esempio della rivolta che c’è stata a Lampedusa per quelli che chiamano centri di accoglienza ma che sono dei veri e propri lager: i lampedusiani vivono anche loro di turismo ma non sopportano che la loro isola diventi un lager a cielo aperto, molti questi poveri infelici hanno anche perso la vita.
Se questi turisti approdando a Lipari, nelle isole Eolie leggessero prima e conoscessero i 5000 anni di storia che ha avuto soprattutto Lipari, la stratificazione di civiltà che c’è stata andando a vedere il museo unico che c’è a Lipari capirebbero che luogo unico è, al di là del mare e del cielo. Sulle Eolie c’è anche il libretto “Isole dolci del Dio” uscito nel 2002 per le edizioni l’Obliquo, scritto per amore delle isole. Al momento sono impegnato a scrivere un’opera per Mondadori, alla conclusione della quale l’editore ristamperà tutta la mia produzione nella collana Meridiani. Dopo quest’ultima fatica, mi piacerebbe lasciare Milano e tornarmene finalmente nella mia amata Sicilia, ma non so se mia moglie Caterina è d’accordo…
Vincenzo Consolo
venerdì, 03 aprile 2009 – (da “Il notiziario delle Isole Eolie)
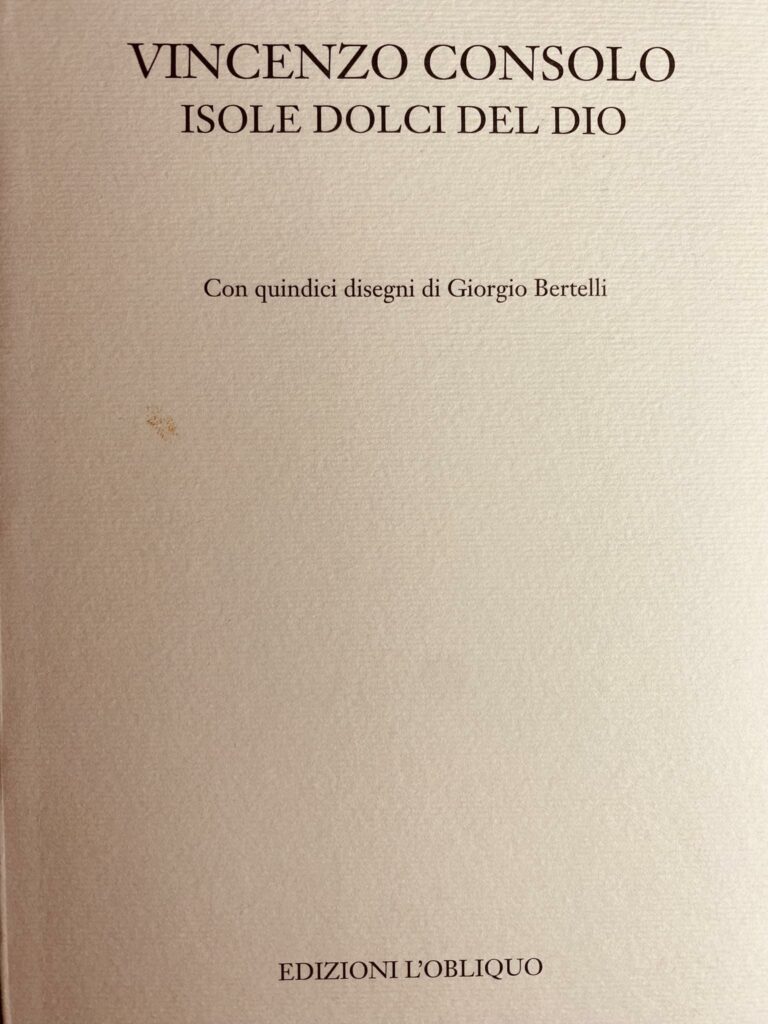




Forme della visione nel Sorriso dell’ignoto marinaio.
Giulio Ferroni Università La Sapienza
La lingua di Vincenzo Consolo sembra come scavare la realtà,
sfidandone la sostanza fisica, l’evidenza visiva, la materia pullulante
che la costituisce: e il capitolo iniziale de Il sorriso dell’ignoto
marinaio, subito dopo la sintesi dell’ Antefatto si muove subito
in due direzioni essenziali, verso l’apertura “geografica” e storica
su di vastissimo ambiente fisico e umano, con la visione della
Sicilia che il Mandralisca ha dalla nave che si avvicina, e verso la
presa in carico del dolore umano, con il «rantolo» del malato, il
cavatore di pomice di Lipari, che sorge dal buio della stessa nave.
È un vero e proprio “quadro”, in cui l’eco di quel lacerante dolore
sembra come sovrapporsi allo svelarsi e al progressivo definirsi
del paesaggio, che quella lingua a forte caratura “poetica” sembra
come voler catturare nella densità delle presenze che lo abitano:
con un’espressività che si addensa intorno alle cose, che mira a
rivelare il loro pulsare, il loro sofferto palpitare, la loro espansione
nella luce o nel buio, ma che non si risolve mai in liricità
pura, producendo movimento, procedendo anche verso atti e gesti
fulminanti (che spesso giungono improvvisamente a rilevarsi
e fissarsi nei finali dei capitoli, nelle clausole quasi lapidarie che
li serrano).
Il primo circostanziato segno visivo, dopo la più indefinita
rivelazione della «grande isola», è costituito dai «fani sulle torri
della costa», con i loro colori e l’incerto oscillare della loro luce
(«erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci
»). Dopo questa prima apertura l’attenzione ritorna all’interno
del bastimento, sembra come ritrarsi nel buio, nel fragore delle
acque e nel cigolio delle vele squassate dal vento che avevano segnato
il percorso notturno della nave e nel presente silenzio del
«mare placato e come torpido», lacerato dal «respiro penoso» e dal
«lieve lamento» del malato. Questo respiro suscita l’immagine del
corpo sofferente, dei «polmoni rigidi, contratti», delle contrazioni
della «canna del collo», della «bocca che s’indovinava spalancata»:
s’indovinava, appunto, perché questa visione di dolore è solo
intuita, non vista; quello che il Mandralisca vede è solo «un luccichio
bianco che forse poteva essere di occhi». Ma proprio a partire
da questo bianco che sinistramente viene a fendere il buio,
la visione viene ad allargarsi verso il cielo ed ancora verso i fani
sopra le torri, che ora definiscono più nettamente il loro aspetto
ed evocano i nomi dei feudatari:
“Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte,
i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i
lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangersi di
tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella,
del Lauro e Gioiosa, del Brolo…”.
La serie dei nomi fa sì che dall’ultimo appaia improvvisamente
uno squarcio di un passato, con l’immagine di una dama affacciata
sul «verone», ma in posa molto realistica, lontana da ogni stilizzazione
cortese: è Bianca de’ Lancia di Brolo, che ha in grembo
Manfredi, figlio di Federico II e che ha la nausea e i contorcimenti
della gravidanza («Al castello de’ Lancia, sul verone, madonna
Bianca sta nauseata. Sospira e sputa, guata l’orizzonte»): è Federico
II, evocato in termini danteschi (il «vento di Soave», da Paradiso,
III) ad aver segnato le sue viscere, è il suo seme ad agire
nervosamente sul suo corpo («il vento di Soave la contorce»); e da
tutto si svolge la parola stessa dell’imperatore, con la citazione di
versi che si immaginano rivolti direttamente al falcone, strumento
essenziale della sua passione per la caccia. Ma ancora, dopo la
citazione, lo sguardo si apre sulla costa, verso le città sepolte, che
non ci sono più ma che sono vagheggiate dall’avidità conoscitiva,
dal gusto storico ed archeologico del barone:
“Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano
Abacena e Agatirno, Alunzio e Apollonia, Alesa… Città nelle
quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni,
fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una
moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente
vaghi, suoni, sogni”.
Ma questo pensiero alle città sepolte, all’improbabile ipotesi di
un loro ritorno alla luce, riconduce poi il Mandralisca alla certezza
della tavoletta «avvolta nella tela cerata» che stringe al petto e
in cui sente persistere gli odori della bottega dello speziale che
gliel’ha venduta. Ma poi questi odori sono sopraffatti da quelli
che ormai provengono da terra, come il buio è sopraffatto ormai
dalla luce («svanirono le stelle, i fani sulle torri impallidirono»):
e ciò porta finalmente alla visione del malato e della donna che
lo assiste e lo soccorre. Da questa visione scaturisce poi la voce
che designa il male dello sventurato; e solo dopo la voce si rivela
la figura dell’ignoto marinaio, col suo «strano sorriso sulle
labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro,
di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce
del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e
da un moto continuo di pietà». Il sorriso dell’ignoto marinaio è
insomma affidato soprattutto allo sguardo (di uno che molto sa
e molto ha visto); la descrizione si appunta sui suoi occhi («E gli
occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia»);
e anche se è vestito come un marinaio, a guardarlo si evidenzia
tutta la sua stranezza («in guardandolo, colui mostravasi uno strano
marinaio») e la forza penetrante della sua «vivace attenzione».
E dopo aver parlato dei cavatori di pomice di Lipari e delle loro
malattie, l’ignoto sorride, mentre il barone si chiede dove mai
l’aveva già visto e, sotto il suo sguardo, vede balenare dentro
di sé le immagini dei cavatori di pomice, del loro duro lavoro e
della loro sofferenza, sotto cui si nascondono ed emergono altre
immagini, quelle per lui consuete dei molluschi che studia e
colleziona e dei volumi degli studi ad essi dedicati, il tutto come
sottoposto ancora allo sguardo criticamente ironico del marinaio.
Si tratta di una formidabile serie di passaggi visivi, segnati da
questo sguardo che tocca il personaggio sconosciuto e che da lui
si svolge: passaggi che toccano le immagini che sorgono dentro
la coscienza stessa del barone e che, pur se solo interne a lui,
egli sente come scrutate e indagate dal marinaio, che gli sembra
addirittura leggere i titoli di quei libri, ironizzando sulla futilità di
quelle così minute ricerche:
Il marinaio lesse, e sorrise, con ironica commiserazione.
Quel sorriso sembra come suscitare il senso di colpa del ricco
intellettuale e amateur, per le sue così marginali predilezioni,
confrontate con la dura realtà dei cavatori di pomice. Ma a questo
punto si sentono i clamori e i rumori dell’ancoraggio, dell’arrivo
ad Olivèri, che fa sorgere un nuovo, vastissimo sguardo all’affollato
paesaggio che pullula sulla riva; sguardo che si svolge a partire
dalla luce che dal sole sorgente riceve la rocca in alto, per scendere
giù fino agli splendori mattutini della spiaggia, alle presenze
animali, alle barche immobili come relitti; distesa visione da cui
balenano ancora le immagini di un passato sepolto, del crollo
dell’antica città, dei «tesori dispersi» vagheggiati dal barone. E poi
ancora uno sguardo indietro, ad una scena del passato, ancora
ad una donna del medioevo, Adelasia (o Adelaide) di Monferrato,
la moglie giovanissima del sessantenne Ruggero I e fondatrice
di un convento a Patti, nei pressi di Tindari, la cui figura, fissata
nell’«alabastro» di un sarcofago, sembra aver atteso impassibile
la rovina del convento, e infine l’immagine del santuario della
madonna nera: «sopra la rocca, sull’orlo del precipizio, il piccolo
santuario custodiva la nigra Bizantina, la Vergine formosa chiusa
nel perfetto triangolo del manto splendente di granati, di perle,
d’acquemarine, l’impassibile Regina, la muta Sibilla, líbico èbano,
dall’unico gesto della mano che stringe il gambo dello scettro,
l’argento di tre gigli». Dopo la discussione col «criato» Sasà, la
spinta visiva si rivolge allo sciamare dei pellegrini che si affollano
per scendere dalla nave, alle offerte e agli ex-voto che essi portano
con sé: e tra di essi viene come centrata ancora la figura del
cavatore malato e della moglie che lo accompagna. Al barcone
che raccoglie i pellegrini che scendono dalla nave fa poi come
da pendant la «speronara» che porta via marmi antichi e piante
di agrumi e si allontana dalla riva, passando sotto il veliero da
dove la osserva il Mandralisca («ebbe modo così di osservare
a suo piacimento»); e infine, dopo la riflessione (appoggiata su
una citazione in corsivo da un testo del Landolina) si ritorna alla
visione dei pellegrini, che stanno salendo in processione verso il
santuario; dal loro canto si svolge improvvisamente quello osceno
di una ragazza che è nel barcone, tra i pellegrini scesi dal
veliero, fermata dalla madre che nella concitazione lascia cadere
in acqua una testa di cera.
La successione e i passaggi continui di dati visivi, intrecciati a
più riprese a dati sonori, vengono a creare, in questo avvio del
romanzo, una sorta di disteso movimento panoramico, in continui
passaggi tra campi lunghi e primi piani, formidabili zoomate
che procedono attraverso distensioni e concentrazioni della parola.
Lo sguardo di Consolo, quello del barone Mandralisca, quello
dell’ignoto marinaio (che, sappiamo è lo stesso della tavoletta di
Antonello e di Giovanni Interdonato), sono come animati da una
tensione a “vedere” che tocca le grandi distese dello spazio, la
vita che variamente si muove in esse, e mette a fuoco non solo
ciò che vi è direttamente visibile, ma anche il peso di quanto
esse hanno alle spalle, ciò che sono state, nel passato storico e
biologico: la visione coglie l’esistere che si distende, il suo carico
di presenze, di memorie, di suggestioni, l’agitazione che lo
sommuove, l’offerta che esso sembra fare di sé, l’ostinazione e la
volontà di vita che lo corrode, il suo stesso disperdersi e consumarsi
nell’aria.
Se si attraversa tutto il romanzo, emerge in piena evidenza
l’intreccio e l’essenzialità dei dati visivi, fissata del resto già nello
stesso riferimento del titolo alla tavola di Antonello. In questa
dominante della visività, è determinante la disposizione ad allargarne
i confini: il volto e il sorriso dell’individuo effigiato dal pittore
sono il punto di irradiazione di una apertura verso i grandi
spazi, verso una moltiplicazione delle presenze e delle evidenze.
Consolo “vede” la Sicilia come un grande corpo brulicante di
vita, esuberante, malsano, appassionato, lacerato, ne vuol rendere
conto come di una totalità; cerca di comprenderne il senso
afferrandone un’evidenza visiva che in ogni squarcio sembra
voler rivelare la densità, la fascinazione e la tremenda rovinosa
disgregazione del tutto, di un insieme di corpi che vi annaspano,
vi soffrono, vi si espandono, vi si mostrano.
La disposizione di Consolo a seguire l’evidenza degli slarghi
che si presentano all’occhio agisce del resto in modo vigoroso anche
nella sua scrittura saggistica, nei suoi larghi percorsi sul territorio
siciliano (in primis ne Le pietre di Pantalica). Qui nel Sorriso
un altro eccezionale squarcio d’insieme è quello su Cefalù, a cui
l’Interdonato si avvicina entrando in porto con il San Cristoforo,
all’inizio del capitolo secondo. Si comincia con la visione dell’affollarsi
di barche nel porto, salendo poi verso le case più vicine:
“Il San Cristoforo entrava dentro il porto mentre che ne uscivano
le barche, caicchi e, coi pescatori ai remi alle corde vele reti lampe
sego stoppa feccia, trafficanti, con voci e urla e con richiami,
dentro la barca, tra barca e barca, tra barca e la banchina, affollata
di vecchi, di donne e di bambini, urlanti parimenti e agitati;
altra folla alle case saracene sopra il porto: finestrelle balconi
altane terrazzini tetti muriccioli bastioni archi, acuti e tondi, fori
che s’aprivano impensati, a caso, con tende panni robe tovaglie
moccichini sventolanti”.
Poi l’obiettivo si muove rapidamente al polo opposto, concentrandosi
sulla rocca lassù in alto e scendendo poi più lentamente
sulle torri del duomo, che addirittura sembrano generate dalla
rocca stessa:
“Sopra il subbuglio basso, il brulicame chiassoso dello sbarcatoio
e delle case, per contrasto, la calma maestosa della rocca,
pietra viva, rosa, con la polveriera, il tempio di Diana, le cisterne
e col castello in cima. E sopra la bassa fila delle case, contro
il fondale della rocca, si stagliavano le due torri possenti del
gran duomo, con cuspidi a piramidi, bifore e monofore, soffuse
anch’esse d’una luce rosa sì da parere dalla rocca generate,
create per distacco di tremuoto o lavorio sapiente e millenario
di buriane, venti, acque dolci di cielo e acque salse corrosive di
marosi”.
Si torna poi all’agitazione furiosa del porto per la pesca abbondante,
alla gara delle barche per piazzarsi «sul filo giusto dei sessanta
passi», allo sbattere delle imposte e ai bagliori del sole che
si distende poi su di un ampio spazio geografico, slargando verso
le località della costa, con un gioco di immagini (il palpitare «a
scaglie» della luce sulla costa) che riconduce dentro il duomo, ai
dorati mosaici del Pantocratore:
“Tanta agitazione era per le pesche abbondanti di quei giorni.
Si diceva di cantàri e cantàri di sarde sàuri sgombri anciove,
passata portentosa di pesce azzurro per quel mare che manco i
vecchi a memoria loro rammentavano.
E venne su la febbre, gara tra flotta e flotta, ciurma e ciurma,
corsa a chi arrivava primo a piazzarsi sul filo giusto dei sessanta
passi. E gara tra famiglie, guerra. Smesso lo sventolio dei
pannizzi, il vociare, si chiusero le imposte con dispetto. I vetri
saettarono bagliori pel sole in faccia, orizzontale, calante verso
la punta là, Santa Lucia, e verso Imera Solunto l’Aspra il Pellegrino”.
Quando più tardi l’Interdonato scende dalla nave, si para in
modo più diretto davanti a lui e al ragazzo che l’accompagna il
pulsare della «gran vita» della città, delle diverse figure umane,
con il loro muoversi affaccendato, su cui echeggiano i segni sonori
del lavoro di chi non si vede, che è intento all’opera nel buio
degli interni:
“Discesi che furono sullo sbarcatoio, passata la Porta a Mare,
imboccarono la strada detta Fiume. Giovanni era eccitato e divertito
per la gran vita che c’era in questa strada: carusi a frotte
correndo sbucavano da strada della Corte, da Porto Salvo, da
Vetrani, da vanelle, bagli e piani, su da fondaci interrati, giù da
scale che s’aprivano nei muri e finivano nel nulla, in alto, verso
il cielo; vecchi avanti agli usci intenti a riparare rizzelle e nasse;
donne arroganti, ceste enormi strapiene di robe gocciolanti in
equilibrio sopra la testa e le mani puntate contro i fianchi, che
tornavano dal fiume sotterraneo, il Cefalino, alla foce sotto le
case Pirajno e Martino, con vasche e basole per uso già da secoli
a bagno e lavatoio. Sui discorsi, le voci, le grida e le risate, dominavano
i colpi cadenzati sopra i cuoi dei martelli degli scarpari,
innumeri e invisibili dentro i catoi.
Il mercatante, come dal San Cristoforo allo spettacolo dello sbarcatoio,
guardava dappertutto estasiato e sorrideva”.
E una Cefalù distesa e panoramica ritorna ancora, più avanti,
nello studio del barone visitato dall’Interdonato, nella copia della
pianta della città del secentesco Passa fiume, «ingrandita e colorata,
eseguita su commissione del barone dal pittore Bevilacqua»:
“La citta era vista come dall’alto, dall’occhio di un uccello che
vi plani, murata tutt’attorno verso il mare con quattro bastioni
alle sue porte sormontati da bandiere sventolanti. Le piccole
case, uguali e fitte come pecore dentro lo stazzo formato dal
semicerchio delle mura verso il mare e dalla rocca dietro che
chiudeva, erano tagliate a blocchi ben squadrati dalla strada
Regale in trasversale e dalle strade verticali che dalle falde scendevano
sul mare. Dominavano il gregge delle case come grandi
pastori guardiani il Duomo e il Vescovado, l’Osterio Magno, la
Badia di Santa Caterina e il Convento dei Domenicani. Nel porto
fatto rizzo per il vento, si dondolavano galee feluche brigantini.
Sul cielo si spiegava a onde, come orifiamma o controfiocco,
un cartiglione, con sopra scritto CEPHALEDUM SICILIAE URBS
PLACENTISSIMA. E sopra il cartiglio lo stemma ovale, in cornice
a volute, tagliato per metà, in cui di sopra si vede re Ruggero
che offre al Salvatore la fabbrica del Duomo e nella mezzania di
sotto tre cefali lunghi disposti a stella che addentano al contempo
una pagnotta”.
La visione dello stemma con i tre cefali dà poi luogo ad un
vero e proprio corto circuito con una visione precedente, quella
di una «guastella» gettata in mare dal ragazzo che accompagna
l’Interdonato e rapidamente divorata da un branco di cefali; e da
qui sorge una riflessione “politica” su Cefalù, la Sicilia, la speranza
del superamento della feroce lotta per la vita e di un trionfo
dell’eguaglianza, della solidarietà, della ragione:
“L’Interdonato, alla vista dello stemma, si ricordò della guastella
buttata dentro l’acqua da Giovanni e subito morsicata dai cefali
del porto. La sua mente venne attraversata da lampi di pensieri,
figure, fantasie. Stemma di Cefalù e anche di Trinacria per via
delle tre code divergenti, ma stemma universale di questo globo
che si chiama Terra, simbolo di storia dalla nascita dell’uomo
fino a questi giorni: lotta per la pagnotta, guerra bestiale dove
il forte prevale e il debole soccombe… (Qu’est-ce-que la propriété?)
… Ma già è la vigilia del Grande Mutamento: tutti i cefali
si disporranno sullo stesso piano e la pagnotta la divideranno
in parti uguali, senza ammazzamenti, senza sopraffazioni animalesche.
E cefalo come Cefalù vuol dire testa; e testa significa
ragione, mente, uomo… Vuoi vedere che da questa terra?…”.
In un romanzo successivo come Nottetempo casa per casa si
aprono altri squarci eccezionali su Cefalù e dintorni, che sembrano
seguire un movimento che attraversa lo spazio casa per casa
e ne coglie l’effetto globale, la configurazione rivelatrice: affidandosi
in primo luogo alla forza evocativa dei nomi, alla precisione
dell’onomastica geografica e topografica, che viene come ad addensare
in sé la vita vibrante del mondo, le esistenze molteplici,
esuberanti e disperate, trionfanti e rapprese, le luci e le ombre
che lo abitano. Nello stesso romanzo il capitolo IV, La torre, apre
anche uno squarcio su Palermo, seguendo il percorso compiutovi
dal protagonista Petro, venuto a partecipare ad una manifestazione
socialista: ai nomi che fissano i dati urbanistici, architettonici,
storici, si mescolano i dati “moderni” delle insegne pubbliche e
della pubblicità e poi quelli delle scritte dei cartelli di un corteo
(mentre dal palco del comizio, su Piazza Politeama, si svolge un
nuovo slargo verso il paesaggio marino, riconosciuto nei suoi più
definiti dati geografici).
Lì, come nel Sorriso, e nelle stesse pagine che abbiamo citato,
i nomi costituiscono un strumento più determinante della resa
espressiva: nomi propri e nomi comuni, sostantivi rari e preziosi,
di forte sostanza letteraria o di rude carica realistica, nomi che
emergono da un passato ancestrale o nomi legati al più dimesso
fare quotidiano, nomi radicati nel fondo dell’esperienza popolare,
nelle pratiche artigiane o contadine o portati dall’invasione della
modernità, dalle sue spinte liberatrici o dai suoi miti più distruttivi
e perversi. L’elencazione seriale, che costituisce il dato stilistico
più diffuso e ben riconoscibile della scrittura di Consolo, agisce
soprattutto nell’ambito dei nomi, collegandosi talvolta a scatti
improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il
linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo
ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità
delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco
della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone
l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo
appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a
farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso
di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro.
Chiuso nella torre (il vecchio mulino avuto in lascito da don
Michele) a meditare sul dolore della propria famiglia (oltre la malattia
del padre, la disperata follia della sorella Lucia), il Petro di
Nottetempo si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di
tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce
come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da
cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un
rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata
dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere
dato dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà
senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del
tempo:
“E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete.
Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo.
Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna.
Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza.
Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno…» scandì come a
voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento
in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si
svolgeva serena, sereno il tempo” (IV, La torre).
Si noti qui come nell’elencazione, che la punteggiatura fissa
in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi,
riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione
che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del
volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno.
Nel Sorriso, peraltro, nel capitolo sesto, rivolgendosi
all’Interdonato nel presentare la sua Memoria sui fatti d’Alcàra Li
Fusi, il Mandralisca rifletteva sulla lingua e sull’«impostura» della
scrittura e proiettava verso il futuro l’utopia di «parole nuove»,
vere anche per gli esclusi dal linguaggio colto, per coloro che
non hanno avuto ancora la possibilità di comprendere le parole
della moderna democrazia:
“E dunque noi diciamo Rivoluzione, diciamo Libertà, Egualità,
Democrazia, riempiamo d’esse parole fogli, gazzette, libri, lapidi,
pandette, costituzioni, noi, che quei valori abbiamo già conquisi
e posseduti, se pure li abbiam veduti anche distrutti o minacciati
dal Tiranno o dall’Imperatore, dall’Austria o dal Borbone. E gli
altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la
terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione,
questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle
parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno
quei valori, ed essi allora li chiameranno con parole
nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i
nomi saranno interamente riempiti dalle cose”.
Ma sappiamo (e ce lo mostrerà il Petro di Nottetempo) che forse
la piena solidarietà tra i nomi e le cose si dà solo nella fantasia
del ritorno alla loro origine, nell’utopia della letteratura, di quella
scrittura che certo tradisce la vita col suo dolore e con la sua
evidenza, ma che sola cerca di dirla e di “vederla”, più a fondo
possibile.
Irene Romera Pintor (coord.)
Editores: Generalidad Valenciana = Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport : Universidad de Valencia = Universitat de València
Año de publicación: 2007
Recoge los contenidos presentados a:Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (1. 2006. Valencia).