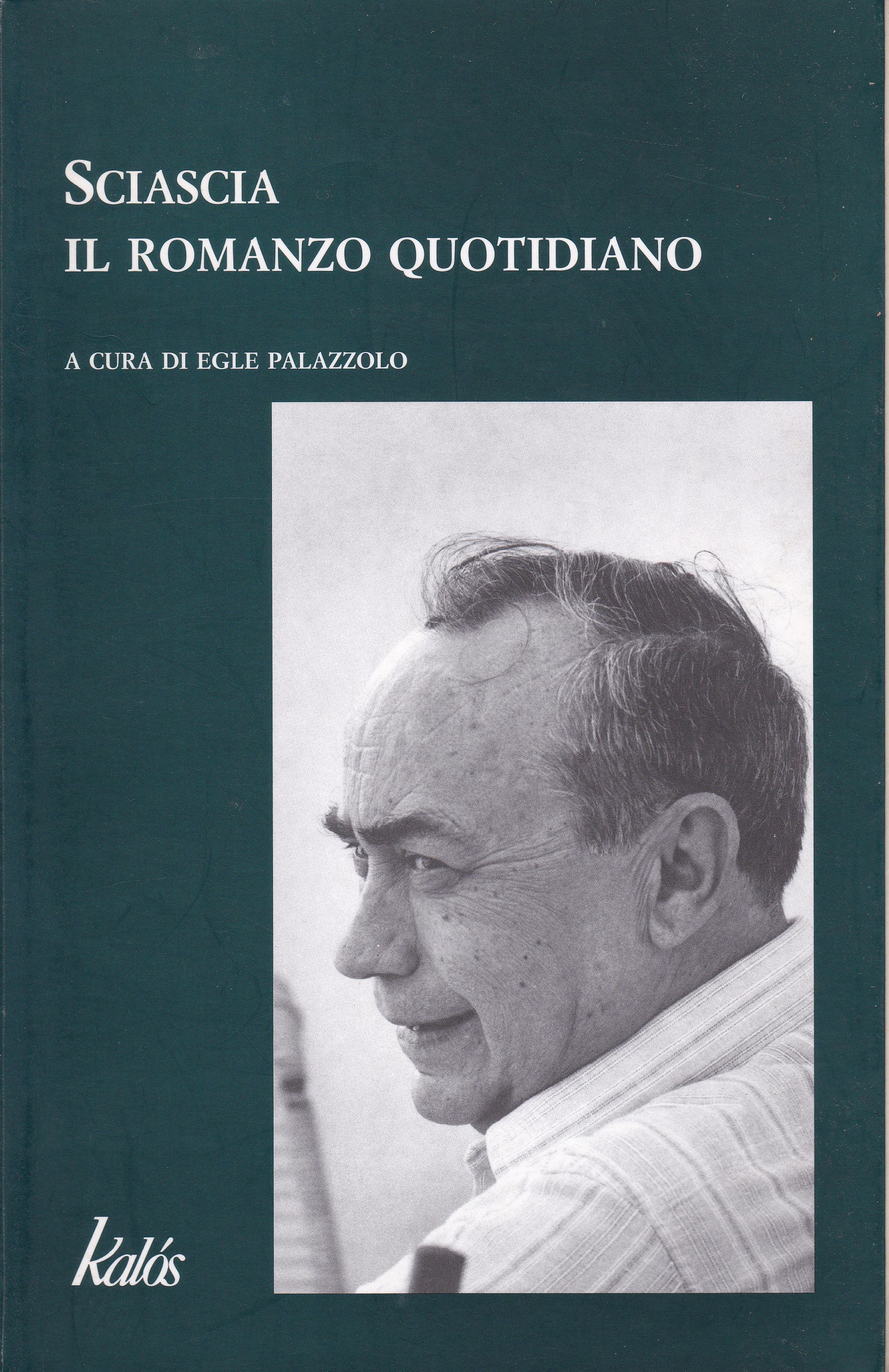Cinzia Gallo
Università di Catania
Riassunto Lo Spasimo di Palermo è esempio di una crisi che ha ripercussioni nella forma espressiva: da una parte, emerge la consapevolezza che «sul ciglio dell’abisso la parola si raggela, si fa […] simbolo sfuggente», dall’altra il romanzo appare un «genere scaduto, corrotto, impraticabile». Il conflitto generazionale fra Chino e Mauro rientra pure in quest’ambito. Da qui derivano varie soluzioni che portano al «poema narrativo» di Consolo e testimoniano il disorientamento prevalente: accumuli paratattici, metafore, figure retoriche, figure del discorso. Le suggestioni pittoriche trovano il loro centro nello Spasimo di Sicilia di Raffaello, simbolo di una sofferenza che da Palermo arriva alla Sicilia e a tutto il mondo, mentre gli spazi hanno una grande importanza e mostrano la perdita della memoria storica, responsabile della crisi.
Consolo, crisi, memoria, storia Secondo Ugo Dotti,
Lo Spasimo di Palermo è caratterizzato dal «contrapporsi di storia a memoria, nel vano bisogno di conforto che il . 8 ricordo potrebbe dare e che suscita al contrario un cocente sentimento di patimento, di sconfitta, di spasimo» (Dotti, 2012, 315). Dunque, uno stretto nesso fra storia, crisi e memoria percorre l’intero testo, anche se esso è, innanzitutto, specchio di una crisi, sia collettiva che individuale. Consolo presenta non solo «il fallimento della generazione del dopoguerra nel creare una società più giusta e più civile» (O’Connell, 2008, 173), per cui terrorismo e mafia risultano uniti «in un clima da fine dei tempi, che nega la storia» (Donnarumma, 2011, 446), ma anche la sconfitta di Chino, padre e scrittore. Da ciò l’impossibilità di narrare, cioè di utilizzare i tradizionali mezzi espressivi. Raccontare è però necessario, come attestano le due battute del Prometeo incatenato di Eschilo poste in epigrafe: «Rivela tutto, grida il tuo racconto… / Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore» (Consolo, 1998, 7). Quest’urgenza di dire si realizza subito tramite la letteratura, come nella conclusione di Nottetempo, casa per casa, in cui essa appare «ultima consolazione […] e ultima possibilità di spiegazione del “dolore” del mondo» (Luperini, 1999, 166). Lo stesso Consolo chiarisce: «[…] è caduta la fiducia nella comunicazione, nella possibilità […] della funzione sociale, politica della scrittura. Non rimane […] che l’urlo o il pianto, o l’unica forza oppositiva alla dura e sorda notte, la forza della poesia» (Consolo, 1993, 58). Il gioco citazionistico è, quindi, subito in primo piano: l’iniziale «Allora tu, […] ed io» (Consolo, 1998, 9), con cui il narratore si rivolge a Chino, è stato collegato da O’Connell (2008, 181) al celebre verso di Eliot «Let us go then – you and I», con cui, peraltro, si chiude il quinto capitolo. Un’altra citazione eliotiana («In my beginning is my end» [Consolo, 1998, 9]), rimandando al consueto simbolo consoliano della chiocciola, della spirale, rileva invece l’importanza della memoria, necessaria per recuperare un’identità veicolata dai nomi («il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza» [Consolo, 1998, 9]), di cui Consolo sottolinea spesso l’importanza come segno identitario. Queste citazioni forniscono subito una prima chiave di lettura, in quanto Eliot utilizza termini spesso non uniti fra loro da legami logici, alterna espressioni auliche con altre colloquiali, mescola svariate lingue, rappresentando così la crisi esistenziale dell’uomo: similmente si comporta Consolo. Anche nel nostro testo, comunque, il narrare significa «rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta» (Consolo, 2012, 92), che «assolva la tua pena, il tuo smarrimento» (Consolo, 1998,10). Questi stati d’animo, già nel primo capitolo, sono rapportati da Chino, giunto a Parigi per incontrare il figlio, con la parola che «si fa suono fermo, […] simbolo sfuggente» (Consolo, 1998, 12). Egli, dunque, respinge come false la lingua accademica («Stendono prose piane i professori, […] decorano le accademiche palandre di placche luccicanti» [Consolo, 1998, 12]) e quella giornalistica («Nul n’échappe décidément, au journalisme ou voudrait-il…» [Consolo, 1998, 12]), e nega il potere evocativo del linguaggio: se dapprima, infatti, il prete oppone alla forza delle armi quella delle parole (Giacomo – Marcellesi, 2004, 73-74), quando chiede, all’inizio dei bombardamenti, «di cantare l’aria con parole senza senso» (Consolo, 1998, 14), queste, poi, non servono a disincantare una «trovatura» (Consolo, 1998, 19). Tornano in mente a Chino, invece, termini legati ad epoche passate («Il maggiore parlò in un modo che credeva ancora di quel luogo» [Consolo, 1998, 13]). Per Consolo, difatti, «la vera scrittura […] poggia sulla memoria letteraria soprattutto» (Consolo, 2006, 71 – 72). O’Connell l’ha definita «un ricco mosaico di intertestualità, le cui tessere sono fatte di testi sia antichi sia moderni», in quanto pone accanto «linguaggi e dialetti diversi e spesso stridenti tra di loro», oscillando «tra registro alto e basso» (O’Connell, 2008, 164). Nei primi due capitoli, alcuni termini dialettali o colloquiali («anciove» [Consolo, 1998,15]; «caruso», «scarparo» [Consolo, 1998, 26]; «buatta» [Consolo, 1998, 32]; «a forma di lasagne» [Consolo, 1998, 25]) coesistono, dunque, con altri più elevati, o desueti, formando uno strano impasto linguistico, espressione dello smarrimento in cui vive Chino nel tentativo di superare i fantasmi del passato. Lo stesso Consolo ha dichiarato, in un’intervista: «sono stato […] sperimentatore, senza però arrivare all’estensione linguistica e alla straordinaria polifonia gaddiana, ma operando verticalmente, nel senso di riportare in superficie, […] parole e strutture di lingue sepolte» (Ciccarelli, 2005, 96). Si inserisce in tale ambito il termine «marabutto», di origine araba e perciò legato alla storia della Sicilia, che ritornando varie volte nel nostro testo, ne suggellerà l’andamento circolare svelando il suo carattere di «metafora malinconica» (Traina, 2001, 107). Rientra in questa circolarità anche il rilievo dato alle immagini, in quanto Consolo avverte «Sempre […] l’esigenza di equilibrare la seduzione […] della parola con la visualità, con […] una concretezza visiva» (O’Connell, 2004, 241). . 10 Il primo capitolo, così, accosta, secondo una tecnica cinematografica, parti quasi autonome, corrispondenti alle vicende affiorate alla memoria di Chino. Non a caso l’albergo di Parigi in cui egli soggiorna, oltre a chiamarsi La dixième muse, mostra alle pareti foto di vari divi del cinema, e alla mente di Chino ritorna l’immagine del IUDEX, protagonista del serial cinematografico di Feuillade che adesso egli vede per intero, dopo cinquant’anni, e che sarà richiamato anche alla fine del libro. L’ultimo segmento del capitolo presenta invece il dolore di Chino quale dolore collettivo attraverso il tipico uso consoliano delle figure retoriche, confermando l’orientamento dello scrittore verso il ben noto poema narrativo: Lo strazio fu di tutti, di tutti [anadiplosi] nel tempo il silenzio fermo [allitterazione], la dura pena, il rimorso scuro [chiasmo], come d’ognuno ch’è ragione, […] d’un fatale arresto, d’ognuno che qui resta, o di qua d’un muro, d’una grata, parete di fenolo [metafora], vacuo d’una mente, davanti alla scia in mare, all’arco in cielo che dispare di cherosene [iperbato]. L’esilio è nella perdita, l’assenza, in noi l’oblio, la cieca indifferenza (Consolo, 1998, 24). Un’anastrofe («il tempo suo più avventuroso» [Consolo, 1998, 25]) conclude invece le enumerazioni con cui si esprime lo stato di abbandono di Chino dopo la morte del padre. Analogamente, le enumerazioni indicano il disordine, il caos che contraddistinguono il viaggio di Chino ed Urelia, il loro arrivo a Palermo: Il viaggio fu infinito, nel fumo, nel freddo, raffiche di vento, pioggia, spruzzi delle onde, stretti fra reduci, sbandati, intrallazzisti, donne scasate e di mestiere, ragazzi fuggitivi, frati di questua e ceffi di galera. […] Mai erano stati Urelia e Chino nella città, mai avevano udito tanto chiasso, urla richiami imbonimenti, visto tanto correre e affannarsi tra macerie, travi fili ferri lamiere tufi calcinacci, cantoni in bilico, tappezzerie e maioliche esposte all’aria, giare e bidoni su lastrici crollati, statue riverse, guglie mozzate e cupole sventrate (Consolo, 1998, 31). piccano l’aggettivo dialettale «scasate», il neologismo «intrallazzisti» tra termini più elevati, quali «questua», «fuggitivi», mentre gli aggettivi «riverse», «mozzate», «sventrate» umanizzano gli oggetti, rendendo più forte la sensazione di sofferenza. A Palermo, i «ciechi vaiolosi, storpi, appestati d’ogni sorta che dallo Spasimo si recavano ogni giorno per mangiare alla Dogana» (Consolo, 1998, 32) ricordano l’ «orda di mendichi, ciechi, storpi, nani, malformati» che, in Retablo, si presentano davanti a Clerici, «con lamenti, cantilene e preghiere strazianti» (Consolo, 1992, 51). Con queste autocitazioni, Lo Spasimo di Palermo si conferma, come la critica unanime ha riconosciuto, testo che riassume l’evoluzione artistica ed ideologica di Consolo. Dopo un’ellissi, intanto, tornati nel tempo primo della narrazione, il terzo capitolo inizia, significativamente, con la parola «orrore» (Consolo, 1998, 33): è lo stato d’animo di Chino davanti al suo volto ritratto nello specchio, segno, perciò, quasi, di un’intima dissociazione, che egli descrive, grazie alle enumerazioni, espressionisticamente. Del resto, Norma Bouchard ha riscontrato, ne Lo Spasimo, «[…] an expressionism so radical that it has baffled more than one critic» (Bouchard, 2005, 6). Il pensiero subito rivolto al padre testimonia la persistenza di una lacerante distanza, messa in risalto dall’interrogativa: «Fosse vissuto, sarebbe scaduto così anche suo padre, avrebbe avuto quella faccia, quella sagoma avvilita, si sarebbe piegata la sua testa, il suo orgoglio si sarebbe [chiasmo] con gli anni incenerito [metafora]?» (Consolo, 1998, 33). La stessa incomunicabilità impernia, adesso, il suo rapporto con il figlio Mauro: le parole appaiono infatti «una pazzia recitata, un teatro dell’inganno» (Consolo, 1998, 35) quando i due si incontrano, in un clima di precarietà evidenziato da metafore: «Chi può sapere in questo mulinello di sagome simili e cangianti, questo turbinio di figure, quest’infinito scorrer d’apparenze?» (Consolo, 1998, 34). Se, da una parte, tale incertezza si manifesta, nuovamente, a livello individuale, per cui Chino è consapevole di non essere «riuscito a placare» i suoi «assilli» (Consolo, 1998, 36), «il panico, l’arresto, […] l’impotenza, l’afasia, il disastro» della sua vita, dall’altra lo «scadimento» (Consolo, 1998, 37) è generale, rappresentato dai gusti letterari dei frequentatori della libreria che Daniela ha voluto, per tentare di diffondere romanzi e poesie fra i compagni, «ignari e sprezzanti d’ogni forma letteraria» (Consolo, 12 1998, 37). Responsabile è l’omologazione, lo smarrimento della memoria storica, il predominio delle «mode» (Consolo, 1998, 37): nella vetrina della libreria, antifrasticamente chiamata «La porta d’Ishtar», notiamo allora «la foto d’un giovanotto levigato, riccioletti e occhio vellutato [omoteleuto], ultimo autore di successo, mistico e divo della tivù, […]» (Consolo, 1998, 36). Rafforza questo svilimento della memoria culturale il menu del ristorante Les philosophes: «Cotolette Spinoza – Salade Bergson – Salade Platon – Salade Aristote – Coupe Virgile – Coupe Socrate» (Consolo, 1998, 38). Mauro, poi, che enumera i mali italiani («Sempre nel marasma, nel fascismo inveterato, nell’ingerenza del pretame, nella mafia statuale il paese beneamato?» [Consolo, 1998, 39]), sottolineando le responsabilità del fascismo con l’omoteleuto («inveterato […] beneamato») e l’allitterazione («marasma […] fascismo»), rivolge al padre delle accuse ben precise, rese più incisive dalle metafore, dall’omoteleuto (ornamento-annientamento), dall’anafora, e che coinvolgono tutti i letterati: «tu e i soavi letterati siete le epigrafi d’ornamento, la lapide incongrua e compiaciuta sul muro di quel carcere mentale, quel manicomio d’annientamento» (Consolo, 1998, 39). I riferimenti al romanzo El recurso del método di Carpentier, autore particolarmente caro a Consolo, alla vicenda di Camille Rodin ribadiscono, poi, ancora, la volontà di distacco da una realtà costituita da un «tempo feroce e allucinato» (Consolo, 1998, 42). Il capitolo IV si apre allora con un lungo periodo che accosta immagini metaforiche apparentemente distinte, in realtà accomunate da un senso di negatività, dolore, precarietà, sottolineato dalle enumerazioni miste ad anafore e assonanze: Muro che crolla, interno che si mostra, fuga affannosa, segugio che non molla [assonanza], esito fra ruderi sferzati dalla pioggia, ironiche statue in prospettiva, teschi sui capitelli, maschere sui bordi delle fosse, botteghe incenerite, volumi che in mano si dissolvono, lei al centro d’un quadrivio accovacciata, lei distesa nella stanza che urla e che singhiozza, ritorna dall’estrema soglia, dall’ insulinico terrore, entra ed esce per la porta sull’abisso, il tempo è fisso nel continuo passaggio, nell’assenza, nel fondo sono le sequenze, i nessi saldi e veri (Consolo, 1998, 45). La serie di metafore può apparentarsi al flusso di coscienza di Joyce, il cui Ulisse Consolo definisce «L’odissea dei vinti»[1] (Consolo, 1999, 111). D’altra parte, vedere il film della sua giovinezza non risolve i problemi di Chino ma gli fa capire l’importanza dell’immaginazione e della memoria[2]: «Il tempo, la memoria esalta, abbellisce ogni pochezza, ogni squallore, la realtà più vera. Per la memoria, la poesia, l’umanità si è trasfigurata, è salita sull’Olimpo della bellezza e del valore» (Consolo, 1998, 53). La reazione di Mauro («”Ne hanno combinate i letterati!”» [Consolo, 1998, 53]) conferma che il contrasto generazionale con il padre coinvolge pure la funzione della letteratura e dei letterati, come si chiarirà nella conclusione. L’incomunicabilità fra i due sembra venir meno solo quando Chino dice al padre: «Portale [alla madre, Lucia] per me, quando sarà fiorito, il gelsomino» (Consolo, 1998, 55), mostrando così che, pure per lui, i legami con la Sicilia, di cui quel fiore è simbolo, al pari di quello che avviene ne L’olivo e l’olivastro, sono ineludibili. Per Chino, invece, ritornare in Sicilia significa ripercorrere le vicende della propria vita, che somiglia sempre più ad una fuga, per placare le proprie angosce. Milano e la Sicilia, ovvero i «due poli» entro cui si svolge la vicenda di questo e di molti testi consoliani, si precisano quali simboli «di una condizione di esilio perenne» (Lollini, 2005, 32). Da qui le tantissime «metafore dell’esilio, dell’erranza» (Lollini, 2005, 29), la ricorrenza dei termini ‘esilio-esule’, ‘fuga-fuggire, ‘partire-partenza’, ‘evadere-scappare’, insieme a quelli relativi al campo semantico del dolore. Il quinto capitolo registra questi concetti in modo particolare. Il primo segmento esprime ancora il disagio di Chino con i procedimenti già notati: brevi proposizioni cooordinate per asindeto, enumerazioni. Spicca il chiasmo «lame squame gemini binari» (Consolo, 1998, 57), in cui i due aggettivi aulici (‘squame’, antico; ‘gemini’, latinismo) sono incastonati fra i sostantivi ‘lame, binari’, del registro quotidiano. Segue un’analessi in cui vita e letteratura appaiono strettamente unite, visto che i libri hanno scandito le varie tappe dell’esistenza di Chino. Inverano, intanto, lo spazio: Chino si reca con Lucia, infatti, a visitare la tonnara e il mare descritti nelle [1] Un’allusione all’Ulysses di Joyce e «the re-inauguration of the modern nostos into twentieth-century literary culture», si troverebbe, secondo O’Connell (2012, 246), nel seguente passo: «Ascesero man mano e si dispersero per i vari cieli, entro le celle di quella Sandycove dell’introibo, teca babelica, averno del viaggio» (Consolo, 1998, 46). [2] Secondo O’Connell (Consolo narratore cit., 178), si ha qui un richiamo al saggio Angelus Novus di Benjamin, che peraltro Consolo cita in I ritorni, ed esattamente ai concetti di «rimembranza» e memoria. 14 Osservazioni pratiche intorno la pesca, corso e cammino dei tonni. Quando i poliziotti perquisiscono la sua casa, come si narra anche in Un giorno come gli altri, i suoi libri sparpagliati sembrano «storie perenti, lasche prosodie, tentativi inceneriti, miseri testi della sua illusione, del suo fallimento» (Consolo, 1998, 66), dovuto, comunque, al «tempo feroce, disumano» (Consolo, 1998, 67) in cui vive. Lo testimoniano i procedimenti espressivi. Il «boemo paonazzo», in cui si riconosce Milan Kundera, definisce infatti «merde» gli intellettuali insensibili ai problemi della primavera di Praga nella discussione tra le signore che, con allusione ad Eliot, «in seriche casacche orientali andavano e venivano, […] rivolgevano domande a Saul Bellow» (Consolo, 1998, 66). Il narratore, poi, inserisce la parola antica ‘grascia’ in un’enumerazione («ingombro, grascia, fermento, trionfo di laidume, baccano d’osceno carnevale» [Consolo, 1998, 68]) per raffigurare la disastrosa situazione di Milano. Essa, la «città ignota» è poi descritta con una citazione da Excelsior di Luigi Manzotti («“D’improvviso la scena si trasforma, la Luce e la Civiltà trovansi abbracciate…”» [Consolo, 1998, 69]), menzionato pure in Sopra il vulcano, e una dai Promessi Sposi («“Quel contrapposto di gale e di cenci, di superfluità e di miseria”» [Consolo, 1998, 70]). Il segmento successivo rielabora il brano I barboni, scritto nel 1995 per il catalogo di Ottavio Sgubin, che termina con una citazione dell’Odissea, l’unica di tutto Lo Spasimo («Di’ perché piangi e nel tuo animo gemi / quando odi la sorte…» [Consolo, 1998, 72]), che, non a caso, rimanda ad una condizione di sofferenza. Lo stesso Consolo ne chiarisce, ne Lo spazio in letteratura, il significato, collegando il nostro testo con L’olivo e l’olivastro. Quindi risponde alla richiesta contenuta nella citazione dell’Odissea sostenendo l’impossibilità della narrazione: «“Io sono… no, no, l’aridità, la lingua spessa, l’oblio d’ogni nesso… illuso ancora dell’ascolto, tu procedi”» (Consolo, 1998, 72), affermazione apparentemente in contrasto con il montaliano «varco» che avrebbe condotto Chino, all’inizio del capitolo, «nel passato, nel racconto, in cui […] tutto sembrava decifrabile» (Consolo, 1998, 69). In effetti, nell’analessi in cui il narratore rievoca la vita familiare inizialmente felice di Chino, di Lucia e poi devastata dalle circostanze, la letteratura è dapprima celebrata come depositaria della «verità umana» («“Là si trova” […] “negli assoluti libri, la verità umana”») ma poi, di fronte al precipitare degli eventi, ritenuta inadeguata a riprodurre correttamente la realtà («Ogni parola ora, povera, incapace, riduce quell’incanto, […]» [Consolo, 1998, 73]). Consolo, allora, da un canto adotta una tecnica cinematografica, mostrando i vari eventi (le intimidazioni, la conversazione con il commissario, la vendita della casa) come fotogrammi, dall’altro ritorna alla ‘narrazione poematica’ propria de L’olivo e l’olivastro[3], a confermare la corrispondenza tra i due testi. Così è facile riconoscere degli endecasillabi quando il narratore riferisce la decisione di Chino di lasciare Palermo per andare sulle tracce dell’originaria ed autentica identità siciliana. E il viaggio, vero e proprio topos per Consolo, avviene, significativamente, durante la Pasqua, momento di resurrezione: «S’era fatta smunta, pallida, inquieta /, […] Chino decise di rompere l’assedio, / d’evadere, fuggire dalla casa, / […] Andò con l’infelice per le strade, / […]. Andò in un aprile, nel tempo della Pasqua [due settenari]» (Consolo, 1998, 76-77). Una serie di immagini, combinate con un’anafora e un endecasillabo finale, presenta la Sicilia quale metafora del mondo: «Era là il centro dello spazio, la visione sconfinata, là il cuore della terra, / del mito più oscuro e luminoso» (Consolo, 1998, 77). Il nome di Borges, del resto, rimanda non solo ai «sogni», agli «incubi», agli «specchi», ai «labirinti» (Consolo, 1998, 80), temi presenti nel nostro testo, ma al suo prevalente carattere metaforico. La vicenda di Lucia, con il suo «precipitare nel gorgo medicale, nell’ignoranza, nel dominio, nel cinico interesse di luminari, case di cura, […] rete di sciacalli» (Consolo, 1998, 78) e quella di Chino testimoniano i danni causati dalla perdita della memoria storica: Palermo è, difatti, ormai, una città «stravolta, squallida nell’uniforme volto, nell’anonima sua morsa, nel cieco manto sopra ogni verde luce, nella grigia muraglia avanti a vecchi squarci, immobili macerie, […]» (Consolo, 1998, 79). All’insegna della metafora si svolge, allora, il capitolo settimo. «un re che narra e che governa, elude la metafora, annulla la contraddizione della prosa» (Consolo, 1998, 83) è, intanto, il personaggio principale del racconto letto dal glottologo protagonista de La perquisizione, dietro cui la critica ha scorto Un giorno come gli altri. La metafora si precisa, dunque, quale una necessità, legata a una narrazione in crisi, che tratta di periodi in crisi: appaiono così chiari i rapporti di Consolo con il postmodernismo. Da [3] Esso è l’«apice» di una vera e propria «sperimentazione “poetica”» (Francese, 2015, 70) . 16 una parte vi sembrerebbero rimandare il citazionismo, il plurilinguismo, il tema del complotto; dall’altra, però, Consolo se ne mantiene distante, proprio per l’importanza attribuita alla memoria e alla storia, come Norma Bouchard ha puntualizzato: «it is important to point out that even though Consolo’s novels exhibit many of the rhetorical devices that we have come to associate with postmodern writing practices, they also remain fundamentally distinct from dominant, majoritarian forms of postmodernism» (Bouchard, 2005, 10-11). Una «metafora perenne» giudica poi Chino il romanzo di Manzoni, modello per Consolo di romanzo storico, in quanto allude «alle pesti in ogni tempo di Milano» (Consolo, 1998, 85). Il «lazzaretto più appestato» sembra a Chino «una piazzetta» in cui, avvolti in un’omologazione che cancella ogni identità, «Stavano ragazzi barcollanti o immobili, il busto avanti, piegati sui ginocchi. Sembravano bloccati in quelle pose, pietrificati […]» (Consolo, 1998, 85). Modellato sull’Addio ai monti di Manzoni è, inoltre, l’Addio che Consolo rivolge a Milano, «Città perduta» (Consolo, 1998, 91) non meno della Milano di Berlusconi e della Lega Nord, condannata attraverso la consueta tecnica dell’accumulo: Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, […] scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità (Consolo, 1998, 91). Così, quando Mauro chiede al padre se stia scrivendo, egli risponde negativamente. E se il suo comportamento è differente da quello di altri scrittori (Calvino, Moravia, Sciascia, indicati con delle metafore – «il castoro ligure, il romano indifferente, l’amaro tuo amico siciliano»), ciò accade perché essi hanno «la forza […] della ragione, […] la geometria civile dei francesi» (Consolo, 1998, 88): non vivono cioè una condizione di disorientamento. Costituiscono dunque, queste parole, opinioni dello stesso Consolo (Chino Martinez sarebbe cioè un alter ego dello scrittore), che, proseguendo il suo discorso, una sorta di dichiarazione di poetica, confessa: «mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono…» (Consolo, 1998, 88). La letteratura, però, deve essere, soprattutto, espressione di una società, tant’è che Mauro, in carcere, chiede al padre di portargli I demoni di Dostoevskij, L’affaire Moro di Sciascia, Scritti corsari di Pasolini, Une saison en enfer, Illuminations di Rimbaud. Chino, allora, abbina alla letteratura, che perciò rappresenterebbe un’ancora di salvezza come nella conclusione di Nottetempo (si rifugia nella biblioteca, per esempio), il valore della memoria, delle radici, individuali e collettive. Sul treno per Napoli, infatti, ascoltando parlare dei ragazzi, individua facilmente, e con piacere, «le città e i paesi da cui quei ragazzi provenivano. […] Leggeva in quel concerto la storia d’ogni luogo, i segni […] superstiti delle migrazioni, dei remoti insediamenti» (Consolo, 1998, 95). Egli, pertanto, considera negativamente, al punto da definirla «trucida» (Consolo, 1998, 94), la nuova lingua annunciata da Pasolini, in quanto segno di un’omologazione negatrice della storia. Di questa sono testimonianza i luoghi, lo spazio, che Consolo ritiene, sempre, molto importanti. In prossimità di Palermo Chino scorge, difatti, «il piano di Sant’Erasmo, la foce melmosa dell’Oreto, […] la Porta dei Greci, […] gli antichi palazzi dietro nobiliari, le cupole e i campanili delle chiese, il Càssaro Morto e la Porta Felice, Santa Maria della Catena, la conca stagna affollata d’alberi di lussuose barche della Cala» ma anche «le palazzate nuove del sacco mafioso» (Consolo, 1998, 98). Attraverso lo spazio, cioè, è possibile leggere i cambiamenti della società. Se i luoghi, allora, come la letteratura, manifestano la memoria storica, Chino sente di dover «ricominciare» dai libri, oltre che «dalla chiara geografia» (Consolo, 1998, 102). Si presentano, questi, strettamente uniti, interdipendenti nelle pagine finali dello Spasimo, che, perciò, chiarisce e conclude l’esperienza letteraria di Consolo, rappresentando «al contempo la mediazione verso» quella che Consolo considera una vera e propria «impasse e la risposta ad essa» (O’Connell, 2008, 174). Così, dopo aver raccolto notizie sul musicista D’Astorga, da cui prende nome la strada in cui abita, ed aver scoperto il quartiere intorno, aver collegato il castello della Favara ad alcuni versi del poeta arabo Ab dar-Rahmân, Chino decide di «indagare sulla prigionia in Algeri di Cervantes», su quella di Antonio Veneziano[4] e di scrivere «della [4] Ne L’olivo e l’olivastro (1994, 105), Consolo afferma che, ad Algeri, Cervantes scrive dei versi per Antonio Veneziano. 18 pena vera di due poeti, fuori da ogni invenzione» (Consolo, 1998, 105). Infatti, Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio. Si doleva di non avere il dono della poesia, la sua libertà, la sua purezza, la sua distanza dall’implacabile logica del mondo (Consolo, 1998, 105). Consolo ripropone, in tal modo, le riserve nei confronti del romanzo manifestate in altri testi (Fuga dall’ Etna, Nottetempo, L’olivo e l’olivastro). Un «libro raro» (Consolo, 1998, 106), in spagnolo, trovato in biblioteca, conferma le sue convinzioni. Vi legge di ogni regione d’Italia e del mondo, apprende i vari significati, positivi, del termine ‘marabutto’. È consapevole, anche per questo, di come i tragici eventi che avevano portato alla morte del padre avessero costituito una stortura. Poi, dopo aver vagato per le strade di Palermo ed aver visto, nella «casba di Seralcadio» (Consolo, 1998, 108), un’altra faccia della città, come avvenuto a Milano, si ferma nella chiesa di Santa Maruzza, luogo carico di ricordi, personali e letterari, opposto al drammatico presente. Difatti, «Dentro era l’accesso, racconta il Natoli, alle caverne, alle camere segrete dei processi e delle sentenze dei giustizieri» (Consolo, 1998, 108). Ma al tribunale dei Beati Paoli si lega il vero Palazzo di Giustizia, a cui Chino giunge seguendo un «corteo, fantasmatico» (Consolo, 1998, 109). Il suo pensiero va, allora, al lavoro dei magistrati contro i gruppi mafiosi e, in particolare, al «figlio della sua dirimpettaia» (Consolo, 1998, 109), cioè il giudice Borsellino. L’incontro fra i due avviene nel segno dei libri e conferma come Chino sia alter ego di Consolo «Ho letto i suoi libri… difficili, dicono» (Consolo, 1998, 115), dice il giudice che, dopo aver citato un passo de Le pietre di Pantalica («Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e gelsomino…» [Consolo, 2012, 132]), commenta: «Ma nulla è cambiato, creda. Vedrà, il prossimo luglio sarà uguale… o forse peggio» (Consolo, 1998, 115). Egli legittima, in tal modo, la funzione civile della letteratura, legata anche ad altre arti. Chino trova, infatti, nella «memoria d’un anonimo spagnolo», delle notizie sulla tela che Raffaello dipinge per la chiesa di Santa Maria dello Spasimo, e che intitola «sgomento della Vergine e Spasimo del Mondo» (Consolo, 1998, 112). Giustamente, dunque, la Sicilia è metafora del mondo: la sua crisi, la sua degenerazione sono generali, così come «questo Spasimo, da Palermo» (Consolo, 1998, 112) coinvolge la Sicilia e il mondo tutto. E i luoghi, come la letteratura testimonia, lo confermano: Lesse di Santa Maria dello Spasimo abbandonata dai frati per il nuovo baluardo di difesa che a ridosso il viceré don Ferrante Gonzaga fece costruire. Della magnifica chiesa che divenne poi nel tempo teatro, lazzaretto nella peste, granaio, magazzino, albergo di poveri, sifilicomio, cronicario, luogo di dolore, solitudine, abbandono (Consolo, 1998, 113). Una metafora indica il perdurare di questa condizione, ormai generalizzata, al presente: lo scirocco è un «sudario molle» (Consolo, 1998, 113). Le immagini mettono poi, in parallelo, la peste e il colera, che nel passato hanno oppresso Palermo, con la mafia. Al «paranzello o brigantino» che arrivava a Palermo «con l’infetto» (Consolo, 1998, 113) corrisponde «il corpo sfatto, quasi scheletrico» (Consolo, 1998, 116) rinvenuto dentro il pilastro del portico del palazzo dove abita Chino, il quale ricorda i vv. 10-12 del quarto canto dell’Inferno quale metafora dell’incapacità di trovare una soluzione a questa situazione: «Oscura e profonda era e nebulosa / tanto che, per ficcar lo viso a fondo, / io non vi discernea alcuna cosa» (Consolo, 1998, 118). L’ultimo capitolo si svolge dunque la domenica successiva al Festino di Santa Rosalia, per sottolineare come pure la Santa che aveva salvato Palermo dalla peste, nel 1624, sia adesso impotente. La conformazione della città, con «il fitto ammasso dei palazzi, il cantiere dietro il muro, la corta via d’Astorga [allitterazione]», mostra la perdita di ogni memoria storica, «sepolta sotto il cemento» (Consolo, 1998, 123). Le enumerazioni, mettendo insieme termini di origine araba (‘càssaro’, ‘kalsa’), spagnola (‘criadi’), neologismi (‘villena’), rappresentano questa condizione di disordine, che la metafora conclusiva suggella: «Congiura, contagio e peste in ogni tempo» (Consolo, 1998, 123). 9, 2020. 20 Alla memoria storica, invece, ci riporta il fioraio che in «questa città infernale» (Consolo, 1998, 126), in cui ogni ragionevolezza sembra essere venuta meno, si chiama, non a caso (il riferimento è ad Erasmo da Rotterdam e al suo Elogio della follia), Erasmo, e che, dopo aver donato a Chino dei gelsomini, gli rivolge delle parole, apparentemente oscure, inquietanti, ma che legano il suo passato al suo presente: «Ddiu ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi / chi ti manciunu lu pani. / Ddiu ti scanza di marabutta» (Consolo, 1998, 124). Ciò è evidente nella lettera che Chino scrive al figlio, in cui troviamo insieme i cinque romanzi che Massimo Onofri ha individuato fra le pagine de Lo Spasimo: «un romanzo sul rapporto Italia – Sicilia; un romanzo sul rapporto padre e figlio (il padre di Gioacchino / Chino e Chino); un secondo romanzo padre – figlio (Chino e Mauro); […] un romanzo d’amore (Chino e Lucia); e […] un romanzo di “oblio e dimenticanza”» (Onofri, 2004, 183). Si precisano qui, quando Chino allude all’omicidio del giudice Falcone, le corrispondenze con il passo de Le pietre di Pantalica citato da Borsellino: «Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia, un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo, straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiaccicano membra su alberi e asfalto – ah l’infernale cratere sulla strada per l’aeroporto! – E’ una furia bestiale, uno sterminio»[5] (Consolo, 1998, 128). Ne Le pietre di Pantalica aveva detto: «Questa città è un macello, le strade sono carnazzerie con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. […] La guerra contro la civiltà, la cultura, la decenza» (Consolo, 2012, 132 – 134). E, ne L’olivo e l’olivastro, si indica in modo chiarissimo come responsabile di questa situazione, non limitata a Palermo ma diffusa in tutta Italia, sia la perdita della memoria storica: «Via, via, lontano da quella città che ha disprezzato probità e intelligenza, memoria, eredità di storia, arte, ha ucciso i deboli e i giusti. / Ma è Palermo o è Milano, Bologna, Brescia, Roma, Napoli, Firenze?» (Consolo, 1994, 125). Ne Lo Spasimo, questa situazione di crisi comporta una divaricazione tra letteratura e società. Chino ne matura la consapevolezza: Un paradosso questo del mantello nero in cui si muta qui la toga di chi inquisisce e giudica usando la forza della legge. E per me anche letterario. Voglio dire: oltre che in Inghilterra, nella [5] Da sottolineare come i quattro verbi (sparano-straziano-carbonizzano-spiaccicano) abbiano la stessa finale. Francia dello Stato e del Diritto è fiorita la figura del giustiziere che giudica e sentenzia fuori dalle leggi. Balzac, Dumas, Sue ne sono i padri, con filiazioni vaste, fino al Bernède e al Feuillade di Judex e al Natoli nostro, […]. In questo Paese invece, in quest’accozzaglia di famiglie, questo materno confessionale d’assolvenza, dove lo stato è occupato da cosche o segrete sette di Dévorants, […], dove tutti ci impegniamo, governanti e cittadini, ad eludere le leggi, a delinquere, il giudice che applica le leggi ci appare come un Judex, un giustiziere insopportabile, da escludere, da rimuovere. O da uccidere (Consolo, 1998, 129-130). Il letterato, dunque, l’intellettuale vive in una condizione di esilio, non è adeguatamente apprezzato, tant’è che quando Chino tenta di fermare Borsellino mentre suona al citofono, il giudice si gira ma non lo riconosce. Nell’attentato viene colpito Erasmo che, morendo, recita due versi de La storia di la Baronissa di Carini, ad attestare come, anche se al presente la letteratura non è ascoltata, è da questa, voce della tradizione, della memoria storica, che deve venire la salvezza:
O gran mano di Diu, ca tantu pisi, cala, manu di Diu, fatti palisi!
(Consolo, 1998, 131). 9, 2020. 22 Bibliografia Bouchard, Norma (2005). Vincenzo Consolo and the Postmodern Writing of Melancholy. Italica, 82, (1), 5 – 23. Ciccarelli Andrea (a cura di) (2005). Intervista a Vincenzo Consolo. Italica, 82, (1), 92 – 97. Consolo, Vincenzo (1988). Le pietre di Pantalica. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1992). Retablo. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1993). Fuga dall’Etna. Roma: Donzelli. Consolo, Vincenzo (1994). L’olivo e l’olivastro. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1998). Lo Spasimo di Palermo. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (1999). Di qua dal faro. Milano: Mondadori. Consolo, Vincenzo (2006). «Ma la luna, la luna…». In Pintor Romera I. (a cura di). Lunaria. Vent’anni dopo. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Consolo, Vincenzo (2012). La mia isola è Las Vegas. Milano: Mondadori. Donnarumma, Raffaele (2011). Storia, immaginario, letteratura: il terrorismo nella letteratura italiana (1969 – 2010). In Aa. Vv., Per Romano Luperini. Palermo: Palumbo. Dotti, Ugo (2012). Il senso della storia nell’opera di Vincenzo Consolo. In Ugo Dotti, Gli scrittori e la storia. La narrativa dell’Italia unita e le trasformazioni del romanzo (da Verga a oggi). Torino: Nino Aragno editore. Francese, Joseph (2015). Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità» (1992 – 2012), ovvero la poetica della colpa – espiazione. Firenze: Firenze University Press. Lollini, Massimo (2005). Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo. Italica, 82, (1), 24 – 43. Luperini, Romano (1999). Controtempo. Napoli: Liguori. Marcellesi – Giacomo, Mathée (2004). Vincenzo Consolo: l’alchimie du logos. Croniques italiennes. 2-3, 197 – 214. Onofri, Massimo (2004). Il sospetto della realtà: Saggi e paesaggi italiani novecenteschi, Cava de’ Tirreni: Avagliano. O’Connell, Daragh (2004). Il dovere del racconto: Interview with Vincenzo Consolo. The Italianist. 24: II, 238 – 253. DOI: 10.1179 / ita.2004.24.2.238 O’Connell, Daragh (2008). Consolo narratore e scrittore palincestuoso. Quaderns d’Italià, (13), 161 – 184. O’Connell, Daragh (2012). «Tizzone d’Inferno»: Sciascia on Joyce. Totomodo, 237 – 248. Traina, Giuseppe (2001). Vincenzo Consolo. Fiesole: Cadmo.
Summary
Lo Spasimo di Palermo is example of a crisis that has repercussions on the expressive form: on the one hand, the consciousness that «sul ciglio dell’abisso la parola si raggela, si fa […] simbolo sfuggente» comes out, on the other hand novel seems a «genere scaduto, corrotto, impraticabile». The generational conflict between Chino and Mauro is included in this sphere too. Hence it follows many solutions that lead to Consolo’s «poema narrativo» and testify the prevailing disorientation: paratactic accumulation, metaphors, literary quotations, figures of speech. Pictorial suggestions find its centre in Raphael’s Lo Spasimo di Sicilia, symbol of a pain that from Palermo arrives to Sicily and all world, while the spaces have a great importance and show the loss of historical memory, responsible for crisis. Key words: Consolo, crisis, memory, history 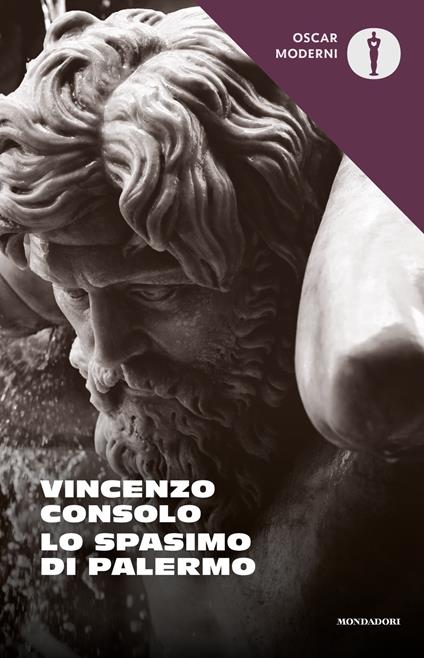
Tag: Antonio Veneziano
Vincenzo Consolo, dal sorriso allo spasimo: l’impossibile romanzo
Lise Bossi
Lo Spasimo di Palermo può essere considerato l’ultimo romanzo di Vincenzo
Consolo, anche se può sembrare «abusivo» classificarlo in questo genere
letterario dato che l’opera si presenta come la conclusione di una riflessione
e di un lavoro di scrittura che non riconoscono alla narrazione romanzesca,
nella sua accezione e nella sua forma classica, la capacità di rendere conto
del mondo, di ordinarlo e di dargli un senso. Nelle sue opere precedenti,
grazie a un nuovo logos, Consolo ha tentato di sostituire un nuovo epos alle
Grandi Narrazioni individuali e collettive – confiscate dai Padri, e più
generalmente dal potere – allo scopo di porre le basi di un nuovo ethos.
Qui si è voluto esplorare l’ipotesi secondo la quale Lo Spasimo di
Palermo sarebbe insieme la forma più estrema di tale tentativo e
l’ammissione del suo fallimento, almeno in questa forma. Forse perché non basta
uccidere i Padri – siano essi simbolici, politici o letterari – perché i figli
si possano salvare.
Aborriva il romanzo, questo genere
scaduto, corrotto,
impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in
una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale
ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio.
(Consolo 2000: 105)
2 «Si tratterebbe del racconto dei tre fallimenti
della storia unitaria. Nel primo, sarebbe rappres (…)
1 Abbiamo scelto di incamminarci sulle orme di Consolo, lungo la traiettoria
esistenziale e letteraria da lui percorsa, seguendo i titoli delle tre opere
che costituiscono quello che egli stesso ha chiamato «Il ciclo dell’Italia
unita» (De Gregorio 2013)2, una traiettoria che va quindi dal sorriso
risorgimentale allo spasimo degli anni Novanta attraversando la notte buia del
Ventennio fascista. Ci è parso ovvio infatti che, alla stregua di tutte le
scelte stilistiche di Consolo, la scelta di quei titoli non fosse e non potesse
essere gratuita: attraverso quei titoli ci veniva offerta una strada per
arrivare fino all’ultima sua opera, Lo Spasimo di Palermo (Consolo 2000), cioè
fino all’ultima tappa di un lungo e doloroso viaggio, fino agli ultimi
frammenti, alle ultime parole troncate e stroncate di una conversazione
nostalgica e metaforica con e sulla Sicilia.
2 Allo stesso modo, non poteva essere e non è gratuito il fatto che Consolo apra Lo Spasimo di Palermo, quel libro che porta quindi il dolore iscritto nel proprio titolo, con una citazione tratta dal Prometeo incatenato di Eschilo, in cui Prometeo, colui che viene martoriato per aver portato la luce, ossia, metaforicamente e ulissianamente, virtute e conoscenza al genere umano, dichiari che «il racconto è dolore ma anche il silenzio è dolore» (Consolo 2000: 7). Questo incipit fa sorgere un certo numero di domande poiché, com’è risaputo, un incipit – e Consolo, autore di un saggio sulle Epigrafi (Consolo 1999b), più di ogni altro lo sa e lo mette in pratica – fornisce indicazioni sul significato, se non sul contenuto, dell’opera che apre.
3 Una domanda, per cominciare, sull’ambiguità della dichiarazione di Prometeo, prima delle tante e senz’altro volute ambiguità che troveremo nel testo di Consolo non appena si tratterà di racconto o, meglio, di narrazione. Tale dichiarazione significa infatti che il raccontare è doloroso quanto o più del tacere, oppure che, quando si tratta di esprimere il dolore, il silenzio è efficace quanto o più del racconto?
4 Nella prima ipotesi, l’incipit ci induce a pensare che il racconto sia una specie di male minore al quale per lo scrittore sia stato giocoforza rassegnarsi pur di non incorrere nel dolore maggiore che sarebbe potuto derivare dal silenzio. Nella seconda ipotesi, lo stesso incipit ci porta a pensare che il silenzio non sia meno adatto del racconto a dire il dolore, ma anzi, possa esserne l’espressione più alta e compiuta. Se accolta, questa seconda interpretazione implica che il dolore, lo spasimo, che, come la sciasciana linea della palma, si dilata «da Palermo, alla Sicilia, al mondo» (Consolo 2000: 112), si può dire facendo a meno del racconto. Ovvero, se proseguiamo fino in fondo con il ragionamento, ciò significa che Lo spasimo di Palermo è un non-racconto nei cui silenzi viene detto il dolore prima dell’opera, e il dolore espresso nell’opera s’inabissa definitivamente nel silenzio. Il che, se guardiamo alla bibliografia di Consolo, corrisponde esattamente alla realtà, giacché, dopo Lo Spasimo, egli non ha effettivamente più scritto nessun racconto, romanzo o anti-romanzo.
5 Queste prime constatazioni ci permettono, tra l’altro, di capire perché Lo Spasimo di Palermo si configuri insieme come un testamento e un tombeau letterario. Un testamento, perché l’opera si chiude proprio con una lettera in forma di bilancio personale e intellettuale scritta dal protagonista al proprio figlio; ma anche di bilancio dall’autore al proprio lettore, prima che chi scrive scompaia con le sue ultime parole ancora nella penna, in una di quelle esplosioni al tritolo che ricorrono in un crescendo ossessivo negli ultimi racconti di Consolo, proprio come nei giorni e nelle notti di Palermo. E Lo Spasimo è anche un tombeau poetico-letterario perché, posto fin dall’inizio sotto il segno di un’oscillazione tra i due poli opposti e complementari del racconto e del silenzio, quest’ultimo opus sembra destinato a spiegare le ragioni di tale oscillazione, offrendo al lettore una specie di compendium di tutti i precedenti tentativi stilistici attraverso i quali Consolo ha cercato di proporre un epos alternativo che, partendo da una lingua poematica, lo ha portato fino all’urlo panico, per poi riportarlo alla narrazione. In effetti, si tratta di un doppio tombeau, i cui piani sovrapposti entrano in relazione attraverso una serrata rete intra- ed intertestuale, poiché quella specie di sopralluogo personale e letterario si combina con un paradossale omaggio parricida di Consolo a tutti gli auctores che egli ha ammirato per poi rinnegarli, come fanno tutti i figli quando intraprendono una crociata contro i propri padri, nella vita e nella letteratura; perché i padri sono stati giudicati troppo spesso «imbell[i], ipocrit[i] o impotent[i]» (Consolo 2000: 89); perché le loro parole non hanno saputo essere l’ultimo baluardo contro il sonno della ragione e il caos.
6 Sembra, infatti, che quest’ultimo libro, alla stregua di quanto dichiara l’incipit dell’ultimo romanzo di Sciascia, sia un modo per «ancora una volta […] scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia» (Sciascia 1989: 7) e, vorremmo aggiungere, alla letteratura. Sennonché tale ricerca ha portato Sciascia a scrivere Una storia semplice mentre, per Consolo, è venuta fuori una storia maledettamente complicata, condotta come un’analisi retrospettiva, alla maniera delle inchieste politico-filologiche dello scrittore di Racalmuto, ma senza ricorrere fino in fondo ai suoi strumenti di investigazione della realtà e del discorso; quelli di Pausania, tanto per intenderci, il saccente geografo che ne L’olivo e l’olivastro sentenziava: «a me è affidato il dovere del racconto: conosco i nessi, la sintassi, le ambiguità, le malizie della prosa, del linguaggio» (Consolo 1999a: 39).
7 Come il suo protagonista, lo scrittore Gioacchino Martinez, Consolo si è infatti rifiutato di entrare nella logica «fiduciosamente comunicativa, di padre e fratelli – confrères – più anziani, involontari complici, pensav[a], dei responsabili del disastro sociale» (Consolo 2000: 127). Da allora, per lui, ha trovato «solo senso il dire o ridire il male, nel mondo invaso in ogni piega e piaga dal diluvio melmoso e indifferente di parole atone e consunte, con parole antiche o nuove, con diverso accento, di diverso cuore, intelligenza. Dirlo nel greco d’Eschilo, in un volgare vergine come quello di Giacomo o di Cielo o nella lingua pietrosa e aspra d’Acitrezza» (Consolo 1999a: 77). Fino a Lo Spasimo di Palermo. Fino al momento in cui, dopo un ultimo tentativo per lottare contro il disordine, il silenzio sostituisce il coro che, poc’anzi ancora, «in tono alto, poetico, in una lingua non più comunicabile, commenta[va] e lamenta[va] la tragedia senza soluzione, il dolore senza catarsi» (Consolo 1999b: 262).
8 Come la maggior parte dei libri precedenti di Consolo, Lo Spasimo di Palermo è la storia di un viaggio, quello dello scrittore Gioacchino Martinez. Un viaggio nello spazio, da Parigi a Milano e da Milano a Palermo, e un viaggio nel tempo, quello dell’infanzia durante la Seconda Guerra Mondiale, dei primi trasporti e del matrimonio con Lucia, che diventerà sua moglie e la madre di Mauro, il figlio rifugiatosi appunto a Parigi per sfuggire alla repressione politica della fine degli “anni di piombo”, mentre Lucia sprofonderà a poco a poco nella follia per sfuggire all’insopportabile realtà della violenza mafiosa degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, prima di scomparire nel buio. Un viaggio a misura d’uomo dunque, chiuso e concluso, almeno in apparenza, nei limiti di una vita d’uomo, con gli inevitabili punti di contatto con il mondo che gli sta attorno, cioè con la Storia con la S maiuscola i cui disordini e le cui convulsioni si ripercuotono sull’esistenza dell’individuo e la possono travolgere senza remissione.
9 Però, anche se l’invocazione liminare è quella di un Omero-Consolo a un Ulisse-Consolo la cui commistione-confusione sarà nel libro un’ulteriore fonte di ambiguità, non si tratta più, proprio per lo spasimo, del solito nostos ulissiano di cui L’olivo e l’olivastro è forse l’espressione più compiuta e dichiarata, ma si tratta piuttosto di un percorso di anamnesi dalle coordinate incrociate e sovrapposte, che trasforma l’effettivo ritorno a casa del protagonista e il suo tentativo di ricongiungersi con il proprio passato, in viaggio penitenziale (Francese 2015: 66 e 104; Consolo 1999a: 19). Un viaggio per espiare colpe insite nelle confessate manchevolezze di chi scrive attraverso la di nuovo paradossale, nonché scaramantica, trasformazione della scrittura/lettura di questo libro in una complessa operazione di cifratura e decodifica storico-letteraria.
10 La principale fonte di complessità sta nella frammentazione o variazione della voce narrante. Il procedimento non è nuovo e Consolo lo ha ampiamente sfruttato fin dal Sorriso e anche in Nottetempo (Consolo 1994). Solo che allora si trattava di dare alle «‘voci’ dei margini» (Consolo 1997: 182) una possibilità di farsi sentire pur riconoscendo l’inadeguatezza della scrittura, dotta per definizione, nella restituzione di un’oralità per così dire primitiva, nonché «l’impotenza, l’incapacità di dire, di raccontare la vita, il patimento» (Consolo 1994: 53) per colui che scrive. Il dilemma sembrava si fosse risolto in senso sperimentalista con l’«adottare […] moduli stilistici della poesia, riducendo, per rimanere nello spazio letterario, lo spazio comunicativo, logico e dialogico proprio della narrazione» (Consolo 1997: 183); e l’intento di far combaciare logos, epos ed ethos pareva fosse stato raggiunto ne L’olivo e l’olivastro come dimostrano l’omogeneità di tono e la stabilità dell’istanza narrativa (Bossi 2012).
11 Ma con Lo Spasimo di Palermo si sgretola quel fragile equilibrio nella frantumazione dei punti di vista e nella variazione dei toni e dei gradi della diegesi. Più conturbante ancora: vengono di nuovo sfruttate soluzioni narratologico-espressive da tempo dichiaratamente abbandonate e, nel libro stesso in cui ricompaiono, presentate come detestabili (Consolo 2000: 105).
12 Il corifeo-narratore de L’olivo e l’olivastro – che cantava la storia del nuovo Ulisse in una specie di discorso indiretto libero intriso di quella tragicità antica che per Consolo è «l’esito ultimo […] della
ideologia letteraria, l’espressione estrema della [sua] ricerca stilistica» (Consolo 2007: 21) e in cui si intercalavano registrazioni/restituzioni di voci testimoniali – è ancora presente nel prologo in corsivo, ma solo per un ideale passaggio di testimone narrativo ed esistenziale allo stesso Ulisse. E nel suo augurio per il viaggio da compiere sta senz’altro la spiegazione delle contraddizioni e dei paradossi che abbiamo segnalati fin qui: «Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza. In my beginning is my end» (Consolo 2000: 9).
13 Solo attraverso la volontà di tornare al punto di partenza, geografico ed esistenziale, si può infatti spiegare il metaforico ritorno a una specie di autobiografismo letterario che si palesa attraverso una fitta rete di autocitazioni più o meno esplicite come, ad esempio, quella testuale tratta da Le pietre di Pantalica (Consolo 1988: 166): «Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e gelsomino». Messa in bocca al giudice che ne Lo Spasimo di Palermo (con la S maiuscola) viene omaggiato in quanto uno tra i pochi difensori della polis e del vivere civile, quella citazione già parlava dello spasimo (con la s minuscola) di Palermo e, anche se Gioacchino-Consolo si schermisce dicendo che «sono passati da allora un po’ di anni», il giudice – di nuovo sciascianamente, come conferma il paragrafo successivo – profetizza: «Ma nulla è cambiato, creda. Vedrà, il prossimo luglio sarà uguale… o forse peggio» (Consolo 2000: 115).
14 Allo stesso modo, questo appellarsi di continuo a Sciascia come pure a Manzoni con riferimenti espliciti – oltre che alla peste che allora infettava Milano come ora infetta Palermo – anche al famoso manoscritto manzoniano (Consolo 2000: 106), ossia alla finzione letteraria destinata a conferire verosimiglianza al testo fondatore dei Componimenti misti di storia e d’invenzione, delinea una specie di autobiografia non più o non solo personale, bensì familiare, nel senso di una famiglia spirituale, un omaggio intertestuale in forma di metaromanzo di formazione «ai suoi» (Consolo 2000: 36), come egli chiama i suoi autori prediletti.
15 Sembra infatti che Consolo si chieda se proprio nel tornare alle origini, alle fonti e, quindi, a quei «linguaggi logici, illuministici», «alla loro serena geometrizzazione» (Consolo 1997: 182) non risieda la possibilità di dire il male e di sanarlo. Ragion per cui egli conserva effettivamente, ad inizio capitolo, quei paragrafi che segnano «l’interruzione del racconto e il cambio di tono della scrittura, il suo alzarsi di tono, svolgersi in forma ritmica, lirico-poetica», che sono per lui «le parti corali o i cantica latini» (Consolo 2007: 35); quei paragrafi che dicono il male come rottura, alla stregua di quel passaggio dalla luce all’ombra che spaventa la Lucia di Gioacchino (Consolo 2000: 65 e 117) come segno precursore di un’irrimediabile condanna alla follia, con «lei distesa nella stanza che urla e che singhiozza, ritorna dall’estrema soglia, dall’insulinico terrore, entra ed esce per la porta sull’abisso, il tempo è fisso nel continuo passaggio, nell’assenza, nel fondo sono le sequenze, i nessi saldi e veri» (Consolo 2000: 45). E quelli sono i nessi, tra afasia e urlo, che, soli, la poesia, il linguaggio poematico, possono dire.
16 Ma allo stesso tempo Consolo, come Gioacchino, ha
la tentazione di riannodare il discorso interrotto, di riprendere il film
dell’infanzia, rappresentato metaforicamente dalla storia di Judex, nel punto
in cui è stato tagliato, e farlo ripartire con «la sutura, l’acetone sulla
memoria, il nastro che s’attacca, lo scintillio dei carboni, il ronzio che
riprende, la storia che prosegue e si conclude». Pena però la riscoperta dei
«fotogrammi segreti della sua storia, della vita sua oscura e inconclusa, della
frana, delle colpe sepolte e obliate» (Consolo 2000: 47). In altri termini,
sembra che Consolo si chieda, in un libro che insiste sull’interruzione della
comunicazione tra padri e figli a causa delle compromissioni e dei tradimenti
rimproverati dai figli ai padri, se non si dovrebbe compiere una sutura tra gli
uni e gli altri, tra passato e presente, ricorrendo ai pure ripetutamente
rinnegati strumenti di Pausania – il geografo che, come si diceva prima,
conosce «i nessi, la sintassi, le ambiguità, le malizie della prosa, del
linguaggio» (Consolo 1999: 39). Ed è proprio a quel lavoro di sutura personale
e letteraria che si accinge Gioacchino, confrontato al falso ordine della sua
biblioteca risistemata “cromaticamente” dalle incolte persone di casa:
Giorni trascorsi a rimettere ordine fra i libri. Da questi doveva ricominciare,
dalla chiara geografia, dai confini certi, dal conforto loro, per potersi
orientare, riprendere la strada. Oltre, non era che mutamento, cancellazione
d’ogni segno, realtà infida, landa d’inganno, sviamento. (Consolo 2000: 102)
A partire dai libri della sua biblioteca, egli comincia dunque a ricostruire
una mappa letteraria della propria città, uno di quei Cruciverba (Sciascia
1983) che tanto piacevano a Sciascia, come quello dedicato dal racalmutese a
Parigi dove egli si recava, come ricorda lo stesso Consolo (Consolo 2016: 124),
compiendo un viaggio le cui tappe erano Palermo-Milano e poi Milano-Parigi,
ovvero l’esatto rovescio, quasi a specchio, del viaggio raccontato dalla
doppia, se non dubbia, figura di Empedocle-Pausania e compiuto dall’ambiguo
Ulisse de Lo Spasimo di Palermo. Infatti l’Ulisse consoliano ha avuto bisogno
di attingere di nuovo ai valori civili e letterari della Francia illuminista
tanto amata da Sciascia. Questo spiega perché, per la prima volta, non lo vediamo
approdare fin dall’inizio del libro alla sua Itaca-Sicilia come invece
succedeva nei precedenti racconti: è dovuto prima andare a cercare a Parigi,
nella città in cui «tutto parla di letteratura» e dove si parla «quella che
Leopardi chiamava una lingua ‘geometrizzata’» (Consolo 2016: 132), quei pezzi
mancanti, quelle colpe sepolte e dimenticate della propria storia, prima di
intraprendere il suo nostos espiatorio (Traina 2001: 43).
17 A quell’Ulisse, costretto quindi a usare quasi
simultaneamente due lingue diverse, una poematica e l’altra geometrizzata,
viene assegnato il compito di riannodare i fili spezzati per tentare non solo
di dire, poeticamente ed espressivamente, ma anche di denunciare, razionalmente
e comunicativamente, i mali passati e presenti e la loro
diffusione-dilatazione. Infatti essi hanno ormai da tempo varcato lo Stretto,
come mostra la cantica dedicata a Milano, che fu «approdo della fuga,
quell’asilo della speranza, antitesi al marasma, cerchia del rigore, probità,
orgoglio popolare, civile convivenza, magnanimità e umore, tolleranza». Ormai Illusione
infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso
dalle acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro
oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo
della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza,
banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro
della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e
della volgarità. (Consolo 2000: 91) Una Milano reificata attraverso la
soppressione di tutte le maiuscole, una Milano al cui quadro orrifico
corrisponde, “di qua dal faro”, quello di Palermo. Non la Palermo dell’approdo
– e siamo già oltre i tre quarti del libro – di Ulisse-Gioacchino-Consolo al
porto che fu anche il loro comune punto di partenza, ancora ingentilita dalla
memoria dell’esiliato e dal ricordo dei passati splendori: Nella luce bianca,
vaporosa, apparivano il piano di Sant’Erasmo, la foce melmosa dell’Oreto, le
palazzate nuove del sacco mafioso, la Flora e le possenti mura, la Porta dei
Greci, la passeggiata delle Cattive, gli antichi palazzi dietro nobiliari, le
cupole e i campanili delle chiese, il Càssaro Morto e la Porta Felice, Santa
Maria della Catena, la conca stagna affollata d’alberi di lussuose barche della
Cala. (Consolo 2000: 98)
Ma la Palermo della banalità secolare del male. «L’amata sua odiata» che non
nasconde più il proprio vero viso: Intrigo d’ogni storia, teatro di storture,
iniquità, divano di potenti, càssaro dei criadi, villena degli apparati,
osterio di fanatismo, tribunale impietoso, stanza della corda, ucciardone della
nequizia, kalsa del degrado, cortile della ribellione, spasimo della cancrena,
loggia della setta, casaprofessa della tenebra, monreale del mantello bianco.
(Consolo 2000: 122)
Oltre alle scelte stilistiche illustrate da questi due cantica speculari, la
cui espressività, non sempre compensata dalla comunicatività dei fatti e delle
date, costringe il lettore a indovinare situazioni ed epoche, nonché bersagli
della denuncia, il cambiamento maggiore portato dall’ambiguità della nuova
istanza narrativa poematico-geometrica sembra risiedere nel filtro che una
specie di stream of conciousness di stampo quasi gattopardiano impone alla
rimemorazione, come pure nello sfasamento che tale rimemorazione provoca tra
tempo e spazio ricordati rispetto ai tempi e allo spazio della narrazione e a
quelli della Storia, con la conseguenza di appiattire e concentrare tempi ed
epoche diverse nello stesso movimento narrativo. Come quando, ad esempio, a
partire dal vivido ricordo della peste manzoniana (Consolo 2000: 85) e senza
nessuna rottura temporale apparente, il narratore ci parla del «tempo febbrile
delle pesti, del colera di Palermo» (Consolo 2000: 113), giocando peraltro
sull’ambiguità tra tempo meteorologico e tempo cronologico, in una
sovrapposizione allucinata in cui diventa impossibile discernere in quale epoca
vivano i «ciechi vaiolosi storpi appestati d’ogni sorta che dallo Spasimo si
recavano ogni giorno per mangiare alla Dogana» (Consolo 2000: 32).
18 Infatti, se Consolo, fedele alla sua definizione dello scrittore siciliano
come uno per cui «il romanzo storico, e in specie in tema risorgimentale [è un]
passo obbligato» (Consolo 1997: 181), ci presenta con Lo Spasimo di Palermo «un
ulteriore fallimento delle speranze italiane» per cui «[le] speranze di una
rinascita crollano di fronte alla pervasività del potere mafioso, e alle sue infiltrazioni
nello Stato repubblicano» (De Gregorio 2013), nelle modalità pratiche sembra
invece che egli aspiri, da un lato a cancellare e distruggere la rete
cronologica, dialogica e narrativa di cui necessita la storia per essere detta
o per raccontarsi, dichiarando di «aborri[re] il romanzo, questo genere
scaduto, corrotto, impraticabile» (Consolo 2000: 105) e, dall’altro, a
ristabilire i nessi logici atti a rendere conto dell’orrenda realtà palermitana
e italiana di quegli anni.
19 L’operazione di distruzione non è nuova: Consolo aveva infatti rivendicato che Il sorriso dell’ignoto marinaio, primo opus del ciclo, fosse classificato nella categoria degli antiromanzi storici, in una formulazione peraltro già ambigua poiché, se è antiromanzo, non può essere racconto e, se non è racconto, non può essere storia, per cui non si vede come un antiromanzo possa essere storico. Infatti sembrava degno della quadratura del cerchio il tentativo da allora condotto da Consolo di raccontare una storia e, addirittura, la Storia, che è la Grande Narrazione per eccellenza senza gli strumenti del racconto, col solo spostare il problema della scrittura «dalla comunicazione all’espressione» (Consolo 2007: 35). Questa è probabilmente la ragione dello scarso effetto di tali scelte sulla società civile e del conseguente mea culpa di Gioacchino-Consolo a destinazione dei figli che, alla stregua di Mauro Martinez, «si nega[no] a ogni confidenza, tentativo di racconto, chiarimento» (Consolo 2000: 42), esattamente come lo stesso Gioacchino Martinez confessa di averlo fatto con i propri padri intellettuali e letterari (Consolo 2000: 129).
20 Quello che è nuovo, invece, e diretta conseguenza di quanto precede, è la costruzione filologico-letteraria in puro stile sciasciano avviata da Consolo-Gioacchino a partire da fatti diversi di storia letteraria e civile (Sciascia 1989b), organizzati e ramificati in modo da costituire quello che Sciascia, ancora, chiamava un “teatro della memoria”, cioè un sistema di «oggetti eterni […] che variamente, alternativamente, imprevedibilmente splendono, si eclissano, tornano a splendere e ad eclissarsi – e così via – alla luce della verità» (Sciascia 1979: 231) poiché, come ha scritto lo zio Mauro di Gioacchino nel suo testamento, là si trova, «negli assoluti libri, la verità umana» (Consolo 2000: 73). Infatti, proprio dai libri di botanica e dal giardino dello zio scatta il primo “teatro della memoria” inscenato da Gioacchino, giacché, per lui come per lo zio, il giardino è «luogo platonico, ordine del mondo […], immagine del giardino interiore, sogno del ritorno, ripristino». Sotto il segno di questo ritorno e di questo ripristino, che però possono anche portare «offesa, patimento» (Consolo 2000: 49), nasceranno gli ulteriori elementi del suo sistema di “oggetti eterni” destinati a comporre una specie di antistorica – perché sorta dall’eterna e quindi atemporale verità letteraria – Storia delle storie: messe insieme, la storia delle tonnare (Consolo 2000: 59), quella del codice di San Martino – di nuovo di sciasciana ascendenza – e quella del Libro intorno alle palme di Abu-Hâtem-es-Segestâni (Consolo 2000: 64) tracciano i confini storico-geografici della Sicilia araba; quella poi, già più complessa e ricorrente, della «prigionia in Algeri di Cervantes e [di] quella insieme, d’un poeta [palermitano], dialettale, Antonio Veneziano» (Consolo 2000: 41, 105, 115, 118) disegna i contorni della Sicilia dei tempi dell’occupazione spagnola e conduce a sua volta alla scoperta, nella topographia e historia general de Argel (Consolo 2000: 107), di una parola che permetta a Consolo di collegare gli oggetti letterari già messi in risonanza con la più recente storia siciliana e italiana e, a Gioacchino, di seguire uno dei fili più dolorosi della sua personale storia umana. La parola è “marabutto”, e il filo che da essa dipana Gioacchino va dal massacro di suo padre e della madre di Lucia nel Marabutto di Rassàlemi per arrivare all’ultima scena del libro, quella dell’esplosione, in cui, mentre scrive a suo figlio, egli scompare insieme al giudice, figlio della sua vicina di casa: una scomparsa preannunciata da una specie di predizione dell’amico fioraio: «Ddiu ti scanza d’amici e nnimici, e di chiddi chi ti manciunu lu pani. Ddiu ti scanza di marabutta» (Consolo 2000: 124). Tutta questa intricata storia di fili e di figli permette inoltre al lettore di ricostruire, pure se a volte faticosamente, i famosi nessi grazie ai quali Gioacchino-Consolo spera di «scrivere di una storia vera […] fuori da ogni invenzione, finzione letteraria» (Consolo 2000: 105), insomma, fuori dall’aborrita scrittura romanzesca.
21 Tuttavia intento alla (per lui) illuminante, salvifica e lenificante ricostruzione letteraria e culturale di un passato comune a sé e, a una seppur «devastata» (Consolo 2000: 105) civiltà mediterranea nella quale riaffondare le proprie radici per ripartire verso un futuro riconciliato, Gioacchino non presta abbastanza attenzione ai messaggi sempre più cupi che provengono dall’altro “teatro della memoria”, concorrente del primo, che si sta costruendo quasi suo malgrado a partire da altri elementi anch’essi perfettamente collegati: un altro “teatro” che ha le stesse radici del primo, ma si sviluppa in modo subdolo e morboso esattamente come, a partire dallo stesso tronco, quello dell’olivo in cui Ulisse ha intagliato il proprio letto, si possono sviluppare sia l’olivo che l’olivastro. E infatti, dalla sua stessa casa, anzi dal suo stesso letto appunto, «sporcato ignobilmente» (Consolo 2000: 119) ad opera dei nuovi Proci, dei sempre rinnovati Proci della mafia e della politica, seguendo poi quella strada intitolata al musicista Emanuele d’Astorga da cui Gioacchino credeva di poter cominciare a riprendere possesso della sua città inseguendo memorie storiche e civili, proprio da lì ricomincia invece a proliferare la mai sanata peste, il cui nome, le cui immagini, i cui manzoniani echi percorrono tutto il libro al ritmo sempre più serrato di un’allucinata cavalcata mortifera per le strade, i monumenti della città, per poi proseguire, alla stregua del quadro di Raffaello, la sua anti-Odissea «da Palermo, alla Sicilia, al mondo» (Consolo 2000: 112), a celebrare il Trionfo della Morte (Consolo 2000: 117), della Follia (Consolo 2000: 111) e del Caos (Consolo 2000: 117). Il “teatro della memoria”, messo in moto dalla vita, ossia dalla vita di d’Astorga, si ramifica generando un’escrescenza cancrenosa che fagocita progressivamente gli “oggetti eterni” positivi che si stavano sviluppando serenamente sull’altro ramo, quello della riconciliazione, fino a mettere in una luce sinistra, di malaugurio, le notizie sulla chiesa di Santa Maria dello Spasimo «per cui Raffaello aveva dipinto La caduta di Cristo sul cammino del Calvario, chiamato qui Lo spasimo di Sicilia», ma chiamato dal suo artefice «sgomento della Vergine e Spasimo del mondo» (Consolo 2000: 112). Come anche la notizia secondo la quale il pezzo più conosciuto di d’Astorga era uno Stabat mater. Quello Stabat mater le cui note, la cui grafia diversa da quella della scrittura, la cui espressività che mai la scrittura potrà raggiungere, anche se cerca di farsi pura espressività e puro suono, bucano ad un tratto la pagina di Consolo a sostituire le parole (Consolo 2000: 125), preannunciando sia lo strazio, lo spasimo della madre del giudice di fronte alla morte del figlio in veste di laico redentore di tutte le colpe dei padri, sia «la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna» (Consolo 2000: 127), confessati da Martinez nella sua lettera al figlio e quindi da Consolo al suo lettore.
3 Basterebbe seguire le tracce lasciate dall’uomo dalle scarpe gialle, dal falso ragioniere, dal ma (…)
22 Ci si può chiedere se sarebbe stato possibile evitare tale sconfitta, una sconfitta che ha portato Consolo a riconoscere, con la metafora della lettera interrotta, l’impossibilità di un sereno passaggio di testimone tra le generazioni, per poi chiudersi nel silenzio dopo la morte del suo doppio letterario. Ci si può chiedere se, rifiutando i nessi razionali, la comunicazione dialogica propria del romanzo e in particolare la lettura ipotetico-deduttiva propria del romanzo poliziesco che gli avrebbe permesso di collegare gli indizi, pur presenti nel testo, della proliferazione del male3 e, limitandosi a scrivere «solo di cultura, storia, vicende curiose del passato, di questa città com’era un tempo» (Consolo 2000: 74), Consolo-Gioacchino non si sia precluso ogni possibilità di analizzare correttamente il presente e di riformarlo. Ci si può chiedere se non sarebbe stato opportuno approfittare di quel «varco che conduceva nel passato, nel racconto, in cui tutto era accaduto, tutto sembrava decifrabile» (Consolo 2000: 69), per scrivere, a dieci anni dalla morte dell’amico Sciascia, una storia finalmente semplice, invece di considerare che la volontà di riannodare i fili della propria storia personale e civile, di riprendere il film della lotta di Judex contro i cattivi laddove si era interrotto era, per finire, «uno sbaglio» (Consolo 2000: 53).
23 Quello che possiamo dire è che Consolo ci ha provato. Con Lo Spasimo di Palermo è infatti giunto a quanto di più vicino al romanzo – al, per lui, “impossibile romanzo” – fosse lecito spingersi, senza rinunciare completamente alle scelte e agli impegni di tutta una vita, in quanto scrittore e in quanto cittadino. Lo ha fatto cercando di ibridare la sua abituale scrittura poematica con quella geometrica comunicazione presa in prestito dal «castoro ligure; [dal] romano indifferente, [dall’]amaro [suo] amico siciliano», ma anche da quelli che, come loro, «hanno la forza […] della ragione, la chiarità, la geometria civile dei francesi» (Consolo 2000: 88): Pasolini, Vittorini, Manzoni, e tanti altri, i cui nomi, i cui libri, compongono a poco a poco un superiore “sistema di oggetti eterni”, una specie di borgesiano Aleph letterario.
24 Sennonché, anche quest’ultimo tentativo per dire il male, seppur condotto sotto l’alto patrocinio di sì autorevoli padri, si conclude con la morte di quelli che, almeno per Consolo, sono, erano, gli ultimi difensori dell’umana civiltà, il giudice e l’intellettuale. E con la loro morte non solo scompare la possibilità di una redenzione civile, ma viene anche dimostrata, attraverso quella specie di suicidio parricida, l’impotenza della letteratura – i cui rappresentanti sono pur stati convocati in schiere compatte – ad arginare, con qualsiasi mezzo o strumento, il dilagare del male.
4 «Questo di oggi è un libro sul presente, ma anche un ripercorrere gli anni Sessanta, con il terro (…)
25Il che non ci deve stupire, poiché neanche Judex, che pure «giudica e sentenzia fuori dalle leggi» (Consolo 2000: 129), ci può riuscire: ovunque e comunque «la nera sagoma trionfa del giustiziere» e «si conclude il feuilleton fuori da leggi, tribunali, si scioglie la vendetta precivile nel sentimento, si ricompone l’ordine del denaro e del potere» (Consolo 2000: 47) 4.
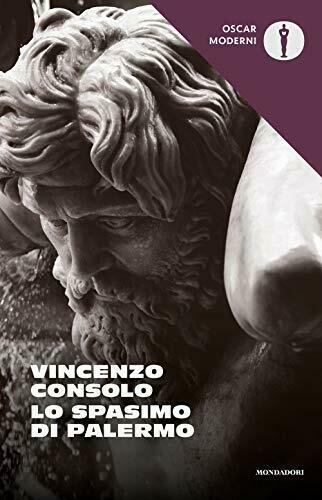
Bibliografia
Bossi, L., 2012, «‘L’olivo e l’olivastro’ de Vincenzo Consolo: pour une Odyssée
du désastre», Cahiers d’études italiennes, n°14/2012, Les années quatre-vingt
et le cas italien, a cura di Barbara Aiosa e Leonardo Casalino, p. 201-212.
Consolo, V., 1988, Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori.
Consolo, V., 1992, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori.
Consolo, V., 1997, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori.
Consolo, V., 1999a, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori.
Consolo, V., 1999b, Di qua dal faro, Epigrafi, Milano, Mondadori, «Oscar».
Consolo, V., 2000, Lo Spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, «Oscar».
Consolo, V., 2016, Passi a piedi, passi a memoria in Sciascia e Parigi,
Catania, Passim Editore.
Consolo, V., 2007, La metrica della memoria, in Vincenzo Consolo, éthique et
écriture, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle.
De Gregorio, F., 2013, In ricordo di Vincenzo Consolo
in: Eidoteca, https://eidoteca.net/2013/04/30/in-ricordo-di-vincenzo-consolo/
Francese, J., 2015, Vincenzo Consolo: gli anni de «l’Unità» (1992-2012), ovvero
la poetica della colpa-espiazione, Firenze University Press.
Sciascia, L., 1979, Nero su nero, Torino, Einaudi.
Sciascia, L., 1983, Cruciverba, Torino, Einaudi.
Sciascia, L., 1989, Una storia semplice, Milano, Adelphi.
Sciascia, L., 1989b, Fatti diversi di storia letteraria e civile, Palermo,
Sellerio.
Traina, G., 2001, Vincenzo Consolo, Firenze, Cadmo.
Note
2 «Si tratterebbe del racconto dei tre fallimenti della storia unitaria. Nel primo, sarebbe rappresentato il fallimento risorgimentale, il naufragio delle speranze democratiche e garibaldine nella Sicilia dei Gattopardi; e con esso, è descritta anche l’eclissi dell’intellettuale: inattuale, inconsapevole, passivo, non ancora engagé, per così dire. Nel secondo romanzo, Nottetempo, casa per casa, anche qui un intellettuale, maestro elementare, è travolto dal secondo e drammatico fallimento dell’Italia unitaria, quello dovuto all’avvento del fascismo. Per la seconda volta, le speranze degli italiani naufragano in un gorgo storico, nel Ventennio del buio novecentesco. E infine il terzo romanzo, Lo Spasimo di Palermo, ci presenta un ulteriore fallimento delle speranze italiane, quello repubblicano. Le speranze di una rinascita crollano di fronte alla pervasività del potere mafioso, e alle sue infiltrazioni nello Stato repubblicano».
3 Basterebbe seguire le tracce lasciate dall’uomo dalle scarpe gialle, dal falso ragioniere, dal mafioso delle Falde…
4 «Questo di oggi è un libro sul presente, ma anche un ripercorrere gli anni Sessanta, con il terrorismo vissuto a Milano e anche con quello che è il male della Sicilia, con le atrocità delle stragi di mafia. Infatti, il libro si conclude con la strage di Via d’Amelio e con la morte del giudice Borsellino. Questo è stato il mio progetto letterario. Poi, naturalmente, accanto a questi libri, ci sono dei libri collaterali, ma tutti convergono su questa idea, cioè, sul potere, sulla corruzione del potere» in Intervista inedita a Vincenzo Consolo, a cura di Irene Romera Pintor, http://vincenzoconsolo.it/?p=1299 poi pubblicata in Vincenzo Consolo, “Autobiografia della lingua” – Conversazione con Irene Romera Pintor http://books.openedition.org/res/318.
Autrice
Lise Bossi
Université Paris-Sorbonne
Rcherches
Culture et historie dans l’espace Roman
Consolo e la Spagna
Cervantino contro i padri illuministi: Consolo e la Spagna
Sciascia, Moravia, Calvino, usciti dal fascismo e dalla guerra, avevano scelto la Francia dei lumi come cultura di elezione: Vincenzo Consolo opponeva loro il dissesto del mondo e la dolce follia rappresentati dai classici spagnoli, in primis Cervantes

Vincenzo Consolo aveva il viso levigato come un ciottolo marino. Un viso bello e lucente. Nel parlare la statura della sua persona, certo non alta, aumentava. E un sorriso pieno di sottintesi si faceva strada, e tu lo guardavi e ne eri contagiato. Forse Vincenzo sorrideva per gioco, e quel gioco veniva voglia di farlo anche a te.
Se gli stavi vicino, seduto con lui allo stesso tavolo, non potevi non sentirne l’energia; così tanta che ti sembrava a volte che il suo corpo tremasse, soprattutto le mani. I suoi furori civili emergevano netti. E capivi che oramai non si sentiva a casa da nessuna parte. Però la sua vera casa era chiaro dove fosse: in Sicilia, non c’era nessun dubbio. Ma lui si era fatto maestro dei dubbi, e per anni aveva viaggiato come se fosse stato in una fuga continua.
Ma non si pensi solo alla fuga di chi scappa, di chi non riesce a stare in nessun luogo; si pensi anche alla figura musicale della fuga. Quella che lui cercava era una polifonia geografica, dentro la quale i luoghi si versavano l’uno nell’altro, e il Nord e il Sud perdevano i loro connotati primari e ne assumevano altri, dai quali lo scrittore traeva una vasta gamma di sonorità e di ritmi. Manzoni e Verga si davano la mano.
Il viso di Consolo somigliava al ritratto di ignoto di Antonello da Messina. Si tratta di un piccolo quadro, piccolo come spesso piccole sono le pitture di un artista che aveva tutte le qualità per esser considerato anche un miniaturista. Il quadro se ne sta a Cefalù, nel museo Mandralisca; ha una sala tutta per sé, e quando gli capiti dinanzi ti guarda con occhi ambigui; sembra che ti segua; forse sta prendendoti per i fondelli.
Per arrivare dinanzi al suo sguardo malandrino, hai attraversato alcune sale, e soprattutto ti sei fermato ad ammirare la collezione di conchiglie che il barone Mandralisca, fervente malacologo, era stato capace di radunare in pochi metri quadri. Mandano barbagli nella stanza in cui sono esposte, e gli occhi si perdono nel gioco di curve che li movimenta. La figura della spirale si fa avanti con prepotenza e la linea retta deve retrocedere (si tratta, si sa, di temi cari al saggismo e alla narrativa di Consolo).
È tale l’identificazione visiva che lo scrittore stabilì tra sé e il ritratto di Antonello che a volte viene il ghiribizzo di lasciarsi trasportare nel flusso di un anacronismo fruttuoso e pensare che sia stato proprio lo scrittore di Sant’Agata di Militello a posare per lui.
Parlando di Antonello e del barone Mandralisca siamo già entrati, quasi senza volerlo, tra le pagine del secondo libro di Consolo, quel Sorriso dell’ignoto marinaio che fu il frutto di una lunga elaborazione e che venne definito da Leonardo Sciascia come un parricidio.
Eh sì, da qual momento Consolo aveva scelto una sua strada che lo distanziava dall’illuminismo linguistico del suo maestro: punto di vista plurimo, stratificazione linguistica, prosa ritmica, inserti di materiali documentali, e soprattutto un modo di considerare la Storia come un’enorme cava dalla quale estrapolare materiali da sottoporre alla traduzione della letteratura.
Tutto questo era anche il risultato di uno spostamento dello sguardo: dalla Francia prediletta da Sciascia (ma anche da Calvino, che fu sempre un altro suo punto di riferimento) alla Spagna. L’irrequietezza geografica di Consolo lo aveva fatto approdare al paese del Chischiotte; i suoi pendolarismi tra l’illuminismo milanese (a Milano era andato a vivere quando aveva deciso di spostarsi dalla Sicilia) e il ribollire paesaggistico di una Sicilia girata in lungo e in largo durante i periodici ritorni, lo avevano portato a un’esplorazione fatta per strati ellittici.
Un incontro a Messina
Della sua predilezione per la Spagna, Vincenzo parlò anche durante un lungo incontro pubblico che avemmo a Messina. Sentiamo cosa disse a proposito.
«Devo dire che gli scrittori della generazione che mi ha preceduto, parlo di scrittori di tipo razionalistico, illuministico, come Moravia, come Calvino, come Sciascia, avevano scelto la strada della Francia. Erano passati attraverso la Toscana rinascimentale, soprattutto dal punto di vista linguistico, e oltrepassando le Alpi, com’era già avvenuto a Manzoni, erano approdati alla Francia degli illuministi. La loro concezione del mondo rifletteva proprio questo reticolo della lingua, e non solo della lingua, quella che Leopardi chiama la lingua geometrizzata dei francesi. Questo lo si vede nella lingua cristallina, limpida, che hanno usato questi scrittori. Io mi sono sempre chiesto del perché questi scrittori, che hanno vissuto il periodo del fascismo e il periodo della guerra, abbiano optato per questo tipo di illuminismo, di scritture illuministiche e di concezione illuministica del mondo. Io ho pensato che appunto, avendo vissuto il fascismo e la guerra, speravano, era una scrittura di speranza la loro, speravano che finalmente in questo paese si formasse, dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, una società civile con la quale comunicare. Era la concezione utopica anche di Manzoni, quando immagina che in questo paese finalmente si potesse parlare un’unica lingua. I panni che sciacquava in Arno erano panni che aveva portato già umidi dalla Senna, e mentre li sciacquava in Arno, immaginava una lingua ideale, la lingua attica che era l’italiano comune.
Quelli della mia generazione, che hanno visto succedersi al regime fascista un altro regime, quello democristiano, hanno dovuto prendere atto che questa società non era nata, che la società civile alla quale lo scrittore poteva rivolgersi non esisteva, quindi la mia opzione non è stata più in senso razionalistico, ma in senso, diciamo, espressivo. E quindi il mio itinerario mi portava non più alla Francia, ma verso la Spagna.
La Spagna, appunto, partendo dalla dolce follia, dalla follia simbolica, dalla follia metaforica del cavaliere errante del Don Quijote, e quindi attraverso tutti i poeti del Siglo de Oro, e quindi anche la letteratura spagnola che Vittorini ci indicava in quegli anni, scrittori non solo sudamericani come Rulfo, o scrittori spagnoli come Cela, o come Ferlosio, tanti altri scrittori del secondo dopoguerra che avevano vissuto il periodo del franchismo. Quindi la mia educazione, sia di contenuti che stilistica, è di tipo spagnolo».
Le segrete dell’Inquisizione
La Spagna in Sicilia significa anche Inquisizione. Consolo lo sapeva benissimo. E anche lui, come Sciascia, aveva voluto ficcare i suoi occhi nelle segrete di Palazzo Steri a Palermo. Era lì che aveva avuto sede il terribile tribunale e lì erano stati incarcerati i prigionieri. Alle pareti rimangono i loro segni, e spesso sono molto più che segni o semplici graffiti. Si tratta infatti di narrazioni murali, di poesie, di piccoli affreschi monocromi, di grida silenziose.
Consolo non poteva non essere attratto da quello che può considerarsi il documento più sconcertante di come si provi a mantenersi umani in un regime disumano. Basta riaprire Retablo – e riaprirlo seguendo la pista spagnola che già il titolo mette in rilievo in modo così palese – per imbattersi nelle prime pagine in una duplicità di sguardo: da una parte c’è la descrizione dell’arrivo del pittore lombardo Clerici nel porto di Palermo: «In piedi sul cassero di prora del packet-boat Aurora, il sole sul filo in oriente d’orizzonte, mi vedea venire incontro la cittade, quasi sognata e tutta nel mistero, come nascente, tarda e silenziosa, dall’imo della notte in oscillìo lieve di cime, arbori, guglie e campanili, in sfavillìo di smalti, cornici e fastigi valenciani, matronali cupole, terrazze con giare e vasi, in latteggiar purissimo de’ marmi nelle porte, colonne e monumenti, in rosseggiare d’antemurali, lanterne, forti e di castell’a mare, in barbaglìo di vetri de’ palagi, e di oro e specchi di carrozze che lontane correvano le strade».
Dall’altra, nel bel mezzo di quest’incanto, la presenza inquietante di «istromenti strani e paurosi. Istromenti giudiziali di tortura e di condanna, gabbie di ferro ad altezza d’uomo, tine che si rivelano per gogne, e ruote infisse al capo delle pertiche, e letti e croci, tutti di ferro lustro e legno fresco e unto». Tra questi spicca il «più tristo»: «lo stipo d’una gran porta issato su un palchetto, porta di grossi travi incatramati, vuota contro la vacuità celestiale, alta sul ciglio della prora, le grosse boccole pendenti per i capi ch’ogni piccola onda o buffo facea sinistramente cigolare».
Incanto e tormento: parole che si slanciano a carezzare il paesaggio e parole che sono costrette a documentare l’orrore macchinale di questi obbrobriosi oggetti atti alla tortura. Mai come in Retablo, che usci nel 1987 come numero 160 della collana di Sellerio intitolata a «La memoria», lo scrittore si abbandona al fluire giocoso e serissimo delle parole, al loro sommovimento sintattico, al gusto per la spirale che il barone Mandralisca aveva esaltato nel suo museo di Cefalù. E sempre al centro della narrazione c’è un viaggio, un andare e un cercare insieme dei due protagonisti: Fabrizio Clerici (i disegni del «vero» Clerici adornano il libro) e Isidoro. E di nuovo si rinnova il tacito modello duale di Don Chischiotte e del suo scudiero Sancio Panza, in un processo di «infinita derivanza», che mescola le epoche e che mette le persone le une dinanzi alle altre, e tutte alla ricerca de El retablo dela maravillas cervantino, usato alla stregua di un velo di Maya: «velo benefico, al postutto e pietoso, che vela la pura realtà insopportabile, e insieme per allusione la rivela; l’essenza, dico, e il suo fine il trascinare l’uomo dal brutto e triste, e doloroso e insostenibile vallone della vita, in illusori mondi, in consolazioni e oblii».
Amore e movimento
Entrambi i viaggiatori consoliani sono innamorati di donne che non li corrispondono: Isidoro, addirittura, vive in una sorta di deliquio continuo per la sua Rosalia. L’amore li spinge al movimento, a un ennesimo attraversamento della Sicilia, in parte coincidente con quello di Goethe, in parte dissimile. E anche ne L’olivo e l’olivastro avverrà qualcosa di simile. Ma non più in un tempo retrodatato, piuttosto tra le rovine della contemporaneità; e tali sono, in alcuni casi, queste rovine, che lo scrittore decide di «saltare» a piè pari Palermo, la capitale corrotta, il luogo del delitti, lo sprofondo del paese. Ma ci tornerà, ci tornerà con Lo Spasimo di Palermo. E di nuovo saprà individuare il luogo emblematico, quella chiesa senza tetto, dove gli alberi sono cresciuti cercando il cielo. Chiesa di grande bellezza, a segnare un confine dentro il quartiere della Kalsa.
Ogni volta è così: Consolo si «consola» proiettando se stesso in un manufatto esterno a lui; ne cerca le rassomiglianza; ne estrapola il dna visivo e se lo inocula.
In questo senso fa pensare al grande scultore che compare in Retablo, al «cavalier Serpotta». Chi abbia visitato i suoi oratori palermitani, sa bene di che genio si tratti. Bianchissime figure danzano le loro forme in sequenza. Sono modellate all’infinito, con una tecnica che disdegna il marmo, e fa uso di un materiale più malleabile. Si tratterebbe di stucchi, ma il Serpotta è stato capace di rafforzarli facendo cadere nei punti nevralgici una polverina di marmo.
Ma non fa solo figure umane, santi e sante; raffigura anche la battaglia di Lepanto, nella quale aveva combattuto Cervantes. Le navi hanno le vele fatte d’oro, e sembrano anticipare le svelte e filiformi figure di Fausto Melotti.
La battaglia viene rappresentata «in discesa», rendendo possibile all’occhio dell’osservatore di gustarne i dettagli e di avere una visione d’insieme. A ben pensarci, Consolo adotta nella scrittura una tecnica simile a quella del Serpotta. Modella la lingua con agilità, conoscendone le verticalità, usando i depositi di lessico scartati dal tempo. E quando è necessario fissa il tutto con una polverina marmorea.
Ma torniamo a Cervantes. Per lo scrittore siciliano contava non solo l’opera; lui considerava Cervantes «una figura straordinaria, oltre alla grandezza dello scrittore e del poeta, perché era quello che aveva sofferto la prigionia nei Bagni di Algeri. Aveva scritto due opere, I Bagni di Algeri e Vita in Algeri, proprio mentre era prigioniero, e poi anche nel Don Chisciotte c’è un lungo capitolo intitolato “Il prigioniero”, che è autobiografico, dove racconta la sua esperienza. Lì era stato prigioniero con un poeta siciliano, si chiamava Antonio Veneziano. Si erano incontrati, questi due ingegni, questi due poeti, nella prigione di Algeri, e Veneziano era stato riscattato prima perché pensavano che fosse un uomo di poco valore, mentre avevano intuito che Cervantes doveva costare molto e quindi il suo riscatto avvenne successivamente. In seguito i due ebbero uno scambio di versi, e lo spagnolo scrisse le Ottave per Antonio Veneziano. Cervantes, che aveva partecipato alla battaglia di Lepanto, ed era stato a Messina, si era imbarcato a Messina, mi era caro anche per questa congiunzione tra Sicilia e Spagna».
Leggere Cervantes significava anche spostare il baricentro della narrazione. Dai racconti marini, «dove la realtà svanisce, e dove c’è l’irruzione della favola e del mito», che avevano visto nascere i poemi omerici, al romanzo del viaggio. «Cervantes sposta il viaggio, fa dell’andare, del peregrinare, una cifra che poi adottò Vittorini con Conversazione in Sicilia. Ecco, Cervantes è stato quello che ha spostato il viaggio dal mare alla terra, ed è una terra di desolazione, di dolore – la Mancia – che diventa metafora del mondo».
Gli anni ammutoliti
E quella terra di desolazione, con il tempo si estende, e lo stesso Mediterraneo che per lo scrittore era stato «uno dei luoghi civili per eccellenza, dove c’era stato un grande scambio di cultura, una grande commistione, una reciproca conoscenza», si contamina, diventa guerresco, riaffiorano le guerre di religione, risorgono i nazionalismi.
Sono gli anni in cui lo scrittore si ammutolisce. Continua a viaggiare, ma il suo sguardo ha perso in prensilità. L’arte della fuga perde i suoi caratteri musicali e diventa un andare da una Milano che si desidera abbandonare a una Sicilia che si fa sempre più fatica a riconoscere. Il mondo è diventato casa d’altri. Il velo di Maya gli è stato levato per sempre, pensa tra sé e sé. Forse comincia a dubitare della stessa letteratura, che vede prostituirsi in facili commedie di genere.
Però è sempre dalla letteratura che trae i suoi esempi; è da lì che riparte. A Messina, alla fine del nostro colloquio – che ho poi trascritto in un mio libro di viaggi siciliani, intitolato In fondo al mondo. Conversazione in Sicilia con Vincenzo Consolo, ed edito da Mesogea – disse con il sorriso da ignoto marinaio affiorante sul volto levigato come un ciottolo marino: «Mi piace sempre ricordare una frase che Calvino mette in bocca, ne Il castello dei destini incrociati, a Macbeth». La frase suona così: «Sono stanco che Il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del Mondo, che si mescolino le carte del gioco, i fogli dell’in-folio, i frantumi di specchio del disastro».
Silvio Perrella
Il Manifesto Alias Domenica Edizione del 30.08.2015
Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello: vicinanze e lontananze di due scrittori del secondo Novecento
Giuliana Adamo
L’attenzione critica che qui si vuol dare a un confronto tra Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello trae spunto, a ritroso, dall’evento unico ed ultimo che li ha visti insieme il 20 giugno del 2007, a Palazzo Steri, a Palermo, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Filologia Moderna conferita ad entrambi, in curiosa conclusione del viaggio parallelo dei due scrittori, iniziato proprio nel 1963, anno del loro rispettivo esordio letterario.1 Escono, infatti, nel 1963 La ferita dell’aprile di Consolo – storia di un adolescente che dopo un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e dolori, arriva alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza; misto sapientemente dosato di autobiografia e di storia, di quotidiano e di mito – e Libera nos a malo di Meneghello, testo autobiografico che ‘offre un ritratto della vita a Malo, di una incomparabile ricchezza e incisività. È l’Italia […] della prima metà del secolo, nei decenni successivi alla Prima guerra mondiale’ che suscita anche nei lettori che veneti non sono ‘la “scossa del riconoscimento” (lo shock of recognition, come si dice in inglese) – un senso di partecipazione, di familiarità, nonostante le grandi differenze di contesto culturale’.2 Importante richiamare – anche se rapidamente – le superficiali analogie tra le rispettive scelte biografiche che rendono conto, in parte, delle ragioni della posizione peculiare che i due scrittori hanno avuto nel panorama culturale coevo: essendo tra i pochi ad essersi espatriati o dispatriati, con tutte le differenze dei singoli casi (Consolo a Milano, Meneghello a Reading in Inghilterra), dal proprio Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 39 luogo natìo e ad avere vissuto in un costante confronto tra le diverse culture con cui sono venuti a contatto. Entrambi, e ciascuno a suo modo, ulissici nel nóstos continuo con la propria Itaca: la Sicilia per Consolo, Malo per Meneghello. Prima di proseguire è importante ricordare, in sintesi, che il contesto letterario in cui prendono l’avvio i due scrittori è quello a cavallo degli anni ’50 e ’60 del Novecento, momento in cui, in un’Italia che faceva ancora i conti con gli strascichi della già conclusa esperienza del Neorealismo postbellico, imperversavano dibattiti e polemiche riguardanti soprattutto le nuove forme di espressione letteraria da ricercarsi, in ambito linguistico, nei territori che si estendevano tra il ricorso alla lingua italiana e la necessità dell’uso letterario dei dialetti. Per intendere la lezione stilistica di Meneghello sono preziose le parole di Cesare Segre, secondo cui lo scrittore di Malo si muove in uno spazio indipendente di outsider, di dispatriato e apprendista in Inghilterra, da Meneghello chiamata il ‘paese degli angeli’. Lo scrittore di Malo, quindi, ‘ha ben poco a che fare’ – sostiene Segre – con i precedenti più rappresentativi quali Fenoglio, Testori, Pasolini, Mastronardi perché la loro scelta dialettale è connotata da un ‘marchio sociologico’ di eredità neorealistica estraneo alla scrittura di Meneghello. E ha anche poco a che spartire sia con la diversa matrice della dialettalità espressionistica di Gadda; sia con l’uso mimetico del dialetto di Fogazzaro; sia con la dialettalità contenutistica di Verga, e poi di Pavese, in cui il ricorso alla dimensione dialettale esula dalle caratteristiche lessicali e morfosintattiche del dialetto. A queste differenze, si aggiunga, infine, il tratto peculiare della scrittura di Meneghello in cui, benché la funzione del dialetto sia in lui fondativa, il discorso narrativo avviene ‘prevalentemente in lingua’.3 Per Consolo il discorso è differente in quanto lo scrittore siciliano – pur con tutta la sua peculiare originalità espressiva che vede fondere l’eredità barocca di Lucio Piccolo con la ratio illuminista di Sciascia – si inscrive pienamente nella tradizione del romanzo storico siciliano che si estende, notoriamente, dal Verga della novella ‘Libertà’, al De Roberto de I viceré, al Pirandello de I vecchi e i giovani e allo Sciascia de Il consiglio d’Egitto. Tutti i romanzi e le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Per quel che riguarda, invece, la sua ricerca linguistica, come da lui stesso ampiamente ribadito nei suoi scritti, essa rimanda alla linea della sperimentazione di Pasolini e di Gadda (in opposizione alla soluzione razionalista e illuminata della lingua di Calvino e Sciascia), risultando in una scrittura che, come coglie la poetessa e scrittrice Maria Attanasio, ‘non è mai rotonda fertilità espressiva, 40 Giuliana Adamo levigato specchio, ma frantumazione caleidoscopica, allusivo aggiramento, inesauribile nominazione; al di là della parola, resta, indicibile, il vivido pulsare della vita’.4 Fatta questa necessaria premessa, torno all’argomento su cui mi soffermo in questa sede. Per il confronto che mi appresto ad abbozzare e a proporre – nulla di esaustivo ovviamente, ma ugualmente passibile, spero, di critiche costruttive, approfondimenti, analisi di differente approccio – il punto di partenza mi è sembrato giusto che fosse dato dalle rispettive lectiones magistrales – in apparenza così diverse – indirizzate, dai due laureandi, al Senato accademico e al pubblico presenti nella sala palermitana. Quella di Consolo, il primo a parlare, dal titolo ‘Due poeti prigionieri in Algeri. Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano’; quella di Meneghello intitolata ‘L’apprendistato’. 5 Le due lectiones mi pare si prestino ad essere usate come specimen delle rispettive opere, permettendo di tracciare linee di contatto e/o distacco, di analogie e/o differenze tra i due autori. Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano La lectio di Consolo, fin dalla dedica alla memoria di Leonardo Sciascia, segnala l’instancabile e appassionata militanza, da sempre parallelamente giornalistica e letteraria, dell’autore siciliano e verte sui temi che costituiscono il cuore di tutta la sua scrittura: 1) Il rapporto tra passato e presente (da cui il suo sguardo storico indagatore trae la linfa vitale: il passato come metafora del presente). 2) L’attenzione particolare alla Storia siciliana inquadrata nel contesto più ampio della storia mediterranea, fatta di incontri e scontri di popoli e civiltà e dalle stratificazioni culturali e linguistiche che ne conseguono. A questo, inoltre, si lega l’immancabile tema dell’opera di Consolo: il viaggio. Tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio: viaggio rituale dall’esistenza alla Storia, che invita alla conoscenza di sé e del mondo. Viaggio alla ricerca della luce-ragione che illumini, pur se in modo intermittente, le tenebre che avvolgono la condizione umana. 3) La necessità ineludibile della poesia (con il ricorso nella sua narrativa ad una lingua poetica, non comunicativa ma espressiva). 4) La citazione e la menzione continue di testi poetici e narrativi, scritti e orali, nelle diverse lingue del mondo consoliano: italiano, siciliano, spagnolo, latino, sabir, nonché il costante intarsio realizzato dalle fedeli Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 41 riprese di cronache e documenti d’epoca ufficiali e non, altro polo costitutivo della poetica e dell’opera di Consolo. Quanto al contenuto della lectio, in parole brevi, che valgono quasi come un sottotitolo, parla della vita terribile nel tardo Rinascimento, vissuto tra le sponde del Mediterraneo, che fa da sfondo alla comune prigionia, nelle carceri di Algeri, di Miguel de Cervantes e del poeta siciliano Antonio Veneziano alludendo, per via di metafora, all’attuale situazione del mare nostrum, crocevia di diverse civiltà e doloroso luogo degli scontri tra di esse. Si pensi, soprattutto, al problema dei migranti, nei confronti del cui trattamento da parte dell’Europa occidentale e, in particolare dell’Italia, la sensibilità dell’intellettuale Consolo ha raggiunto punte estreme di indignazione civile e di profonda pietas. Consolo ricostruisce la oscura biografia di Antonio Veneziano ‘l’elegantissimo latinista, il più rinomato poeta siciliano del secolo XVI’6 vissuto tra 1543 e 1593. Per fare questo, applica il suo rigoroso metodo di indagine storica e storiografica – eredità manzoniana e fondamento dei suoi romanzi storici, o meglio anti-romanzi storici – risalendo alle fonti scritte ed ufficiali e, quando possibile, a fonti più in ombra (archivi, fondi di parrocchie, testimonianze di oscuri cronisti coevi, lettere dimenticate, atti notarili, scritte murali, graffiti, canzoni popolari, etc.).7 In questo caso, Consolo cita, tra gli altri, le testimonianze di Giuseppe Lodi (bibliotecario ottocentesco della palermitana Società di Storia Patria); del demo-psicologo ed etnologo Giuseppe Pitrè; del canonico Gaetano Millunzi; di Leonardo Sciascia che, nel 1967, a proposito del Veneziano ricorda che era: ‘Violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti, incostante negli affetti famigliari e negli amori, assolutamente sprovvisto di rispetto per le istituzioni e per gli uomini che le rappresentano’.8 Tuttavia, ed è questo che interessa a Consolo sia per il plurilinguismo sia per la militanza polemica dell’intellettuale: malgrado il carattere e la mala condotta, scrive, scrive il Veneziano, scrive poesie in siciliano, in latino, in spagnolo, prose e composizioni in versi per gli archi di trionfo in onore dei vari viceré che s’installano a Palermo. Ma scrive anche satire contro gli stessi viceré, contro il potere politico, satire affisse sui muri. (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 26) La vita del Veneziano si rivela curiosamente speculare a quella di Cervantes (ricca come risulta di accuse malevole, assilli economici, disordini familiari, varie incarcerazioni). Ed è ad una di queste incarcerazioni, presumibilmente, che si deve l’incontro, o il re-incontro (forse, congettura Consolo, si 42 Giuliana Adamo erano incrociati anni prima a Palermo, ma questo resta da dimostrarsi), e la conseguente ammirazione reciproca, quasi amicizia, tra l’autore del Quijote e quello della Celia. Il Veneziano venne preso prigioniero sulla galea Sant’Angelo, al seguito di Don Carlo d’Aragona, dai corsari, al largo di Capri, il 25 aprile 1578. Quindi venne condotto come schiavo ad Algeri nel cui bagno penale incontrò Cervantes, a sua volta schiavo in quella città da più di tre anni. Anche la biografia di Cervantes, soprattutto in relazione alla sua prigionia algerina e ai suoi ben quattro tentativi di evasione, è ricostruita storicamente da Consolo sulla scia di scritti, documenti, testimonianze di autori vari, incluse quelle dello stesso Cervantes. Ecco, dunque, che è importante rilevare (e la lectio ce ne dà prova) come Consolo lavori col materiale che ha cercato, documentato, elaborato. Da un lato, quindi, vediamo emergere, l’importanza che ha per lo scrittore la Storia e il metodo usato nella sua ricerca di ricostruzione e ricomposizione del passato; dall’altro – e in maniera costitutivamente intrecciata – il lavoro creativo dello scrittore che intaglia una storia ricca di dettagli documentati in modo meno ufficiale dentro alla grande Storia, che lui avvertiva sempre come immobile e immutevole nelle sue prevaricazioni, nei suoi inganni, nelle sue menzogne, nelle sue ingiustizie, nei suoi silenzi, nelle sue esclusioni. Ed ecco – analogamente a quanto avviene nei suoi lavori storici, memori della lezione manzoniana ma prodotti nella sua lingua ‘rigogliosamente espressivistica’,9 plurivocale,10 pluridiscorsiva e pluristilistica – che Consolo si spinge a ricreare che cosa possano avere detto, fatto, provato insieme, ad Algeri, i due scrittori secenteschi: I due in carcere, ascoltano la cantilena in sabir, la lingua franca del Mediterraneo, che i ragazzi mori cantavano sotto le finestre dei bagni: Non rescatar, non fugir Don Juan no venir morir… cantilena riportata da Cervantes in Vita ad Algeri e ne I bagni di Algeri. Tutte e due avranno avuto catene alle caviglie e saranno stati vestiti allo stesso modo, il modo come Cervantes descrive il Prigioniero che entra con Zoraide nella locanda ‘il quale mostrava dagli abiti d’essere un cristiano giunto recentemente da terra di mori, perché era vestito d’una casacca di panno turchino, a falde corte, con mezze maniche e senza collo; anche i calzoni erano di tela turchina, e il berretto dello Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 43 stesso colore.’In quel carcere, con chissà che emozioni e sensazioni, scrivono l’uno la Celia (preso d’amore non si sa bene per chi fra i due possibili oggetti del suo amore: quello incestuoso per la nipote Eufemia o quello impossibile per la viceregina Felice Orsini Colonna, moglie di Marc’Antonio Colonna, comandante della flotta veneziana nella battaglia di Lepanto, nel 1571, allora viceré di Sicilia); l’altro presumibilmente Vita ad Algeri, le Ottave per Antonio Veneziano e comincia la stesura della Galatea. (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, pp. 30-31)11 I due protagonisti della lectio lasceranno Algeri, finalmente riscattati: il Veneziano nel 1579 (morirà nel 1593 nel carcere di Castellamare per lo scoppio doloso della polveriera), mentre Cervantes nel 1580 (per poi finire nel carcere di Siviglia o in quello di Castro del Rio dove nel 1592 concepisce il Quijote). In seguito, ricorda significativamente Consolo, Cervantes ritornerà sulla passata dolorosa esperienza: ‘[d]ice ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Non c’è sulla terra, secondo il mio parere, gioia che eguagli quella di conseguire la libertà perduta”’ (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 33). A questo punto, da quel che emerge da una lectio così costituita possiamo cogliere un insieme di elementi che offrono una misura valida per farsi un’idea dei tratti essenziali che permeano tutta l’opera di Consolo: 1) L’ ineludibile necessità etica che lo spinse, da sempre, a studiare, indagare, scavare, scrivere – cercando di capire e di aiutare a fare capire – la complessità della vita, nel Cinquecento come nel 2000, che si svolgeva e svolge nell’area mediterranea, dove sono nate incontrandosi e/o scontrandosi le grandi civiltà della storia occidentale. 2) La necessità di mostrare che la Storia – se distaccata dalla storiografia ufficiale, sempre soggettiva e parziale, scritta dai vincitori e mai dai vinti – può emergere più contraddittoria, ma più completa, grazie al corale contributo delle voci di ‘più picciol affare’. In tal modo, la scrittura della storia diventa (con certa utopia) incrocio di punti di vista diversi: Storia, insomma, come una messa a fuoco plurima e dialettica della realtà. In Consolo il rapporto Storia-invenzione del romanzo storico classico è rovesciato: ‘ciò che lì era documento qui è racconto, universo opinabile, discorso retorico. Ciò che lì è veramente accaduto, qui è come realmente accaduto’, evidenzia finemente Nisticò a proposito, in particolare, de Il sorriso dell’ignoto marinaio. La critica operata da Consolo è volta alla Storia in quanto scrittura, nella sua ‘demistificazione permanente del mito 44 Giuliana Adamo dell’oggettività e della verità dei documenti e della tradizione storica’.12 Ed è su questo assunto che si è basata la sua intera attività di scrittore. 3) Il valore della scrittura qui esemplato dall’esperienza di due intellettuali che si trovano in mezzo a indicibili difficoltà oggettive e, di conseguenza, il ruolo salvifico della poesia che – nonostante tutto e tutti e nonostante i suoi stessi autori – è eternamente valida e, a differenza della Storia, super partes. 13 4) La metafora del presente che quell’antica, tormentata, feconda esperienza cinquecentesca è chiamata simbolicamente a rappresentare, in quanto per Consolo: ‘un testo è vivo quando è metafora, quando non parla solo di sé’.14 5) La fondante tensione metaforica resa attraverso uno stile che rende ragione del coro di voci e di lingue che scintillano in questo testo (come in tutti i suoi testi) intrecciandosi per ricordarci che quel che è successo succede ancora e che, e qui Consolo usa le parole, tragicamente attuali, che Fernand Braudel riferiva all’età di Filippo II: ‘In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli ‘universi concentrazionari’ (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 34). Rappresentativa della poetica di Consolo è questa lectio che ho voluto usare come microtesto per individuare le linee portanti del macrotesto consoliano: non autobiografica, se non per pulsioni spesso inconsce; storico-filologica; testimonianza del suo impegno di scrittore e di intellettuale contro soprusi e ingiustizie. Le attestazioni dell’inesausto agire civile di Consolo, oltre che in tutti i suoi libri e nei suoi saggi, anche sulle pagine dei quotidiani italiani storicamente più schierati a sinistra, come l’Unità e Il manifesto, che hanno accolto i suoi veementi articoli sui temi dell’immigrazione, dei migranti, delle angherie e degli abusi perpetrati ai loro danni, della micidiale miopia italica e dell’assenza di memoria di quel popolo di migranti che sono sempre stati gli italiani. Per Consolo etica e scrittura sono una cosa sola,15 la memoria individuale e la memoria storica consentono lo scavo nel passato per riflettere sul presente; la lingua del suo scrivere – con le lingue sottostanti che la nutrono storicamente e culturalmente – è una lingua storica e filologica e non la si capirebbe se la si alienasse dal fondamento del determinarsi storico e sociale dei linguaggi. La esibita letterarietà di Consolo, tanto sottolineata dai critici, per essere correttamente intesa va ricompresa in un progetto artistico che utilizza l’opacità e il peso della tradizione letteraria come strumenti di una più acuta e complessa lettura della realtà. Se, infatti, Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 45 pur nell’ambito di una insistita critica sociale mossa dalla prospettiva di una solidarietà coi ‘vinti’ e coi subalterni non possiamo sottrarci alla constatazione (è questa la critica mossa a Consolo) della preziosità erudita del suo linguaggio, delle sue notevoli densità e perspicuità letterarie, lo si deve soprattutto al suo tentativo di drammatizzare una contraddizione che da sociale diventa, performativamente, stilistica e retorica. Quello che in realtà è lo scontro tra isole di ricchezza e oceani di indigenza diventa, nelle strutture narrative di Consolo, lotta tra l’abbandono lirico di un linguaggio (spesso anche in veste parodica) che è esso stesso ‘cosa’ (strumento di gioco e di piacere) e il dover essere etico e razionale per garantire la narrazione. Prosa e poesia si fronteggiano, esibendo ciascuna le proprie ragioni. La sua narrativa usa a piene mani una lingua e dei moduli poetici non strettamente narrativi (ma lontanissimi dalla prosa d’arte da lui aborrita): il retablo, il cunto, l’opera teatrale, la metrica versificatoria, espedienti stilistico-retorici quali l’enumerazione e l’iperbato, il repentino mutamento dei registri, che con il loro andamento ipotattico frangono la paratassi del più generale impianto narrativo. Le apparenti dissimmetrie, che la lectio riflette, tra piano dell’espressione – iper-letteraria, barocca – e quello del contenuto – materialistico, progressivo – sono ricomprese ma non ricomposte o pacificate nella sua scrittura, a causa di una contradditorietà mai risolta: il conflitto (sociale e retorico) rimane la cifra estetica più propria nell’opera di Consolo.16 L’apprendistato E veniamo alla lectio di Meneghello ‘L’apprendistato’, quintessenzialmente meneghelliana: autobiografica, riflessiva, ironica, giocata sapientemente sui diversi registri retorici che, come sempre nella sua scrittura, sono capaci di suscitare, in chi legge uno spettro variegato di emozioni: dal riso alla commozione alla riflessione al disincanto. Dall’inizio emerge subito l’interesse primario di una vita, il motore di tutti i suoi libri: l’attenzione alle parole e alle cose che esse veicolano inquadrata, da subito, nel suo personale percorso di studente dialettofono italiano e di professore di italiano in Inghilterra. Le sue lingue di cultura (italiano, greco, latino, inglese) affiorano subito, nel primo lungo paragrafo della lectio laddove, in modo colto e ilare, racconta di quel che provoca in lui l’essere in procinto di diventare ‘filologo’ e cerca di definire che cosa sia la filologia. Risale all’origine greca del termine dovuto a Eratostene, nel III secolo a.C., ‘matematico, ma bravo anche come 46 Giuliana Adamo astronomo, geografo, filosofo, storico, e altro ancora’ (‘L’apprendistato’, p. 37), che ‘[d]oveva essere un personaggio straordinario, molto più di Tagliavini’ (ibid., p. 36) – maestro di Glottologia di Meneghello a Padova che aveva scommesso coi propri alunni di ricostruire, partendo da una mezza pagina, nello spazio di un’ora, la grammatica (morfologia e sintassi) di una lingua sconosciuta. Meneghello si sofferma sulla definizione antica di Eratostene che pare fosse chiamato dai colleghi ‘pèntathlos’ come a dire ‘pentatloneta’, per segnalare questa versatilità, e forse per denigrarla. […] In inglese uno che riesce bene in molte cose […] è un all-rounder: dove io non ci sento sottointeso ‘[bravo in tutto] e dunque non supremo in nulla’. Ma ad Alessandria pare proprio che il sottointeso ci sia stato. (‘L’apprendistato’, p. 36) Alle ipotesi sulla filologia come versatilità di conoscenze e applicazione delle stesse, seguono le considerazioni sul lavoro filologico svolto da Eratostene nella sua qualità di direttore, a suo tempo, della Biblioteca di Alessandria ‘editore, recensore e emendatore di testi letterari’ (‘L’apprendistato’, p. 37). Tuttavia permane l’ambiguità del termine con cui si definiva ‘filologo’. Termine ombrello, per Meneghello, che accoglie almeno tre significati: 1) espressione legata al gusto del discorrere; 2) amante del lógos, ovvero più estensivamente ‘dotto’, ‘studioso’; 3) più specificamente e circoscrittamente ‘studioso delle parole […] insomma un linguista’ (ibid.). Le diverse facce della filologia che affascinano Meneghello lo portano ad uno dei suoi tipici scarti logici in conclusione della prima parte del suo testo: Contro le mie tendenze, mi si affaccia l’idea che anche per la filologia ‘it takes all sorts to make a world’, ci vuole gente di ogni risma per fare un mondo, vale a dire il mondo così com’è. Ma nei riposti ventricoli del mio sentimento non ci ho mai creduto del tutto. (‘L’apprendistato’, p. 38) Passa, quindi, ad una riflessione, brillantemente argomentata, sul suo rapporto con la linguistica (‘non mi considero un linguista’, ibid.), soffermandosi sulla sua lingua nativa, non materna (la mamma, friulana, non aveva latte) ma della balia maladense. Il dialetto di Malo è percepito da Meneghello quale ‘lingua del genere umano, gli esseri umani parlavano così, e i loro modi entravano in me, davano forma alle strutture interne (preesistenti, penso) della mia competenza, creavamo circuiti indistruttibili’ (‘L’apprendistato’, p. 38) lingua parlata, pre-logica, del cui apprendimento non aveva coscienza. Accanto, parallelamente, si innesca il processo Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 47 di apprendimento di una sorta di lingua seconda: l’italiano, di origine più artificiosa e innaturale appreso a scuola e sui libri, prevalentemente attraverso la lettura. Una lingua, sia ben chiaro, tutt’altro che nitida e netta a proposito della quale Meneghello si sente in dovere di precisare: veramente c’erano due filoni, quasi due matasse di viscoso tiramolla, schiaffate una sull’altra e annodate in una specie di doppia elica, come si vedeva fare nelle sagre di paese: il filone ufficiale, di stampo aulico e di derivazione letteraria, e il filone reale dell’italiano regionale. Quest’ultimo aleggiava attorno a noi, imparavamo noi stessi a servircene – quando si cercava di parlare in chicchera – e a mano a mano a scriverlo: certamente non ci rendevamo conto che fosse ‘italiano regionale’, la nozione non si era ancora formata o diffusa, e la cosa non sarebbe parsa allora una variante legittima della lingua nazionale. (‘L’apprendistato’, p. 38) La complessità di queste esperienze per lungo tempo non ha dato luogo ad un sistema articolato di idee sulla lingua, questo è potuto avvenire molto più tardi, grazie all’influenza di amici e colleghi incontrati in Inghilterra, parecchi dei quali a Reading, e la menzione silenziosa a Giulio Lepschy in particolare è connotativa del modo in cui Meneghello – si pensi soprattutto ai volumi delle Carte – alluda spesso a persone della sua realtà biografica evitando di farne i nomi, cifra tipica della sua scrittura zibaldonica.17 L’incontro e il confronto con il nuovo mondo culturale inglese, portano Meneghello a riconsiderare la sua precedente visione del proprio rapporto con le lingue: la struttura delle lingue ha subito un rivolgimento radicale, le vecchie impostazioni abolite e cancellate. Questa del nuovo che sopravviene e soppianta l’antico, pare uno schema ricorrente nella mia vita mentale. (‘L’apprendistato’, p. 39) Il punto cruciale della lectio, che lo avvicina pur nella loro diversità a Consolo, è dedicato a sottolineare che il suo vivo interesse per le lingue non riguarda l’analisi teorica delle loro strutture, ma ‘ciò che le lingue che frequentavo recavano con sé, un’immagine intensificata delle cose del mondo’ (ibid.), e questo si verifica soprattutto nella poesia: i poeti lirici in particolare, antichi e moderni, nelle lingue in cui li leggevo, latini, italiani, francesi, e per frammenti anche tedeschi e spagnoli (non inglesi, in principio: quelli sono venuti in seguito, nella mia tarda gioventù, in Inghilterra, ed è stata un po’ una gran 48 Giuliana Adamo mareggiata poetica). In queste scritture percepivo gli effetti di una forza oscura che mi sprofondava nel cuore della realtà: e non pareva rilevante, e nemmeno pertinente, che si trattasse davvero di lingue diverse, era come se fosse una lingua sola. (‘L’apprendistato’, p. 39) La lingua ha risorse infinite per sondare la realtà e Meneghello usa, per fare questo, l’unica lingua che conosce davvero: l’Alto Vicentino, o meglio, la lingua di Malo. Alludendo a Libera nos a malo sottolinea: Si formava in me scrivendo, il quadro naturale di queste varianti, ero in grado di distinguere con spontanea precisione tra questi diversi usi, e intravederne a sprazzi le separate capacità di esplorare, trivellando in profondo il reale. (‘L’apprendistato’, p. 39)18 Nell’ultimo scorcio del testo evoca uno dei temi a lui più cari, quello del lungo apprendistato che lo ha reso in grado di portare ‘ciò che scrivo a pareggiare la potenza di quell’antica esperienza, nei vari settori della vita che mi è capitato di attraversare’ (ibid.). Di grande efficacia retorica, e commovente, è la chiusa della lectio in cui, con un procedimento analogo a quello esperito da Seamus Heaney in ‘Digging’ nella raccolta Death of a Naturalist del 1966, laddove evoca la mano contadina del padre che afferra la vanga per scavare e la propria che impugna la penna per fare altrettanto (vv. 1-5): Between my finger and my thumb The squat pen rests: snug as a gun. Under my window, a clean rasping sound When the spade sinks into gravely ground: My father, digging. I look down per, quindi concludere (vv. 29-31): Between my finger and my thumb The squat pen rests. I’ll dig with it. si istituice un parallelo tra l’apprendistato di Luigi Meneghello scrittore e quello di Cleto Meneghello, suo padre, tornitore: Aveva imparato a tornire da ragazzo a Marano […]. Sui vent’anni era andato a Verona a fare il suo Capolavoro. […] Il capolavoro che gli diedero da fare era una vite senza fine; preparò il pezzo, misurò, ci fece i segnetti che bisogna farci per tornire una vite senza fine, e a Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 49 questo punto il capo che lo stava a guardare aveva già capito che era bravo e disse: ‘Basta così’. (‘L’apprendistato’, p. 40) Segue l’explicit, profetico, dell’ultimo discorso pubblico di Meneghello: Vorrei poter fare anche io così, se ne avrò il tempo, scrivere qualcosa di veramente conclusivo, magari solo una paginetta, o un paio, ma da scrittore finalmente maturo. E che voi, come già a mio padre i suoi esaminatori, mi diceste: ‘Ok, basta così’. (ibid.) Quanto emerso da questa lectio permette di ravvisarvi, analogamente a quanto visto nel caso di Consolo, le trame costitutive dell’intera opera di Meneghello: 1) La prima lingua innata e l’incontro con le altre lingue apprese che ha determinato la sua attività di vita e di scrittura. 2) Il ricordo di Malo – oggetto del suo continuo nóstos – eternato nelle sue opere. 3) La sua vita di perenne apprendista. Tutti elementi che convivono simultaneamente nella sua ultima lectio e in tutti i suoi libri. Cosa, dunque, hanno in comune Consolo (nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, in Sicilia, provincia di Messina e morto a Milano nel Gennaio del 2012) e Meneghello lo scrittore di Malo (nato nel 1922 a Malo, in Veneto, provincia di Vicenza e morto nel 2007 nella vicina Thiene)? Alcune cose più ‘esteriori’ furono indicate dallo stesso Consolo nel ricordo dedicato allo scrittore maladense, suo contributo alla Biografia per immagini su Meneghello, curata da Pietro De Marchi e da chi scrive. Lo riporto qui di seguito: La laurea honoris causa in Filologia moderna, a noi due insieme, a Meneghello e a me, quel giorno di giugno del 2007, là nell’aula magna del Rettorato di Palazzo Steri, in quel trecentesco palazzo che tante ne aveva viste (fu abitato dall’illustre famiglia dei Chiaramonte che l’aveva fatto costruire, fu poi sede vicereale, sede del Santo Uffizio, del tribunale e del carcere della terribile Santa Inquisizione). La laurea, dunque, insieme, a Meneghello e a me. E a me sembrava quel giorno, in quella magnifica aula, davanti al senato accademico e al vasto pubblico, di usurpare il posto di Licisco Magagnato, il Franco di Bausète, che si laureò a Padova nello stesso giorno insieme a Meneghello ed ebbero, i due laureati, insieme un solo ‘papiro’ di laurea ‘a due teste’. Però, quel giorno, mi rassicurava il fatto che Meneghello ed io eravamo gemelli, voglio dire che eravamo nati scrittori nello stesso anno, nel 1963, lui col suo Libera nos a malo ed io con il mio La ferita dell’aprile; e tutti e due ancora con uguale assillo linguistico, 50 Giuliana Adamo l’intrusione, nell’italiano, del vicentino, o meglio della lingua di Malo, ed io del siciliano, vale a dire di tutte le antiche lingue che giacevano nel siciliano. E poi… E poi, eravamo due dispatriati, il Meneghello in Inghilterra, a Reading, ed io nella Milano dei Verri, di Beccaria, di Manzoni, di Verga, di Vittorini… Dispatriati, noi due insomma, in due diverse ‘patrie immaginarie’. Cosa univa ancora, Meneghello e me? A guardare le immagini di quella cerimonia, l’autoironia dipinta sui nostri due volti. Ah, caro Meneghello, che incontro è stato quello con te a Palermo! Primo e ultimo incontro, perché subito, tornato a Thiene, tu sei partito per quel viaggio dal quale non si ritorna più. Ed io ti rimpiango. Tutti ti rimpiangiamo, ma ci confortano però i tuoi libri, tutti i tuoi magnifici libri. Quelli, sì, resteranno sempre con noi.. (Luigi Meneghello. Biografia per immagini, pp. 172-173) L’ironia, tratto assoluto dell’intelligenza, unisce di certo i due scrittori, ed il distacco anche geografico con il conseguente, lungamente reiterato, rispettivo nóstos. Così come il loro essere sempre stati fuori dal coro, spesso a remare contro le patrie tendenze critiche e letterarie (ricordo, per esempio, l’insofferenza di Meneghello per Quasimodo e Ungaretti e pure per Moravia, nonché quella di Consolo nei confronti del – per lui – letterariamente troppo tradizionalista Tomasi da Lampedusa, per l’avanguardista Gruppo 63, e per la maggior parte della nuova narrativa italiana, tra cui spiccava l’avversione per il dialetto posticcio e folklorico di Camilleri). Entrambi fuori, per loro (e nostra) fortuna, dalla logica aberrante del mercato editoriale. Pur in modi diversi entrambi voci contro nel panorama letterario italiano del secondo Novecento. E questo vale, ovviamente e ancor di più, per il problema della ricerca e della definizione della propria lingua di espressione letteraria a cui entrambi hanno dedicato il meglio della loro sapienza e della loro perizia, del loro talento e della loro passione. Tratti questi che li accomunano anche nel loro amore totale per la poesia, per la sua funzione e per la sua libertà espressiva. A questo punto, forzandolo in qualche modo ai fini del mio discorso, vorrei citare Wittgenstein che, nel 1929, in una sua lezione a Cambridge sostiene: ‘So far as facts and propositions are concerned there is only relative value and relative good, relative right’ e ancora: I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 51 This running against the walls of our cage is perfectly absolutely hopeless.19 Meneghello e Consolo si scontrano con lo stesso problema: in che lingua esprimere il mondo ‘possibile’ del proprio narrare? Dal canto suo Meneghello, che si è sempre misurato con la sostanza non univoca dell’esperienza umana cercando di darle una forma espressiva che il più possibile si avvicinasse al vero – anzi che fosse ‘più vera del vero’ – ammette: ‘Con le parole è impossibile essere precisi: non dico difficile, impossibile’ (Le carte III, p. 95). Eppure occorre narrare per capire il mondo, ma come? Risponde: con ‘la lingua nativa che illumina l’andamento delle cose’ (Le carte III, p. 99). Consolo, a sua volta, e analogamente dal suo punto di vista storicofilologico, si confronta con una realtà sfaccettata, plurivoca, composita, contraddittoria – si ricordi la sua visione e il suo tentativo di una resa plurima e dialettica della Storia – e per esprimerla, ritenendo ormai insufficiente e superata la lingua razionale-geometrica-comunicativa di Sciascia e Calvino, crea una lingua espressiva, dove la poesia evoca quello che la lingua italiana ormai ‘massificata’ e fatta scadere dall’abuso dei massmedia non è più in grado di comunicare. Una pulsione analoga muove i due scrittori. I risultati? Sorprendenti in ambo i casi. Sulla lingua di Meneghello critici e linguisti hanno detto tante cose e tra tutte si stagliano le perfette analisi di Giulio Lepschy che in un saggio del 1983,20 a proposito di Libera nos a malo, individua le tre lingue del libro quali: ‘italiano prezioso, italiano popolare, dialetto’, segnalando che ‘il dialetto è usato più per il suo valore espressivo o per la sua crudezza, che per la sua normalità o spontaneità’.21 E alla domanda ‘in che lingua?’ è scritto il libro, Lepschy, in sedi diverse, risponde senza indugi:22 In italiano. Libera nos a malo è un libro ‘italiano’, scritto ‘in italiano’, che appartiene alla cultura italiana (e attraverso ad essa a quella europea e internazionale), e insieme la arricchisce di elementi nuovi e originali.23 Un italiano reso più leggero e antiretorico grazie a quanto imparato nell’apprendistato inglese. Consolo, a cui potrebbero attagliarsi le parole di Lepschy su Meneghello (e a garantirne l’appartenza alla cultura internazionale, basterebbe la lista delle traduzioni delle opere di Consolo in quasi tutte le lingue romanze e in inglese, tedesco, olandese) arriva a forgiarsi una lingua espressiva, barocca (nel senso migliore del termine), 52 Giuliana Adamo ricchissima di citazioni – echi – rimandi che vanno dalla sfera erudita a quella più bassa. Lingua in cui convergono le lingue mediterranee: greco, latino, arabo, spagnolo, le varie parlate siciliane, incluse le lingue delle isole linguistiche (tra cui spicca il dialetto gallo-italico di san Fratello, paesino sui Nebrodi), italiano colto. La ricchezza linguistica consente la realizzazione della scrittura palinsestica di Consolo (per il quale sotto la superficie della propria scrittura ci devono essere i segni più importanti della letteratura di chi ci ha formato. E direi che su questo punto l’analogia con il ricchissimo tessuto narrativo di Meneghello è palese) e la messa a fuoco dell’irriducibile complessità del reale (da qui il suo preferito procedimento stilistico dell’amplificatio: l’accumulatio, soprattutto nominale), nello strenuo tentativo di rendere quello che è stato. La ricerca dei nomi di questo ‘archeologo della lingua’ non è semplice ricordo memoriale, ma attestazione del travaglio e del dolore di quella parola attraverso il male della storia. Rievocazione del tempo e dello spazio della Sicilia perduta attraverso i nomi che non sono segni di un’origine metafisica, ma della materialità del mondo prima della lacerazione, delle ferite, del dolore. Analogamente, Meneghello si è dedicato alla ricerca del recupero ‘archeologico’ di una società e di una cultura conosciute nell’infanzia e nella giovinezza e poi irrimediabilmente perdute. Non si tratta, però, di una rivisitazione della memoria percorsa dalla nostalgia e dalla retorica, ma di una vera e propria ricostruzione di ambienti, frammenti di vita e di cultura che mira a ridisegnare quella realtà attraverso una specie di ricerca antropologica, segnata sempre dal filo dell’ironia. E Consolo, in che lingua scrive? Non usava il dialetto: le espressioni, le parole dialettali sono sempre citazioni. Il suo linguaggio è l’italiano, ma l’italiano di Sicilia. Consolo, insomma, ripercorre la storia di Sicilia, dal Risorgimento all’ascesa del fascismo alla violenza mafiosa contemporanea, servendosi di un italiano costruito su ‘un fasto barocco e un ritmo musicale, con un gusto del dialettismo, del latinismo e dell’ispanismo, che contrastano espressionisticamente con i contenuti spesso tragici e con l’analisi, non sottolineata ma palesata e severa delle ragioni storiche’.24 Dice Consolo: Io non ho cercato di scrivere in siciliano assolutamente, ma vista la superficializzazione della lingua italiana e proprio per un’esigenza di memoria ho cercato la mia lingua che attingeva ai giacimenti linguistici della mia terra che erano affluiti nel dialetto siciliano, che io traducevo in italiano secondo la mia metrica della memoria.25 Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 53 Si potrebbero indicare molte altre aree di tangenza, vicinanza, analogia tra questi due scrittori che, pur diversi e geograficamente lontani, hanno dedicato la loro esistenza a mostrarci l’uno (Meneghello), più ‘antropologicamente’, che nella propria lingua nativa, innata e fondante, ‘le parole sono le cose’; l’altro (Consolo), con più impegno civile e utopia storica, che verrà un tempo in cui con parole nuove e, finalmente vere, perché riscattate dalla parzialità e dalle menzogne a senso univoco della Storia, ‘i nomi saranno riempiti interamente dalle cose.’26 È evidente che per entrambi il binomio etica e scrittura è indissolubile e che per entrambi scrivere sia una funzione del capire per avvicinarsi il più possibile alla realtà, all’unico ‘vero’ e, a questo proposito, grande è il debito nei confronti di Leopardi – di cui entrambi amano il poeta, il prosatore e il filosofo – contratto dai due scrittori. 27 Mi pare che la vicinanza più importante tra Consolo e Meneghello risieda in quella moralità che le parole di Franco Fortini definiscono come una forte e costante ‘tensione a una coerenza di valori e di comportamento’,28 espressa coerentemente e rispettivamente nella loro narrativa originale, coraggiosa, fieramente facente parte per sé stessa contro ogni tipo di omologante dittatura o partigianeria ideologica, letteraria, e del mercato editoriale. Trinity College Dublin Note 1 Ero presente a quella indimenticabile giornata palermitana sia per Consolo (su cui avevo appena finito di curare un volume di saggi), sia per Meneghello sulla cui opera stavo lavorando. Cfr. La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, con prefazione di Giulio Ferroni (San Cesario di Lecce: Manni, 2006) e Volta la carta la ze finia. Luigi Meneghello. Biografia per immagini, a cura di Giuliana Adamo e Pietro De Marchi con curatela iconografica di Giovanni Giovannetti (Milano: Effigie, 2008). 2 Giulio Lepschy, ‘Introduzione’, in Luigi Meneghello, Opere scelte, progetto editoriale e introduzione di Giulio Lepschy, a cura di Francesca Caputo (Milano: Arnoldo Mondadori, 2006), pp.xlv-lxxxiv (p.xlvii). 3 Cfr. Cesare Segre, ‘Libera nos a malo. L’ora del dialetto’, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, Atti del Convegno Internazionale di Studi In un semplice ghiribizzo (Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003), a cura di Giuseppe Barbieri e Francesca Caputo (Vicenza: Terra Ferma, 2005), pp. 23-27 (pp. 23-24). 4 Maria Attanasio, ‘Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10 (2005), 19-30 (p. 24). Ricordo, inoltre, che Consolo, nel solco di una discussione europea, negli anni del suo esordio letterario, circa il destino e la funzione del romanzo storico, ha ripudiato nella sua opera gli intrecci intrattenitori del romanzo tradizionale, ragione per cui, come non si è stancato di rimarcare nei suoi scritti e nei suoi 54 Giuliana Adamo interventi pubblici, scelse di spostare la scrittura dal ‘romanzo’ alla ‘narrazione’, secondo l’accezione datane da Walter Benjamin. Quanto al ripudio della lingua razionale e illuminista, lingua di una speranza ormai perduta irrimediabilmente, esso è motivato dalla mutazione antropologica avvenuta a seguito del boom industriale italiano nel corso degli anni ’50 del Novecento, su cui il Pasolini del saggio ‘Nuove questioni linguistiche’ (1964) ha scritto pagine fondamentali. La scelta poetico-espressiva della lingua letteraria di Consolo era in polemica con il linguaggio comunicativo, omologante, impoverito, tele-stupefacente determinato dall’avvento inarrestabile dei mass media. 5 Vincenzo Consolo, ‘Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano’ in Lectio Magistralis, documento ciclostilato (Palermo: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2007), pp. 23-34 (questo è il mio testo di riferimento): ora in La passion por la lengua: Vincenzo Consolo. Homenajes por sus 75 años, a cura di Irene Romera Pintor (Generalitat Valenciana: Universitat de Valencia, 2008), pp. 29-38. Luigi Meneghello, ‘L’apprendistato’, in Lectio Magistralis, documento ciclostilato (Palermo: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2007), pp. 49-56; ora in Luigi Meneghello. Biografia per immagini, pp. 36-40 (è questa l’edizione a cui faccio riferimento). 6 Consolo alla p. 24 della sua lectio ricorda: ‘Nel 1894 la palermitana Società di Storia Patria pubblica il fascicolo dedicato ad Antonio Veneziano per il terzocentenario della sua morte’ e annota che il bibliotecario della Società era Giuseppe Lodi, a cui si devono le parole riportate nella citazione. 7 I romanzi di Vincenzo Consolo, di cui cito solo le prime edizioni: La ferita dell’aprile (Milano: Mondadori, 1963); Il sorriso dell’ignoto marinaio (Torino: Einaudi, 1976); Lunaria (Torino: Einaudi, 1985); Retablo (Palermo: Sellerio,1987); Nottetempo, casa per casa (Milano: Mondadori, 1992); Lo spasimo di Palermo (Milano: Mondadori, 1998). 8 Leonardo Sciascia, ‘Introduzione’ in Antonio Veneziano, Ottave (Torino: Einaudi, 1967), p. 7. 9 Enrico Testa, Lo stile semplice (Torino: Einaudi, 1997), p. 348. 10 Sulla plurivocità della lingua consoliana d’obbligo il riferimento al saggio di Cesare Segre, ‘La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio’, in Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento (Torino: Einaudi, 1991), pp. 71-86 (p. 83). 11 A proposito della descrizione riportata a testo, alludo di volata alla necessità visiva della scrittura di Consolo che – basti solo pensare a qualche suo titolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio (Antonello da Messina), Lo Spasimo di Palermo (Raffaello), Retablo etc. –, contrae un debito sostanziale e fondante con la pittura analogamente a Meneghello che notoriamente rimase folgorato, all’inizio del suo apprendistato inglese, dal metodo didattico del Warburg Institute su cui ha scritto pagine importanti e sui cui ha ampiamente basato il suo insegnamento e quello del dipartimento di Studi Italiani da lui fondato a Reading. Si veda, inoltre, quanto riportano Giuseppe Barbieri e Ernestina Pellegrini, rispettivamente, alle pp. 191 e pp. 197-202 di Luigi Meneghello. Biografia per immagini. 12 Renato Nisticò, ‘Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo’, Filologia antica e moderna, 4 (1993), 179-223 (p. 182). 13 Sulla salvezza della scrittura, da varie prospettive, si ricordino le parole di Meneghello: ‘la crisi di tutto il mio sistema di idee pre-inglesi, durata decenni, un lungo, interminabile periodo in cui ho dovuto tener duro, hold tight, come un naufrago su uno scoglio: usando ciò che potevo, aggrappandomi a ciò che avevo, per esempio, la prosa di Leopardi’: Luigi Meneghello, Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta, 3 voll. (Milano: Rizzoli, 2001), III, p. 185. E ancora: ‘“Scavi”. Estrarre “salvezza” dallo scrivere […]. È una specie di scavo continuo […]. Vado a scavare in tutto quello che mi è capitato: scavo, butto via e ricomincio, perché sono convinto che in qualche parte là sotto deve esserci quello che cerco, i nuclei del materiale effusivo e il luccichìo delle scorie vetrificate dove si Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 55 vede risplendere, che cosa di preciso? come dirlo?’ (ibid., p. 258). 14 Si confronti con quanto, analogamente, dichiara Meneghello, a proposito dell’autobiografia, nell’intervista concessa a Luca Bernasconi, in Luigi Meneghello. Biografia per immagini, p. 205: ‘Però tutto questo non è fondato sull’idea che ciò che è accaduto a me ha qualche importanza, anzi sono convinto che non ne ha praticamente nessuna per gli altri, se non per me. Ma dentro contiene qualche cosa che non appartiene solo a me e, scrivendo, qualche volta emerge. Quando emerge, allora va bene, ce l’abbiamo fatta; e l’autobiografia è diventata qualche cosa di più e di diverso.’ 15 A questo argomento nel 2002 è stato dedicato un convegno a Parigi, alla Sorbonne Nouvelle, i cui atti si possono leggere nel seguente volume: Vincenzo Consolo. Étique et Écriture a cura di Dominique Budor (Parigi: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007). 16 Su questi aspetti si veda Nisticò, ‘Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo’. 17 Cfr. I seguenti volumi: Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta. Volume I: Anni Sessanta (Milano: Rizzoli, 1999); Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta. Volume II: Anni Settanta (Milano, Rizzoli, 2000). Per il volume III delle Carte si rimanda alla nota 13. 18 Si confrontino Meneghello e Consolo: le operazioni fatte sono diverse ma analoghe. Entrambi scavano nella propria lingua. Meneghello in quella parlata e non scritta del paese natale, nell’ambito storicamente ristretto alla propria esperienza biografica infantile e giovanile a Malo, nei due decenni degli anni ’20- ’40 del Novecento. Consolo, dal canto suo, scava storicamente e socialmente in un contesto storico millenario, secolare per: a) restituire la ricchezza linguistica del passato altrimenti destinata all’oblio; b) per rapportarsi sempre, metaforicamente, al presente. Meneghello: lingua della propria memoria biografica; Consolo: lingua della memoria storica collettiva. Ma la spinta etica a cercare di raccogliere nella loro lingua di espressione quanto di essenziale, di universale sia possibile reperire e tale da travalicare le proprie esperienze individuali è quello che li accomuna nel loro essere due ‘classici’ fuori dal coro. 19 Cfr. Ludwig Wittgenstein, ‘Lecture on Ethics: 1929- 1930’, ora in Ludwig Wittgenstein’s Lecture on Ethics. Introduction, Interpretation and Complete Text, a cura di Valentina Di Lascio, David Levy, Edoardo Zamuner (Macerata: Quodlibet, 2007), p. 42. 20 Sulle lingue di Meneghello, si vedano i lavori di Giulio Lepschy: ‘“dove si parla una lingua che non si scrive”’, in Su/Per Meneghello, a cura di Giulio Lepschy (Milano: Edizioni di Comunità, 1983), pp. 49- 60; ‘Le parole di Mino. Note sul lessico di Libera nos a malo’, in Luigi Meneghello, Il tremaio. Note sull’interazione tra lingua e dialetto nelle scritture letterarie (Bergamo: Lubrina Editore, 1987), pp. 75- 93. 21 Lepschy, ‘“dove si parla una lingua che non si scrive”’, p. 49 e p. 50. 22 Cfr. Giulio Lepschy, ‘In che lingua?’, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, pp. 15-22; ‘Introduzione’, pp.xliii-lxxxiv. 23 Lepschy, ‘In che lingua?’, p. 22 24 Cesare Segre, La letteratura italiana del Novecento (Roma-Bari: Laterza, 2004), p. 92. 25 Vincenzo Consolo, ‘I muri d’Europa’, Estudos Italianos em Portugal, Nova Série, numero a cura di Giovanna Schepisi, 3 (2008), 229-236 (p. 233). 26 Il sorriso dell’ignoto marinaio (Milano: Oscar Mondadori, 2004), p. 114. 27 Cfr. quanto Meneghello dice a proposito di Leopardi nella nota 13. 28 Franco Fortini, Attraverso Pasolini (Torino: Einaudi, 1993), p. 67
The Italianist (2012)
Presentazione del libro Filosofiana, di Vincenzo Consolo racconto tratto dal libro le “Pietre di Pantalica”. Madrid istituto Cervantes. Il 17 di aprile 2008 Presenta: Manuel Gil Esteve (Cattedratico de Filologia Italiana. Universidad Complutense. Partecipano: Renzo Cremante, Cattedratico de Filologia Italiana Director del Fond de Manuscritos de Autores Contemporaneos. Università di Pavia. Salvatore Trovato, Cattedratico de Linguistica Universidad de Catania. Irene Romera Pintor: Professora Titular de Filologia Italiana. Univesidad de Valencia.
Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano
VINCENZO CONSOLO
“Al Señor Antonio Veneziani. Señor mio: dichiaro alla Signoria Vostra, come cristiano, che sono tante le fantasticherie che mi affaticano, che non mi hanno permesso di portare a compimento come volevo questi versi che Le invio, in segno del desiderio che ho di servirla, già che questo mi ha indotto a far vedere così presto i difetti del mio ingegno, fiducioso che l’alto ingegno della Signoria vostra accoglierà le mie scuse e mi animerà affinché in tempi più tranquilli non tralasci di celebrare come potrò il cielo che così tristemente la trattiene su questa terra, dalla quale ci liberi Dio, e la porti in quella dove vive la vostra Celia.
Ad Algeri, il 6 Novembre del 1579 Della Signoria Vostra vero amico e servitore. Miguel de Cervantes”. Questa lettera e le ottave a Antonio Veneziano, che essa accompagna, furono scoperte nel 1914, nella Biblioteca Nazionale di Palermo, dal professore Eugenio Mele. Lettera e versi entrarono quindi nelle Obras completas di Cervantes, a cura di Rodolfo Schevill e Adolfo Bonilla (Madrid, 1914-31). Questi alcuni versi delle Ottave a Antonio Veneziano: “Il cielo, che contempla il vostro ingegno, ha voluto impiegarvi in queste cose, e segue i vostri passi perché aspira a innalzarvi, per Celia, sino al cielo: (…)
Mi sorprende veder che quel divino ciel di Celia nasconde un vero inferno, e che la forza della sua potenza vi abbia costretto a piangere e a pensare”. Chi era Antonio Veneziano a cui Cervantes indirizza quella lettera, piena di formale deferenza ma venata d’ironia, e le Ottave? el 1894 la palermitana Società di Storia Patria pubblica il fascicolo dedicato ad Antonio Veneziano per il 3º centenario della sua morte. Scrive il bibliotecario della Società Giuseppe Lodi: “Di Antonio Veneziano, l’elegantissimo latinista, il più rinomato poeta siciliano del secolo XVI, ricorreva nell’Agosto del 1893 il terzo centenario della morte, avvenuta per lo scoppio di una polveriera, mentr’egli era detenuto entro il forte di Castellamare. La ricorrenza di questo avvenimento non potea lasciarsi passare inosservata da una Società, come la nostra, la quale (…) non trascura, all’occorrenza di tener desti con solenni commemorazioni l’amore e la riverenza per quanti hanno onorato con il loro ingegno e le loro opere questa non infima parte d’Italia, questa nostra prediletta Sicilia”. C’era spesso nei membri di quelle Società o Accademie un po’ di ampollosità, un po’ di retorica. Retorica non vi è invece in uno scienziato, un demopsicologo o etnologo: Giuseppe Pitré. Scrive nel fascicolo: “io imposi a me stesso l’assoluto silenzio sulla sua vita. Me lo imposi, non per manco di ammirazione per l’illustre poeta, ma per la ferma convinzione ch’ebbi sempre, ed ora più che mai ho, delle inesattezze e, lo dico senza reticenze, dei grossi errori che sono stati scritti su di lui”. Grossi errori, come afferma il Pitré, nati dalla leggenda popolare in cui il Veneziano era stato avvolto, a cui venivano attribuite vicende, spesso fantastiche o surreali, e rime che erano spesso di malaccorti epigoni. Un altro scritto del fascicolo è del monrealese canonico Gaetano Millunzi. Che stende la prima documentata biografi a del Veneziano. Il poeta nasce nel 1543 da una ricca famiglia di origine veneziana, come denuncia il cognome, ma che è ben assestata, già dal Quattrocento, in quel di Monreale, all’ombra della gran cattedrale dei re normanni. Il padre, Antonio, mastro notaro della Curia e pretore, ebbe ben tre mogli, un figlio dalla prima moglie, uno dalla seconda, e ben sette dalla terza, di nome Allegranza Azolina. Antonello, detto Antonio dopo la morte del padre, era il terzo di quest’ultima nidiata. Ancora nella prima adolescenza fu mandato a Palermo per studiare nel collegio dei Gesuiti, quindi a Messina e infine a Roma. È un periodo, questo del Veneziano, di severi studi: di filosofia e teologia, di lingua e letteratura italiana, latina, greca, ebraica. Nel Collegio Romano ha come professore Francesco Toleto, il quale, oltre a insegnare la filosofi a tomista, inizia gli allievi agli studi di giurisprudenza. Studi che saranno utili al Veneziano quando, lasciata la Compagnia di Gesù, ritorna a Monreale e inizia tutta una serie di cause civili contro fratelli e parenti per la divisione della roba, dell’eredità paterna; e cause penali perché accusato non solo dell’omicidio di un tal Polizzi, ma anche del rapimento di Franceschella Porretta, serva della terziaria domenicana suor Eufrigenia Diana. Per questo rapimento la madre lo disereda perché “figlio disubbidiente”, come scrive nel testamento. “Violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti, incostante negli affetti famigliari e negli amori, assolutamente sprovvisto di rispetto per le istituzioni e per gli uomini che le rappresentano”. Scrive del Veneziano Leonardo Sciascia1. E pensa Sciascia, che questo carattere, questo maledettismo del poeta siano stati una reazione alle costrizioni dell’educazione gesuitica. E, malgrado il carattere e la mala condotta, scrive, scrive, il Veneziano, scrive poesie in siciliano, in latino, in spagnolo, prose e composizioni in versi per gli archi di trionfo in onore dei vari viceré che s’installano a Palermo. Ma scrive anche satire contro gli stessi viceré, contro il potere politico, satire anonime
affisse sui muri. Sospettato quale autore di una di queste satire, un cartello, “appizzato alla cantonera di don Pietro Pizzinga allo piano delli Bologni”, contro il viceré conte di Albadeliste, definito uomo “fatale”, vale a dire jettatore, fi nisce nel carcere di Castellamare. Nell’educazione presso i Gesuiti, nell’accusa di omicidio, nella cultura e nelle composizioni poetiche per gli archi di trionfo, nel 1 Sciascia, L. (1967): “Introduzione a Antonio Veneziano”, Ottave, Einaudi: Milano. continuo assillo per le difficoltà economiche, nei disordini della famiglia paterna, nella varie incarcerazioni infine, non possiamo non vedere una curiosa specularità tra la vita di Cervantes e quella di Antonio Veneziano. Specularità che poi diviene immedesimazione nella comune condizione di schiavi nei bagni di Algeri. Il 1574 è l’anno in cui il Veneziano fa donazione di tutti i suoi beni ad Eufemia de Calogero, figlia di sua sorella Vincenza, la quale Eufemia è obbligata per contratto e rimanere nubile e a non farsi monaca. Questa donazione ha fatto sorgere il sospetto che ad Eufemia, la nipote, fossero indirizzate canzoni d’amore della Celia, che fosse insomma, quella di Veneziano, una passione disdicevole, vergognosa. Canta:
“Donna d’auti biddizzi fatta ‘n Celu,
mandata pri ricchezza e gloria in terra,
cu l’occhi toi lu diu di l’aureu telu
fa quasi all’universu ingiuria e guerra;
si sa quanta npi tia m’ardu e querelu,
tempra, si poi, st’arduri chi m’atterra,
ch’in tanta estrema dogghia, affannu e jelu
non dura lungamente omo di terra”.
Il 25 aprile 1578, Veneziano s’imbarca a Palermo sulla galea Sant’Angelo, al seguito di don Carlo d’Aragona, imbarcato a sua volta sulla galea detta Capitana. Al largo di Capri, vengono assalite, le due navi, da galee corsare. La Capitana riesce a fuggire, la Sant’Angelo viene bloccata dai corsari. “Gagliardamente si combatte con mortalità d’entrambe le parti, ma arrivate dopo l’altre da fianchi, dandoli un terribile assalto di saette, e d’archibugiate, furono astretti li difensori a buttare l’armi, a rendersi vivi”. Scrive il monaco cassinese Giovanni Tornamira. Antonio Veneziano viene dunque preso, insieme ad altri, chierici e frati soprattutto, e portato schiavo in Algeri. “Cervantes si trovava schiavo in Algeri da tre anni. Può darsi avesse già conosciuto il Veneziano durante il suo soggiorno a Palermo, nel 1574; certo è che ad Algeri si trovarono (o si ritrovarono) e che tra loro nacque una qualche dimestichezza e un rapporto di reciproca estimazione letteraria, se non di amicizia”. Scrive ancora Sciascia. Ne La nenia così lamenta il Veneziano: “…
l’alma in Sicilia,
già temp’è cattiva,
in manu de la diva,
cinta di forti amurusa catina,
… e lu corpu in Algeri,
fattu di genti barbara suggettu
chì, di lu gran rispettu
di stà partenza e di gran pinseri
acerbamente offi su
era lu cori esanimatu estisu”.
“Ai primi di settembre (1575) Cervantes, soldato aventajado (scelto), s’imbarca a Napoli sulla galera El Sol. Comandata da don Gaspar Pedro de Villena, questa era una delle quattro navi costituenti la piccola fl otta agli ordini di don Sancho de Leiva, che si disponevano a fare rotta per Barcellona (…) Assieme a Miguel, salgono a bordo, oltre al fratello Rodrigo e a qualche loro amico, diverse personalità di rilievo. (…) In capo a qualche giorno la tempesta disperde le galere. Tre di esse riusciranno infi ne ad arrivare in porto; ma l’ultima, El Sol, sarà sorpresa dai corsari barbareschi, e i suoi passeggeri condotti come prigionieri ad Algeri”. Così racconta Jean Canavaggio2 in Cervantes. In questo assalto dei corsari avrà provato, il futuro autore del Don Chisciotte, le stesse ansie, le stesse paure dell’archibugiere Miguel de Cervantes imbarcato sulla Marquesa in quel 7 ottobre del 1571; ma avrà dimostrato lo stesso coraggio, coraggio che allora, nella battaglia di Lepanto, gli costò la perdita della mano sinistra. Sulla mano perduta, così risponderà al falso Avellaneda, l’autore della seconda parte apocrifa del Don Chisciotte, il quale l’accusa d’essere vecchio e monco e quindi incapace di scrivere la seconda parte del suo romanzo: “Ciò di cui non ho potuto fare a meno di dolermi è che mi si accusi d’esser vecchio e monco, come se fosse stato in mio po-
2 CANAVAGGIO, J. (1986): Cervantes, biographie, Mazarine: Paris.
tere fermare il tempo perché non passasse per me, o come se l’esser monco, mi fosse stato cagionato in qualche bettola e non nella più illustre battaglia che abbiano visto i secoli passati e i presenti…”. È il rinnegato albanese Arnaut Mami che porta schiavo in Algeri Cervantes e i suoi compagni. Miguel ha solo ventotto anni quando è portato in catene ai bagni. Ci dice, Cervantes, di questa sua cattività durata cinque anni, nel racconto del Prigioniero nella prima parte del Don Chisciotte, nelle commedie La vita ad Algeri e I bagni di Algeri. Ma una notizia della prigionia di Cervantes ce la dà l’inquisitore di Sicilia, e quindi arcivescovo di Palermo e presidente del Regno di Sicilia, Diego de Haedo, autore della Topographia e Historia general de Argel (Valladolid, 1612). L’Haedo, raccogliendo notizie dagli schiavi cristiani riscattati, ci racconta tutto su Algeri, sui corsari, sui cristiani là prigionieri. Nel Dialogo secundo, il prigioniero capitan Geronimo Ramirez racconta al dottor Sosa del fallito tentativo di fuga da Algeri di Cervantes per il tradimento di un rinnegato di Melilla soprannominato El Dorador, dice che i turchi presero tutti i cristiani che stavano per fuggire, “y particolarmente a Miguel Cervantes, un hidalgo principal de Halcalà Henares, que fuera el autor deste negozio y era portanto mas culpado…”. Avrebbe dovuto essere punito, il nostro don Miguel, ma, ci racconta ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Hassan Agà (il Saavedra) non lo bastonò mai, e neanche gli rivolse mai parole offensive; noi temevamo che sarebbe stato impalato ad ognuno dei suoi tentativi di fuga, cosa di cui lui stesso ebbe paura più di una volta”. E ci racconta ancora Diego de Haedo di Cervantes schiavo di Dali Mami, detto El Cojo, lo zoppo, quindi di Ramadan Pascià e infine del terribile Hassan Agà, un rinnegato veneziano che divenne re di Algeri. Nell’aprile del 1578, quando Antonio Veneziano finisce nel bagno di Algeri, Cervantes è appena uscito dal quarto fallimento di evasione dalla prigione per la delazione del prete rinnegato Juan Blasco. Si conoscono là i due, Cervantes e Veneziano, o si riconoscono dopo il loro primo incontro a Palermo? I due, in carcere, ascoltano la cantilena in sabir, la lingua franca del Mediterraneo, che i ragazzi mori cantavano sotto le finestre dei bagni.
“Non rescatar, non fugir
Don Juan no venir
acà morir…”.
Cantilena riportata da Cervantes in Vita ad Algeri e ne I bagni di Algeri. Tutti e due avranno avuto catene alle caviglie e saranno stati vestiti allo stesso modo, il modo come Cervantes descrive il Prigioniero che entra con Zoraide nella locanda, “… il quale mostrava dagli abiti d’essere un cristiano giunto recentemente da terra di mori, perché era vestito d’una casacca di panno turchino, a falde corte, con mezze maniche e senza collo; anche i calzoni erano di tela turchina, e il berretto dello stesso colore”. Antonio Veneziano giunge in Algeri infiammato d’amore, pazzo d’amore: per la nipote Eufemia o per una bella e irraggiungibile signora? Signora che sarebbe stata, secondo gli studiosi Caterina e Giuseppe Sulli (Antonio Veneziano, Palermo, 1982), Felice Orsini Colonna, moglie di Marc’Antonio Colonna, il comandante della fl otta veneziana nella battaglia di Lepanto, allora viceré di Sicilia, al cui figlio, Ascanio, Cervantes, dedica La Galatea. Ad avanzare l’ipotesi della passione del Veneziano verso la viceregina c’è una ottava del poeta che così termina:
“Pirchi’ mi tratti comu li ‘nnimici?
Rimedia cu lu meghiu modu c’hai,
Filici, fi licissima, Filici”.
Là, nel bagno di Algeri, il Veneziano avrebbe scritto La Celia. E là, nel bagno, sembra che Cervantes abbia scritto Vita ad Algeri e incominciato la stesura de La Galatea. Inimmaginabili sono gli incroci della storia, nonché della poesia. Nel 1650, un gruppo di nobili siciliani congiurava contro il viceré don Giovanni d’Austria, vagheggiando di porre sul trono di un regno indipendente di Sicilia don Giuseppe Branciforti, conte di Mazarino e principe di Butera. La congiura falliva per la delazione del prete Simone Rao e per la confessione dello stesso Branciforti. Sei dei congiurati furono giustiziati. Il Branciforti lasciava quindi Palermo e si ritirava a Bagheria, tra la fenicia Sòlunto e la greca Imera, si faceva là costruire una villa e si chiudeva in quella sua dimora che era fortezza, castello, tomba non di libri e di salme come l’Escorial, ma di orgoglio umiliato e di rimorso. Sull’arco d’ingresso della villa faceva incidere un emistichio del Tasso, O corte a Dio, e oltre, sopra un altro arco, questi versi in spagnolo:
“Ya la esperanza es perdida
Y un solo bien me consuela
Que el tiempo que pasa y buela
Lleverà presto la vida”.
E sono i versi questi che recita Teolinda nel Libro primo de La Galatea di Cervantes. Ma ritorniamo al bagno di Algeri, ai due poeti là rinchiusi, Cervantes e Veneziano. Il monrealese, preso com’è dal “vendaval erótico”, come lo defi nisce Américo Castro, dalla bufera d’amore per la nipote Eufemia o per Felice Orsini, scrive là La Celia, e Cervantes (anche lui forse in quel momento nella bufera d’amore, se nel personaggio di Lauso de La Galatea dobbiamo riconoscere lo stesso autore), e Cervantes scrive là le Ottave per Antonio Veneziano. Veneziano viene riscattato nel 1579, e il cronista Ortolani così scrive:
“Fu fatta festa in Palermu pillu ricattu e ritornu di lu celebri
poeta Veneziano”.
Morirà poi, il povero poeta, il 19 agosto 1593, come sappiamo, per l’incendio (doloso, sembra) e lo scoppio della polveriera nel carcere di Castellamare. E morirà, in quello scoppio, anche Egisto Giuffredi, l’autore di Avvertimenti cristiani. Cervantes, riscattato, lasciava Algeri il 24 ottobre 1580. Dice ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Non c’è sulla terra, secondo il mio parere, gioia che eguagli quella di conseguire la libertà perduta”. E sarà, quella di Cervantes, una vita libera, ma, come quella di prima della prigionia in Algeri, una vita molto tribolata. Nulla però gli impedirà di concepire (nel carcere di Siviglia o in quello di Castro del Rio -1592) e di scrivere quindi le avventure dell’ingegnoso hidalgo, di don Alonso Quijana, ribattezzatosi Don Chisciotte della Mancia, e del suo fi do scudiero Sancio Panza. Don Chisciotte, il primo grande romanzo della storia letteraria, uno dei grandi capolavori dell’umanità. Nel 2005 ricorreva il quarto centenario della prima pubblicazione del romanzo. E, nell’aprile di quell’anno, ad Alcalà de Henares, nella casa natale-museo di Cervantes, si inaugurava la mostra delle prime edizioni del Quijote, in cui compariva l’edizione del 1610, stampata a Milano “por el Heredero de Pedromartir Locarni y Juan Bautista Bidello”, e dedicata dal Cervantes, questa edizione, non più al conte di Bejar, ma “All’Ill.mo Señor el Sig. Conde Vitaliano Vizconde”. Abbiamo voluto sin qui raccontare della prigionia in Algeri di due poeti, Cervantes e Veneziano. Ma abbiamo anche voluto signifi care, soprattutto attraverso Cervantes, la terribile vita che si svolgeva allora, nel ‘500, tra le sponde del Mediterraneo, in questo spazio dove si svolge il grande poema omerico e dove sono nate le prime grandi civiltà della storia umana. Terribile vita allora, nel ‘500, tra le sponde del Mediterraneo. E terribile di nuovo oggi, dopo cinque secoli, per le tragedie quasi quotidiane che tra queste sponde si consumano. Tragedie di poveri infelici che fuggono da luoghi di guerra, di malattia e di fame e che cercano salvezza in questo nostro mondo di opulenza e di alienazione. Infelici che spesso trovano la morte per acqua, come l’eliotiano Phlebas il Fenicio, naufragano presso le sponde di Sicilia e di Spagna. E con dolore dunque possiamo ripetere le parole di Fernand Braudel, riferite all’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari
03/11/2005 – La prigione dei destini incrociati: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano nei bagni di Algeri
Instituto Cervantes Napoli
14/04/2008 Universitat de Valencia. Spagna.La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO
Antonio Veneziano e Miguel de Cervantes


Quanto ci mancano la penna e la spada di Sciascia.
di Vincenzo Consolo
«Chi sei?» domanda Danilo Dolci a Leonardo Sciascia durante il dibattito tenutosi al Circolo Culturale di Palermo il 15 aprile 1965. E Sciascia risponde: <<Sono un maestro delle elementari che si è messo a scrivere libri. Forse perché non riuscivo ad essere un buon maestro delle elementari. Questa può essere una battuta, ma per me è una cosa seria>>.
No, non è una battuta, perché sappiamo dalle sue Cronache scolastiche, pubblicate nel1955 nel numero 12 di “Nuovi Argomenti”, la malinconia, la pena, lo smarrimento e l’indignazione per le condizioni di quei suoi alunni di 5″ elementare, alunni poveri, figli di contadini e zolfatari. Pena e indignazione per le condizioni di Racalmuto, della Sicilia di allora e di sempre, sfruttata e umiliata dai “galantuomini”, oppressa dalla mafia. Inadeguato, incisivo, come si sente, nell’ insegnare, si mette a scrivere (ma Sciascia aveva già pubblicato, le Favole della dittatura nel 1950 e La Sicilia, il suo cuore nel 1952) e scrivere per lui, impugnare la penna, è come impugnare la spada, L’affilata, lucida e luminosa spada della ragione per dire, denunciare e quindi combattere i mali della società, le ingiustizie, le offese all’uomo, alla sua dignità. Aveva scritto Sciascia, nella premessa a Le parrocchie di Regalpetra, pubblicato nel 1956, parlando del suo paese, di Racalmuto: <<La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso. Paolo Luigi Courier vignaiolo della Turenna e membro della legion d’onore, sapeva dare colpi di penna che erano colpi di spada; mi piacerebbe avere il polso di Paolo Luigi per dare qualche buon colpo di penna.,.>>, e ribadisce, nella conversazione con Dolci: «Io concepisco la letteratura come una buona azione. Il mio ideale letterario, la mia bibbia è Courier, l’autore dei libelli. Courier definì il libello una buona azione.,.>>. Anch’io <<in effetti non ho scritto che libelli». Il libello o pamphlet. E siamo nel ’65, quando già Sciascia aveva pubblicato vari libri di narrativa, fra cui Gli zii di Sicilia, Morte dell’inquisitore, Il giorno della civetta, Il consiglio d’Egitto. Ma libello, dice, nel senso di buona azione, di impegno civile, vale a dire, sia in campo narrativo che in campo saggistico o giornalistico. Dice, ancora in quell’incontro con Dolci: <<Ho scritto libri di storia locale, in un certo modo, nel tentativo di raggiungere un pubblico anche popolare. Cosa che parzialmente mi è riuscita. E il mio impegno – ormai è diventato quasi ridicolo palare di impegno – ma io continuo a ritenermi uno scrittore impegnato. Perché fin quando c’è una realtà che si deve mutare, pena proprio la morte, come il caso nostro della Sicilia, io ritengo che esiste l’impegno dello scrittore>>. Scrittura narrativa, dunque, e scrittura libellistica, e scrittura saggistica e scrittura. giornalistica. E in tutte le scritture Sciascia ha come principio, come cifra stilistica la chiarezza. <<Il problema della chiarezza è per me come se lo può porre un giornalista, non come se lo può porre un letterato>>. E qui, in tema di chiarezza, di scrittura chiara ed estremamente comunicativa, siamo nel problema dello stile. Scrive Roland Barthes ne Il grado zero della scrittura: <<Lo sconfinare dei fatti politici e sociali nel campo di coscienza della letteratura. ha prodotto un nuovo tipo, diciamo, di scrittore situato a metà strada tra il militante e lo scrittore vero e proprio (…) Nel momento in cui l’intellettuale si sostituisce allo scrittore, nelle riviste e nei saggi nasce una scrittura militante interamente liberata dallo stile e che è come il linguaggio professionale della “presenza”>>. E ancora: «Nelle scritture intellettuali si tratta di scritture etiche, in cui la coscienza di chi scrive trova
l’immagine confortante di una salvezza collettiva.
Ora, crediamo che la distinzione barthesiana tra scrittore e intellettuale la si possa applicare a tanti scrittori, a partire dall’ Émile Zola del caso Dreyfus, ma nel caso di Sciascia non è possibile vedere quella dicotomia. Perché in Sicilia, in Italia, i fatti politici e sociali sconfinano con una tale irruenza, costanza e urgenza nella coscienza della letteratura che non è più possibile, per uno scrittore come Sciascia, praticare una lingua, uno stile per la scrittura narrativa e un altro per la scrittura di “presenza” o militante. <<Sono le grandi cose da dire che fanno la lingua>> afferma Sciascia. E anche; «Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono>>. La ragione che dalla buia miniera di Racalmuto, dalla Sicilia, lo porta alla luce di quella regione, di quella città dove la lingua ha avuto la sua più alta e limpida declinazione, a quelle rive dell’Arno in cui Manzoni volle sciacquare i panni. Manzoni fino ai rondisti. «Debbo confessare che proprio dagli scrittori “rondisti” – Savarese, Cecchi, Barilli – ho imparato a scrivere. E per quanto i miei intendimenti siano maturati in tutt’altra direzione, anche intimamente in me restano tracce di tale esercizio>> scrive il Nostro nella prefazione alla seconda edizione del’67 delle parrocchie di Regalpetra. La fiorentina lingua dei rondisti, sì, ma scavalcando poi le Alpi e trovando più robusta consistenza in quella lingua “geometrizzata”, come la definisce Leopardi, che è il francese, la lingua dei suoi illuministi, degli amati Diderot, Voltaire e Courier, la lingua del suo “adorabile” Stendhal. Scrive Italo Calvino a Sciascia, in data 26 ottobre 1964 (la lettera è pubblicata nel numero 77 della rivista francese “LArc”, dedicato a Sciascia): <<Tu sei molto più rigoroso “filosofo” di me, le tue opere hanno un carattere di battaglia civile che le mie non hanno mai avuto, esse hanno una univocità che è loro propria nel pieno del pamphlet. (…) Ma tu hai, dietro di te, il relativismo di Pirandello, e Gogol tramite Brancati, e, continuamente tenuta presente, la continuità Spagna-Sicilia, Una serie di cariche esplosive sotto i pilastri dello spirito filosofico. Io m’aspetto sempre che tu dia fuoco alle polveri, le polveri tragico-barocco-grottesche che tu hai accumulato”. E questo potrà difficilmente prodursi senza una esplosione formale, della levigatezza della tua scrittura>>. Ma mai e poi mai Sciascia avrebbe dato fuoco alle polveri, avrebbe fatto esplodere il suo stile, la sua lingua illuministico-comunicativa. Poiché polveri, esplosioni e tragici continui crolli, caligini e disordini erano già nella realtà storicosociale della Sicilia, dell’Italia; libertà e giustizia erano in quelle realtà continuamente offese, offeso era il cittadino, l’uomo nei suoi diritti, nella sua dignità. E allora Sciascia, tagliente penna-spada, con quella limpida, luminosa lingua “geometrizzata” scrisse i suoi romanzi, racconti. pamphlet, articoli di giornale, con la barthesiana scrittura di “presenza” o militante. I fatti poi, i fatti siciliani, italiani erano (e, ahinoi, sono tuttavia, direbbe Manzoni) così gravi e urgenti da spingere Sciascia a scrivere, a intervenire sulle pagine dei giornali, a spingerlo a dire, a denunziare, a indicare là dove un male civile era in atto o avrebbe potuto manifestarsi. Ma in lui gli intellettuali giornalistici erano anche occasione di ripercorrere la storia, rivisitare episodi, indicare personaggi, libri, autori che quegli episodi ci fanno capire, di cui ci indicano la soluzione. Già, da anni lontani. dalla metà degli anni Quaranta, Sciascia comincia a scrivere sui “giornali, sulla “Sicilia del Popolo” e quindi sul ‘Corriere del Ticino”. la “Gazzetta del Mezzogiorno”. sul “Corriere della Sera”. “La Stampa”, oltre che su varie riviste italiane e straniere. Ma il suo rapporto più assiduo, costante e direi più connaturale, è stato con il giornale “L’Ora”.
Inizia nel 1955) con un articolo su Micio Tempio, la collaborazione se pure saltuaria, con quel glorioso giornale di frontiera. Ma è dal ’64 al ’67 che Sciascia tiene sul quel giornale la rubrica settimanale “Quaderno”. E il nuovo direttore del giornale, Vittorio Nisticò. approdato a Palermo nel 1955, per restare alla direzione di quel giornale fino al ’75, a invitare Sciascia, tramite Gino Cortese e Mario Farinella. A collaborare col giornale. E lo farà, Sciascia, fino agli ultimi suoi anni, fino a dettare alla figlia, poco prima di morire, una nota su Giuseppe Antonio Borgese. La grande firma di Sciascia si affiancava nella gloriosa storia dell’ “Ora”, Fondato nel 1900 da Ignazio Florio e diretto da Vincenzo Morello (Rastignac), a quella di Verga, Capuana, Borgese, Rosso di San Secondo, Serao, Scarfoglio, Brocca, Di Giacomo, Guglielminetti, Ojetti; e, alla grande firma di Sciascia, si affiancavano firme di scrittori e intellettuali a lui vicini: Guttuso, Caruso, Addamo, Renda, Marck Smith, Sapegno, Sanguineti, Lanza Tomasi, Franco Grasso, Dolci, Giarrizzo, Pantaleone, lo stesso che qui vi parla, ed altri ed altri ancora: per non dire di intellettuali entrati come giornalisti a “L’Ora”: Farinella, Cimino, Saladino. Perriera, Nicastro e altri. Il rapporto più stretto, più assiduo di Sciascia con “L’Ora” è stato, come dicevo, attraverso la rubrica settimanale “Quaderno”, che va dal 24 ottobre 1964 al 27 giugno 1967. Rubrica poi raccolta in volume, pubblicato nel ’91 dalla stessa editrice “L’Ora”. Nella introduzione da me scritta per quel volume, definivo Sciascia “scrittore di pensiero”, in contrapposizione a quello scrittore di sentimento che era Verga. E l’uno e l’altro quindi, con due visioni del mondo e con due stili, con due lingue diverse: l’uno, ripetiamo, con una chiara ed estremamente comunicativa lingua centrale” o illuministica; l’altro con un italiano “irradiato di dialettalità”, come l’ha definito Pasolini. L’uno con una lingua articolata, dialettica; l’altro con una lingua chiusa, circolare, come di versetti biblici o sure del Corano. E cosa più importante, dietro Sciascia e Verga vi erano due biblioteche. Dietro Sciascia vi furono quei dieci importanti libri in cui s’imbattè nella sua infanzia, e quindi la sterminata biblioteca del suo vasto, inesauribile sapere. Per cui la lineare chiara scrittura di Sciascia, aveva in sé delle vaste e profonde risonanze; era la sua, in modo esplicito o implicito una scrittura palinsestica (di riscrittura egli parlava). In Verga, invece, non c’era nessuna biblioteca (ci poteva essere, sì, Zola o Flaubert), c’era solo in luì la memoria di Acitrezza o di Vizzini, la memoria dei proverbi e dei modi di dire siciliani che egli traduceva appena, in italiano.
La Spagna, innanzitutto. La Francia, abbiamo detto, nel pensiero, ma, com’egli ha scritto, <<La Spagna nel cuore>>. La Spagna della Guerra civile, la Spagna di Cervantes e di Unamuno, quella dei poeti della generazione del ’27, antologizzati da Gerardo Diego, di Lorca, di Alberti, di Guillén, Cernuda. Machado, Salinas, Aleixandre, Alonso .,. La Spagna di Manuel Azana, l’ultimo presidente della repubblica spagnola, l’autore de La veglia a Benicarlò, che Sciascia aveva tradotto e introdotto per Einaudi. La Spagna ancora di Hemingwy e di Malraux, della città martire di Guernica e di Picasso dell’architetto Gaudì e di Robert Capa, della sconfitta dell’esercito fascista italiano a Gudalajara. Spagna e quanto di Spagna, attraverso lo schema del grande storico Américo Castro, è rimasto in Sicilia. Rimasto nelIa sua storia, nei costumi, nel modo di essere. Rimasto in quell’atroce fenomeno dell’lnquisizione. Inquisizione che è sì quella del Santo Uffizio a Palermo, del suo carcere qui. in questo palazzo dello Steri, dei messaggi degli inquisiti, dei Palinsesti del carcere. Quella Spagna e quella Sicilia di dolore e di orrore da cui sono scaturiti i racconti L’antimonio, Morte all’inquisitore, il Consiglio D’Egitto. Si chiude sì il Santo Uffizio a Palermo e il suo carcere, il giorno 27 marzo 1782, viene abbattuto l’orribile mostro”, come scrive il marchese Caracciolo al suo amico d’Alambert, ma le inquisizioni e le carceri continuano in Italia e nel mondo, là dove impera il “sonno della ragione” e si commettono ludibri, oscene vergognose violenze di uomini contro altri uomini, Di questo parlano, per esempio, le pareti delle carceri naziste o staliniste le carceri di via Tasso a Roma, così le pareti delle carceri argentine o cilene o greche, delle dittature dei colonnelli o di Pinochet; così oggi, e ancora con maggior ludibrio palano le pareti delle carceri americane in Iraq, di Abu Ghraib e quelle di Guantanamo. E, a proposito dell’Inquisizione a Palermo, Sciascia scrive ancora sul “Quaderno” del 21 novembre 1964: << II 19 agosto del 1953 incappò foco a due dammusi di polveri» nel castello a mare di Palermo: <<et essendo vicine le carceri, tutte le scacciò>>. Tra quei prigionieri di Castellamare perirono Argisto Giuffredi, autore di quel libretto (che precorre Beccaria) contro la tortura e la pena di morte intitolato Avvertimenti Cristiani, e il poeta Antonio Veneziano, che, nei bagni di Algeri, aveva conosciuto e stretto amicizia con Cervantes.
Tanti, tanti sono i tempi svolti da Sciascia in quei 125 articoli, scritti trai,’64 eil’67 per il “Quaderno”. Articoli che prendono spunto di volta in volta da fatti di cronaca – di mafia soprattutto -, da letture, viaggi, incontri, accadimenti politici, polemiche. Fra queste ultime vogliamo ricordare quella del 21 febbraio col giornalista dell’“Avanti!” Fidia Sassano. Il quale rimproverava a Sciascia di essere pessimista nei confronti del futuro della Sicilia, nonostante la miracolosa scoperta del petrolio in Sicilia, la presenza del “colosso europeo” del petrolchimico di Priolo, Melilli, Gela. E, dice Sassano a Sciascia: <<Questi benedetti letterati!». Ma benedetto letterato non era Sciascia allora, lo è stato invece, e ci dispiace dirlo, Vittorini, che in quel “petrolio siciliano” aveva visto il risveglio e il riscatto dei siciliani ed era stato indotto a scrivere Le città del mondo, uscito postumo. Del disastro, dello sfacelo di quell’utopia industriale che era stato il petrolio siciliano, Sciascia ne vede, profeticamente, il fallimento, così come profeticamente vede il fallimento del Psi, il Partito socialista italiano, cui Fidia Sassano appartiene. Quel partito socialista che alla sua fine, come frutto avvelenato, ci avrebbe lasciato in eredità un uomo e un partito: Berlusconi e Forza Italia, del cui potere o strapotere tutti soffriamo e di cui ci vergogniamo. Scriveva Sciascia: <<Sassano appartiene a quella categoria di socialisti che io chiamo soddisfatti: talmente soddisfatti che dalle loro soddisfatte viscere si possono trarre auspici non del tutto rassicuranti per il nostro immediato e lontano avvenire >>. Potrei ancora dire d’altri temi e d’altri spunti. Dire che questo illuminista interviene sempre là dove la ragione è offuscata, la libertà conculcata, il cittadino, l’uomo offeso. Ed è certo che la sua “conversazione” sempre dalla Sicilia parte e alla Sicilia si riduce, a quest’isola che duole al siciliano Sciascia, a questa regione in cui i siciliani onesti si ritrovano sempre “con la faccia per terra”, quei siciliani di “alta dignità e di tenace concetto” che non hanno meritato tutti i malgoverni locali e nazionali del passato, non meritano quelli nefasti e vergognosi di oggi, a Palermo e a Roma. Ci è mancato dal 1989 e ci manca ancora oggi e ogni giorno di più uno scrittore e un intellettuale come Leonardo Sciascia. Ci manca la sua penna, la sua spada. Come ci è mancata e ci manca quella di un suo confrère, di Pier Paolo Pasolini, il Pasolini delle Lucciole, del Palazzo, il Pasolini corsaro e luterano. Luterano come Sciascia, come pochi altri in questo Paese segnato da sempre da viltà e conformismo. Nel deserto e nella malinconia di questo nostro attuale Paese, di questo nostro contesto occidentale, ci conforta sapere che è stato qui con noi, per noi, un uomo come Leonardo Sciascia. Ci conforta sapere che possiamo tornare a rileggere le sue forti e luminose parole.
da Kalos “Sciascia il romanzo quotidiano”
2005 Gruppo editoriale Kalos