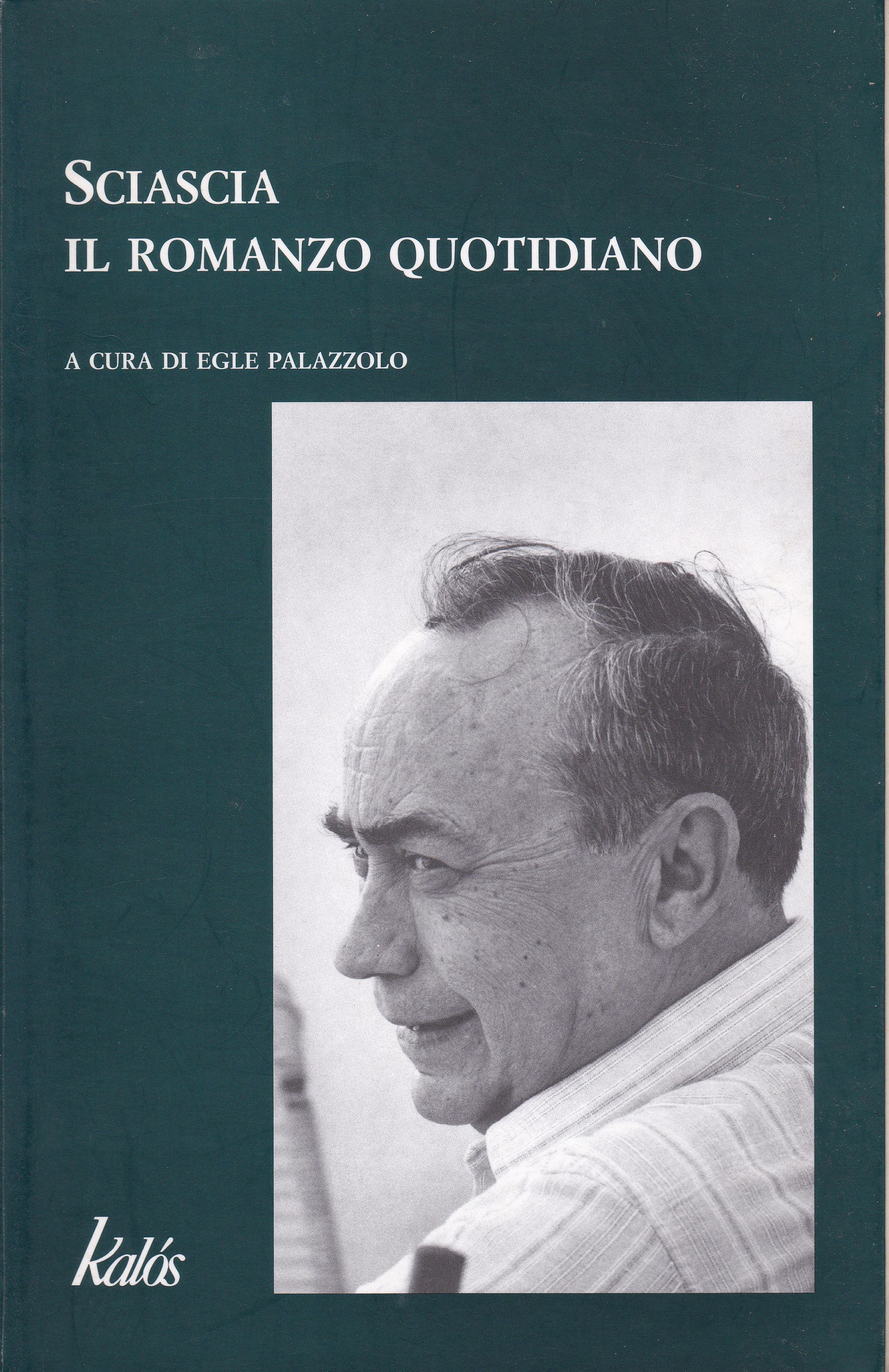*
Vincenzo Consolo, Cosa Loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010,
a c. di Nicolò Messina, Milano, Bompiani, 2017, pp. 315. Nel mantenere la visibilità di Vincenzo Consolo dopo la sua morte avvenuta nel 2012, il curatore del presente volume, Nicolò Messina, ha avuto un ruolo importante, anche grazie a La mia isola è Las Vegas (Milano, Mondadori, 2012), organica sistemazione di brevi scritti, racconti li chiamava lo scrittore (tra cui alcuni preziosi inediti), che coprono un arco di più di cinquant’anni. Un rapido censimento dei testi consoliani, pubblicati dopo il 2012, non può naturalmente prescindere dal Meridiano (L’opera completa, Milano, Mondadori, 2015) curato da Gianni Turchetta e con uno scritto di Cesare Segre. Ma vanno comunque citati anche gli Esercizi di cronaca, una raccolta di articoli pubblicati su L’Ora di Palermo, a cura di Salvatore Grassia, con prefazione di Salvatore Silvano Nigro (Palermo, Sellerio, 2013); gli Accordi, versi inediti, a cura di Claudio Masetta Milone (Sant’Agata di Militello, Zuccarello, 2015) e sempre in ambito poetico le 4 liriche, 77 esemplari numerati con acquaforte originale di Luciano Ragozzino (Milano, “Il ragazzo innocuo”, 2017). Oltre ad alcune interessanti conversazioni”: Conversazione a Siviglia a cura di Miguel Ángel Cuevas (Caltagirone, Lettere da Qalat, 2016) che rimanda a Conversación en Sevilla, sempre a cura dello stesso (Sevilla, La Carbonería, 2014) e Autobiografia della lingua. Conversazione con Irene Romera Pintor (Bologna, “Ogni uomo è tutti gli uomini”, 2016). Per finire, le prose brevi di Mediterraneo. Viaggiatori e migranti (Roma, Edizioni dell’Asino, 2016). Cosa loro consta di sessantaquattro articoli scritti tra il 1970 ed il 2010, due anni prima della morte, pubblicati su diverse testate giornalistiche (L’Unità, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, L’Ora, L’avvenire), su riviste (Linea d’Ombra, Euros) e su pubblicazioni di diversa natura, libri collettanei, ecc. Chiude il libro un’appendice
nella quale il curatore dell’edizione, Nicolò Messina, fornisce utilissime informazioni storiche e filologiche sui diversi pezzi, alcuni dei quali ha potuto collazionare con gli originali, dattiloscritti o manoscritti. Il titolo, Cosa loro, intende apportare, mediante lo scambio del possessivo, una modifica, di certo non solo grammaticale, alla definizione vulgata di “Cosa nostra”, per segnalare, si legge in una nota introduttiva, «un sistema da cui prendere senza compromessi le distanze e da contrastare indefettibilmente ». Consolo lo ha fatto nel corso di tutta la sua vita in quanto, ammetteva, «non si nasce in un luogo impunemente. Non si nasce, intendo, in un luogo senza essere subito segnati, nella carne, nell’anima da questo stesso luogo» («Memorie», ora in La mia isola…). In un articolo apparso su L’Ora nel 1982 («I nemici tra di noi», Cosa loro) proclama infatti che «la lotta alla mafia ha bisogno di noi, di ognuno di noi, nella nostra limpida coscienza civile, della nostra ferma determinazione; che è lotta politica, lotta per la nostra civiltà». Così Consolo “impugna” la scrittura per fare la sua parte. Scrive, come dice in «Un giorno come gli altri» (La mia isola…) perché la
scrittura «può forse cambiare il mondo». Con il narrare, invece, che è l’altro versante della sua ispirazione, il mondo non lo si cambia, lo si descrive soltanto. Negli articoli ora riuniti in Cosa loro, Consolo adotta quindi una “scrittura di presenza”, ossia una prosa militante che vibra fino ad innalzarsi alla liturgia indignata della riscrittura di un Dies irae da Requiem eseguito il 27 marzo 1993 nella cattedrale di Palermo per ricordare le stragi in cui persero la vita i giudici Falcone, Borsellino («soldati in prima linea » come li definisce), le loro scorte ed i congiunti («Dies irae a Palermo»). La “scrittura di presenza” assume, in certi scritti, la connotazione fisica dell’inviato speciale che segue “in diretta” le vicende che descrive: così ritroviamo lo scrittore al processo di Milano contro Michele Pantaleone nel 1975, querelato ma poi assolto, per aver denunciato un soggetto mafioso o a Comiso («Ero anch’io là, quella primavera del 1982, là a Comiso» – proclama con orgoglio – per protestare contro l’installazione di missili Cruise nella base della Nato. Ma l’intervento più solenne per un inviato speciale mandato in prima linea è quello al “maxiprocesso” del 1986: 475 mafiosi in gabbia. «Anch’io, in quel piovoso mattino del 10 febbraio del 1986, ero nella famosa, avveniristica, metafisica aula-bunker», afferma lo scrittore con
l’orgoglio di chi assiste, sono ancora parole sue, «al più grande psicodramma della storia siciliana, della storia nazionale». A cui seguirà purtroppo la tragica sequela di Capaci e di Via Amelio, nel 1992. Di Giovanni Falcone, a cui sono dedicati diversi articoli ed uno straziante necrologio, Consolo ha un ricordo personale: si conoscono ad una cena in casa di amici comuni e lo scrittore non può fare a meno di notare la tragica solitudine di quel commensale taciturno con «quell’aria triste di uomo “con toda su muerte a cuestas”», dice citando Federico García Lorca. Anche Falcone, come Ignacio Sánchez Mejía, era già avviato verso l’irreparabile destino. Consolo traccia la linea genealogica degli scrittori «siciliani e no» militanti: a cominciare dall’archetipo ottocentesco, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, i primi che denunciarono, nella famosa inchiesta del 1870, l’esistenza della mafia e l’arretratezza della Sicilia. Seguono, più vicino a noi, il già citato Michele Pantaleone che passò dalla scrittura all’azione, raggiungendo il record di quaranta querele mossegli da presunti mafiosi, Danilo Dolci, con i suoi scritti e le sue inchieste e soprattutto Leonardo Sciascia che «come Sherlock Holmes – è il titolo di un articolo del 1994 – scende nei sotterranei del potere di Cosa nostra». Leonardo Sciascia è inevitabilmente per il nostro scrittore una sorta di nume tutelare. Ma anche per «quel grande illustratore dell’Italia di ieri e di sempre» che risponde al nome di Alessandro Manzoni, Consolo dice di nutrire una grande ammirazione. Del tutto diversi i giudizi di Consolo su alcuni prestigiosi scrittori siciliani; quali Luigi Capuana, Giovanni Verga, e soprattutto Giuseppe Tomasi di Lampedusa. All’autore de Il sorriso dell’ignoto marinaio non poteva naturalmente andare a genio l’affresco storico de Il Gattopardo, definito peraltro come un «sentenzioso romanzo» che cerca di occultare con l’enfasi delle famose parole pronunciate da Fabrizio Salina, («Noi fummo i Gattopardi
e i Leoni; quelli che ci sostituiranno […]» eccetera eccetera..), le complicità
dell’aristocrazia siciliana nell’avvento delle iene in futuro odore di mafia. Ma il
«principe di Salina – si legge ne I nostri eroi di Sicilia del 2007 – ignorava o voleva
ignorare che le iene e gli sciacalli, i don Calogero Sedara, erano nati e cresciuti, si
erano ingrassati nelle terre, nei feudi dei suoi pari, dei nobili, mentre loro, i feudatari, se ne stavano nei loro palazzi di Palermo a passare il tempo tra feste e balli. Vogliamo dire che la mafia dei gabellotti, dei soprastanti e dei picciotti, mafia che sfruttava e opprimeva i braccianti, era nata là, nel latifondo, nel feudo, in quel sistema economico che durava da più di mille anni. Tomasi di Lampedusa, l’autore del Gattopardo, ignorava questo?». Sotto la “scrittura di presenza” che cerca di «cambiare il mondo», circolano, nei diversi capitoli di Cosa loro, frammenti dell’altra vena, narrativa, dello scrittore, che il curatore del libro, profondo conoscitore dell’opera di Consolo, individua puntualmente nell’appendice. Il frammento più solido è, a mio avviso, quello relativo ad un episodio che prende forma in un articolo del 1991 per raggiungere poi l’elaborazione definitiva nel racconto «Le lenticchie di Villalba» del 2000 ( La mia isola…) e rientrare successivamente nella “scrittura di presenza” nel 2004 con il titolo significativo di «Prima educazione alla legalità». Nell’articolo apparso su Linea d’ombra nel 1991, troviamo infatti l’embrione del futuro racconto di un episodio che Consolo dice di narrare per la prima volta, «risalente –precisa – a poco meno di cinquant’anni or sono […]». C’è una colpa, confessa ironicamente lo scrittore, da cui intendo liberarmi: «io
sono stato in casa a Villalba, del famoso capomafia don Calogero Vizzini, [non solo] ho avuto in dono, dallo squisito personaggio, un torroncino di sesamo e un buffetto sulla guancia». «Racconto com’è andata», precisa, quasi per avvertire che dalla scrittura militante sta scivolando in quella narrativa della memoria. «Era l’estate del ‘43», così ha inizio l’episodio. Consolo, a quell’epoca aveva dieci anni, viaggiava in camion con il padre, commerciante di cereali, per racimolare generi alimentari che scarseggiavano. A Villalba, in provincia di Caltanisetta, riescono a rifornirsi di derrate tra cui le lenticchie per cui era famosa la cittadina. Dopo aver caricato il camion, stanno per partire ma vengono bloccati da un maresciallo dei carabinieri che proibisce loro di trasportare la merce. Gli consigliano di ricorrere a don Calò che in effetti sblocca la situazione, li fa partire ed in più regala il torroncino al piccolo Vincenzo. Seguendo la cronologia delle lenticchie arriviamo al racconto del 2000 che ha un finale da un punto di vista etico, più pertinente: niente dolci e buffetti sulle guance del bambino e soprattutto c’è il padre che rifiuta la protezione mafiosa di don Calò, fa scaricare il camion e durante il viaggio di ritorno fa notare al figlio che «in questi paesi ci sono persone che comandano più dei marescialli». E lo invita a raccontare l’episodio «in un bel copiato» che Consolo metterà per iscritto quasi sessant’anni dopo. Nell’articolo del 2004, intitolato, come si è appena detto, «Prima educazione alla legalità», l’episodio non può che riconfermare il finale sancito nel racconto del 2000, con una messa a fuoco piu ravvicinata del losco personaggio che il padre definisce senza mezzi termini “capomafia” ed ancora l’invito, quasi un lascito morale al figlio, a raccontarlo a scuola in un “copiato”. Una curiosità lessicale: il ritratto di don Calò attraversa diverse varianti iconografiche: nel 1991 («Mafia e media») è descritto come un «vecchio, imperioso, compassato»; nel 2000 («Le lenticchie…»), è semplicemente «un vecchio con gli occhiali e il bastone» mentre nel 2004 («Prima educazione alla legalità ») viene bollato definitivamente come «un vecchio laido e bavoso». In altre circostanze lo scambio tra scrittura e narrazione (anche di taglio saggistico) procede all’inverso, nel senso che è questa a fornire alla prosa militante, atmosfere, spunti o addirittura interi brani contenuti nei romanzi. Così l’«Invettiva» del 1992 nei giorni successivi all’assassinio di Giovanni Falcone («Adesso odio il paese,
l’isola, odio questa nazione disonorata, il governo criminale, la gentaglia che lo vuole… Odio finanche la lingua che si parla…»), è una citazione – è lo stesso Consolo a confermarlo – del coevo romanzo Nottetempo, casa per casa. Continuando questo rapido inventario, sempre sotto la guida attenta del curatore del volume, troviamo Al di qua dal faro come fonte ispiratrice dell’articolo «Sciascia come Sherlok Holmes nei sotterranei del potere di Cosa nostra». Per quanto riguarda la città di Palermo (in «I fantasmi di Palermo») essa è bersaglio di invettive, «Palermo è fetida» e «Questa città è diventata un campo di battaglia», che provengono rispettivamente da Le pietre di Pantalica e Lo spasimo di Palermo. Attraverso gli articoli di Consolo ripercorriamo quarant’anni di una tragedia nazionale di corruzione e di morti ammazzati che ha il suo apice con l’attentato a Falcone ed a Borsellino: dopo la loro morte, possiamo dire con lo scrittore che «non siamo stati più gli stessi». Ai registri usati da Consolo nei diversi capitoli del suo lungo “copiato”, si deve aggiungere anche quello comico-grottesco in cui agiscono personaggi come Salvatore (Totò) Cuffaro (governatore della regione siciliana), il suo successore, Raffaele Lombardo, e dulcis in fundo Silvio Berlusconi. I primi due sembrano maschere della commedia dell’Arte. A Cuffaro (rinviato a giudizio per «rivelazione di notizie riservate e favoreggiamento» che, sia detto per inciso, approfittò della reclusione per scrivere una tesi di laurea sul sovraffollamento delle carceri) Consolo attribuisce una illustre ascendenza, nientemeno che Sancho Panza: come il personaggio di Cervantes è, afferma lo scrittore, governatore dell’Isola di Baratteria e come lui potrà affermare, alla fine del suo mandato: «nudo son nato e nudo mi ritrovo». L’elemento farsesco è suggerito dalla sua ghiottoneria: nei diversi “cammeo” che gli sono dedicati nel volume, da «Totò il buono» (2004) fino a «Totò se n’è juto» (2008), è raffigurato come un cicciottello in estasi «davanti a una enorme cassata siciliana». Il menù della sua voracità comprende anche altre leccornie come «cannoli, cassate e mammelle di vergine». Anche il suo successore Raffaele Lombardo eredita il debole per la pasticceria ed in effetti, dice Consolo, scivola pure lui «su un vassoio di cannoli» e sull’accusa di concorso in associazione mafiosa. Lombardo inoltre si è fatto portavoce dell’annoso assioma
secondo il quale a parlare della mafia si infanga la Sicilia. E se la prende pure
con chi a suo avviso l’ha denigrata: la lista include persino Omero, per aver rappresentato lo stretto di Messina nelle fogge mostruose di Scilla e Cariddi, poi Garibaldi, Verga, De Roberto, Pirandello, Tomasi di Lampedusa. Si salvano invece Camilleri e curiosamente lo stesso Consolo verso cui Lombardo manifesta una grande ammirazione. Al che lo scrittore in persona prende divertito la parola per esprimere la propria sorpresa: «Ohibò! […] se il Lombardo avesse letto qualche libro di Consolo, se ne sarebbe accorto che razza di denigratore della Sicilia è questo scrittore!». Il cast del grottesco si chiude con Silvio Berlusconi, «l’anziano uomo truccato, quello che secondo Pirandello susciterebbe, come la vecchia signora “goffamente imbellettata”, l’avvertimento del contrario il quale crea a sua volta la comicità». In un contributo ad un libro su don Pino Puglisi, sacerdote assassinato dalla mafia nel 1993, intitolato «La luce di don Puglisi nelle tenebre di Brancaccio», lo scrittore si chiede se la Sicilia e l’intero paese siano, per usare un’espressione di Sciascia, «irredimibili». La risposta è lui stesso a formularla in un intervento successivo in cui si sofferma, a mio avviso, in modo enigmatico sulla soglia della parola “utopia”: «Sì –risponde all’intervistatore che gli chiede un messaggio di speranza – come scrittore, devo dare speranza. E la do, credo la speranza, come gli altri, con la scrittura. Il grande critico letterario russo Michail Bachtin affermava che il romanzo critico nei confronti del contesto storico-sociale è romanzo utopico: vale a dire che esso, narrando il male sociale, fa immaginare il bene, indica la società ideale».
Cuadernos de Filología Italiana
Giovanni Albertocchi
Universitat de Girona