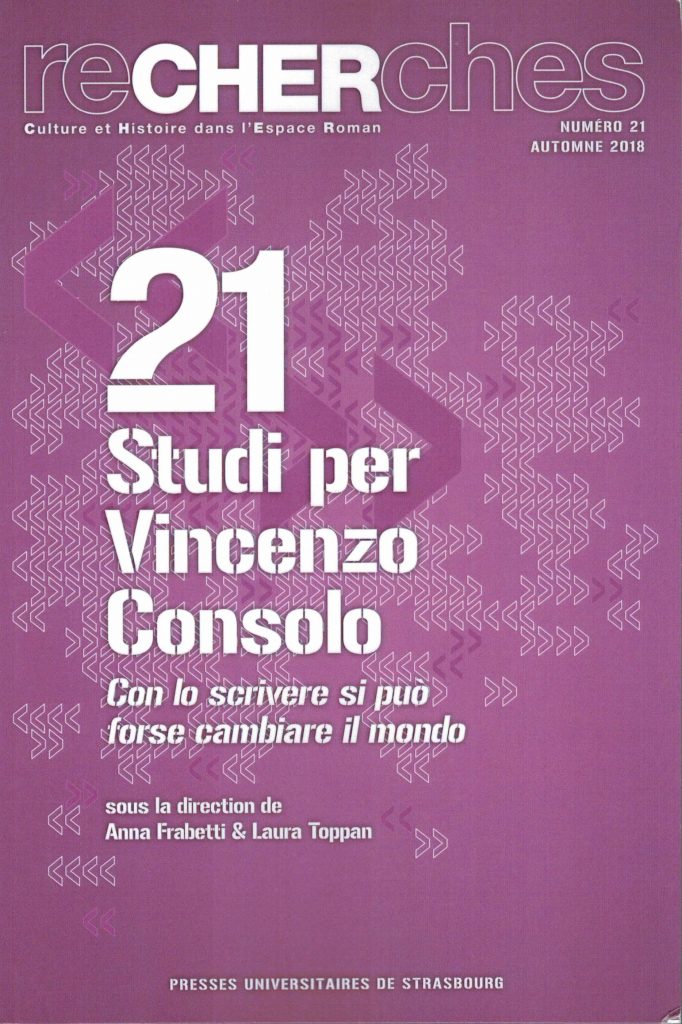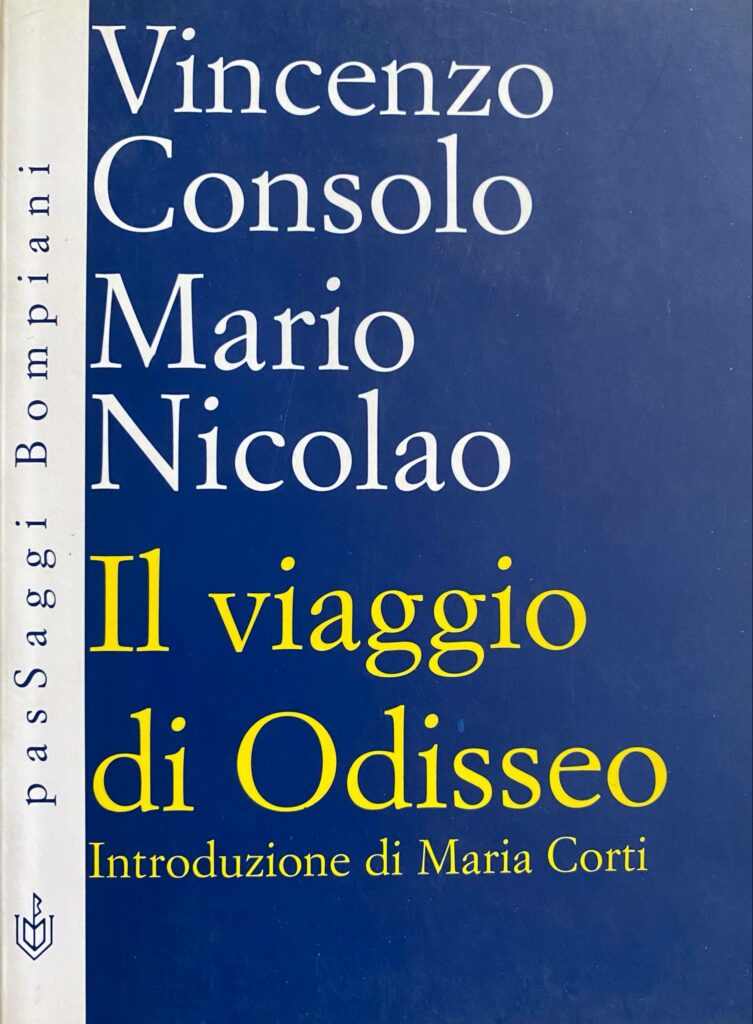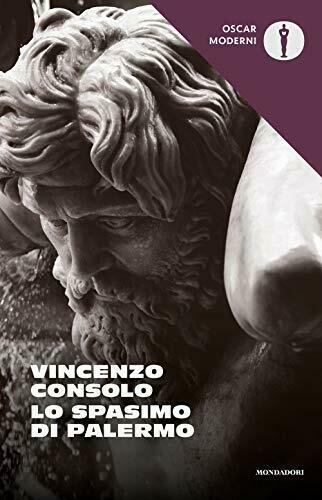Daniel Raffini
Problema centrale dell’opera e della riflessione di Consolo è quello del linguaggio, un problema che si ripercuote a più livelli. Appare evidente alla lettura l’intenso lavorio che lo scrittore siciliano mette in atto sulla lingua, una lingua che si arricchisce a vari livelli, esplora nel tempo, nello spazio e nella stratificazione sociale. Tale operazione, per ammissione dello stesso Consolo, ha come fine un salvataggio: lo scrittore vuole salvaguardare la lingua letteraria dall’appiattimento del linguaggio dei media1. In questo modo la letteratura finisce per avere un doppio ruolo: salvare una tradizione, ritagliandosi dunque uno spazio autonomo, e combattere contro le derive estreme della contemporaneità. La scrittura di Consolo è elitaria e impegnata allo stesso tempo, torre d’avorio ma anche strumento di intervento sulla realtà. Per questo motivo la lingua di Consolo si fa difficile, per chi legge, una difficoltà ripagata dalla ricchezza d’invenzione e giustificata con un fine etico. Ma la difficoltà del linguaggio in Consolo, oltre ad essere un dato stilistico, diventa anche un importante elemento tematico e nodo di riflessione, quasi un rovello per lo scrittore, un dilemma sul quale torna a interrogarsi in diversi momenti della sua opera. In una prima fase la riflessione sulla difficoltà del racconto, sull’impossibilità del dire, si configura in Consolo sotto una prospettiva storica e sociale. Il sorriso dell’ignoto marinaio tematizza lo scontro sociale tra le élite e le classi subalterne al momento dell’Unità d’Italia, presentando il tentativo storico di riunire due mondi inconciliabili sotto un unico vessillo. Se i nobili siciliani accettarono la nuova dominazione certi che nulla sarebbe cambiato nei loro privilegi, allo stesso modo il popolo capisce che con il nuovo Stato italiano nulla cambierà nella sua condizione2. Di qui il racconto della rivolta popolare di Alcara Li Fusi, attorno alla quale ruota il romanzo di Consolo. Personaggio di mediazione tra i due mondi è Mandralisca, che nella memoria sui fatti di Alcara Li Fusi riportata a partire dal sesto capitolo del romanzo tenta di spiegare le ragioni del popolo. Dall’incompatibilità tra le classi sociali nasce la difficoltà di narrare: Parlai nel preambolo di sopra d’una memoria mia sopra i fatti, d’una narrazione che più e più volte in tutti questi giorni mi studiai di redigere, sottraendo l’ore al sonno, al riposo, e sempre m’è caduta la penna dalla mano, per l’incapacità scopertami a trovare l’avvio, il timbro e il tono, e le parole e la disposizione d’esse per poter trattare quegli avvenimenti, e l’imbarazzo e la vergogna poi che dentro mi crescean a concepire un ordine, una forma, i confini d’un tempo e d’uno spazio, e contenere quell’esplosione, quella fulminea tromba, quel vortice tremendo; e le radici, ancora, le ragioni, il murmure profondo, lontanissimo, da cui discendea? La contraddizione infine nel ritrovarmi a dire, com’io dissi, dell’impossibilità di scrivere se non si vuol tradire, creare impostura, e la necessità insieme e l’impellenza a farlo3. La difficoltà di Mandralisca nasce da una differenza di fondo, da un contrasto tra la tendenza a cercare un ordine, una forma, e l’inafferrabilità di quei fatti, la potenza e il disordine insito negli eventi che si appresta a raccontare. Si profila insomma la differenza di base tra il mondo del dire, la gabbia del linguaggio, e l’irruento progredire degli eventi, la realtà che si espande su diversi piani. Ed è così che il personaggio, e con lui lo scrittore, finisce per percepire il carattere fittizio della narrazione, l’impostura che nasce all’insufficienza del linguaggio a dire la realtà. È questa una riflessione che ritorna più volte nei romanzi dello scrittore siciliano e che viene così sintetizzata nell’ultimo capitolo di Nottetempo, casa per casa: È mai sempre questa la scrittura, è l’informe incandescente che s’informa, il suo freddarsi, il trapassare stilla a stilla nel segno, suono, nel senso decretato, nella convenzione, nella liturgia della parola? È canto, movimento, pàrodo e stàsimo per liberare pena gioia furia rimorso, mostrare nella forma acconcia, nella più bella tempesta? È malizia, compromesso, cedimento, riconciliazione con il mondo?
Oh anima sfuggente, oscura, oh fondo tenebroso.
È menzogna l’intelligibile, la forma, o verità ulteriore?4 Il dubbio di fondo, se la scrittura sia imperdonabile menzogna o scoperta di una verità ulteriore, resterà costante in tutta la produzione consoliana. Allo stesso tempo il racconto si presenta come un’azione imprescindibile, unico modo, seppur monco, di trattenere i fatti dopo che sono avvenuti, di far compiere alla letteratura il suo compito «di essere testimone del nostro tempo»5. In soccorso a Mandralisca viene la realtà stessa, che gli appare nella forma di una serie di testimonianze dei protagonisti dei fatti, «alcune carte ove calato avea di pugno mio, pari pari, con fede notarile, le scritte di carbone sopra un muro, […] le testimonianze personali de’ rotagonisti»6. Proprio sulla disparità tra il linguaggio di chi racconta e quello del popolo si gioca la riflessione del barone. Nel sesto capitolo Mandralisca, annunciando l’invio della memoria a Interdonato, si lasciava andare a una riflessione sulla natura della storia: «E cos’è stata la storia sin qui, egregio amico? Una scrittura continua di privilegiati »7. La storia raccontata dai vincitori, da chi detiene il potere, appare per forza di il popolo e scaturisce dall’impossibilità di maneggiare un linguaggio per il quale non è stato istruito e che anzi è stato fatto con lo scopo di tenerlo in soggezione. La riflessione sulla difficoltà del racconto viene però gradualmente interiorizzata da Consolo, che la proietta in prima istanza su sé stesso e in seguito sui propri personaggi e sull’umanità intera. Le difficoltà incontrate nel ricostruire la storia dei vinti devono aver portato lo scrittore a riflettere sempre più sul carattere illusorio del racconto. Ciò si lega alla volontà di esprimere il dolore e il male nella storia, che caratterizza sempre più la scrittura di Consolo. Nei romanzi degli anni Novanta il problema della difficoltà del racconto diventa di carattere esistenziale: il dolore, legato alla perdita di una condizione originaria di stabilità, determina la difficoltà di dire, l’inciampo della narrazione; ma allo stesso tempo il racconto diventa necessario, unico strumento per non cadere nel baratro, nel nulla che c’è in fondo a ogni dolore. Nottetempo, casa per casa è in questo senso un romanzo emblematico, in quanto romanzo il cui «tema centrale potrebbe essere sintetizzato come “l’irrazionale e la storia”»11. Consolo stesso dirà a proposito del libro: «Ho voluto rappresentare il dolore… e questo libro è stato da me concepito come una tragedia»12. «La funzione della letteratura è di essere testimone non soltanto della storia, ma anche del dolore dell’uomo»13, tanto che la storia e il dolore sembrano spesso sovrapporsi, diventare la stessa cosa. La difficoltà di dire il male si percepisce nelle pagine di Nottetempo, casa per casa, nel suo apparire sempre in procinto di dire per bloccarsi sempre un attimo prima che la narrazione diventi dispiegata. La ragione di questo andamento a singhiozzi che si percepisce nella scrittura e nella struttura stessa del romanzo, nei salti da un capitolo all’altro, nel non detto e nelle reticenze, viene resa palese nel finale. Petro Marano, fuggendo da Cefalù alla volta di Tunisi, sente finalmente di potersi abbandonare al racconto: «Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata la calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro»14. Attraverso l’allontanamento dal luogo del male, dal luogo dove il dolore personale ha avuto modo di attecchire, il personaggio ritrova la forza di raccontare. Su questo punto il romanzo si conclude, esaurendo il suo compito primario. Il libro si chiude così un attimo prima dell’inizio, trova il suo culmine nel momento in cui la narrazione dovrebbe dispiegarsi per bocca del personaggio, configurandosi come un viaggio difficoltoso verso la possibilità di dire.
Nottetempo, casa per casa è il romanzo di Consolo che tematizza più degli altri lo sfioramento dell’abisso per quanto riguarda l’uomo e del silenzio per quanto riguarda la scrittura, l’espressione di quello che ne Lo spasimo di Palermo l’autore definirà come «il passo breve tra il moto e la paralisi»15. Nel capitolo IV, di fronte alla rovina sua e della sua famiglia, Petro sembra sul punto di cedere all’urlo estremo, alla disperazione: cose distorta. Meglio sarebbe poter disporre di «un immaginario meccanico instrumento […], che fermasse que’ discorsi al naturale»8, anche se in fin dei conti – conclude Mandralisca – anche una macchina di tale genere risulterebbe inutile, giacché non possederemmo «la chiave, il cifrario atto a interpretar que’ discorsi»9. Consolo individua così una delle difficoltà principali del narrare nel punto di vista, nella soggettivizzazione che ogni racconto subisce da parte di chi lo enuncia. In una società impari tale soggettivizzazione diventa quasi un reato: colui che detiene gli strumenti del racconto finisce per usarli per tenere in soggezione l’altro. La sottomissione del popolo nasce in primo luogo, secondo quanto dice Mandralisca, dalla mancanza di un linguaggio proprio, atto ad esprimerne l’esperienza. La creazione di un linguaggio nuovo diventa allora il mezzo attraverso il quale le classi subalterne potranno ottenere la libertà. Per questo Mandralisca sceglie di donare i suoi beni per la costruzione di una scuola per i figli dei popolani: «Sì che, com’io spero, la storia loro, la storia, la scriveran da sé, non io, o voi, Interdonato, o uno scriba assoldato, tutti per forza di nascita, per rango e disposizione pronti a vergar su le carte fregi, svolazzi, aeree spirali, labirinti…»10. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio dunque il problema della scrittura si presenta come un problema storico e sociale, la difficoltà di narrare riguarda «Uuuhhh…» ululò prostrato a terra «uuhh… uhm… um… umm… umm…
umm…» e in quei suoni fondi, molli, desiderava perdersi, sciogliere la testa, il petto. Sentì come ogni volta di giungere a un limite, a una soglia estrema. Ove gli era dato ancora d’arrestarsi, ritornare indietro, di tenere vivo nella notte il lume, nella bufera. E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Formo. Pane, ulivo. Carrubo. Sommaco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficidindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Frainguello. Nuvola. Sole. Arcobaleno…» scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento in cui nulla era accaduto, la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo16. Petro si aggrappa all’essenzialità delle parole per non cedere al baratro, all’urlo disarticolato che rappresenta il disordine e la fine di ogni razionalità, dell’elemento umano, una regressione a una condizione ferina. Il male è pervasivo, tanto che le parole stesse sembrano più avanti essere minacciate dal suo avanzare: «E corrompeva il linguaggio, stracangiava le parole, il senso loro – il pane si faceva pena, la pasta peste, la pace pece, il senno sonno»17. Tuttavia, attraverso il valore creatore della parola, Petro come un novello Adamo tenta l’illusorio ritorno a una condizione edenica, la condizione di tranquillità precedente alla rottura dell’equilibrio, la frattura da cui è generato il dolore18. La condizione iniziale di equilibrio rimanda a un momento specifico della vita di Petro, precedente alla morte della madre, alla follia della sorella, alla malattia del padre, ma è anche una condizione universale, che accomuna tutti gli uomini, il sentimento di un’origine perduta e percepibile ormai solo in via frammentaria: Una suprema forza misericordia immensa potrebbe forse sciogliere l’incanto, il grumo dolorante, ricomporre lo scempio, far procedere il tempo umanamente. O l’invocare ognuno, il mondo intorno, a capire, assumere insieme l’enorme peso, renderlo comune, e lieve. E il dolore suo sembrò a Petro sorto non solo dalla madre troppo presto assente, dal padre malinconico, piegato, da Serafina torpida, di pietra, da Lucia che sola e orgogliosa se n’andava per altra strada, ma da qualcosa che aveva preceduto la sua, la nascita degli altri. Era così per lui, per la famiglia o pure per ogni uomo, per ogni casa? Di questo luogo, di questa terra in cui era caduto a vivere, di ogni terra?19 Borges, autore caro a Consolo20, diceva che ogni uomo è tutti gli uomini: così il destino personale di Petro, la disgrazia e il dolore, diventa il destino di ogni uomo. Il dolore allontana il senso, offusca la ragione, che è alla base del linguaggio. Ed è così che lo scrittore finisce per interrogarsi sulla dicibilità stessa del dolore e del male: In questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichìo di quell’oro, è possibile ancora la scansione, l’ordine, il racconto? È possibile dire dei segni, dei colori, dei bui e dei lucori, dei grumi e degli strati, delle apparenze deboli, delle forme che oscillano all’ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono? E tuttavia per frasi monche, parole difettive, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione21. Pur nella difficoltà il racconto deve dunque andare avanti, continuamente minacciato dagli estremi opposti e uguali dell’urlo, quello a cui sta per cedere Petro, e del silenzio, «l’inespresso, l’ermetico assoluto, il poema mai scritto, il verso mai detto »22. La tentazione verso di essi è forte, e anche il dubbio che in essi sia il senso ultimo, tanto che nel finale del romanzo l’autore arriva a ipotizzare: «È la ritrazione, l’afasia, l’impetramento la poesia più vera, è il silenzio. O l’urlo disumano»23. Ma subito dopo, come detto, c’è la fuga da Cefalù, in cui Petro trova la sua possibile riconciliazione con il racconto, una riconciliazione che rimane sospesa sul finale del romanzo. Il discorso sulla difficoltà della narrazione espresso da Consolo in Nottetempo, casa per casa trova una sua ideale continuazione ne Lo spasimo di Palermo. L’epigrafe del romanzo riprende una frase del Prometeo Incatenato di Eschilo, in cui Prometeo, incitato a rivelare il suo racconto risponde: «Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore». La scelta tra dire e non dire si gioca allora, come detto, su un piano etico: il dire può incidere sulla realtà, o almeno redimere in qualche modo dal dolore. Consolo rifugge dalla tentazione dell’urlo e da quella del silenzio, opta per la narrazione; ma la riflessione su questo punto deve essere ormai giunta a un punto di non ritorno e l’autore decide di tematizzarla. Lo spasimo di Palermo racconta la storia di uno scrittore che non riesce più a scrivere, si tratta di un romanzo che attraverso la narrazione parla «dell’impossibilità di narrare»24. In questo modo Consolo esorcizza la propria tentazione trasponendola sul personaggio, che si fa carico dell’impossibilità di raccontare. Gioacchino Martinez è d’altronde un alter ego imperfetto di Consolo stesso, nel suo personaggio è possibile rintracciare molti elementi dello scrittore. Al di là delle vicende biografiche, come l’origine siciliana e il lungo soggiorno a Milano, a identificare Gioacchino con Consolo è il profilo intellettuale dello scrittore: Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una diversa lingua, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio. Si doleva di non avere il dono della poesia, la sua libertà, la sua purezza, la sua distanza dall’implacabile logica del mondo25. L’identificazione di Consolo con Gioacchino passa dunque proprio attraverso la dicotomia urlo-silenzio che già abbiamo incontrato in Nottetempo, casa per casa.
Gioacchino però, a differenza di Consolo, opta per abbandonare la scrittura. «Sai bene che non sono più scrittore, se mai lo sono stato»26 dice in risposta a una provocazione del figlio Mauro; mentre alla richiesta della compagna del figlio di una dedica per una lettrice risponde: «Non scrivo più, neppure dediche. Di’ che sto lontano, non viaggio…»27. Il narratore motiva così la decisione del personaggio: «S’era chiuso nel silenzio, nel dominio della notizia, invasione del resoconto, scomparsa di memoria, nell’assenza o sordità dell’uditorio, vana era ormai ogni storia, finzione e rimando del suo senso diceva e si diceva»28. Il blocco di Gioacchino deriva dunque da una sorta di ipertrofia della realtà esterna, dall’impossibilità di mettere in atto quella «lenta sedimentazione della memoria»29 che è per Consolo condizione necessaria alla narrazione. Questo si ricollega ancora una volta all’idea del logoramento del linguaggio nella società mediatica contemporanea, che si ripercuote sulla scrittura, ed è evidente anche nel più volte ribadito rifiuto di Gioacchino verso gli scrittori contemporanei30. Ma al di là delle condizioni esterne, il blocco di Gioacchino si manifesta come una condizione interna al soggetto: «Ma sapeva che suo era il panico, l’arresto, sua l’impotenza, l’afasia, il disastro era nella sua vita»31. Ancora una volta, come nel caso di Petro Marano, il disastro personale va letto anche come disastro collettivo, condanna di tutta l’umanità al dolore. Il figlio di Gioacchino, esule a Parigi per aver partecipato alle vicende torbide legate agli Anni di Piombo, rappresenta un’altra faccia della lotta al dolore, il volto razionale, disincantato, di chi ha provato attraverso la vita reale a lasciare un segno nel mondo ed è rimasto scottato dal fallimento e dalla consapevolezza dell’errore32. Il figlio Mauro, costantemente polemico verso l’attività letteraria del padre, cinico e ironico verso il suo chiudersi in mondi altri33; ma anch’egli abitante di una menzogna fatta di parole, vittima di ideologie illusorie: «Le parole con cui ti mascheri e nascondi sono solo una pazzia recitata, un teatro dell’inganno»34.Anche il figlio, come Gioacchino, come Petro Marano, come ogni uomo, vive nell’angoscia di un impossibile ritorno all’origine: «Riparti sempre dall’inizio, non sei riuscito a placare dopo anni i tuoi assilli»35. Il figlio rappresenta per Giacchino una parte del dolore, il silenzio che li divide diventa impossibilità di racconto; il linguaggio ancora una volta mostra tutta la sua insufficienza a dire il tormento umano: Il silenzio, ancora e sempre, il silenzio duro si stendeva tra di loro. Quali parole poi, e quale tono? Oppure quali gesti sguardi balbettii? L’avrebbe fermato Mauro, schernito con la sua ironia, il suo sarcasmo, gli avrebbe rivelato il suo disagio, il suo risentimento, mostrato forse ancora di peggio. Aveva tentato infinite volte la scrittura, lettere memorie resoconti, ma l’orrore nasceva puntuale per quell’ordine assurdo, quel raggelare la ferita, quella codificazione miserevole dell’assenza prima o poi assoluta, dell’improvviso vuoto, dello sgomento fisso. S’era accontentato dei continui viaggi per rivedere il figlio, colmare così un qualche modo, con le elusioni, coi silenzi quel silenzio36. L’esilio del figlio, la sua lontananza fisica ma anche emotiva, determina il dolore che impedisce a Gioacchino di dispiegare il racconto. L’impossibilità di dire appare ancora una volta prima di tutto nella resistenza della lingua a incanalarsi in una cadenza, in un tono, come una macchina inceppata che non riesce ad avviarsi. La macchina del linguaggio appare difettosa e menzognera, inadatta allo scopo al quale la si vuole piegare. Nottetempo, casa per casa si chiudeva con il riferimento di Petro alla falsità della scrittura; Lo spasimo di Palermo inizia con lo stesso tema, in una sorta di continuazione ideale del discorso: Capiva che sempre, sul ciglio dell’abisso la parola si raggela, si fa suono fermo, forma compatta, simbolo sfuggente. Arriva mai la remissione, la fine d’ogni sisma, d’ogni fuga, l’ora di sciogliere il nodo marinaro, placare lo sgomento, immaginare ancora una cerchia confidente?37 Allo stesso modo Nottetempo, casa per casa si chiudeva con Petro che, abbandonato il luogo del dolore, si apprestava finalmente a scrivere il proprio racconto. Lo spasimo di Palermo rappresenta il fallimento di quel proposito, presentandoci uno scrittore che non riesce a scrivere, quasi che Gioacchino Martinez fosse un Petro Marano sconfitto in quello slancio finale. Lo spasimo di Palermo entra dunque in dialogo col romanzo precedente proprio sul tema della difficoltà della narrazione. Ma non è l’unico elemento di intertestualità interna presente in questo romanzo. Si può rimandare, ad esempio, anche alla riflessione sulla scrittura della storia come discorso dei vinti di cui parlava Mandralisca ne Il sorriso dell’ignoto marinaio e metterlo in relazione con la critica che Consolo fa, ne Lo spasimo di Palermo, ai codici abusati degli scrittori: «Stendono prose piane i professori, narrano storie tonde, scrivono aulici elzeviri, decorano le accademiche palandre di placche luccicanti. […] I tristi imbonitori, trame, panie catturanti, gerghi scaduti o lingue invase, smemorate»38. Per Consolo e per il suo personaggio la scrittura ha tutt’altro fine, e proprio a causa di questo scopo più alto si scontra con la difficoltà di dire. Il blocco deriva da uno scontro con una realtà difficoltosa, ma anche da una natura diversa rispetto a quella degli altri scrittori, che appare evidente in un dialogo col figlio: Chiese al padre se scriveva. «Nulla» disse. «Ho assoluta ripugnanza, in questo stordimento, nell’angoscia mia e generale.» «Altri riescono, e assai felicemente… lo scoiattolo ligure, il romano indifferente, l’amaro tuo amico siciliano…» «Hanno la forza, loro, della ragione, la chiarità, la geometria civile dei francesi. Meno, meno talento, e poi mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono…»39. Il proposito è lo stesso di Nottetempo, casa per casa: la riconciliazione con un’origine perduta. In una sorta di invocazione proemiale che apre il romanzo Consolo scrive: «Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza », e cita il verso eliotiano «In my beginning is my end»40. L’autore si presenta qui come «voce fioca nell’aria clamorosa, relatore manco del lungo tuo viaggio»41, rimandando di nuovo alla frammentarietà insita nel racconto, all’impossibilità di dire in maniera chiara. Ed è così che anche questo romanzo non riesce a dispiegarsi in una forma lineare, il racconto è continuamente interrotto, con continui salti temporali dovuti all’impossibilità stessa del personaggio di stabilire la collocazione reale degli eventi: «Non riusciva a scandire quel numero di anni, un cumulo uniforme, una landa sconfinata»42; e dall’altra parte il tentativo, quello di sempre, di rientrare «per il varco che conduceva nel passato, nel racconto, in cui tutto era accaduto, tutto sembrava decifrabile»43. I due romanzi dialogano non solo nell’incipit, ma anche nel finale. Se il finale di Nottetempo, casa per casa si apriva sulla possibilità del racconto, quello de Lo spasimo di Palermo invece si chiude sul silenzio. L’ultima scena del romanzo mostra l’attentato al procuratore, la bomba che esplode e lo uccide e il tentativo estremo di Gioacchino di salvarlo. Dopo il fragore il silenzio diventa impossibilità di dire. Il fioraio – ma potrebbe trattarsi anche di Gioacchino, la costruzione è forse volutamente vaga, a significare ancora una volta l’universalità dell’esperienza – si rialza, stordito, e non riesce a parlare: «Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono»44, e gli rimane solo l’implorazione muta, l’invocazione a Dio, che stenda la sua mano potente su quella terra disgraziata:
«O gran manu di Diu, ca tanti pisi, / cala,
manu di Diu, fatti palisi!»45.
In una lettera al figlio contenuta nel capitolo finale del romanzo, Gioacchino spiega le ragioni che lo avevano spinto a scrivere, il dubbio tremendo di aver rivelato ai tedeschi il luogo in cui il padre aveva nascosto un disertore, causandone la morte: Al di là di questo, rimaneva in me il bisogno della rivolta in altro ambito, nella scrittura. Il bisogno di trasferire sulla carta – come avviene credo a chi è vocato a scrivere – il mio parricidio, di compierlo con logico progetto, o metodo nella follia, come dice il grande Tizio, per mezzo d’una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente comunicativa, di padri e fratelli – confrères – più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili del disastro sociale. Ho fatto come te, se permetti, la mia lotta, e ho pagato con la sconfitta, la dismissione, l’abbandono della penna46. Gioacchino Martinez descrive a più riprese la esperienza di scrittore come un fallimento. Raccontando la perquisizione avvenuta nel suo appartamento in occasione dell’arresto del figlio, Consolo scrive: Nello studio erano sparsi i libri suoi, storie perenti, lasche prosodie, tentativi inceneriti, miseri testi della sua illusione, del suo fallimento. Ricordò il racconto La perquisizione che appena scritto aveva lasciato sopra il tavolo. Mentre i militi, venuti per il figlio, buttavano giù libri, rovistavano cassetti, armadi, il poliziotto lo leggeva. «Mi sembra di sognare» disse. A lui, primo di
metafore, correlativi obbiettivi, puntelli di rovine. Viene citato qui per la prima volta il racconto La perquisizione, che tornerà a comparire di nuovo in una seconda descrizione dell’irruzione dei poliziotti nella casa. In questo secondo passo, oltre alla scena della perquisizione, si fa riferimento a un sogno dello scrittore, in cui appaiono un glottologo e un re: Ed era nel passato della storia, nei goyeschi disastri d’una guerra, fra contadini rivoltosi, cieche stragi, rapidi processi e fucilazioni contro i muri delle chiese. Era sulle assolate sabbie, il tell che seppelliva il regno, davanti all’archivio, alle tavole d’argilla. Il glottologo sagace ricomponeva frasi, testi, leggeva
il racconto alto d’un re che narra e che governa, elude la metafora, annulla la contraddizione della prosa. Dissolveva il sogno archeologico, le tessere, i cunei della scrittura, l’incubo dei colpi fragorosi dei poliziotti sulla porta, mitra spianati, che irrompono, sconvolgono la casa. Poi reali, a frantumare tutto, urla di sirene, strida di freni, sgommate furiose sulla strada. “Cristo cosa sarà successo ancora, cosa sarà successo?” Terminato il racconto La perquisizione, aveva lasciato il foglio sopra il tavolo47. La scena della perquisizione e il riferimento alla storia del re permettono di identificare senza dubbio il racconto citato nel romanzo con il racconto Un giorno come gli altri dello stesso Consolo. Come spesso accade nello scrittore, i passi maggiormente significativi, su cui si concentra la riflessione e il rovello, risultano ripetuti, con piccole o grandi variazioni, in diverse opere48. In questo caso la riproposizione riguarda proprio il sogno del re e del glottologo, che si rivela fortemente significativo per decifrare il senso ultimo della riflessione sulla difficoltà della narrazione che Consolo, come si è cercato di dimostrare, porta avanti per tutta la sua vita. Vale la pena trascrivere per esteso il sogno – di sapore fortemente borgesiano – come è raccontato in Un giorno come gli altri, passo che poi verrà abbreviato ne Lo spasimo di Palermo: A poco a poco non sento più il rumore delle macchine che sfrecciano sui Bastioni, mi allontano, viaggio per l’Asia Minore e l’Egitto, sprofondo in antichità oscure, indecifrate. M’immagino che nel futuro, fra cinquanta, cento o più anni, i biblio-archeologi non scaveranno più sotto i tell alla ricerca dei Libri, ma sotto montagne di libri, sotto Alpi, Ande, Himalaia di carta stampata, alla ricerca del Libro. Quindi è la volta di Ninive, della biblioteca di Assurbanipal, e di Ebla, delle quindicimila tavolette d’argilla incise dell’archivio di
stato eblaita. Mi sembra di sentire tutto il caldo del deserto siriano, in viaggio traAleppo e Tell Mardikh. Sugli scavi, il glottologo, lo scopritore della lingua eblaita, con fare complice, dopo segni d’intesa dietro le spalle dell’archeologo e dei suoi assistenti, mi conduce di nascosto fino a un piccolo vano della corte. In un angolo, dove l’ombra di un muro taglia l’abbaglio del sole sulle pietre bianche del pavimento, scosta un cespuglio di cardi e di rovi secchi che nascondono una piccola botola. Il glottologo alza la botola, affonda le mani nella bocca buia del pozzetto e tira fuori tavolette d’argilla. «Sono testi letterari » mi dice, e allinea sul pavimento le argille, le compone in un gioco di puzzle come una pagina di un grande libro. «È un racconto» dice, «un bellissimo racconto scritto da un re narratore… Solo un re può narrare in modo perfetto, egli non ha bisogno di memoria e tanto meno di metafora: egli vive, comanda, scrive e narra contemporaneamente…» E punta l’indice su quei bastoncini,
su quella stupenda scrittura cuneiforme e sta per cominciare a tradurmi… 49
Su questo punto, un attimo prima della rivelazione, della comprensione, il narratore
si sveglia a causa dell’irruzione della polizia nella sua casa. Ancora una volta è la realtà della vita contemporanea, nei suoi aspetti più crudi, ad allontanare il senso, a non permettere il dispiegarsi del racconto. D’altronde quello che il glottologo stava per rivelare al sognatore è qualcosa di non dicibile, il racconto di un re che vive, governa, scrive e narra insieme, un racconto composto dunque in un linguaggio perfetto, un linguaggio che non è un linguaggio, in quanto privo di filtri, un linguaggio che fa tutt’uno con la realtà50. In questo modo Consolo risolve l’eterno dissidio tra realtà e parola, ma allo stesso tempo ci dice che tale risoluzione rimane un’utopia.
Solo un re immaginario potrebbe scriverlo e solo un glottologo altrettanto immaginario potrebbe decifrarlo. È la rassegnazione finale al paradosso del linguaggio, lo scacco e l’accettazione della difficoltà di d ire. Dopo verranno Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo, i due romanzi nei quali il tema – come si è cercato di dimostrare – diventa centrale e pervasivo. Dopo ancora, il silenzio. 1 Scrive Traina a questo proposito: «Consolo è comunque fermamente convinto che una prosa non referenziale ma ricercata, piena di echi e risonanze, con picchi di esibita letterarietà o forti sprezzature semantiche, sia la strada necessaria da percorrere per una letteratura che si vuole antagonista rispetto a n’omologazione culturale che è innanzitutto omologazione linguistica, propagandata riduzione del lessico a un basic Italian da comunicazione pubblicitaria» (G. Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole, Cadmo, 2001, p. 104). 2 L’immutabilità della condizione dei subalterni nella storia è un elemento importante di molte opere di Consolo e sembrerebbe essere anzi proprio uno dei motori della sua scrittura. Nell’accoglienza di tre paesani agli americani, il narratore del racconto Lo Sherman vede la stessa cerimonia «di sempre, che sempre ripetono i baroni, proprietari e alletterati con ognuno che viene qua a comandare, per aver grazie, giovamenti, e soprattutto per fottere i villani» (V. Consolo, Lo Sherman, in Id., Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori, 1988, p. 25). 3 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1987, p. 95. 4 V. Consolo, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori, 1992, pp. 167-168. 5 Cit. in J. Fracchiolla, Storia e storie nell’opera di Vincenzo Consolo, inAa.Vv., La pasión por la lengua: Vincenzo Consolo, a cura di I. Romera Pintor, Valencia, Generalitat Valenciana y Universitat de València, 2008, p. 77.
6 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit., p. 96. Anche se qui si tratta di un espediente narrativo per far sì che il personaggio possa raccontare ciò che non ha vissuto in prima persona, tuttavia la commistione tra realtà e finzione è un elemento tipico della scrittura di Consolo e del suo particolare riutilizzo del romanzo storico (cfr. R. Cremante, La sperimentazione di Vincenzo Consolo fra storia e invenzione, inAa.Vv., Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de «Il sorriso dell’ignoto marinaio», a cura di I. Romera Pintor, Valencia, Generalitat Valenciana y Universitat de València, 2007, pp. 63-74; D. Raffini, La scrittura ibrida di Vincenzo Consolo, inAa.Vv., Contro la finzione. Percorsi della non-fiction nella letteratura italiana contemporanea, a cura di C. Baghetti e D. Comberiati, Verona, Ombre corte, 2019, pp. 50-69; Id., I personaggi di Vincenzo Consolo tra verità
storica e finzione romanzesca, inAa.Vv., Il personaggio nella letteratura italiana, a cura di P. Ortolano
eA. Sorella, Firenze, Cesati, 2019, pp. 157-174).
7 Ivi, p. 88.
8 Ivi, p. 89.
9 Ibidem.
10 Ivi, p. 91. 11 C. Segre, Un profilo di Vincenzo Consolo, in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta,
Milano, Mondadori, 2015, p. XIII.
12 Cit. in J. Fracchiolla, art. cit., p. 77.
13 Ibidem.
14 V. Consolo, Nottetempo, casa per casa, cit., p. 175.
15 Id., Lo spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, 2013, p. 58. 16 Id., Nottetempo, casa per casa, cit., pp. 42-43. 17 Ivi, p. 144. 18 Spesso in Consolo la parola nella sua essenzialità viene presentata come ultimo appiglio alla realtà in situazioni estreme. Ne Lo spasimo di Palermo, il protagonista rievoca una scena in cui da bambino, durante un bombardamento, il prete «ordinò di cantare l’aria con parole senza senso, ch’erano forse parodia, scherno d’una liturgia» (V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 10). Perfino privata di significato, ridotta alla pura sonorità, la parola è uno strumento di ancoraggio al mondo, un modo per sopportare il dolore. Dalla parola si può ripartire per la ricostruzione: tornato a Palermo dopo tanti anni di assenza Gioacchino decide di ricominciare documentandosi sul nome della sua via di casa e inizia a risistemare i propri libri, profilando una riconciliazione con la parola che si era rotta nel momento in cui aveva deciso di smettere di scrivere.
19 V. Consolo, Nottetempo, casa per casa, cit., pp. 109-110. 20 Ne Lo spasimo di Palermo Consolo inserisce un incontro tra il protagonista Gioacchino e il
«fantastico bibliotecario, […] cieco poeta bonarense ch’era andato quella volta ad ascoltare nell’affollato anfiteatro» (V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 44).
21 Ivi, pp. 68-69.
22 Ivi, p. 168.
23 Ibidem.
24 G. Traina, op. cit., p. 102. 25 V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 89. Nella stessa pagina viene detto che Gioacchino sta scrivendo un articolo su Cervantes e Antonio Veneziano, pezzo su cui in quegli anni stava lavorando Consolo, citando anche le fonti che lo stesso Consolo userà nel suo articolo. Come si vedrà più avanti,
Consolo attribuisce a Gioacchino anche un altro racconto proprio, Un giorno come gli altri, che nel romanzo prende il titolo La perquisizione. Infine, nel capitolo X, il procuratore attribuisce a Gioacchino un passo del racconto Le pietre di Pantalica di Consolo: «”Ho letto i suoi libri… difficili, dicono. Di uno mi sono rimaste impresse frasi su Palermo” socchiuse gli occhi, recitò: “Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e gelsomino…”. “Sono passati da allora un po’ di anni…” disse Gioacchino» (Ivi, p. 97)
26 Ivi, p. 45. 27 V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 31.
28 Ibidem. 29 V. Consolo, Un giorno come gli altri, «Il Messaggero», 17 luglio 1980, ora in Id., La mia isola è Las Vegas, p. 87. In questo passo Consolo, partendo dalle riflessioni di Benjamin, porta avanti un sottile discorso sulla differenza tra scrivere e narrare, che vale la pena riportare: «È che il narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, a quella lenta sedimentazione su cui germina la memoria, è sempre un’operazione vecchia arretrata regressiva. Diverso è lo scrivere, lo scrivere, per esempio, questa cronaca di una giornata della mia vita il 15 di maggio del 1979: mera operazione di scrittura, impoetica, estranea alla memoria, che è madre della poesia, come si dice. E allora è questo il dilemma, se bisogna scrivere o narrare. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perché il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta». 30 La critica assume a volte i caratteri di una caricatura grottesca: «Mutavano, si deformavano i volti appesi tra le scansie e il soffitto, sparivano sorriso bonomia profondità tormenti serenità entusiasmo comprensione condiscendenza, si leggevano sotto le maschere di quella galleria di scrittori vacuità furbizia vizio rancore supponenza idiozia…» (V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 31) 31 Ibidem. 32 «Il suo andare è il segno ancora umano, la ferita aperta, il dolore immoto, l’antica tragedia sempre in atto. È nostro, è nella cavea del male, la peste dilagante. Dall’inferno di là siamo finiti in questo, nelle nebbie fitte, nella notte… no, io non resto inerme, non voglio esser complice» (ivi, p. 56) 33 Dirà al padre: «Tu e i soavi letterati siete le epigrafi d’ornamento, la lapide incongrua e compiaciuta sul muro di quel carcere mentale, quel manicomio d’annientamento» (ivi, p. 32). In questa frase è racchiusa anche l’impossibilità del figlio di capire la lotta interna del padre, il distanziarsi da quei “soavi letterati” che determina in Gioacchino l’allontanamento dalla scrittura.
34 Ivi, p. 29.
35 Ibidem.
36 Ivi, p. 44.
37 Ivi, p. 8.Anche L’olivo e l’olivastro, che si pone tra i due romanzi qui presi in esame, presenta il tema dell’impossibilità di dire, tanto da aprirsi così: «Ora non può narrare. Quanto preme e travaglia arresta il tempo, il labbro, spinge contro il muro alto, nel cerchio breve, scioglie il lamento, il pianto. Solo può dire intanto che un giorno se ne partì con un bagaglio di rimorsi e pene. Partì da una valle d’assenza
e di silenzio, mute di randagi, nugoli di corvi su tufi e calcinacci» (V. Consolo, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori 1994, p. 9). La posizione incipitaria e finale di questi riferimenti è maggiormente significativa in Consolo, autore che dà molta importanza ai momenti liminari dei suoi libri e dei singoli capitoli.
38 V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 8. 39 Ivi, p. 73.
40 Ivi, p. 5.
41 Ibidem.
42 Ivi, p. 57
43 Ibidem.
44 Ivi, p.109.
45 Ibidem. 46 Ivi, p 108.
47 Ivi, p. 69. 48 Un altro esempio interessante, che si ricollega al discorso sulla storia fatto per Il sorriso dell’ignoto marinaio, è quello della riproposizione di un pensiero espresso da Montesquieu. Commentando le parole lodevoli spese dal filosofo sul fatto che i siracusani abbiano interrotto l’usanza fenicia di sacrificare bambini, Consolo ribadisce la relatività dei punti di vista sulla storia e sulla pervasività del male. Tale passo, con poche modifiche, appare sia in Retablo che nel racconto La grande vacanza orientale occidentale. Ecco come appare in quest’ultimo: «Ammirevole sì, quel trattato, ma l’illuminato barone francese dimenticava che quegli stessi Siracusani, dopo la vittoria, avevano crocifisso tutti i greci che
avevano combattuto accanto ai Fenici-Cartaginesi. È crudeltà, massacro, orrore dunque la storia? O è sempre un assurdo contrasto? Quei Fenici che sacrificavano i loro figli agli dèi erano quelli che avevano inventato il vetro e la porpora, e la scrittura segnica dei suoni, aleph, beth, daleth… l’alfabeto che poi usarono i Greci e i Latini, usiamo anche noi, quei Fenici che, con i loro commerci, per le vie del
mare portarono in questo Mediterraneo occidentale nuove scoperte e nuove conoscenze» (V. Consolo, La grande vacanza orientale-occidentale, in Id., La mia isola è Las Vegas, cit., p. 67). 49 V. Consolo, Lo spasimo di Palermo, cit., p. 96. 50 Nello stesso racconto Consolo indicava nella memoria e nella metafora gli strumenti necessari per mettere in atto la narrazione. Il re del sogno non ne ha bisogno, la sua condizione supera i confini dell’umano, si avvicina al divino, all’assenza di mediazione.