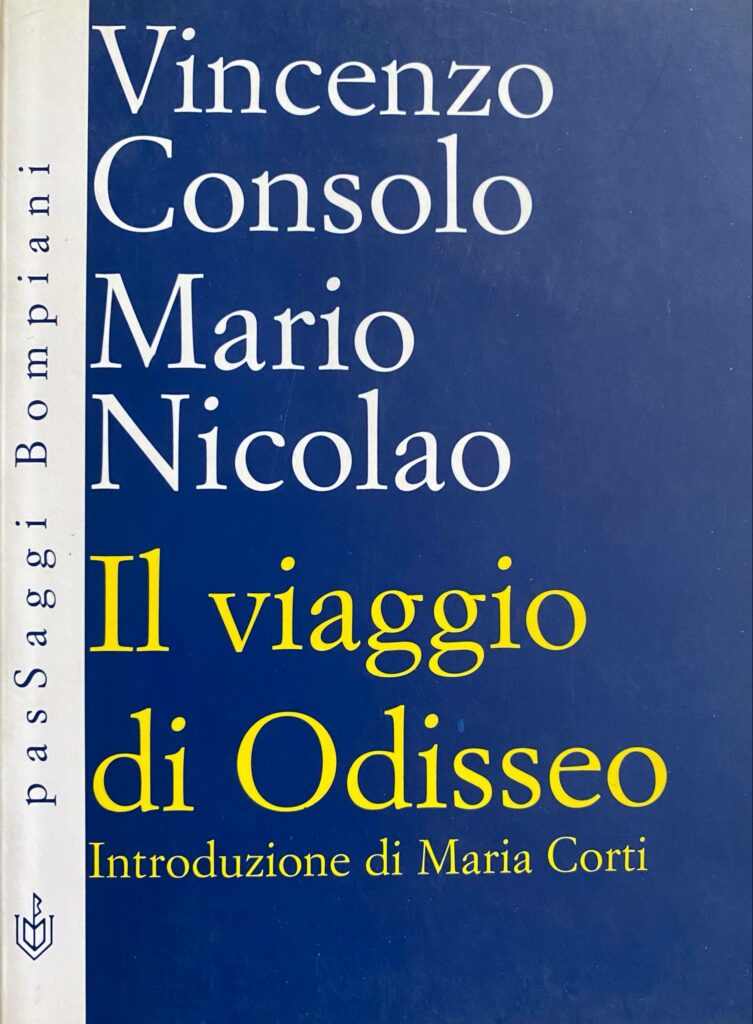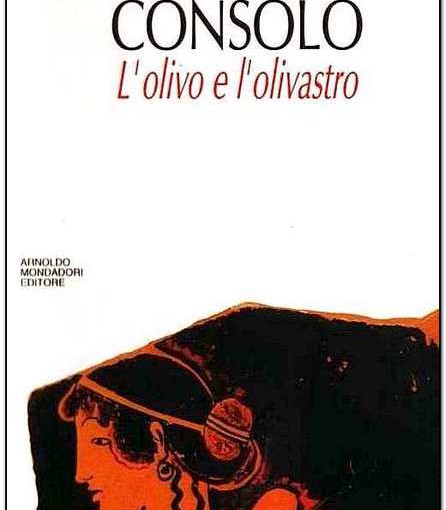ANITA VIRGA (University of the Witwatersrand)

Questo saggio intende analizzare il romanzo di Vincenzo
Consolo Nottetempo, casa per casa (1992) utilizzando il motivo della fine del
mondo come chiave interpretativa dell’opera ed elemento unificante i diversi
piani su cui la narrativa si sviluppa. Se da una parte La nascita della
tragedia di Friedrich Nietzsche costituisce un modello intellettuale di
riferimento e di confronto per il romanzo consoliano, dall’altra le
considerazioni dell’antropologo Ernesto De Martino sull’apocalisse ci
permetteranno di proporre Nottetempo come una risposta psicologica, culturale e
letteraria al rischio della “fine” esperito in questi tre diversi ambiti. Nel volume postumo che raccoglie gli appunti
preparatori all’opera rimasta incompiuta La fine del mondo, De Martino
approccia il tema dell’apocalisse derivando una connessione tra il senso di
fine del mondo vissuto nel disagio psicologico individuale e le grandi
apocalissi culturali elaborate dalle società o da singoli attori collettivi
operanti in esse. Anticipando i temi di questa ricerca in un articolo comparso
un anno prima della morte dell’antropologo su Nuovi argomenti, egli chiariva il
nesso tra apocalisse individuale e apocalisse collettiva nei seguenti termini:
“i caratteri esterni delle apocalissi psicologiche sembrano riprodursi anche in
quelle culturali, dato che anche le apocalissi culturali racchiudono l’annunzio
di catastrofi imminenti, il rifiuto radicale dell’ordine mondano attuale, la
tensione estrema dell’attesa angosciosa e l’euforico abbandono alle
immaginazioni di qualche privatissimo paradiso irrompente nel mondo” (De
Martino, 1964:111). Il compito delle apocalissi culturali sarà allora proprio
quello di scongiurare la fine, costituendosi come difesa e reintegrazione del
rischio della fine esperito nell’apocalisse psicopatologica: esse, cioè, hanno
il compito di rivalorizzare a livello collettivo e condiviso ciò che nella
crisi personale diventa perdita di senso, incapacità di dare valore e incapacità
di operare nel mondo quotidiano, decretandone così la sua fine. Tuttavia,
avverte De Martino, “se il dramma delle apocalissi culturali acquista rilievo
come esorcismo solenne, sempre rinnovato, contro l’estrema insidia delle
apocalissi psicopatologiche, è anche vero che questo esorcismo può riuscire in
varia misura, e di fatto può sbilanciarsi sempre di nuovo verso la crisi
radicale” (De Martino, 1964:113). Anche le apocalissi culturali, dunque,
possono incorrere nel rischio di essere “nuda crisi” senza possibilità di
rinnovamento, “senza escaton”, rischio che De Martino intravedeva
nell’apocalisse dell’occidente contemporaneo che “conosce il tema della fine al
di fuori di qualsiasi ordine religioso di salvezza, e cioè come disperata
catastrofe del mondano, del domestico, dell’appaesato, del significante e
dell’operabile” (De Martino, 2002:470). Il doppio piano della crisi
psicopatologica individuale e della crisi esperita dalla società nel suo
insieme è colta da Consolo in Nottetempo attraverso il dispiegamento di una
fantasmagoria di personaggi reali e fittizi e attraverso l’ambientazione
storica. Il contesto storico nel quale tali personaggi operano (i primordi del
Fascismo), infatti, è rappresentato e
interpretato secondo i modi di una apocalisse storica che rischia di essere
“nuda crisi”, catastrofe senza rinnovamento. Essa, inoltre, fa eco e diventa
metafora per il presente: l’inizio del Ventennio fascista, infatti, diventa
anche il mezzo per parlare dell’inizio della Seconda Repubblica1 – l’anno
di
*
1 Lo stesso autore, chiarendo come il passato sia una metafora per il presente, evidenzia il carattere “apocalittico” di tale passato e tale presente: “Dopo il Sorriso, ho continuato a scrivere romanzi storici […]. L’ultimo, Nottetempo, casa per casa, è ambientato negli anni
**
pubblicazione del libro si colloca proprio nel passaggio tra la fine di un mondo e l’inizio di una nuova era per la società italiana, nonché pare profeticamente avvertire la crisi culturale che sarà presto inaugurata dall’ascesa di Berlusconi al potere. Come De Martino, Consolo avverte nel presente il senso di una fine che non prevede un nuovo inizio, mentre individua nel passato eventi apocalittici che hanno segnato un rinnovamento: ne è esempio concreto la rinascita della Val di Noto attraverso il barocco dopo il terremoto del 16932. Con Nottetempo siamo, dunque, nella Cefalù dei primi anni Venti e un uomo corre forsennatamente nella notte, in preda al “male catubbo”, una forma di depressione in cui l’interpretazione popolare riconosce il licantropismo 3, o “male di luna”, come aveva già mirabilmente descritto Pirandello in una sua omonima novella. Veniamo in seguito a sapere che egli è il padre di una famiglia tormentata dal male interiore, per cui il licantropismo cui è soggetto non può essere spiegato solamente con una diagnosi scientifica, ma ha ragioni ben più profonde. La moglie (“troppo presto assente”) è morta e le due figlie sono affette da problemi psicologici: l’una, Lucia (“che sola e orgogliosa se n’andava per altra strada”), è mentalmente instabile e verrà rinchiusa in una clinica, l’altra, Serafina (“torbida, di pietra”, 106), vive in uno stato catatonico. Petro, il figlio eventi,
, che mi sembrano terribilmente somiglianti a questi che
stiamo vivendo, anni di crisi ideologica e politica, di neo-metafisiche, di
chiusure particolaristiche, di scontri etnici, di teocrazie, integralismi […]
Il Sorriso e Nottetempo formano un dittico. […] Nel primo ho voluto insomma
raccontare la nascita di un’utopia politica, della speranza di un nuovo assetto
sociale; nel secondo, il crollo di quella speranza, la follia degli uomini e la
follia della storia, il dolore e la fuga” (Consolo, 1993:47-48). 2 Nel capitoletto La rinascita del Val di Noto
compreso in Di qua del faro, Consolo descrive il terremoto che distrusse la Sicilia
orientale alla fine del ’600 proprio usando il termine “apocalisse” e
riconoscendo nell’arte barocca un valore escatologico: “E però il Barocco non è
stato solamente il frutto di una coincidenza storica. Quello stile fantasioso e
affollato, tortuoso e abbondante è, nella Sicilia dei continui terremoti della
natura, degli infiniti rivolgimenti storici, del rischio quotidiano della
perdita d’identità, come un’esigenza dell’anima contro lo smarrimento della
solitudine, dell’indistinto, del deserto, contro la vertigine del nulla”
(Consolo, 2001a:99). 3 Spiega Consolo:
“Il padre si ammala di depressione, che nel mondo contadino arcaico viene
chiamata licantropia. Questo fenomeno è stato studiato dalla principessa di
Lampedusa, che era una psicanalista che ha associato la licantropia alla depressione:
nel mondo rurale questi poveretti che soffrivano terribilmente, uscivano fuori
di casa, magari urlavano e venivano scambiati per lupi mannari” (Consolo,
2001b). protagonista del romanzo, è affetto dalla malinconia, da una tristezza
le cui origini egli stesso rintraccia in un tempo primordiale, un tempo perso
nel tempo, di cui il nome della famiglia, Marano4, ne è spia: “‘Da quale
offesa, sacrilegio viene questa sentenza atroce, questa malasorte?’ si chiedeva
Petro. Forse, pensava, da una colpa antica, immemorabile. Da quel cognome suo
forse di rinnegato, di marrano di Spagna o di Sicilia, che significava eredità
di ànsime, malinconie, rimorsi dentro nelle vene” (42). E più oltre riflette
ancora che quel dolore sembra essere sorto “da qualcosa che aveva preceduto la
sua, la nascita degli altri” (106). La famiglia del protagonista e Petro stesso
rappresentano così un articolato inventario dell’apocalisse psicopatologica:
ognuno, chiuso nella propria incomunicabile individualità, esperisce solitariamente
il “delirio di fine del mondo”, cioè la perdita della “normalità” del mondo e
della possibilità dell’intersoggettività
dei valori che lo rendono un mondo possibile e umano. Del male che affligge la famiglia, tuttavia,
si intravede anche una motivazione più contingente e precisa in quel
cambiamento di status, peraltro non giustificato dalle convenzioni sociali, che
verghianamente aleggia sulla famiglia come una rovina: il padre ha ricevuto
infatti l’eredità di un signore locale che ha preferito beneficiare la famiglia
Marano piuttosto che suo nipote, il barone Don Nenè, legittimo erede. La
menzione di questo avanzamento sociale, all’origine anche dell’inimicizia fra
Petro e Don Nenè, viene lasciata cadere qua e là nel romanzo come fosse la
colpa da cui discende tutto il male che gravita sulla famiglia. La ragione
dell’impossibilità del matrimonio fra Lucia e Janu è quella verghiana5 che
impedisce
*
4 “Ho adottato questo nome perché ha due significati per me. Marano significa marrano, cioè è l’ebreo costretto a rinnegare la sua religione e a cristianizzarsi, perché in Sicilia con la cacciata degli Ebrei nel 1492 – così come in Spagna, – ci furono quelli che andarono via ma anche quelli che rimasero e furono costretti a convertirsi. È stata una forma di violenza. Ho dato il nome di Marano a questa famiglia con questa memoria di violenza iniziale e poi per rendere omaggio allo scrittore Jovine che chiama il suo personaggio principale Marano ne Le terre del sacramento, quindi è un omaggio a una certa letteratura” (Consolo, 2001b). 5 E Verga, non a caso, costituisce modello forte e necessario per Consolo, non solo a livello tematico in quanto “cantore” degli umili e ultimi, ma anche a livello stilistico in quanto sperimentatore: “La mia opzione è stata sulla scrittura espressiva che aveva come archetipo un mio conterraneo, Giovanni Verga, che è stato il primo grande rivoluzionario stilistico nella letteratura moderna. Da lui si passava, attraverso altri scrittori, come Gadda e
**
inizialmente ad Alfio Mosca di prendere in moglie la Mena. Lucia si innamorerà poi di un uomo il cui mancato ritorno dalla guerra le procurerà la ferita fondamentale che la porterà alla pazzia; Petro riflette allora che Janu “quell’uomo buono, schietto, avrebbe forse rasserenato la sorella […], cambiato la sua sorte, e provò pena per lui, per Lucia, rabbia per quell’assurdo vallone che s’era aperto fra loro due” (63). Ma su questo motivo verghiano della condizione di classe si innesta quello della roba inteso come voracità di accumulo sconsiderato di beni; si instaura il dubbio che la vera causa della perdita della ragione, il dolore che porta alla pietrificazione, possa trovarsi in quell’accumulo, in quella roba: “Petro si diceva come sarebbe stato meglio per Serafina, per Lucia, non aver avuto nulla, essere incerte nella roba, ma salde nella persona, nel volere, coscienti e attive” (114). Si intravede qui, solo accennata, anche una critica al capitalismo sfrenato e al consumismo, che è in definitiva accumulo di roba per la roba, senza altra finalità. La condizione psicopatologica individuale, dunque, prende forma e mette radice anche in una condizione di “malattia” più generale della società feticizzata, che per questa ragione non è più in grado di generare valori umani ma si accascia su se stessa senza rinnovamento e nuovo significato. Accanto ai Marano, compare poi tutta una sfilza di personaggi che ruotano attorno all’arrivo a Cefalù di un individuo alquanto eccentrico e realmente esistito, il satanista inglese Alastair Crowley, il quale si insedia in una villa poco fuori paese e lì celebra i propri riti coinvolgendo diverse persone. Le proteste contadine e le azioni degli squadristi fascisti, infine, connotano il clima storico e sociale all’interno del quale le vicende si muovono.
Pasolini” (Consolo, 2001b). Lo stesso concetto è ribadito qualche anno dopo in un’altra intervista: “in generale mi sono sempre mosso nel solco gaddiano (solco tracciato per primo, nella letteratura italiana moderna, da Verga)” (Ciccarelli, 2006:96). Si veda anche il commento di Ferroni: “Il suo espressionismo tutto siciliano parte da Verga, dal serrato confronto con lo scrittore verista con il parlato e con la tradizione letteraria, e giunge come a rendere più densa e aggrovigliata la miscela verghiana” (Adamo, 2007:7). Infine, si legga anche il capitolo “Verghiana” in Di qua dal faro.
I tempi dell’apocalisse consoliana: moto e impetramento
Il senso della fine del mondo, cioè la caduta o perdita di questo mondo possibile, si manifesta nel romanzo attraverso due movimenti tra loro opposti che si estremizzano senza armonia: da una parte un moto vano e dall’altra una stasi pietrificata. De Martino individua in questi due poli due segni uguali e contrari della fine del mondo:
Il mondo che diventa “immobile”, il divenire che perde la sua “fluidità”, la vita che si devalorizza costituiscono un momento vissuto dell’ethos del trascendimento che muta di segno: l’altro momento è l’universo in tensione, la onniallusività dei vari ambiti in cerca di semanticità, la forza che travaglia questi ambiti e li sospinge ad andare oltre i loro limiti in modo irrelato, e che li fa partecipare caoticamente a tutto il reale e a tutto il possibile, senza sosta e senza offrire mai un appiglio operativo efficace. La polarità di immobilità e tensione, di rigidezza e forza onniallusiva, di crollo degli appigli operativi e di irrelata scarica psicomotoria, porta il segno dell’alterità radicale e dell’essere-agito-da, cioè il segno dell’alienazione nel senso patologico del termine: in tutti i vissuti cui dà luogo, si manifesta infatti il diventar altro proprio di ciò che sta alla radice dell’io e del mondo, l’annientarsi dell’energia valorizzante delle presenza, il non poter emergere come presenza al mondo e l’esperire la catastrofica demondanizzazione del mondo, il suo “finire”. (De Martino, 2002:631)
Tutti i personaggi di Nottetempo sono tesi ora verso un polo
ora verso l’altro, manifestando e vivendo in maniera diversa il disagio della
catastrofe imminente. Il movimento cui si abbandonano alcuni personaggi, tra
cui in primo luogo il satanista inglese – e che a livello sociale richiama
anche l’imperativo all’azione degli squadristi fascisti – diventa un’agitarsi
vano e inconcludente, un muoversi legato al caos e irrelato al mondo degli
oggetti, dunque privo di significato e incapace di crearne. Questo agitarsi
vano è anche un modo per nascondere e non dover fermarsi a fissare il dolore
che permea l’esistenza umana; infatti, fissare questo dolore può portare alla
pietrificazione, alla stasi completa, se non si riesce ad elaborare tale
sofferenza in maniera produttiva. Osservare questa profonda realtà in un
momento in cui l’individuo o la società nella sua interezza non riescono a
creare valore e significato per tale sofferenza può essere tanto rischioso
quanto guardare negli occhi la Gorgone: è un atto che conduce alla
pietrificazione, la stasi, che racchiude in sé tutto ciò che è mancante di
movimento, ma anche assenza di parola, impossibilità del dire, del
rappresentare e del comunicare. A questa condizione dell’esistenza umana
corrisponde in Consolo quella narrativa, sospesa tra il rischio di dire troppo
dicendo nulla – il vuoto della retorica6 – e la pagina bianca, il non scrivere
e il non dire. Nei poli dell’apocalisse
consoliana possiamo riconoscere una degenerazione dei due impulsi che concorrono
a formare la tragedia greca così come è descritta dal filosofo tedesco
Friedrich Nietzsche in La nascita della tragedia greca: il dionisiaco e
l’apollineo. Il dionisiaco, che dà origine al coro della tragedia, è l’ebbrezza
estatica in cui grazie all’annullamento della soggettività l’uomo può entrare
in contatto con l’“unità originaria” del tutto e riconciliarsi con la natura; è
movimento, danza, musica, scatenamento degli istinti e delle pulsioni vitali.
L’apollineo, invece, è contemplazione, sogno, creazione di immagini,
rappresentazione; nella tragedia è l’“oggettivazione dello stato dionisiaco”
(Nietzsche, 2003:122) del coro, dunque la scena, il dramma. Nell’apollineo si
intravede la qualità statica della contemplazione, di immagini nelle quali si
riduce l’azione; una staticità che Nietzsche definisce come “silenziosa
bonaccia della contemplazione apollinea” (Nietzsche, 2003:103). L’interazione e
l’equilibrio tra l’apollineo e il dionisiaco è ciò che dona forma alla tragedia
greca; Consolo, tuttavia, vede nella modernità la perdita di questo equilibrio
e la perdita della forza creatrice dei due impulsi nietzschiani: il dionisiaco
diventa disumanità, movimento falso, scatenamento di istinti bestiali che
invece di connettere l’uomo con una supposta unità originaria, lo
*
6 “La rottura del rapporto tra intellettuale e società ha lasciato un vuoto di cui si è impadronita una comunicazione che è sempre impostura; è la voce del più forte, la verità falsata del potere” (Consolo in Papa, 2003:193).
**
disconnette dall’umano, dalla comunità e non lo lega né alla dimensione del divino, né alla dimensione di una realtà o verità profonda; e l’apollineo è pura stasi, è l’essere intrappolati nella contemplazione di immagini di dolore. Questi due impulsi generano in Consolo un presente caratterizzato da una tragedia degenerata, priva di catarsi, priva di conclusione; egli stesso lo spiega a commento della propria opera: “l’anghelos, il narratore, non appare più sulla scena poiché ormai la cavea è vuota, deserta. Sulla scena è rimasto solo il coro, il poeta, che in tono alto, lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi” (Consolo 1996:258). In un’opera successiva, L’olivo e l’olivastro (1994), lo scrittore individuerà nella metafora dell’“olivo”, l’albero innestato, l’albero che nasce dalla cultura e dalla civiltà, e dell’“olivastro”, l’albero selvatico, un’altra metafora per esprimere il senso di perdita dell’armonia di due opposti impulsi che, come l’apollineo e il dionisiaco, dovrebbero formare il senso e il valore della civiltà, di un mondo umanamente abitabile: “spuntano da uno stesso tronco questi due simboli del selvatico e del coltivato, del bestiale e dell’umano, spuntano come presagio di una biforcazione di sentiero o di destino, della perdita di sé, dell’annientamento dentro la natura e della salvezza in seno a un consorzio civile, una cultura” (Consolo, 2012a:13-14). Essi “non si combattono: al contrario, si completano. Essi si uniscono in lui [in Ulisse] armoniosamente come il ceppo materno e il ceppo paterno” (Consolo, 1999:25). Ma il dramma della modernità, ciò che porta la civiltà occidentale a vivere la propria apocalisse, è il sopravvento dell’olivastro sull’olivo: “Ecco, nell’odissea moderna è avvenuta la separazione tra il selvatico e il coltivato. L’olivastro ha invaso il campo” (Consolo, 1999:25). Come l’apollineo e il dionisiaco hanno perso la loro forma rendendo la tragedia moderna priva di catarsi, così l’olivo e l’olivastro non coesistono più armonicamente nel tronco della civiltà portando questa verso il suo tramonto.
Primo tempo: il movimento artificioso
In Nottetempo, come già accennato, il polo del movimento è rappresentato in primo luogo dall’inglese satanista e reso con particolare efficacia in un capitolo, La Grande Bestia 666, che reca significativamente in esergo una citazione dall’apocalisse di Giovanni. Aleister Crowley inscena un allucinante e allucinato rito orgiastico che dovrebbe in qualche modo rifarsi all’Arcadia greca, riproporne i miti, riconnettersi con un mondo antico e aureo, ma che nella realtà non è che una degradata imitazione di forme vuote e, soprattutto, una degradata riproduzione di un rito dionisiaco in cui l’ebrezza, la musica, la danza dovrebbero portare alla visione estatica. Il capitolo principia, infatti, con la descrizione di un ballo, che ci immette subito nella sfera del movimento senza arresto, nonché nel regno dionisiaco. È Aleister, immedesimato in una ballerina, a compiere prodezze sostenuto “nella felice trascendenza dai vapori d’oppio, d’etere, di hashish, di cocaina” (85). Il ritmo diventa sempre più incalzante, i lunghi elenchi che riempiono la pagina riproducono il “suono della vibrante cetra, dei cembali tinnanti, dell’acciarino acuto, del timpano profondo” (83) con cui si apre il capitolo; si veda, a titolo di esempio, questa lista di nomi che connotano l’essenza fittizia di Aleister, senza sosta, in un ritmo incalzante che toglie il fiato alla lettura: In lui c’era stato il tebano Ankh-f-n-Khonsu, Ko Hsuan discepolo di Lao-Tze, Alessandro VI Borgia, Cagliostoro, un giovane morto impiccato, il mago nero Heinrich Van Dorn, Padre Ivan il bibliotecario, un ermafrodita deforme, il medium dalle orecchie mozze Edward Kelley, il dottor John Dee, l’evocatore d’Apollonio di Tyana, il gran cabalista Eliphas Levi, in lui, il gentiluomo di Cambridge, Aleister MacGregor, Laird di Boleskine, principe Chioa Khan, conte Vladimir Svareff, Sir Alastor de Kerval, in lui, la Grande Bestia Selvaggia, To Mega Thérion 666, Il Vagabondo della Desolazione, Aleister Crowley (dàttilo e trochèo). (84)
È un elenco dal ritmo vorticoso, che confonde in una sorta di ubriacatura di parole: Consolo rende in tal modo, con un linguaggio che si fa nietzscheanamente metafora del suono7, il senso di un vano agitarsi. Questo moto, sostenuto dall’uso delle droghe, si connota come anormale e nella collezione di identità in cui di volta in volta Aleister Crowley si identifica possiamo vedere un sintomo di schizofrenia e psicopatologia connessa a uno stato epilettico, analizzando il quale De Martino individua il principio del moto distorto come una delle sue caratteristiche: “in tutto sta in primo piano l’elemento del moto: l’alterazione del movimento, la perdita dell’equilibrio, lo scuotimento della sicurezza e della tranquillità nel mondo delle cose, conducono alla conclusione: il mondo crolla, sprofonda” (De Martino 2002:38). Ma quando Janu, “this sicilian caprone” (80) – il satiro – rifiuta di prendere parte al rito, di consumare l’orgia, e scappa, il movimento vorticoso si arresta; il cielo di carta pirandellianamente si squarcia e la messa in scena rivela il proprio carattere fittizio, scoprendo per un attimo la falsità della vita stessa che il rito attraverso il vortice del ballo cercava di occultare: “Declamò ancora più forte la danzatrice in terra. Restò immobile. Attese. S’era interrotta ogni musica, ogni nota, sospeso ogni sussurro, fiato, il silenzio freddo era calato nella sala” (88). È l’assenza di movimento e di parola a rivelare la realtà, a svelarla:
Sentì ch’era sopraggiunto quel momento, quell’attimo tremendo in cui cadeva dal mondo ogni velario, illusione, inganno, si frantumava ogni finzione, fantasia, s’inceneriva ogni estro, entusiasmo, desiderio, la realtà si rivelava nuda, in tutta l’insopportabile evidenza, cava si faceva la testa, arido il cuore. […] Guardava il mondo in quello stato, si guardava intorno, e ogni cosa gli appariva squallida, perduta. (89)
7 Il linguaggio, secondo il filosofo tedesco, nasce da un impulso nervoso che si trasferisce in immagine e poi in suono. Il linguaggio della poesia del canto popolare è quello che meglio di qualunque altro riesce “nella imitazione della musica” (Nietzsche, 2003:101).
È il momento drammatico della rivelazione. Il rischio è la stasi, ma Aleister la scongiura chiedendo che gli venga data altra droga per ridiscendere nella condizione di trance e ricreare un mondo fittizio. Il capitolo, tuttavia, si chiude bruscamente con un altro svelamento, un altro squarcio che irrompe in questa realtà: l’annuncio che l’infante, il figlio di Aleister, è morto. Segue “tutto un trambusto, un irrompere all’aperto, un correre nella notte” (99), ma ovviamente invano, perché la stasi suprema, la morte, si è già impossessata della piccola Poupée. Nella scomparsa dell’infante è da leggersi, metaforicamente, la morte di ogni speranza e del futuro. È anche presagio della futura “apocalisse” che si abbatterà un ventennio dopo su tutta l’Europa nella forma della Seconda Guerra Mondiale causata dai fascismi. Aleister, infatti, rappresenta anche l’irrazionalità e la bestialità del fascismo, se è vero che intorno a lui si convogliano personaggi simpatizzanti e legati al fascismo, come il barone Nenè e la sua cricca, e che lo stesso inglese viene nominato come Superuomo, “colui che aveva varcato ogni confine, violato ogni legge, che aveva osato l’inosabile, lui, la Grande Bestia dell’Apocalisse” (90). Ed egli, nel tentativo di ricreare un mondo antico attraverso una messa in scena irrazionale, si fa simulacro del progetto di Mussolini e del Duce stesso, di colui che ha “varcato ogni confine” umano, reale e metaforico. Per Consolo apocalisse è anche questa: l’andar oltre il limite, il troppo, il movimento che travalica il confine, come l’ultimo viaggio dell’Ulisse dantesco oltre le colonne d’Ercole. In molti, infatti, hanno riconosciuto nei personaggi dello scrittore siciliano dei moderni Ulisse condannati a una continua peregrinazione dove non esiste l’Itaca a cui tornare8 – tema d’altronde, quello della perdita di Itaca, comune a molta letteratura moderna italiana, per cui il ritorno è sempre impossibile, a iniziare dal ‘Ntoni verghiano. E proprio i personaggi del romanzo di Aci Trezza sono descritti da Consolo in
8 Si veda su tutti l’articolo di Massimo Lollini “La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo.” Italica 82.1 (Spring 2005), in cui l’autore analizza le varie figure ulissiache di Consolo, tra cui il personaggio inglese Alastair, il barone Nenè e Petro di Nottetempo. Lollini arriva a far coincidere la figura di Ulisse con quella di Consolo stesso, testimone dello spaesamento e del peregrinamento dell’uomo moderno, descritto “in toni che a tratti si fanno apocalittici” (38), soprattutto quando lo sguardo cade sulle odierne devastazioni che occorrono lungo il Mediterraneo.
L’olivo e l’olivastro come in continua preda di un movimento, una frenesia che ha esplicitamente i caratteri dell’apocalisse: “[il popolo di formiche] visse in quell’apocalisse del movimento rapido, nella vitalità guizzante, nella ferocia del possesso, nel tetro accumulo, nel tumore divorante” (Consolo, 2012a:40). L’Ulisse consoliano è privo di connotazioni romantiche ed eroiche, divenendo anzi spesso simbolo non solo dello spaesamento dell’uomo moderno ma anche della sua folle ricerca di un superamento dell’umano e dei suoi limiti contingenti: “Il soggetto etico di cui i romanzi di Consolo si fanno portavoce […] insiste sull’importanza di una riflessione sui limiti stessi della scrittura, che poi sono i limiti della civiltà, del tentativo di apprezzare e definire i contorni di una cultura della finitudine umana” (Lollini, 2005:34). Il movimento e il dionisiaco degenerato si connotano, perciò, in termini distruttivi e apocalittici quando significano tentativo di superamento dell’umano, che è anche sempre violenza disumana, bestiale. Il varcare le colonne d’Ercole si pone dunque per Consolo entro una dimensione etica che non riguarda più solamente l’individuo e il suo singolare confronto con la divinità, con l’oltre, ma riguarda l’individuo in quanto parte di una comunità9: questo Ulisse moderno senza possibilità di ritorno non è un eroe solitario in lotta contro forze superiori, ma è uomo le cui scelte e le cui azioni sono e si iscrivono sempre entro una dimensione etica che riguarda tutta la comunità circostante. In questo vediamo delinearsi la responsabilità del satanista inglese Alaister che non può essere circoscritta geograficamente e temporalmente all’interno di ciò che avviene nella villa a Santa Barbara, la villa appartata che egli sceglie come dimora. Alaister diventa emblema e portavoce di un modello di ricerca che sfocia nel disumano e che ha come vittima il più piccolo, nonché futuro, della comunità. La vittima, tuttavia, non è prevista dal rito e perciò non è sacrificale; essa, rimanendo legati al significato etimologico del termine, non entra nel regno del sacro e non si connette con una spiritualità superiore, ma rimane ancorata al senso profano, alla materialità terrena, non assume nessun valore superiore.
9 Così, d’altra parte, lo intende anche Dante, collocando Ulisse nell’inferno non già perché ha sfidato gli dei, quanto piuttosto perché si è allontanato dalla comunità degli uomini, trascinando alla rovina anche i suoi compagni.
Diventa una morte disumana, legata al superamento del limite, e non una morte sacra, una morte che può trascendere nel significato.
Secondo tempo: l’incedere umano
È, dunque, attraverso il recupero del senso dell’umano che il movimento può ritrovare il suo giusto ritmo, la sua misura, e non eccedere verso il limite dell’apocalittico, che è superamento dell’umano. Un passo del capitolo successivo a La Grande Bestia 666 collega le tematiche del movimento apocalittico e della stasi con la ricerca di una dimensione umana che possa scongiurare i due estremi. La riflessione avviene in occasione dell’incontro tra Petro e Janu, che per tanti mesi era scomparso e ora appare cambiato:
Pensò Petro a come si può cangiare in poco tempo, al tempo che scorre, precipita e niente lascia uguale. Che solo la disgrazia, la pena grave blocca il movimento, il cuore la memoria, come una bufera immota, un terremoto fermo, una paura assidua che rode, dissecca, spegne volere gioia. E sbianca e invecchia, mentre che dentro la ferita è aperta, ferma a quel momento, nella sfasatura, nella disarmonia mostruosa. Una suprema forza misericordia immensa potrebbe forse sciogliere lo scempio, far procedere il tempo umanamente. (105, corsivo mio)
Petro, dunque, minacciato costantemente come i suoi familiari dal pericolo dell’arresto del tempo, dell’immobilità, scorge dentro sé una via diversa da quella del satanista inglese o del fascismo: movimento sì, movimento che significa vita, ma che “proceda umanamente”. Appare evidente il contrasto con il movimento vorticoso, ossessivo, ritmico e in definitiva artificiale che ha animato il rito delle pagine precedenti. Solo nel tempo umano c’è la possibilità di salvarsi dall’apocalisse. È questo il tempo della memoria, il tempo che può essere articolato dalla coscienza umana, il tempo entro cui può risiedere l’umano. È perciò anche progetto di scavo, archeologia del tempo, del passato da cui recuperare frantumi, frammenti di umanità, come nota Bouchard: “Consolo allows the ruins of the past to haunt the surface of his narratives with the intent of making current the wounds and the lacerations of history. Since these are wounds and lacerations that can no longer be abreacted by a successful work of mourning, they give rise to an interminable writing of melancholy that displaces the ontological certainty of our reality while pointing towards a better future that can only be built out of the memory traces of the past” (Bouchard, 2005:17).
Terzo tempo: “il male di pietra”
Il tempo che scorre umanamente è costantemente minacciato dall’altra possibilità: dall’arresto. È questa la metafora più efficace e pregnante in Consolo, poiché è il rischio che egli stesso in quanto scrittore – e in quanto uomo – corre, è il pericolo che costantemente gravita sulla sua scrittura e che ritorna quasi ossessivamente da una pagina all’altra: è il pericolo che incombe su chi acquista la consapevolezza della realtà, chi sente la sofferenza declinata sia come male di vivere dell’uomo sia nella sua contingenza come male dell’epoca contemporanea. Consolo, rifiutando l’uso di un linguaggio comune troppo abusato e vuoto, cioè la parola che danza ma non dice, cede inevitabilmente il passo alla pietrificazione, alla stasi della parola. Ed è dunque su questo punto che si arrovella, è questo il cruccio della sua scrittura nonché quasi il paradosso dell’urgenza del dire in un mondo dove non è più possibile dire. È questa la degenerazione apollinea di una rappresentazione, qui propriamente intesa come drama, che si pietrifica in un’unica immagine di sofferenza. Ben giustamente Arqués cita Calvino e il suo saggio sulla leggerezza a proposito di Consolo, ma lo fa per stabilire un parallelo tra la narrazione storica dello scrittore siciliano e Perseo, o, meglio, tra la realtà presente e la Gorgone, che non può essere guardata negli occhi, pena la pietrificazione. La metafora, tuttavia, acquista maggior pertinenza se nella figura della Gorgone non proiettiamo semplicemente il presente, ma il dolore, la realtà profonda che soggiace a ogni esistenza, quel male di vivere che non può essere nominato se non con una descrizione e che a seconda di chi parla e del momento può assumere forme diverse, ma che è anche sostrato universale che accomuna l’uomo di tutte le epoche e i luoghi. È quel senso di verità e dolore che, appunto, se viene fissato direttamente, scoperto e guardato nella sua cruda interezza pietrifica, proprio come il mostro mitologico. Calvino userà allora la leggerezza come specchio per guardare quella pesantezza dell’esistere; Consolo, invece, sa che anche il linguaggio è costantemente minacciato dal vano agitarsi di parole e perciò sente di non poter più praticare una lingua troppo tarata da forme vuote; correrà perciò sempre il rischio, come i suoi personaggi, di pietrificarsi fissando la medusa. In Nottetempo il personaggio cui è assegnata la sfida di trovare la giusta misura, il tempo umano, è Petro, che nel nome porta chiaramente il significato di quel cadere nella contemplazione del male d’esistere. Il primo capitolo, nel quale si svolge l’inseguimento notturno di Petro nei confronti del padre affetto dal “male catubbo”, stabilisce il campo semantico entro cui ci dobbiamo confrontare: il licantropismo, fenomeno dell’uomo tramutato in lupo, ci pone nel regno delle metamorfosi. Qui il riferimento classico è ovviamente Ovidio10, di cui la studiosa Galvagno riconosce una caratteristica fondamentale: “La métamorphose ovidienne, soit humaine, animale, végétale, liquide ou minérale (y compris les catastérismes), présuppose comme son moyau le plus intime une pétrification, une immebolité, une fixité de l’être métamorphosé” (Galvagno, 2007:179). Ora tale tratto della pietrificazione dell’essere sarebbe presente, secondo la studiosa, nella scrittura di Consolo – e abbiamo già citato, non casualmente, il mito di Perseo. Tutto in Nottetempo sembra essere sull’orlo della pietrificazione: personaggi, azioni, eventi, il tempo, la scrittura. Pietrificazione
10 Esistono differenti possibilità di interpretazione e stratificazioni di significato nella figura dell’uomo trasformato in lupo, nonché naturalmente differenti storie e tradizioni e appropriazioni di tali tradizioni da parte della letteratura, ma vale forse qui la pena ricordare il racconto che fa Ovidio di Licàone, trasformato in lupo da Giove perché progettava di uccidere il dio. Giove racconta: “[…] io con fuoco vendicatore faccio crollare quella casa indegna del suo padrone. Lui fugge, atterrito, e raggiunti i silenzi della campagna si mette a ululare: invano si sforza di emettere parole” (Ovidio, 1994:15). E dopo Giove invocherà l’apocalisse: la distruzione del genere umano, perché indegno, corrotto e criminale. Si legga, per confronto, il passo di Consolo: “Si spalancò la porta d’una casa e un ululare profondo, come di dolore crudo e senza scampo, il dolore del tempo, squarciò il silenzio di tutta la campagna” (6). E subito dopo l’episodio del lupo mannaro, comparirà sulla scena il satanista Aleister. richiama sia la stasi, l’assenza di movimento, di parola, sia il senso del peso, come aveva rilevato Calvino: la pesantezza dell’essere. E infatti chi si pietrifica è chi fissa, immobile, e contempla tale pesantezza, diventando egli stesso o ella stessa di pietra, avvertendo su di sé tutta la pesantezza del male e sprofondando nel silenzio. Il silenzio e l’impossibilità dell’esprimersi si associano all’assenza di movimento, alla pietrificazione, divenendo l’uno spia dell’altro. Fanno da contraltare le urla disumane, suoni che spesso non si articolano in parole intellegibili (come gli ululati del lupo mannaro) e che esprimono al pari del silenzio il dolore umano; molte volte l’urlo e il silenzio si ritrovano insieme come due espressioni dello stesso concetto di sofferenza. Molti sono gli esempi sparsi nel testo che esprimono il senso della stasi e/o del silenzio; si leggano questi: “il confine del dolore fermo, del vuoto immoto” (9), “ma là era silenzio e stasi, era riposo” (9), “Guardava il silenzio sulle case, ad ogni strada, piano, baglio, il silenzio al meriggio” (13), “nella sublime assenza, nella carenza di ragione” (37), “‘Uuuhhh…’ ululò prostrato a terra ‘uuhh… uhm… um… mmm… mmm… mmm…’” (38, e questa volta è Petro che emette suoni incomprensibili), “nell’attasso del cuore, canto del pendolo bloccato” (42), “nella segreta sua torre d’urla, di lamento” (51), “Siamo un ribollìo celato d’emozioni, un rattenuto pianto” (66), “E tu, e noi chi siamo? Figure emergenti, palpiti, graffi indecifrati. Parola, sussurro, accenno, passo nel silenzio” (67), “la pena grave blocca il movimento” (103), “Serafina torbida, di pietra” (106), “la pietra del dolore” (135). Sono tutte espressioni di sofferenza e legate alla consapevolezza della sofferenza, alla sua contemplazione che sottrae l’azione e la parola. Già nel Sorriso dell’ignoto marinaio (1976) era presente l’idea della pietrificazione come espressione del male, essa però era legata a una contingenza – i cavatori di pomice – che diventava metafora per una sofferenza più generale, quella degli ultimi: “‘Male di pietra’ continuò il marinaio ‘È un cavatore di pomice di Lipari. Ce ne sono a centinaia come lui in quell’isola. Non arrivano neanche ai quarant’anni’” (Consolo, 2010:8). Ma successivamente in L’olivo e l’olivastro la metafora “male di pietra” si approfondisce e diventa l’ossessione costante con cui dire la sofferenza umana. Nelle pagine iniziali ritornano i cavatori come a stabilire quel paragone, fondare quella metafora della pietra che poi diventa il nucleo lessicale fondamentale per esprimere il dolore: “[…] entrò nelle caverne della pomice, parlò con i cavatori silicotici […] Erano secchi e grigi i cavatori, avevano denti corrosi dalla polvere, prendevano anelettici, cardiotonici: cresceva dentro loro poco a poco una corazza di pietra, il cuore s’ingrossava, si smorzava il fiato, si spegneva” (Consolo, 2012a:26-27). E qui in questo testo allora abbondano non tanto – o non solo – espressioni diverse che indicano l’impossibilità del dire e del fare, quanto piuttosto in maniera più specifica lemmi legati alla radice “pietra”: “Che arrestò al suo accadere, pietrificò illusioni, speranze, rese di lava la vita” (34), “un vecchio poeta afasico, irrigidito nel giovanile errore, pietrificato nella follia ribelle” (36), “Una barca di pietra, la pietra in cui si mutò la barca feacica che aveva portato in patria l’eroe punito, l’eroe assolto dopo il lungo racconto–che in pietra si muti la barca, si saldi al fondale prima d’ogni ritorno, poiché nel ritorno, così nel racconto, consiste lo strazio” (39), “si pietrifica per il dolore, perde vigore e ragione” (41), “la Catania pietrosa e inospitale” (52), “la ferma maschera, quasi impietrita del nobile vegliardo” (59), “la loro tragedia s’è svolta in un attimo lasciando impietriti” (125). La pietrificazione è legata all’esperienza personale, alla scrittura, ma anche alla società. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera nel 1977, Paesaggio metafisico di una folla pietrificata, e che O’Connell riconosce come uno degli avantesti di Nottetempo per quell’incipit del tutto simile, Consolo attribuisce alla Sicilia, che sta sempre in rapporto sineddotico con la società, quell’impulso alla pietrificazione come forma generale e risposta alla consapevolezza del male: “c’è una depressione più inclemente e disumana di questa, ed è quella che non arriva all’estremo livello, ma si ferma al di qua, a un passo dall’insopportabilità. È lo stadio che blocca la vita, la congela, la pietrifica” (Consolo 1977:1). E la Sicilia sembra, per lo scrittore, bloccata “in questo limbo, in questa metafisica paralisi”, unica reazione con cui ha controbattuto il movimento artificiale, del quale ne diviene simbolo l’autostrada, “moderno feticcio dell’accelerazione spasmodica”. E pure qui la contrapposizione si ritrova anche sul piano della comunicazione, poiché in questa Sicilia “sequestrata e pietrificata” chi ha cercato “di fare e di dire”, cioè di cambiare la situazione, è stato costretto al silenzio e sulla lunga tradizione letteraria isolana, da Verga a Sciascia, ora domina “la parola vuota, l’inutile incanto, la retorica” (Consolo, 1977:1). In questo precedente di Nottetempo c’è dunque l’esplicitazione di come la metafora dell’impetramento e del movimento, del silenzio e della “vuota parola”, che permea il romanzo sia da leggersi anche sempre come condizione sociale oltreché intellettuale ed esistenziale. Queste considerazioni ci riportano a De Martino e all’associazione tra l’apocalisse psicopatologica e quella culturale. Se gli stati epilettici e la schizofrenia sono caratterizzati da un senso di moto che in ultima analisi veicola il senso della fine del mondo, lo stato catatonico è l’insania che al contrario si lega all’assenza di movimento e diventa negazione del tempo e della storia, cioè ancora del mondo: “Tutte le cose sono diventate immobili, in uno stato senza tempo. Il corpo risponde a questo mondo non muovendosi più: il catatonico sta fermo e dritto come una statua in un museo di curiosità, mentre per noi, non catatonici, il mondo parla così chiaramente di movimento, è così visibilmente in “moto”, che possiamo rispondere al suo appello solo con i movimenti del nostro corpo” (De Martino, 2002:57). Se per il non catatonico il mondo può procedere secondo un tempo che è umano, il catatonico bloccandosi come una statua rifiuta tale tempo e porta il mondo al suo precipitare. In Petro e nella famiglia Marano l’arresto e la catatonia concretizzano la metafora di “folla pietrificata” in una società sull’orlo dell’apocalisse.
La torre dell’urlo e del silenzio
Le sorelle di Petro, come abbiamo già accennato, sono chiuse
e sprofondate nell’impetramento dell’anima e del corpo. Serafina, col nome
programmatico di chi non appartiene a questo mondo e di chi ha una pace che non
è terrestre, è immobile in uno stato quasi catatonico, persa in vagheggiamenti
religiosi che non hanno più alcun referente nel contingente: “E Serafina,
ch’aveva preso prima il ruolo della madre e poi s’era seduta, fatta muta ogni
giorno, immobile, di pietra, dentro nella scranna, il solo movimento delle dita
che sgranano il rosario di poste innumerevoli, di meccaniche preghiere senza
sosta” (42). Serafina nella storia non c’è, è personaggio serrato in questa impossibilità
di essere e di comunicare; è solamente evocata e l’unica volta che compare è
un’immagine di chiusa pazzia: “Era prona la sorella, ai piedi del comò
acconciato come altare, pieno il marmo di fiori ceri avanti a quadri,
immaginette, duplicati nello specchio. Faceva un canto mesto, come un lamento”
(158); ma naturalmente le sue parole sono inintelligibili. L’altra sorella, invece, Lucia, cade in una
pazzia che prima ancora di essere assenza e distanza è urlo innaturale, parole
sconclusionate11, perse in un passato disordinato e non recuperabile. In Lucia,
infatti, si racchiude anche il tema fondamentale del recupero del passato, ma
un recupero che fallisce, poiché il disordine dei frammenti rimane un disordine
che non è in grado di tracciare nessuna via, per quanto precaria e labile. Il
ricordo delle ferite che riemerge in lei è un ricordo che riproduce
meccanicamente il trauma ma non lo supera mai; si legga la scena fondamentale
dove, dopo l’“oltraggio” subìto dalla famiglia Marano a causa dell’antagonismo
fra Petro e Don Nenè, Lucia farnetica pezzi di frasi che riportano alla luce un
passato non attinente all’evento appena accaduto e incapaci di produrre
conoscenza, comunicazione o presa sulla realtà: “‘Ah, tana di cani corsi, di
mastini […]’ riprese a dire la sorella ‘Ah, quanto piangere di madri,
d’innocenti […] Attento, Petro, non uscire!’ […] ‘Che fa Janu, non viene?
Dobbiamo andare o no alla mandra, a mangiare la ricotta? […] Si fece tardi
ormai […] No, no, aiuto! […]’ e indietreggiò, si portò le mani alle
orecchie” (158). Lucia, in un certo
senso, è andata oltre il limite umano, ha varcato un confine oltre il quale
l’uomo non può accedere rimanendo uomo, tanto che Petro osserva parlando all’amico
Janu: “Né io né tu possiamo più raggiungerla” (68). Ella rappresenta attraverso
l’urlo e il movimento irragionevole ciò che Serafina rappresenta attraverso la
stasi e il silenzio. Lucia, al contrario della sorella, è visibile, agisce, ha
una personalità forte e inquieta, va per la campagna con il fratello Petro e
l’amico Janu, è promessa sposa; ma il giovane che ha chiesto la sua mano non
torna dalla guerra. In quel dolore Lucia si chiude, si
*
11 Ancora con De Martino possiamo leggere: “In
generale il dominio della follia diventa comprensibile come caduta dell’ethos
del trascendimento, della presentificazione valorizzante, e come costruzione di
difesa fittizia che accentuano il recedere verso l’incomunicabile, il privato,
il senza-valore-intersoggettivo” (De Martino, 2002:85).
**
pietrifica, ma esplode in urlo piuttosto che cadere nel silenzio, esplode in suoni che non possono articolare e razionalizzare quel dolore: “Finché un giorno, un mezzogiorno che Petro tornava dalla scuola, non si mise a urlare disperata dal balcone, a dire che dappertutto, dietro gli ulivi le rocce il muro la torre la sipale, c’erano uomini nascosti che volevano rapirla, farla perdere, rovinare” (46). E poco oltre: “Lanciò improvviso un urlo e scappò via, si mise a correre, correre per il sentiero, come presa da frenesia, da tormenti” (47). È la fuga di Lucia oltre il limite dell’umano, eppure anch’ella è figura statica, immobile, figura che s’impetra nel dolore e lo fissa perdendo la capacità di vedere altro e cioè anche la capacità di creare e vedere altre visioni apollinee: rimane una sola visione senza drama e in essa Lucia si ferma. Così ecco che anche il suo nome acquista pregnanza, nel momento in cui il testo ci ripete insistentemente nello stretto volgere di un paragrafo che Lucia – che vuol dire luce ma che è anche patrona dei non vedenti e degli oculisti – non vede più, è diventata cieca nella fissità: “La portò via da casa […] perché si dissolvesse in lei l’idea fissa. […] Ma era come lei non vedesse […] era come se avesse gli occhi sempre altrove, fissi dentro un pozzo” (47) – dove quel “pozzo” sta per la profondità del dolore. Lucia è anche figura pietrificata in quel suo guardarsi continuamente allo specchio, atto autoriflessivo che non comunica con il mondo esterno ma ricade sulla persona medesima; ella fissa se stessa e la sofferenza che ha guardato con i propri occhi ora riflessi allo specchio. Atto solipsistico e chiuso, come chiusa è lei nella propria camera: “E stava ore e ore chiusa nella stanza, avanti alla toletta a pettinarsi, in incantesimo, il guardo trasognato, perso nel guardo suo di fronte dentro lo specchio” (46). La sofferenza familiare si racchiude metaforicamente nella concretezza della “torre”, ovviamente fatta in pietra (“la sua voce roca sembrava vorticare per le pietre della torre” 37), che assurge a simbolo di chiusura e solitudine – torre è quel tipo di edificio caratterizzato da una dimensione in altezza nettamente maggiore rispetto alla dimensione della base e che dunque si isola rispetto alle costruzioni circostanti; torre per antonomasia è quella di Babele, dove regna il caos, il disordine e la confusione, principio delle lingue diverse che impedirono all’uomo di comunicare l’uno con l’altro12. Nella torre dove sono chiusi i membri della famiglia Marano la comunicazione non è possibile, le parole non assumono un significato che possa essere compreso dagli altri, decifrato: “‘Pietà, pietà’ implorò in quella solitudine sicura, dentro quel rifugio della torre, quel segreto oratorio d’urla, pianto, sfogo” (38). L’urlo è il simbolo di questo dolore, sfogo inarticolato, contraltare del silenzio: “nella segreta sua torre d’urla” (51), “E nella torre ora, dopo le urla, il pianto”. L’urlo, come il silenzio, è una comunicazione bloccata. Petro allora si rende conto che è necessario recuperare le parole per uscire dalla torre. È questo un momento fondamentale del testo, che è sia riflessione sulla sofferenza umana sia sulla scrittura cui è affidato il compito di esprimere tale sofferenza. Nottetempo è allora anche e “innanzitutto la storia di una vocazione alla scrittura” (Traina, 2001:92). Il tentativo di uscire dalla torre di pietra e scongiurare l’afasia si pone come uno dei temi centrali del testo. Attraverso questo percorso del protagonista, si assiste anche alla lotta che lo stesso Consolo conduce per non cadere nell’impetramento della scrittura, nell’impossibilità del dire, del parlare, nell’apocalisse della parola.
Afasia
Nottetempo è anche romanzo autobiografico, non tanto perché ci siano elementi biografici dello scrittore che possano essere riconosciuti nella vicenda di Petro, quanto piuttosto perché la storia di Petro, la sua uscita dalla torre, è anche il viaggio intellettuale dello scrittore Consolo. Riconosciuta l’oppressione del silenzio familiare e dell’esilio dalla ragione e dalla parola delle due sorelle, nel protagonista del romanzo nasce il desiderio di uscire dalla torre ricomponendo un linguaggio attraverso cui poter di nuovo comunicare una realtà, riconnettersi con essa:
*
12 “Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ‘Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro’” (Genesi 11:5-7).
**
Sentì come ogni volta di giungere a un limite, a una soglia estrema. Ove gli era dato ancora d’arrestarsi, ritornare indietro, di tenere vivo nella notte il lume, nella bufera. E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: “Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno […]” scandì come a voler rinominare il mondo, ricreare il mondo. (38-39)
Questo elenco precede quello che poi ritroveremo nelle pagine dedicate al rito satanico di Alaister e si pone su uno stesso piano di complementarietà: come quello nasceva dal movimento artificioso del dionisiaco degenerato, questo nasce dall’impetramento afasico dell’apollineo degenerato. In entrambi la parola è mimesi del gesto: lì c’è la ricreazione del movimento, in cui il segno della virgola dà il senso del ritmo della danza e della musica, qui c’è la riproduzione della stasi, marcata dal punto che segue ogni parola e che indica la pausa, una cesura di tempo e di spazio, la difficoltà dell’esprimere una parola dietro l’altra, l’inarticolazione di un discorso. E se là il vortice delle parole serviva a confondere, ad allontanare dalla realtà, qui c’è l’avvicinamento, o per lo meno il tentativo di avvicinarsi a qualcosa che si è perso da tempo – o mai avuto. È un elenco di parole semplici, in cui tuttavia si può riconoscere una catena logica di riferimenti che dalla terra vanno al cielo, dalla “pietra” al senso di libertà del volo degli uccelli e alla luce del sole. Attraverso questo “rinominare il mondo” Petro cerca di riattivare un legame con la realtà, o, per dirla ancora con Nietzsche, cerca parole che non esprimono altro che “relazioni delle cose con gli uomini” (Nietzsche, 1964:359); cerca dunque di ritrovare questa relazione con le cose. Nel processo dell’elencare riemerge una realtà frantumata, che si dà appunto solo in frammenti; ed è solo così, in quei frantumi testimoniati dall’accumulo di lemmi che si può cogliere una realtà la cui unità, come il discorso, come il narrare, non può essere (ri)composta. Anche la scrittura, infatti, si arresta, si blocca sull’orlo dell’impossibilità di esprimere, di connettere parole con realtà; così fallisce il tentativo di Petro: “cercò di scrivere nel suo quaderno – ma intinge la penna nell’inchiostro secco, nel catrame del vetro, nei pori della lava, nei grumi dell’ossidiana, cosparge il foglio di polvere, di cenere, un soffio, e si rivela il nulla, l’assenza di ogni segno, rivela l’impotenza, l’incapacità di dire, di raccontare la vita, il patimento” (53). Petro è come l’uomo dionisiaco descritto da Nietzsche: simile a lui cerca la salvezza nell’arte, cerca un’“illusione” che lo salvi dallo sguardo che ha gettato sull’orrore delle cose; egli ha la conoscenza del dolore e rischia per via di essa di rimanere pietrificato, di perdere la volontà dell’azione e dire “no” alla vita. “In questo senso” dice Nietzsche “l’uomo dionisiaco è simile ad Amleto: entrambi una volta hanno gettato uno sguardo vero nell’essenza delle cose, hanno conosciuto, e agire li nausea; poiché la loro azione non può cambiare niente nell’essenza eterna delle cose, essi sentono come ridicolo o infame che venga loro chiesto di rimettere in sesto il mondo uscito fuori dai cardini” (113). Consolo, attraverso il personaggio di Petro, ci descrive allora il viaggio verso l’esaltazione dionisiaca, che qui altro non è che volontà e capacità di esserci ancora, di agire in questo mondo – e di scrivere, di dire. Assistiamo così all’uscita metaforica di Petro dalla torre, alla sua presa di coscienza politica (che passa tramite lo sputo al barone, l’amicizia con il Miceli, la partecipazione alle manifestazioni di piazza, l’“oltraggio” subito e infine l’attentato perpetrato) e alla promessa, a fine romanzo, di una nuova scrittura attraverso cui sciogliere il grumo del dolore: “Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe racconto, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore” (171). Questa scrittura, sappiamo, sarà il rifiuto delle parole cerimoniose e della falsa retorica, si distanzierà tanto dal libro dell’anarchico lasciato cadere in mare quanto dalle “parole rare e abbaglianti” di D’annunzio o quelle “roboanti” (112) di Rapisardi. La vicenda di Petro si conclude perciò in quella dei satiri del coro, nel recupero attraverso la scrittura di un dionisiaco non degenerato: Nella coscienza di una verità, ormai contemplata, l’uomo adesso vede dappertutto soltanto l’orrore o l’assurdità dell’essere […]. Qui, in questo supremo pericolo della volontà, si avvicina, come maga che salva e risana, l’arte: soltanto essa può piegare quei pensieri nauseati per l’orrore o l’assurdità dell’esistenza in rappresentazioni con cui si possa vivere. (Nietzsche, 2003:114)
Questo è anche il percorso intrapreso dal Consolo scrittore, che approda alla tragedia di Catarsi (1989) come simbolo di un modo di scrivere; dice nel saggio Per una metrica della parola: “La tragedia rappresenta l’esito ultimo della mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Un esito, come si vede, in forma teatrale e poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite dell’intellegibilità, tenda al suono, al silenzio” (Consolo, 2002:250). Come ultima possibilità in una società dalla lingua corrotta e degradata, dallo sfaldamento della comunicazione, dalla rottura del rapporto tra scrittore e suo pubblico, suo referente in tale società, come ultima risorsa prima di cadere nell’afasia, nel silenzio, c’è il recupero dello spirito dionisiaco (e apollineo) che si esprime più compiutamente nel coro della tragedia, come si verifica nel Prologo a Catarsi:
La tragedia è la meno convenzionale, la meno compromessa delle arti, la parola poetica e teatrale, la parola in gloria raddoppiata, la parola scritta e pronunciata. Al di là è la musica. E al di là è il silenzio. Il silenzio tra uno strepito e l’altro del vento, tra un boato e l’altro del vulcano. Al di là è il gesto. O il grigio scoramento, il crepuscolo, il brivido del freddo, l’ala del pipistrello; è il dolore nero, senza scampo, l’abisso smisurato; è l’arresto oppositivo, l’impietrimento. (Consolo, 2002:13)
Allora in Nottetempo dobbiamo leggere questo approdo al canto del coro della tragedia, approdo di Petro dietro cui non sarà difficile riconoscere il percorso della scrittura e della poetica di Consolo stesso, teso tra il rifiuto della parola vuota e l’attrazione per quel silenzio che racchiude tutto il dolore. Petro è dunque il personaggio che incrocia tutti e tre i piani tematici su cui si dispone il romanzo e su cui si dispiega il senso dell’apocalisse: quello esistenziale, quello storico-culturale e quello della scrittura. A livello narrativo egli funziona come elemento unificatore di questi piani e, a livello contenutistico, si configura come chiave per trascendere il pericolo dell’apocalisse nel valore che possa rinnovare i mondi (quello interiore, quello sociale e quello letterario) infondendo loro nuovo significato. Più che romanzo “apocalittico”, dunque, Nottetempo è romanzo del “rischio della fine” e dell’inserimento di tale rischio in un’ottica che ne accenni e ne indichi il superamento e la reintegrazione.
Bibliografia
Adamo, G. 2007 La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo. Lecce: Manni. Arqués 2005 Teriomorfismo e malinconia. Una storia notturna della Sicilia: Nottetempo, casa per casa di Consolo. Quaderns D’Italià 10:7994. Calvino, I. 2000 Lezioni americane. Milano: Mondadori. Bouchard, N. 2005 Vincenzo Consolo and the Postmodern Writing of Melancholy. Italica 82.1:5-23. Spring. Ciccarelli, A. 2005 Intervista a Vincenzo Consolo. Italica 82.1: 92-97. Spring. Consolo, V. 1977 Paesaggio metafisico di una folla pietrificata. Corriere della sera: 1. 19 Ottobre. 1993 Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia. Roma: Donzelli. 1996 Per una metrica della memoria. Cuadernos de Filología Italiana 3 (1996):249-259. 2001a Di qua dal faro. Milano: Mondadori. 2001b Le interviste di Italialibri: Vincenzo Consolo. Italialibri. Web. 2002 Catarsi. In Oratorio. Lecce: Manni. 2010 Il sorriso dell’ignoto marinaio. Milano: Mondadori. 2012a L’olivo e l’olivastro. Milano: Mondadori. 2012b Nottetempo, casa per casa. Milano: Mondadori. Consolo, V. e Nicolao, M. 1999 Il viaggio di Odisseo. Milano: Bompiani. De Martino, E. 1964 Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche. Nuovi argomenti 69-71:105-141. 2002 La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali. Torino: Einaudi. Galvagno, R. 2007 “Male Catubbo”. Les avatars d’une métamorphose dans le roman Nottetempo, casa per casa. In Vincenzo Consolo, éthique et écriture. Ed. Dominique Budor. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle: 177-91. Lollini, M. 2005 La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo. Italica 82.1:24-43. Spring. Nietzsche, F. 1964 Su verità e menzogna in senso extramorale. Opere Di Friedrich Nietzsche. Vol. III. Milano: Adelphi. 2003 La nascita della tragedia. Milano: Mondadori. O’Connell, D. 2008 Consolo narratore e scrittore palincestuoso. Quaderns D’Italià 13:161-84. Ovidio, P. 1994 Metamorfosi. Torino: Einaudi.
Papa, E. 2003 Vincenzo Consolo. Belfagor 58.2:179-98. Pirandello, L. 1990 Novelle per un anno. Milano: Mondadori. Traina, G. 2001 Vincenzo Consolo. Fiesole (FI): Cadmo.
Abstract This essay aims to analyse the novel, Nottetempo, casa per casa (1992), by Vincenzo Consolo, considering the motif of the end of the world as a central and unifying element of the different levels on which the narrative unfolds. While The Birth of Tragedy by Friedrich Nietzsche is the intellectual reference for the novel, the considerations by the anthropologist Ernesto De Martino on the apocalypse allows us to interpret Nottetempo as a response to the psychological, cultural and literary risk of the “end” experienced in these three different areas.
Italian Studies in Southern Africa/Studi d’Italianistica nell’Africa Australe Vol 27 No 2 (2014)