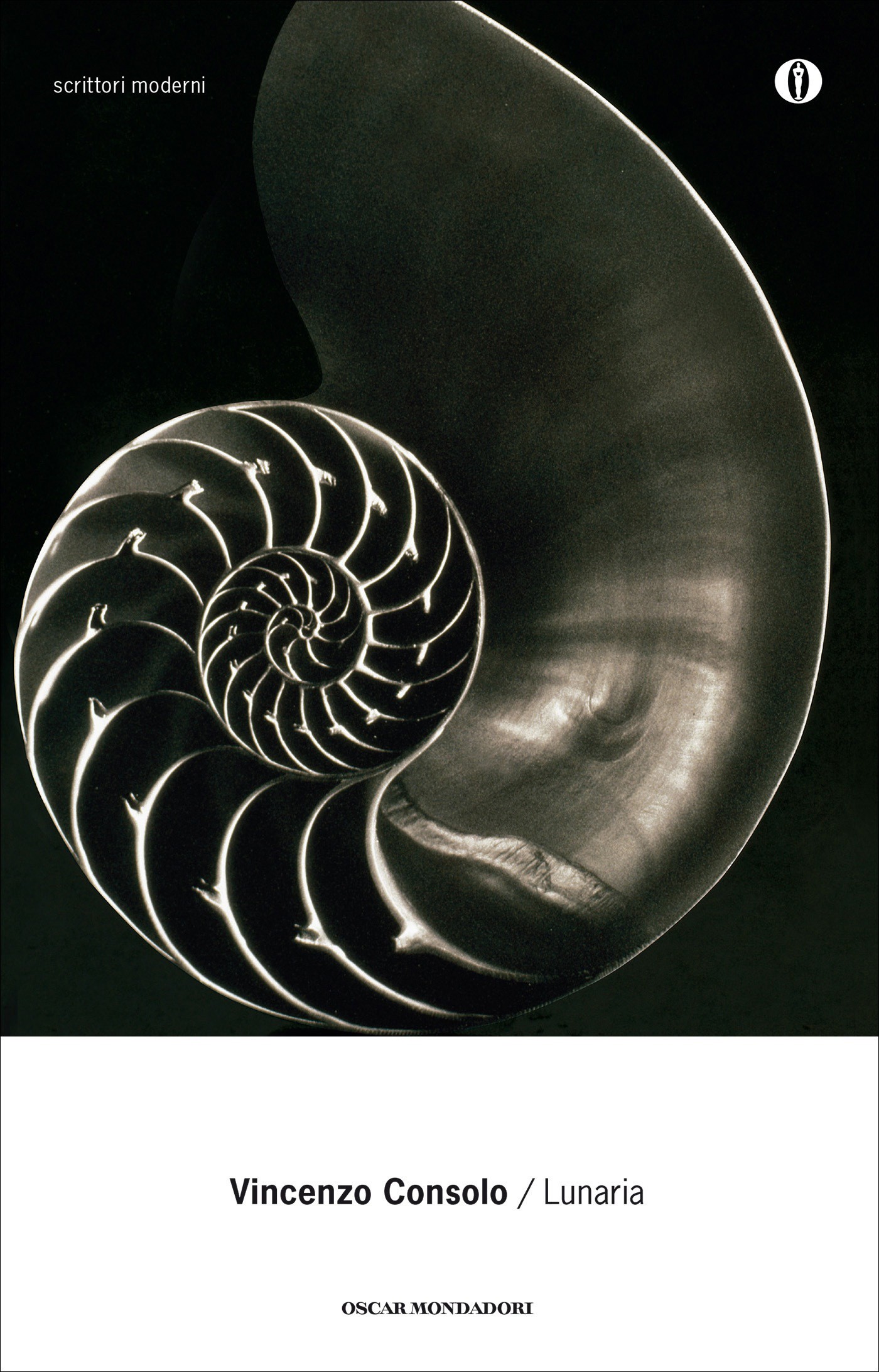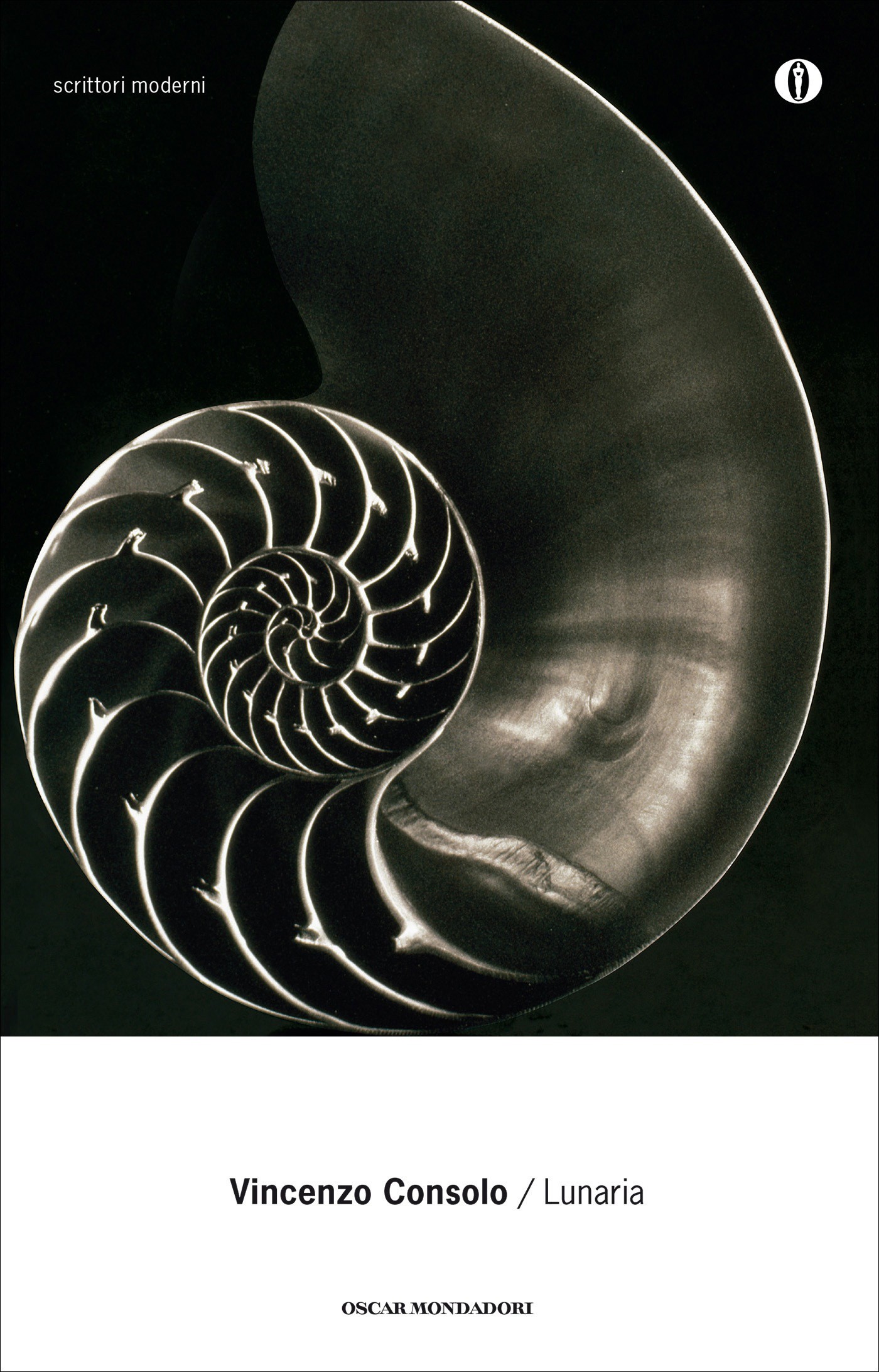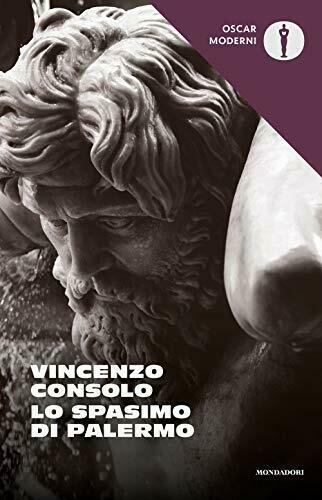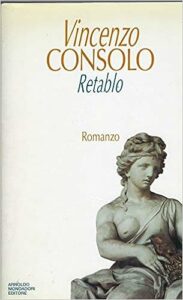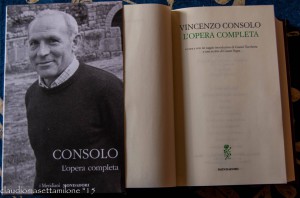La luna di Consolo, tra passato e presente
di Irene Di Mauro
Lunaria, opera multiforme, come l’astro cui è dedicata la narrazione, si presenta come sintesi della sfiducia di Consolo nei confronti del genere letterario del romanzo, e della scrittura prosastica cui esso è collegato. È un esperimento poetico, teatrale, un ritorno alla tradizione siciliana del cuntu, in una prospettiva settecentesca, che risulta ricca di stimoli per una rilettura critica del presente, in quanto «la stessa metafora portante della Luna, proprio perché rimanda alla poesia e a valori di autenticità e umanità, conferisce uno spessore etico-politico a un testo che a prima vista parrebbe tutto fantastico, svagato, quasi dimentico della realtà».[1] Il linguaggio che dà forma e corpo allo scenario arcaico e immaginifico della narrazione, è quanto mai ‘verticale’, arricchito da continui rimandi poetici, resi espliciti in diversa misura e saturi di echi visionari:
Lo stile si avvicina alla poesia come mai prima era
avvenuto: il testo pullula di anafore, allitterazioni, rime interne. Si assiste
così a una sorta di tendenza mimetica per cui al tema dell’intima necessità per
il mondo della poesia (simboleggiata dalla Luna) corrisponde uno stile che si
fa poesia. Il linguaggio si presenta talvolta oracolare, la forma espressiva
risulta nervosa, essenziale: la parola si fa incantatrice e trascina il lettore
nella “poesia” della vita.[2]
Risulta
quindi imprescindibile la comprensione di questa molteplicità di forme,
linguaggi e riecheggiamenti, come l’eredità letteraria a cui l’autore ha
attinto nella composizione della ‘favola teatrale’ della caduta e rinascita
della luna. Quest’ultima, ‘astro’ da sempre presente nell’immaginario popolare,
ha influenzato con la sua languida evanescenza poeti e scrittori, fin dal sesto
libro della Farsaglia di Lucano, la
cui rappresentazione nelle vesti di divinità funesta e ingannevole durante il
celebre scontro tra Cesare e Pompeo, appare come la summa di un retaggio immaginifico proveniente dal pantheon greco. L’accezione
magico-misterica della figura della dea, correlata all’inquietudine e alla
melanconia sepolcrale delle ore notturne, per cui spesso viene associata
all’oltretomba, è assimilata nella cultura latina alla figura delle «femmine
tessale che svelgono la luna dal cielo»[3], descritte da Platone nel Gorgia. Sono molte le testimonianze di
autori classici, segnalate da Leopardi nel Saggio
sopra gli errori popolari degli antichi, che attribuiscono poteri magici ad
alcune donne risiedenti nella regione greca ed in particolar modo Virgilio,
Seneca, Orazio, Ovidio, Tibullo, Stazio fanno riferimento all’operazione magica
narrata da Platone. Non stupisce la rassegna di Leopardi, la cui produzione
letteraria mostra come la luna sia un topos
onnipresente nel panorama letterario, in cui vengono analizzate le ricorrenze
nei testi antichi dell’immagine della caduta dell’astro, nei capitoli quarto e
decimo Della magia e Degli astri nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi:«fu un nulla per gli antichi, dopo aver divinizzati gli astri, il
supporre che qualcuno tra essi precipitasse talvolta dal cielo, con pericolo
evidente di rompersi il collo».[4] Il retaggio popolare e
letterario correlato alla luna viene ereditato da Lucano e filtrato attraverso
la personale lente del poeta romano, che connota la narrazione della Farsaglia di sfumature grottesche e
misteriche, dando forma ad uno dei più affascinanti temi letterari. Le
suggestioni popolari sulla luna, trasformate in poesia da Lucano, saranno
spunto per scrittori come Baudelaire e Goethe, che ne richiameranno l’accezione
sepolcrale, nella formulazione di chiari rimandi alla letteratura latina. La
luna delle visioni del poeta francese, sembra quasi la stessa che secoli prima
era stata strappata dalla sua nicchia celeste dalla maga Erichto:
non la luna placida e
discreta che visita il sonno degli uomini puri,
ma la luna strappata
dal cielo, vinta e ribelle, che le Streghe della
Tessaglia costringono
spietatamente a ballare sull’erba atterrita![5]
Baudelaire
risente del fascino della «sinistra luna inebriante», a cui fa corrispondere la
personificazione della donna,
che
la luna ha segnato «con il suo temibile influsso»[6] e la cui effimera immagine
ha suscitato nel poeta il desiderio di imprimerla perpetuamente. Tuttavia, la
donna ‘lunatica’ di Baudelaire, a differenza delle temibili incantatrici
tessale, è in qualche misura ella stessa vittima del sortilegio lunare e
fautrice dell’inganno dell’astro esclusivamente per potere riflesso. La luna
conferisce alla donna amata la medesima forza attrattiva che l’uomo le ha, nei
secoli, riservato:
Tu sarai bella alla mia maniera. Amerai quello che io
amo e quello che mi ama: l’acqua, le nuvole, il silenzio e la notte; il mare
immenso e verde; l’acqua informe e al contempo multiforme; il luogo in cui non
sarai; l’amante che non potrai conoscere; i fiori mostruosi; i profumi che
danno il delirio; i gatti che spasimano sui pianoforti gemendo come delle donne
con voce roca e dolce!
“Sarai amata dai miei amanti, corteggiata dai miei
cortigiani. […] di quelli che amano il mare, il mare immenso, tumultuoso e
verde, l’acqua informe e al contempo multiforme; il luogo in cui non sono, la
donna che non conoscono; i fiori sinistri che assomigliano ai turiboli di una
sconosciuta religione, i profumi che sconvolgono la volontà, gli animali
selvaggi e voluttuosi che sono gli emblemi della loro follia”.
Ed è per questo, maledetta fanciulla viziata, che ora
sono ai tuoi piedi, cercando in tutto il tuo corpo il riflesso della temibile
Divinità, della fatidica madrina, della velenosa nutrice di tutti i lunatici.[7]
È
ormai evidente il distacco dalle violente immagini della Farsaglia, distacco suggerito e in qualche misura anticipato dal Faust di Goethe nel 1831:
Oh, fosse questa l’ultima volta, o Luna, che tu guardi
sopra di me travagliato! quante volte dinanzi a questo leggio io ho vegliato
tardi nella notte aspettandoti: e tu, mesta amica, sei pur sempre apparsa, a me
su libri e su carte! Oh, potessi in sulle cime dei monti aggirarmi per entro la
tua amabile luce, starmi sospeso cogli Spiriti in sui burroni, divagarmi,
avvolto da’ tuoi taciti albori, sui prati, e, sgombro da tutte le vanità della
scienza, bagnarmi e rinfrancarmi nella tua rugiada.[8]
Il
corollario di immagini che accompagnano la comparsa della luna appare in ogni
caso imprescindibilmente legato alla sfera orfica, immaginifica e
dell’inconscio, tradizionalmente associata alle ore notturne. L’astro diviene
strumento poetico per esaltare i dissidi dell’animo, «i quali, pur non
conciliandosi, sembrano confondersi nell’alternanza in un unico sentimento che
esprime la condizione esistenziale dell’uomo».[9] Questa accezione empatica,
introdotta dai poeti romantici, trasmuta la luna in un essere non più vessillo
di vendetta, brutalità e immonda
crudezza, come era stata per Erichto, la maga che «asperge di abbondante umore
lunare»[10] le sue vittime, dopo
averne squarciato il petto e il ventre. La luna ora ha una dimensione più
empatica, si presenta al poeta «
soave
come l’occhio dell’amico/ sul mio destino »[11] Gli epiteti a lei rivolti
però, appaiono in qualche modo gli stessi, la luna che suscita i sospiri nei
poeti romantici, è lo stesso astro che illuminava la notte precedente allo
scontro di Cesare e Pompeo:
O tu, lassù, perennemente immune da vecchiaia, dai tre
nomi e dalle tre forme, te invoco io, nella calamità del mio popolo, Diana,
Luna, Ecate! Tu che i cuori sollevi, tu, assorta nei pensieri più profondi, tu
tranquilla splendi, in te stessa ascosa e violenta, apri l’orribile abisso
delle tue ombre, l’antica potenza si manifesti senza aiuto di magia.[12]
Dei
Canti leopardiani, nel
trentasettesimo inequivocabilmente, troviamo il cardine, la congiunzione tra il
percorso evolutivo fin qui analizzato e l’opera di Vincenzo Consolo, che
riassume e rielabora tutte le accezioni che la luna, nei secoli, ha assunto in
ambito letterario. Il tema del sogno della luna caduta, è assimilato, in
entrambi gli autori, dalle reminiscenze popolari classiche, in entrambi è
spunto per la narrazione dialogica e teatrale, la cui voce più veritiera è
affidata ai pastori, nel Canto leopardiano
tratti dalla Favola pastorale di
Guidobaldo Bonarelli:
ALCETA
Odi, Melisso: io vo’
contarti un sogno
di questa notte, che
mi torna a mente
in riveder la luna.
Io me ne stava
alla finestra che
risponde al prato,
guardando in alto: ed
ecco all’improvviso
distaccasi la luna; e
mi parea
che quanto nel cader
s’approssimava,
tanto crescesse al
guardo; infin che venne
a dar di colpo in
mezzo al prato; ed era
grande quanto una
secchia, e di scintille
vomitava una nebbia,
che stridea
sí forte come quando
un carbon vivo
nell’acqua immergi e
spegni. Anzi a quel modo
la luna, come ho
detto, in mezzo al prato
si spegneva annerando
a poco a poco,
e ne fumavan l’erbe
intorno intorno.
Allor mirando in
ciel, vidi rimaso
come un barlune, o
un’orma, anzi una nicchia
ond’ella fosse
svèlta; in cotal guisa,
ch’io n’agghiacciava;
e ancor non m’assicuro.[13]
Ed
è proprio ai pastori, i «villani della Contrada Senza Nome, che Consolo
consegna il potere della «memoria, l’antica lingua, i gesti essenziali»[14] in grado, attraverso
antichi rituali di sapore arcardico, di far rinascere in cielo la luna, e con
essa «il sogno che lenisce e che consola»[15] e imprescindibilmente, la
poesia. Il rito compiuto dai contadini con i cocci della luna infranta,
richiama alla memoria la luna ancestrale latina, che risorge dall’oblio,
insieme al retaggio mistico degli epiteti ad essa correlati:
PRIMA DONNA
Così è finita, così è stata
seppellita la Regina.
SECONDA DONNA
La Signora, la Sibilla,
la Ninfa Oceanina.
[…]
QUARTA DONNA
Ecate dei parti,
Kore risorgente,
QUINTA DONNA
Malòfora celeste,
Vergine beata.[16]
La danza delle contadine, con le litanie,
«muta lamentazione di prefiche»[17], le vesti nere e i
capelli sciolti, i «gesti essenziali» dei quali unico depositario sembra essere
il popolo, che, custode delle diversità culturali, del variegato corollario di
influenze ormai perduto altrove dalla campagna, si mostra unico artefice,
grazie alle ‘esequie della luna’, della rinascita dell’astro. Solo il Viceré Casimiro,
non a caso punto di contatto tra l’arcadico mondo contadino della Contrada
Senza Nome e la Palermo settecentesca, mostra di percepire il lascito classico
del prodigio lunare in atto, cadendo in una sorta di estasi visionaria in cui
rivolge alla luna il suo lamento, che diviene supplica e invocazione:
Luna, Lucina, Artemide divina,
possente Astarte, Thanit crudele, Baalet, Militta, Elissa, Athara, Tiratha,
Regina degli Umori, Selene eterna dalle ali distese e celebrate, Signora, Dea
dalle bianche braccia, perché abbandoni il luminoso scettro? […] Deh madre,
sorella, sposa, guida della notte, méntore, virgilia, dimmi, parlami, insegnami
la via.[18]
Divinità che richiamano la fertilità, la
fecondità, l’amore, ma anche la guerra, la morte la bramosia di sacrifici.
Consolo include tutte le sfumature e le accezioni dell’astro, richiamando gli
aspetti più grotteschi e crudi, rispettando quelli più morbidi e romantici; la
«letteratura sulla letteratura»[19] di cui parla Cesare
Segre, si fa più che mai evidente, adempiendo alla verticalità da sempre
caratterizzante la scrittura dell’autore, che si mostra consapevole e attento
agli echi che la narrazione suscita:
Quando Consolo mi mise tra le mani
il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di
chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era
ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso
la letteratura cresce su sé stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare,
come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.[20]
La stessa attenzione dipinge di sfumature
rossastre la luna che rischiara la notte dei villani della Contrada Senza Nome,
mentre ammirano il fenomeno che ne anticipa la caduta, speculando, al pari
degli antichi, sulla reale motivazione. Il particolare fenomeno introduce
l’elemento magico-misterico della caduta, gettando la campagna sottostante in
un’atmosfera tragica in cui si insinua l’ululato ultraterreno, a cui i
contadini pronti rispondono parando i forconi. La luna rossa diventa condizione
necessaria e anticipatrice della magia, come per Orazio nel Sermo VIII, segnalato da Leopardi:
Serpentes,
atque videres
Infernas
errare canes, lunamque rubentem,
Ne foret his testis, post magna
latere sepulchra.
Orazio dà l’epiteto di rubentem
alla luna, perchè questa appare infatti rossa al suo levarsi; e il poeta avea
detto poco prima che le maghe per dar principio ai loro incantesimi aveano
aspettato il sorger della luna:
Nec prohibere….(possum) modo simul
ac vaga luna decorum
Protulit os, quin ossa legant,
herbasque nocentes.[21]
L’incanto è introdotto dall’aleatoria
presenza del lupo mannaro, percepibile dall’ululato che, sempre più forte,
scatena le reazioni atterrite degli astanti:
OLIVA Mamma, il lupo mannaro!…
[…]
MELO Basta un graffio, in fronte…
PIETRO Una stilla di sangue…
VENERA Ma non c’è quadrivio, non c’è incrocio…
La tradizione a cui attinge Consolo per la
composizione di questa spettrale atmosfera, torna ad essere nostrana, seguendo
il filone delle leggende popolari da lui già esaminate nel 1977:
Un urlo bestiale rompeva il
silenzio nella notte di luna piena. Ed era uno svegliarsi, un origliare dietro
le porte serrate, uno spiare dietro le finestre socchiuse, un porsi in salvo al
centro dei crocicchi o impugnare la lama per ferire alla fronte e far sgorgare
gocce di nero sangue. […] Il lupo mannaro era l’incubo, lo spavento notturno,
nella vecchia cultura contadina, carico di male e malefizio, contro il quale
opponeva crudeli gesti esorcistici.[22]
L’attestazione di questa credenza popolare
è lungamente descritta da Cervantes ne
Los trabajos de Persiles
y Sigismunda, dimostrando l’arcaica permanenza
nell’immaginario siciliano della figura del lupo mannaro, e la definizione
dialettale della patologia ad esso correlata è di indubbia provenienza araba: «male catubbo,
derivato dall’arabo catrab o cutubu, che significano canino o lupino».[23] Cervantes mostra di
essere a conoscenza della forte presenza in Sicilia di questa superstizione,
costituendo una testimonianza seicentesca le cui reminiscenze appaiono
nell’immaginario consoliano, così come nella pirandelliana novella Mal di luna:
Lo que
se ha de entender desto de convertirse en lobos es que hay una enfermedad, a
quien los médicos llaman manía lupina, que es de calidad que, al que la padece,
le parece que se haya convertido en lobo, […] y hoy día sé yo que hay en la
isla de Sicilia (que es la mayor del Mediterráneo) gentes deste género, a
quienes los sicilianos laman lobos menar, los cuales, antes que les dé tan
pestífera enfermedad lo sienten y dicen a los que están junto a ellos que se
aparten y huyan dellos, o que los aten o encierren, porque si no se guardan,
los hacen pedazos a bocados y los desmenuzan, si pueden, con las uñas, dando
terribles y espantosos ladridos.[24]
Gli individui affetti da «manía lupina»
avvertono i loro cari in prossimità dell’esternarsi dei sintomi, «que se
aparten y huyan dellos, o que los aten o encierren», similmente al Batà di
Pirandello, che si premura di mettere al sicuro la moglie dall’irruenza della
sua trasformazione: «–Dentro… chiuditi dentro… bene… Non ti spaventare… Se
batto, se scuoto la porta e la graffio e grido… non ti spaventare… non aprire…
Niente… va’! va’!»[25]. Pirandello, rispetto
alla precedente descrizione di Cervantes, introduce come elemento
imprescindibile la luna, che diviene, come in Consolo, causa della
trasformazione, ritratta, ancora una volta, in rossastre sfumature:
Batà mugolò di nuovo, si scrollò
tutto per un possente sussulto convulsivo, che parve gli moltiplicasse le
membra; poi, col guizzo d’un braccio indicò il cielo, e urlò:
– La luna!
Sidora, nel voltarsi per correre
alla roba, difatti intravide nello spavento la luna in quintadecima, affocata,
violacea, enorme, appena sorta dalle livide alture della Crocea.[26]
La luna interagisce e dialoga con i
personaggi, intervenendo essa stessa nell’intreccio della vicenda, al pari di Lunaria, la cui influenza sui personaggi
fa sì che possa essere annoverata «tra gli eroi e gli antagonisti, ‘oggetto del
desiderio’ ricco di valenze simboliche, sognata, contemplata, persa, rimpianta
e infine riconquistata».[27] La sequenza del racconto
di Batà della contrazione del ‘male’ ricalca l’immaginario romantico del
dialogo notturno con l’astro, richiamando gli scenari ritratti dai poeti
‘lunari’ e la stessa tipologia di interazione che si riscontra, tra le altre,
in Claire de lune di Hugo, «la lune
était sereine et jouait sur les flots»:[28]
che la madre da giovane, andata a
spighe, dormendo su un’aja al sereno, lo aveva tenuto bambino tutta la notte
esposto alla luna; e tutta quella notte, lui povero innocente, con la pancina
all’aria, mentre gli occhi gli vagellavano, ci aveva giocato, con la bella
luna, dimenando le gambette, i braccìni. E la luna lo aveva «incantato».[29]
Il Viceré di Lunaria risente a tal punto della sua influenza, da trasmutarsi in
luna egli stesso, intonando una cantilena, o supplica, ricca di allitterazioni
e assonanze, «in cui la quantità di sillabe si fa progressivamente più esigua
fino a culminare, con geniale intuizione poetica, in un’unica sillaba, ampia e
limpida, con un’assonanza nella ‘a’ che significa ‘luna’ in quella lingua
antica e pura che ancora oggi si parla in Iran: il persiano classico»:[30]
Lena lennicula,
lemma lavicula,
làmula,
lémura,
màmula.
Létula,
màlia,
Mah.[31]
Ogni personaggio del microcosmo di Lunaria risente in qualche misura
dell’influsso della rossastra luna in «quintadècima», il cui aspetto inconsueto
genera un dibattito e le goffe argomentazioni avanzate dal dottor Elia,
rimandano anch’esse in qualche modo alle arcaiche credenze popolari, che da sempre
hanno cercato di colmare i vuoti del sapere, fornendo pittoresche spiegazioni
ai fenomeni atmosferici:
DOTTOR ELIA Nessun prodigio. È solo morbo o fiotto per
caso scivolato dal diurno Astro in su l’occaso, quand’è rosso scarlatto,
ingallando l’argentea sembianza, la pallida sostanza della vergine, la
solitaria pellegrina della notte…[32]
L’ironica caricatura del dottor Elia, che
si affanna dietro il rudimentale cannocchiale nell’analisi delle inconsuete
condizioni dell’astro, affiancato dall’aromatario Alì, che produce un’analisi
meno accademica, ma più calzante in quanto supportata dall’osservazione diretta
della natura, e le loro dissertazioni animate, diventano un esempio letterario
della figura dell’uomo ignorante ritratta da Leopardi:
La credulità è, e sarà sempre, come
sempre è stata, una sorgente inesauribile di pregiudizi popolari. […] Un uomo
ignorante, e che nella maggior parte delle cose non presume di sapere più di un
altro crederà sempre tutto ciò che gli verrà detto, e stimerà effetto di folle
arroganza ed anche di stupidità il dubitarne. Si sarà sempre credulo finchè non
si saprà esaminare, o almeno non si ardirà tentare di farlo, […] Accade però
bene spesso che gl’ignoranti non siano assai docili, e non prestino fede
facilmente a chi vuol persuaderli di qualche verità. […] L’affezione che
quell’uomo ha per le antichissime opinioni e per le vecchie costumanze delle
genti di villa; la profonda venerazione che conserva per i suoi maggiori che
gliele hanno trasmesse e raccomandate caldamente; […] altrettante sorgenti di
errori popolari inespugnabili; renderanno inutili le cure di chi travaglierà a
disingannarlo.[33]
La «profonda», ma spesso fuorviante,
«venerazione», di cui parla Leopardi, viene espressa con vigore macchiettistico
dal dottor Elia, che con estrema confusione mette a tacere mastr’Alì,
tacciandolo di mancanza di spessore culturale, elencando una sequela di
luminari di svariate discipline, allo scopo di conferire dignità alle proprie
credenze, nonostante l’identità di alcuni di loro sia ignota: «Tacete, pratico!
Voi non avete letto- voi non sapete leggere- in libri autorevoli. Voi non
conoscete Ippocrate, Galeno, Avicenna, Bellèo, Alàimo, Petronillo…».[34] La lacuna generata da una
parziale mancanza di supporto scientifico, viene colmata dall’uomo con
l’immaginazione, che genera, tra le altre, le astruse teorie dell’Accademia dei
Platoni Redivivi, spunto per Consolo di una caustica satira sul sapere, i cui
protagonisti sono ridotti ad astratte categorie. L’Accademico Anziano, l’
Astronomo, il Fisico, il Metafisico, il Protomedico, si ritrovano a
«pontificare sulla luna, coscienti della loro importanza e sapienza, mostrando
conoscenze scientifiche e idee preconcette del Settecento»[35], creando un’ulteriore
legame con le riflessioni leopardiane sull’approccio ai fenomeni astronomici:
Si vede un effetto meraviglioso, e
come avviene bene spesso, se ne ignora la cagione. […] Ciò bastava per far
nascere un pregiudizio, poichè l’uomo non si contenta di osservare un effetto,
rimanendo nella sua mente affatto incerto intorno alla causa di esso. Sovente
egli si forma subito nel suo intelletto un’idea ordinariamente falsa di ciò che
può produrlo. […] Le stelle si vedevano muoversi regolarmente e con ordine
invariabile: esse si crederono animate. […] Da che sono nati tutti questi
errori, se non dall’ignoranza delle cause?[36]
In antitesi, questa «idea ordinariamente
falsa», a patto di formarsi negli animi incontrovertibilmente inclini alla
scrittura, che non attribuiscono ai doni dell’immaginazione dignità scientifica,
genera poesia, mito, che fin dagli albori della civiltà umana è intervenuto là
dove la scienza coeva era manchevole. E il mito della luna sembra aver avuto un
crollo, al pari della luna di Lunaria, in
un preciso momento individuato da Consolo nelle considerazioni conclusive sulla
genesi dell’opera stessa, conferendo a Piccolo il primato di aver anticipato,
(o l’aveva anticipato Leopardi?)
quello che sarebbe effettivamente accaduto da lì a qualche anno- la caduta del
mito della luna, appunto-, che il 21 luglio del 1969 un’astronave di nome
Apollo-il fratello gemello di Diana- approdasse sulla superficie di quell’astro
e che degli uomini lo profanassero danzandovi sopra con i loro scarponi di
metallo (ah, fu quello un giorno fatale per i poeti, ma Piccolo fece in tempo a
non viverlo, era scomparso nel maggio di quello stesso anno).[37]
L’amara, ma profondamente ironica,
considerazione di Consolo, sembra estendersi, attraverso il generico
appellativo di ‘poeti’, a chi abbia sognato la luna e abbia trasformato questo
sogno in poesia. Il viaggio sulla luna, astro prima d’ora irraggiungibile, ha
incantato poeti e scrittori, che hanno tentato di colmare il divario
tecnologico con l’assegnazione di connotazioni sempre diverse all’ipotetica
conquista della stessa: a partire da Dante, fino a Calvino, la luna ha cambiato
il proprio volto, ma è rimasta sempre, pur sotto diversi aspetti, specchio
dell’umano. E l’impavido paladino di Ariosto, il poeta «cosmico e lunare»[38] viene richiamato alla
memoria da Consolo in forma diretta all’interno dell’opera, a suggellare la
connessione che, attraverso i secoli, perdura nella letteratura di chi omaggia
la luna:
Là, dove giunse Astolfo in groppa
all’Ippogrifo per cercarvi il senno del folle Paladino, là, come canta il Poeta,
è dammuso, catoio, pozzo nero di tutte le carenze, le pazzie, i sonni, gli
oblii, gli errori della Terra.
Dall’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne
istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro
difetto
o per colpa di tempo o di fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.[39]
Ariosto assegna alla luna il ruolo di
detentrice di ciò che sulla terra è stato perso e la descrizione operatane
risulta reduce di precedenti lezioni, alcune accolte, altre riprese ironicamente.
Tra di esse troviamo l’esempio più illustre, il viaggio dantesco, i cui versi
sono esplicitamente riportati nell’opera di Consolo, che affronta, tra le
questioni dottrinali, quella delle macchie lunari, spunto di dissertazione
sulle caratteristiche dell’astro:
La concreata e perpetüa sete
del deïforme regno cen portava
veloci quasi come ’l ciel vedete.
[…]
Parev’ a me che nube ne coprisse
lucida, spessa, solida e pulita,
quasi adamante che lo sol ferisse.
Per entro sé l’etterna margarita
ne ricevette, com’ acqua recepe
raggio di luce permanendo unita.[40]
La superficie lunare viene indagata da un
punto di vista astronomico, con particolare attenzione alla presenza di
imperfezioni sulla sua superficie, sulla cui origine Dante interroga Beatrice:
Ma ditemi: che son li segni bui
di questo corpo, che là giuso in
terra
fan di Cain favoleggiare altrui?».[41]
La luna di Ariosto, al contrario,
ironicamente «non ha macchia alcuna», pur presentando un paesaggio speculare a
quello terreno, per sottolinearne il legame con le vicende umane. Il poeta
appare d’altro canto accogliere la descrizione presente nel Somnium di Leon Battista Alberti, in cui
Libripeta annovera «enormi vesciche piene di adulazione, di menzogne, di flauti
e trombe risonanti» accostate ai «benefici: sono ami d’oro e d’argento»[42], costruendo un paesaggio
speculare a quello albertiano:
Vide un monte di tumide vesiche,
che dentro parea aver tumulti e
grida;
e seppe ch’eran le corone antiche
e degli Assirii e de la terra lida,
e de’ Persi e de’ Greci, che già
furo
incliti, et or n’è quasi il nome
oscuro.
[…]
Ami d’oro e d’argento appresso vede
in una massa, ch’erano quei doni
che si fan con speranza di mercede
ai re, agli avari principi, ai patroni.[43]
Descrizione ritrovata nell’arringa
dell’Accademico Eccentrico in Lunaria, che
richiama alla mente degli astanti il volo siderale di Astolfo, e le conseguenti
osservazioni sul suolo lunare: «si fe’ allora specchio, retaggio, monito
perenne, ricettacolo delle sventure umane, fondaco d’otri, di vessiche, di
regni, filosofie, idoli trapassati».[44] Il momento di
congiunzione tra la visione letteraria di Ariosto e la valenza che la luna
assume nell’opera di Consolo, ultimo baluardo di poesia contro l’inaridimento e
l’afasia, si manifesta in Calvino, che, ripristinando tramite la narrazione
iconografica del Castello dei destini
incrociati il viaggio ariostesco, preannuncia le riflessioni consoliane,
immaginando il paladino Astolfo nell’atto di interrogare un solitario poeta,
ultimo abitante lunare:
Quale saggezza trarre per norma
della Terra da questa Luna del delirio dei poeti? Il cavaliere provò a porre la
domanda al primo abitante che incontrò sulla Luna: il personaggio ritratto
nell’arcano numero uno, Il Bagatto, nome e immagine di significato controverso
ma che qui pure può intendersi — dal calamo che tiene in mano come se scrivesse
— un poeta.
Sui bianchi campi della Luna,
Astolfo incontra il poeta, intento a interpolare nel suo ordito le rime delle
ottave, le fila degli intrecci, le ragioni e sragioni. Se costui abita nel bel
mezzo della Luna, — o ne è abitato, come dal suo nucleo più profondo, — ci dirà
se è vero che essa contiene il rimario universale delle parole e delle cose, se
essa è il mondo pieno di senso, l’opposto della Terra insensata.[45]
La poesia rimane dunque l’ultimo elemento
sull’astro ormai spoglio, ben lontano dalla ricchezza paesaggistica in Ariosto
e maggiormente affine al sentire di Consolo: «la vita lassù, impraticabile, si
fe’ esigua, disparve mano a mano».[46] Nonostante il decorso che
l’astro ha avuto in entrambi gli scrittori, la luna continua ad avere un’
incontrastata, probabilmente ineguagliata, valenza poetica:
«No, la Luna è un deserto,» questa
era la risposta del poeta, a giudicare dall’ultima carta scesa sul tavolo: la
calva circonferenza dell’Asso di Denari, «da questa sfera arida parte ogni
discorso e ogni poema; e ogni viaggio attraverso foreste battaglie tesori
banchetti alcove ci riporta qui, al centro d’un orizzonte vuoto.»[47]
Il Viceré Casimiro e gli abitanti di Lunaria
I figuranti che ruotano intorno alla luna
sono occasione in Consolo per compiere quella critica sociale, onnipresente
nelle sue opere, in cui lo scrittore doveva necessariamente impegnarsi per non
risultare complice delle incongruenze del presente. Persino un’opera così
strettamente legata all’immaginifico mondo settecentesco, grazie alla sapiente
caratterizzazione dei personaggi, «figure archetipiche che si elevano a
categoria di universali, incarnando realtà ontologiche e qualità permanenti»[48] diviene strumento di
lettura dell’umano, prescindendo dal momento storico. Primo fra tutti il Viceré,
di cui viene svelato l’inganno già dalle prime pagine attraverso l’espediente
del manichino, scudo e alter ego del
regnante, inganno confermato dall’epilogo che mostra la profonda consapevolezza
di un disilluso Viceré di rappresentare un’effige di un potere fittizio, il cui
risveglio, dipinto con sfumature squisitamente ironiche, sembra ricalcare le
patetiche rimostranze del Giovin Signore del Giorno di Parini: «No, no, no… Avverso giorno, spietata luce,
abbaglio, città di fisso sole, isola incandescente…»[49]. Il Viceré viene
pazientemente accudito dal valletto Porfirio, similmente ai servi fedeli, che
si affrettano a schermare i raggi del sole per favorire il sonno tardivo del
nobile parodiato da Parini:
Già i valetti gentili udìr lo
squillo
de’ penduli metalli a cui da lunge
moto improvviso la tua destra
impresse;
e corser pronti a spalancar gli
opposti
schermi a la luce; e rigidi
osservaro
che con tua pena non osasse Febo
entrar diretto a saettarte i lumi.[50]
La caricatura di regnante offerta dal
Viceré Casimiro, a cui viene dato maggiore spazio rispetto alla precedente
versione di Piccolo, con la quale l’opera di
Consolo ha un esplicito rapporto di complementarità, è in origine
dipinta dal barone sulla falsa riga del
fratello Casimiro, con palesi intenti canzonatori confermati dalla descrizione
fattane dallo stesso Consolo, in cui l’ossessione per le bacinelle d’acqua,
disseminate in ogni dove all’interno della dimora nobiliare, ricorda
l’ossessione del Viceré di Piccolo per la tintura, di cui erano ricolme
numerose ciotole, similmente posizionate all’interno dell’abitazione:
Ogni tanto appariva anche il
fratello, il barone Casimiro, bello fresco rasato ed elegante come dovesse
uscire per qualche festa. Era invece, come mi rivelò una volta in gran
confidenza, ch’egli dormiva di giorno e vegliava di notte, e nel tardo
pomeriggio, quando s’alzava, faceva toilette perché più tardi sarebbe
cominciata la sua grande avventura dell’attesa notturna delle apparenze, delle
materializzazioni degli spiriti. Il barone era un cultore di metapsichica e
studiava trattati e leggeva riviste come “Luci e ombre”. Mi spiegò una sua teoria
sulle materializzazioni, non solo di uomini, ma anche di cani,
di gatti, mi disse che a quelle
presenze, per lo sforzo nel materializzarsi, veniva una gran sete ed era per
questo che per tutta la casa, negli angoli, sotto i tavoli, faceva disporre
ciotole piene d’acqua.[51]
Il processo di rielaborazione del reale,
innestato alle componenti storico-immaginifiche su cui affonda le radici
l’intreccio della narrazione, viene puntualmente esaminato da Sciascia, le cui
riflessioni sullo stile di Piccolo sono estendibili al sentire poetico di
Consolo, essendo entrambi fautori di uno stile barocco e verticale:
Ma la realtà è, per un poeta
barocco specialmente, insufficientemente poetica: e viene perciò sottoposta a
un processo di «degnificazione». Vale a dire che la realtà viene per troppo
amore soppressa, liquidata, nel punto stesso della massima esaltazione.[52]
I due autori, specchio di due modi diversi
di intendere la scrittura barocca e il proprio apporto alla società, di
aristocratico distacco in uno, di convinto e profondo intervento nell’altro,
hanno in comune la piena adesione al sostrato spagnolo da cui la cultura
palermitana in special modo è stata profondamente influenzata:
Il macabro, nello stesso tempo
fastoso, caratteristico di certi ambienti e di certe mentalità di Palermo (che
ora non ci sono più, credo) proviene dalla Spagna, proviene dall’elemento
spagnolo che noi palermitani abbiamo subìto molto.[53]
Non è un caso che Cesare Segre assimili la
figura del Viceré a quella del Principe Sigismondo de La vida es sueño di Calderòn de la Barca[54], in quanto i due nobili
condividono entrambi i volti della speranza: il sogno e l’illusione. L’intera esistenza per Sigismondo è sogno,
dominata dall’illusorietà, intrinseca nella sfera onirica, in cui illusorio è persino
il tempo, realtà fugace e velleitaria, del cui sentire il Viceré Casimiro si
mostra in qualche misura erede:
Tutto è macèria, sabbia, polvere,
erbe e arbusti ch’hanno coperto i loro resti. Malinconia è la storia. Non c’è
che l’universo, questo cerchio il cui centro è ovunque e la circonferenza da
nessuna parte, questo incessante cataclisma armonico, quest’immensa anarchia
equilibrata. Ma se malinconia è la storia, l’infinito, l’eterno sono ansia,
vertigine, panico, terrore. Contro i quali costruimmo gli scenari, i teatri
finiti e familiari, gli inganni, le illusioni, le barriere dell’angoscia.[55]
Tuttavia l’epilogo della medesima
inferenza è differente: la morte come unica realtà possibile per il principe
polacco, disvelatrice delle illusioni dell’esistenza e dell’inconsistenza
dell’universo sensibile, la luna per il Viceré palermitano, «questa mite,
visibile sembianza, questa vicina apparenza consolante, questo schermo pietoso,
questa sommessa allegoria dell’eterno ritorno. Lei ci salvò e ci diede la parola,
Lei schiarì la notte primordiale, fugò la dura tenebra finale».[56] L’inganno della realtà
teatrante viene svelato e Sigismondo, divenuto Principe, non è più Sigismondo,
d’altro canto Casimiro non è più il Viceré, ammette con amarezza di averlo
malvolentieri impersonato e teatralmente si sveste delle effigi del potere,
abbandonando scettro e mantello. È proprio nei momenti essenziali del racconto,
il prologo e l’epilogo, che Consolo denuncia la natura metateatrale di Lunaria, in cui i confini tra realtà e finzione
vengono consapevolmente e visibilmente intrecciati, per restituire al lettore
un ordito di sensibile profondità critica:
Dal “Preludio”, il Viceré,
collocato dietro il suo manichino che chiama “quel muto commediante di
quest’Opra”, presenta lo scenario dove si sviluppa la favola, spogliato della
sua personalità come fosse un attore mentre recita il suo proemio: “E qui è il
corpo grande, la maschera della giovine disfatta, la rossa, la palmosa, la
bugiarda…”. Al termine dell’opera, nel suo “Epilogo”, Consolo è ancora più
esplicito: “Non sono più il Viceré. Io l’ho rappresentato solamente (depone lo
scettro, si toglie la corona e il mantello). E anche voi avete recitato una
felicità che non avete. Così Porfirio (Porfirio si spoglia della livrea, degli
scarpini, del turbante)”.[57]
Il lascito di entrambe le sceneggiature
teatrali, è ancora una volta speculare: «è finzione la vita, malinconico
teatro, eterno mutamento»[58], «Qué es la vida? Una
ilusiòn, una sombra, una ficciòn…»[59], in quanto l’esplicito
impianto teatrale diviene spunto per polemizzare, attraverso i due periodi
storici in cui operano gli autori, barocco per Calderon de la Barça e moderno
per Consolo, sulla vuotezza dei ruoli societari, rovesciando i rapporti di
potere attraverso l’intreccio della narrazione.
In Consolo l’esasperazione delle dicotomie negli exempla di accademici, la cui ironica categorizzazione riflette la
staticità del ruolo e la cristallizzazione del pensiero, svela le
contraddizioni di chi presumibilmente detiene il sapere, ma sceglie di
avvalersene autoreferenzialmente. Ad essi, così come agli ecclesiastici, a cui
il Viceré riserva caustici interventi, i quali, irrimediabilmente distanti
dalla sostanza ascetica e spirituale cui la loro veste dovrebbe tendere, digradano
verso le bassezze della gola, dell’avarizia e dell’abuso di potere, Consolo
contrappone la saggezza popolare dei villani della Contrada Senza Nome. Essi,
provenienti da una contrada spogliata dai nomi dei luoghi, e quindi in qualche
modo dalla propria storia, recuperano i gesti essenziali e la memoria
dell’antica lingua, dei rituali atavici, in cui risiede la poesia e dunque la
rinascita del mito della luna. Sotto un sole «tiranno indifferente, occhio che
abbaglia, che guarda e che non vede»[60] si consuma il decadimento
di una Palermo che è effige dell’intera società siciliana, al pari della
Regalpetra di Sciascia, che è in ogni dove e in nessun luogo, in quanto realtà
altra, ma plasmata dallo stampo di tutte le desolanti realtà su cui l’occhio
sagace dello scrittore si è posato. E la
desolante realtà presentata da Consolo è quella di un mondo «antico e nuovo,
carico di memoria, invaso dall’oblio»[61] e nell’ossimoro si
consuma la ricchezza del popolo siciliano. La catarsi anelata da Consolo,
inquieta supplica alle Muse nell’epiclesi, ha un’unica via per la sua
manifestazione: «un velo d’illusione, di pietà, / come questo sipario di
teatro»[62] e non è forse la luna,
«sipario dell’eterno»[63], l’assoluzione, il
riscatto, praticando essa stessa la catarsi rinascendo sopra le contrade
siciliane? La poesia, come la storia è imperituro teatro
destinato alla malinconia dell’eterno ritorno, ed è nella sua intrinseca
attitudine alla rinascita che risiede la salvezza dell’uomo.
«Dopo è l’arresto, l’afasia. È il
silenzio».[64]
[1] Gianni
Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, in Vincenzo Consolo, L’opera completa, a cura di Gianni Turchetta, I Meridiani, Milano,
Mondadori, 2015, p. LV.
[2] Paola
Baratter,
Lunaria [di Vincenzo Consolo]: il mondo salvato
dalla Luna, «Microprovincia», Stresa, XLVIII, 2010, pp. 85-93.
[3] Platone, Gorgia, citato in Giacomo
Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, a cura di Prospero Viani, Firenze, Le Monnier, 1851, p.
47.
[4] G.
Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli
antichi, a cura di Prospero Viani, Firenze, Le Monnier, 1851, pp. 127-128.
[5]Charles
Baudelaire, Il desiderio di dipingere, in Lo Spleen di Parigi. Poemetti in prosa,
XXXVI, in. Tutte le poesie e i capolavori
in prosa, trad. di Claudio Rendina, Roma, Newton & Compton, 1998, pp.
549-551.
[6] Ibidem.
[7]C.
Baudelaire, I benefici della luna, XXXVII, Ivi,
p.552.
[8] Johann
Wolfgang Goethe, Faust,
capitolo I, traduzione di G. Scalvini, Milano, Giovanni Silvestri, 1835, p. 22.
[9] Giovanni
Carpinelli, Invocazioni poetiche
alla luna, «Belfagor», 21 giugno 2014, http://machiave.blogspot.com/2014/06/invocazioni-poetiche-alla-luna.html
[10] Lucano, Farsaglia, cit., vv. 667-669.
[11]J. w. Goethe, An den mond (Alla luna), Vienna, Diabelli, 1850, vv. 7-8.
[12]J.W. Goethe, Faust e Urfaust, traduzione, introduzione e note di G. V. Amoretti, Feltrinelli, Milano,
1965, p. 451.
[13] Ivi, XXXVII Canto, Odi, Melisso o Lo spavento notturno, pp. 141-142, vv. 1-20.
[14] V.
Consolo, Lunaria, cit., p. 80.
[15] Ibidem.
[16] Ivi, pp. 71-72.
[17] Ibidem.
[18] Ivi, p. 65.
[19] Cesare
Segre, Un profilo di Vincenzo Consolo, in Vincenzo Consolo, L’opera completa, a cura di Gianni Turchetta, I Meridiani, Milano,
Mondadori, 2015, pp. XIV-XV.
[20] Ibidem.
[21] Orazio, Sermo VIII, citato in G. Leopardi,
Saggio sopra gli errori popolari degli
antichi, cit., p. 37.
[22] V.
Consolo, Paesaggio metafisico di
una folla pietrificata, «Corriere della Sera», 19 ottobre 1977.
[23] Daragh
O’Connell, La notte della ragione – fra politica e
poetica in Nottetempo, casa per casa, Milano, Università degli Studi, 6 – 7
marzo 2019, http://vincenzoconsolo.it/?p=1815 [ultimo accesso: 14 novembre
2020]
[24] Miguel de CERVANTES, Los trabajos de Persiles y
Sigismunda, a cura di C. Romero,
Madrid, Cátedra, 2002, p. 244.
[25] Pirandello,
Male di luna, «Corriere della Sera»,
22 settembre 1913, poi in Le due maschere,
Quattrini, Firenze 1914, poi nella nuova edizione riveduta della raccolta dal
titolo Tu ridi, Milano, Treves, 1920
col titolo Quintadecima, ora in Id. Novelle
per un anno, in Opere di Luigi
Pirandello, vol I, Milano,
Mondadori, 1980, pp. 1297-1298.
[26] Ibidem.
[27] P.
Baratter, Lunaria [di Vincenzo
Consolo]: il mondo salvato dalla Luna, cit., pp. 85-93.
[28] V. Hugo, Claire de lune, Les Orientales, Parigi, Ollendorf, 1912, p. 670, v. 1.
[29] Pirandello,
Male di luna, cit., pp. 1300-1301.
[30] Irene
Romera Pintor, Introduzione a Lunara: Consolo versus
Calderòn, a cura di G. Adamo, La parola scritta e pronunciata. Nuovi
saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, Lecce, Manni, 2006, p.171.
[31] V.
Consolo, Lunaria, cit., p.60.
[32] Ivi, p .46.
[33] G.
Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli
antichi, cit., pp. 300-01.
[34] V.
Consolo, Lunaria, Milano,
Mondadori, 2013, p.45.
[35]Irene
Romera Pintor, Introduzione a Lunara: Consolo versus
Calderòn, cit., pp.166-167.
[36] G. Leopardi,
Saggio sopra gli errori popolari degli
antichi, cit., pp.302-03.
[37] V.
Consolo, Lunaria, pp.125-26.
[38] I. Calvino, Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società, Torino,
Einaudi, p. 183.
[39] V.
Consolo, Lunaria, cit., p. 64.
[40] D.
Alighieri, Canto II, Paradiso, Commedia, a cura di Umberto
Bosco e Giovanni Reggio, Firenze, Le Monnier, 1984, vv. 19-36.
[41] Ivi, vv. 49-51.
[42] L. B.
Alberti, Intercenales, a cura di Bacchelli e D’Ascia, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 228-241.
[43] L. Ariosto, Orlando Furioso, XXXIV, a cura di Lanfranco Caretti, Torino,
Einaudi, 2015, vv. LXXVI-LXXVII.
[44] V. Consolo, Lunaria, cit., p.64.
[45] I. Calvino,
Il castello dei destini incrociati,
Milano, Mondadori, 2016, p.40.
[46] V. Consolo, Lunaria, cit., p.64.
[47] Ivi, p.41.
[48] I. R.
Pintor, La parola scritta e pronunciata, cit.,
p. 169.
[49] V. Consolo, Lunaria, cit., p.18.
[50] G.
Parini, Il mattino, (seconda
edizione), Il Giorno, in Id., Il giorno, le odi, dialogo sopra la nobiltà,
introduzione e note di Saverio Orlando, Milano, Rizzoli, 1978, vv.70-75.
[51] V. Consolo, Il barone magico, «L’Ora», 17 febbraio 1967.
[52] L. Sciascia,
Le “soledades” di Lucio Piccolo, in La corda pazza. Scrittori e cose della
Sicilia, Torino, Einaudi, 1970, p. 23.
[53] A. Pizzuto,
L. Piccolo, L’oboe e il clarino,
a cura di A. Fo e A. Pane, Milano, Scheiwiller, 2002, pp.
177-181.
[54] C.
Segre, Teatro e racconto su
frammenti di luna, in Intrecci di
voci, Torino, Einaudi, 1991, pp. 87-102.
[55] V.
Consolo, Lunaria, cit., p. 80.
[56] Ibidem.
[57] I. R.
Pintor, La parola scritta e pronunciata, cit.,
pp. 169-170.
[58] V.
Consolo, Lunaria, p.85.
[59] Don
Pedro Calderon de la Barça, La
vida es sueno, II Giornara, scena
19, a cura di C.
Morón, Madrid, Catedra, 2005, vv. 2183-4.
[60] V.
Consolo, Lunaria, cit., p.85.
[61] Ibidem.
[62] V.
Consolo, Catarsi, cit.
[63] V.
Consolo, Lunaria, cit., p.85.
[64] V. Consolo, Per una metrica della memoria, Relazione tenuta al Centro di Studi sul Classicismo di Palazzo Pratellesi a San Gimignano in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Milano, 12 gennaio 1996, versione cartacea in «Bollettino ‘900 – Electronic Newsletter of ‘900 Italian Literature», VI-XI, 1997, pp. 25-29.