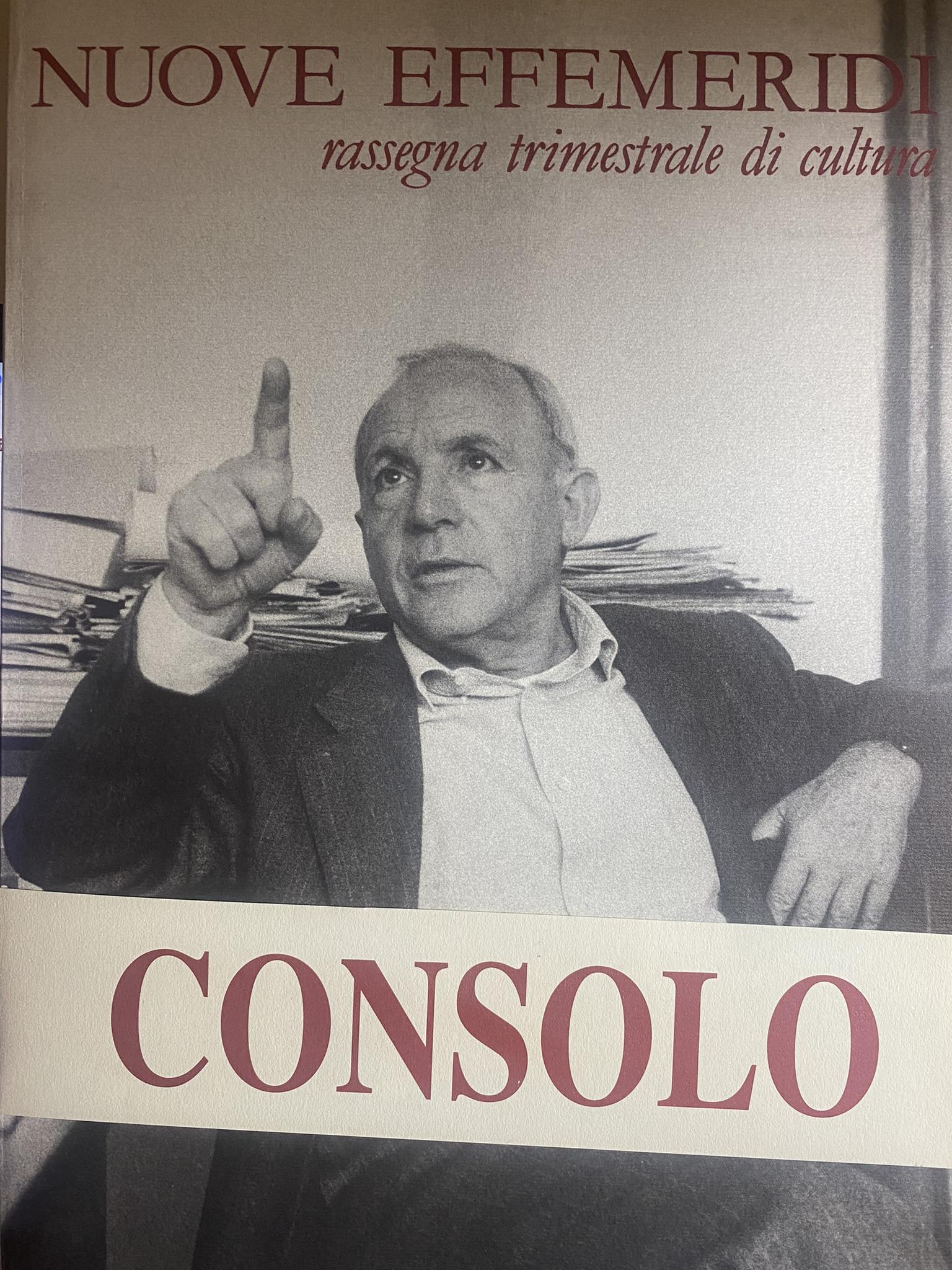Tag: Pier Paolo Pasolini
“Un sogno perso” por PASQUALE SCIMECA
“Un sogno perso” è il mio secondo film, ed è un film che deve molto a Vincenzo Consolo, ma questo lui non lo sa. Nel 1988, io facevo l’insegnante. Come spesso accadeva a tanti della mia generazione, dopo la laurea, sono andato a lavorare nelle regioni del nord Italia; perché lì c’erano più possibilità.
Durante l’estate tornavo al mio paese per stare un po’ con i miei e ritrovare i vecchi amici. Quella estate del 1988, al mio paese, avevano indetto un concorso di fotografia. Il mio è un piccolo paese con poco più di mille abitanti, nel centro del feudo della Sicilia. I miei amici, che sapevano della mia passione per la fotografi a, mi esortavano a presentare le mie foto a questo concorso. Io, sinceramente, non ero molto interessato alla cosa e non volevo farlo; però quando mi dissero che il Presidente della giuria era Vincenzo Consolo, ho deciso di partecipare per avere così la possibilità di conoscerlo. Il primo premio, per chi vinceva questo concorso, consisteva nella solita “targa”, e cosa più importante, in un milione di lire (circa cinquecento euro di oggi). Così cominciai ad andare in giro per le campagne a fotografare i pastori e i contadini, (quelli che ancora resistevano a quella vita di stenti). Alla fi ne fui io che vinsi il primo premio, e con i soldi mi comprai una cinepresa Arriflex 16 mm di seconda mano. Il possesso di questa cinepresa stimolò la mia antica passione per il cinema; e fu così che iniziò la mia carriera cinematografica. Vincenzo Consolo, suo malgrado, ha dunque una responsabilità molto grande per quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro. Anche perché senza quel milione del premio non avrei mai comprato quella cinepresa (che conservo ancora come un cimelio) e non avrei mai iniziato a fare cinema.
I miei due primi film (La donzelletta e Un sogno perso) li ho fatti con quella cinepresa, e questo mi ha permesso, soprattutto, di sviluppare la mia idea di cinema autoriale; dalla scrittura alla fotografia, dal montaggio alla produzione. Eravamo un gruppo di amici ai quali piaceva il cinema e abbiamo coinvolto altre persone, e così abbiamo fatto, a bassissimo costo, La donzelletta. Poi questo fi lm è stato comprato da Enrico Ghezzi per Fuori Orario che andava (e va ancora) in onda su Rai Tre. E sempre Rai Tre ci ha dato i soldi (cento milioni di lire —cinquantamila euro circa di oggi—) per il secondo film: Un sogno perso.
Dopo questa piccola parentesi, vorrei tornare a parlare dei temi, che in questi due giorni di convegno, hanno affrontato l’opera di Vincenzo Consolo, partendo proprio dal mio secondo film Un sogno perso.
I due primi episodi del film sono tratti dalle opere di due grandi scrittori siciliani: Elio Vittorini e Vincenzo Consolo. Dico scrittori siciliani e non italiani, perché una parte importante della letteratura italiana del secolo scorso è stata opera di autori siciliani (Pirandello, Brancati, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, per citare solo i più noti). Una cosa, questa, che mi ha sempre colpito; perché fi no alla metà del secolo scorso, in Sicilia, l’ ottanta per cento della popolazione era analfabeta. Mi sono sempre chiesto; come è possibile che da un popolo di analfabeti siano potuti uscire questi grandi scrittori? Io credo, che in qualche modo, questo abbia a che fare col fatto che l’arte del racconto, il gusto e il piacere del racconto
(che purtroppo oggi si è perso) è un qualcosa di insito nell’animo del popolo siciliano. In tutti i paesi c’erano delle persone: artigiani, contadini, pescatori, minatori, ecc., che erano stimati e amati solo perché avevano il dono del racconto. Da bambino passavo anch’io il mio tempo seduto nelle botteghe dei barbieri o dei calzolai a sentire i loro racconti. E poi c’erano i Cantastorie con le loro chitarre e i loro cartelloni dipinti, e i pupari, questi artigiani dell’arte che intrattenevano il pubblico, non una sera o due, ma trecento sessanta sere all’anno, ogni sera c’era una puntata, con racconti straordinari che assomigliavano molto a quelli delle Mille e una notte. Un sogno perso è un film di tanti anni fa: del 1992. Un film su un sogno, perso per l’appunto. Il sogno di un mondo, quello della mia infanzia, della civiltà contadina spazzata via da una nuova forma di civiltà che P. P. Pasolini chiamava del consumismo, dove ci sono tutte quelle cose che dicevo prima, ma c’è soprattutto la letteratura. Il primo episodio è tratto da Filosofiana di Consolo e il secondo dall’ultimo romanzo (incompiuto) di Vittorini Le città del mondo.
Quello che ho fatto, rispetto al racconto di Consolo, è un’ opera, diciamo così, di tradimento. Perché dal momento che faccio un film tratto da uno scrittore è chiaro che lo tradisco. Lo tradisco nella forma e nella sostanza. Per me, l’episodio del libro di Consolo Filosofiana è anche un modo per raccontare un’altra cosa (che poi, credo, sia insita, sostanzialmente anche in Consolo), ma per me è una cosa più esplicita. Nel mio caso è una scusa per raccontare qualcosa di questo mondo che andava scomparendo; della Sicilia vista come metafora della civiltà contadina, questa millenaria civiltà contadina che si è riprodotta quasi uguale nel tempo. Per secoli e secoli ha riprodotto se stessa, con pochissime innovazioni, però anche con una pratica culturale e sociale, con un’idea del rapporto con la natura, con la cultura, l’educazione, e che nell’arco di qualche decennio è stata completamente annientata, distrutta. E questo in Sicilia è avvenuto anche fisicamente attraverso l’ emigrazione. Milioni di contadini, che avevano iniziato ad andare via già verso la fi ne dell’Ottocento, quando partivano a migliaia e migliaia, sui piroscafi che li portavano in America, in Argentina, in Brasile e perfino in Sudafrica. Ma negli anni cinquanta del secolo scorso, la cosa è diventata una vera e propria desertificazione, di una civiltà, di una cultura ma anche di una terra che cambiava. Prima di partire in massa i contadini, a dire il vero, avevano tentato una qualche forma di resistenza, disperata, folle, eroica. L’ultimo tentativo di resistenza, sono state le lotte contadine. Negli anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale, centinaia di migliaia di contadini hanno tentato di cambiare se stessi, di cambiare le cose, di scardinare quelle forme di potere feudale che si basavano sulla mafia, sulle classi aristocratiche, sulle gerarchie ecclesiastiche, sulle burocrazie del nuovo Stato unitario. Purtroppo queste lotte sono fallite, e il movimento contadino non si è più ripreso. Non solo il movimento contadino, ma l’intero popolo siciliano ha perso la sua identità e la sua anima. Ho parlato di popolo, ma in realtà, in Sicilia vi erano almeno tre popoli: quello dei pescatori, quello dei minatori e quello dei contadini. Erano mondi separati che spesso non avevano alcun rapporto fra di loro. Il minatore la mattina scendeva in miniera e non sapeva se la sera sarebbe tornato in superficie. Questo fatto determinava un modo di essere, una caratteristica esistenziale che lo distingueva da tutti gli altri. I contadini, ad esempio, si vestivano a festa soltanto in rarissime occasioni (funerali, matrimoni, battesimi, ecc.), mentre i minatori, ogni fi ne settimana si vestivano di modo elegante e andavano ad ubriacarsi nelle taverne, spendevano tutti i soldi che avevano guadagnato e che rimanevano, dopo le spese per la famiglia, perché tanto poi, chi sa se sarebbero tornati vivi dalle viscere della terra, l’ indomani tornando al lavoro. Per non parlare dei pescatori, che spesso parlavano dei dialetti propri, incomprensibili agli altri. Erano veramente tre mondi diversi l’uno dell’altro, ma accumunati da un’ unico destino; quello dell’estinzione. Questi popoli, scomparendo, hanno lasciato un deserto, ed è di questo che si parla nel mio film “Un sogno perso”, che poi è anche il mio sogno perso. Io vengo da un piccolo paese contadino… Per qualsiasi ragazzo del mio paese, Cefalù (la stessa Cefalù dove Consolo ha ambientato II sorriso dell’ignoto marinaio) era la civiltà, era il mondo. Sono andato a studiare a Cefalù dopo le scuole elementari, e quando uscivo per strada, spesso rimanevo sbalordito da questo nuovo mondo: i negozi, le ragazze in costume che si vedevano in estate, la cattedrale imponente, i palazzi signorili… Questo film mi ha aiutato a cercare un sogno che non esiste più. Un sogno che non potrà più ripetersi e qual è il modo migliore di cercare i sogni? Cercare nella letteratura; ecco perché Consolo, ecco perché Vittorini. Questi due episodi che i due grandi scrittori raccontano nei loro libri, mi sembravano fossero molto importanti perché in qualche modo erano degli episodi che seguivano in un arco di tempo (dalla fi ne della guerra fi no agli anni cinquanta), la delusione provocata dal fallimento delle lotte contadine. Vito Parlagreco che cerca di rifarsi una vita comprando questo pezzetto di terra pieno di pietre, perché erano delle vere e proprie pietraie le terre che una falsa riforma agraria dava ai contadini. Così come Vittorini in Le città del mondo ci racconta di quello che succede dopo. L’incomunicabilità tra padri e figli, la paura dei padri per l’ignoto e il desiderio dei figli di partire, di cancellare le orme dei padri. La rottura del Mito, l’inutilità della parola e della scrittura che caratterizzeranno gli ultimi anni di vita di Vittorini, e la ricerca spasmodica, quasi maniacale che Consolo dedica alla scrittura, sono le due facce della stessa medaglia. Si può scrivere di un mondo che sta scomparendo? Si può scrivere con parole che per le generazioni future non avranno più alcun significato? Lo si può fare a condizione di guardare alla storia come fosse l’anima del popolo, a condizione di rinunciare a qualsiasi forma di verismo e di andare all’essenza; “Eschilo, è nato qui, in terra di Sicilia” fa dire Consolo a don Gregorio, l’imbroglione che leva a Parlagreco l’ultima vana illusione. Eschilo il grande tragico… Chissà attraverso quale associazione d’idee mi viene in mente Verga. Forse perché penso che Verga è anche lui un grande tragico. Vittorini non è stato un grande tragico, ma tendeva in qualche modo alla tragedia attraverso la costruzione del mito. Consolo cerca la tragedia attraverso la parola, attraverso questo altro modo di lavorare la parola, di alzare il livello della realtà alla metafisica, scavando le parole come un minatore. Io quando sento parlare di letteratura regionalistica provo un po’ fastidio perché penso che la letteratura siciliana non ha niente di regionale, è pura metafora. È un caso che parla di Sicilia, anche se senza Sicilia non potrebbe esistere. Come diceva Vittorini (in Conversazioni in Sicilia) “È per caso che questa storia si svolge in Sicilia”. Dunque la Sicilia —come diceva un altro grande: Leonardo Sciascia— è una metafora del mondo. Quindi è una bella miniera per uno scrittore, dalla quale poter estrarre i minerali che si sciolgono nella lingua, che tra l’altro è una lingua molto ricca (c’è dentro qualcosa della lingua araba, di quella greca, spagnola, francese, italiana). Una lingua profonda che ha radici, che si nutre della terra. Questo è un po’ l’origine di questo film. Dove non c’è solo un riferimento letterario, ma un processo che parte dalla letteratura e diventa altro – perché il cinema è altro – Un bisogno esistenziale, un tentativo di raccontare la desertificazione di un mondo, la scomparsa di un popolo che può tornare a vivere solo nel sogno. Perché senza questo sogno non c’è letteratura, ma non c’è neanche il cinema. Grazie.
La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO
(Homenaje por sus 75 años)
Irene Romera Pintor (Ed.)
foto di Marino Ciardi
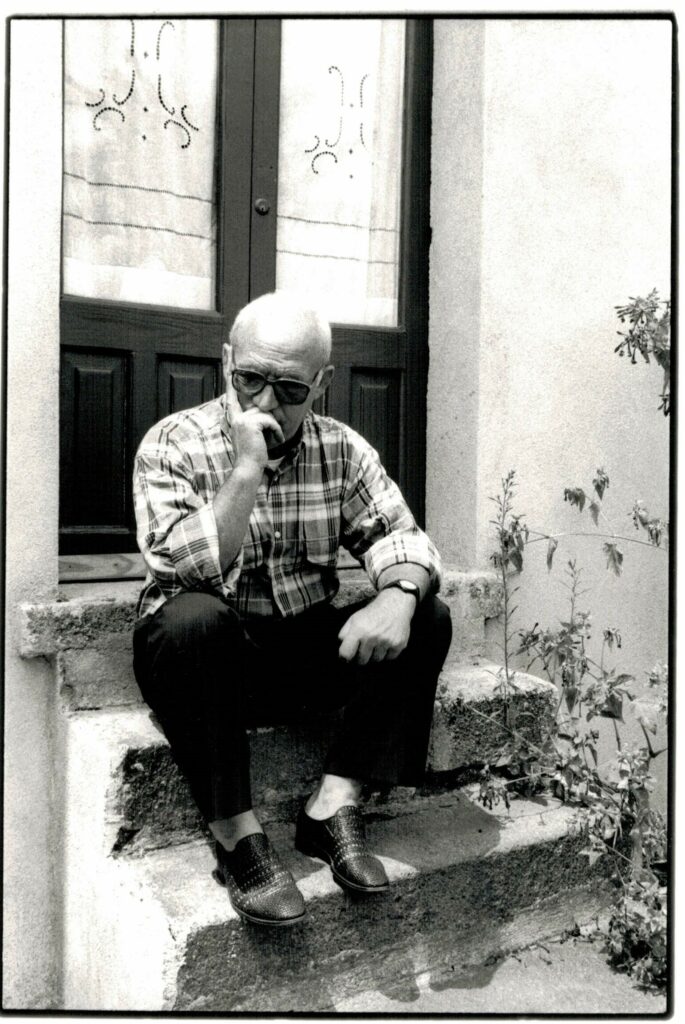
MERCATALE: UN PAESE METAFORA DELL’ITALIA
Nell’esilio di Lucania, nel 1943, Carlo Levi scriveva nel suo Cristo si è fermato ad Eboli: “Noi non possiamo oggi prevedere quali forme politiche si preparino per il futuro: ma in un paese di piccola borghesia come l’Italia, e nel quale le ideologie piccolo-borghesi sono andate contagiando anche le classi popolari cittadine, purtroppo è probabile che le nuove istituzioni che seguiranno al fascismo, per evoluzione lenta o per opera di violenza, e anche le più estreme e apparentemente rivoluzionarie fra esse, saranno riportate a riaffermare, in modi diversi, quelle ideologie; ricreeranno uno stato altrettanto, e forse più, lontano dalla vita, idolatrico e astratto, perpetueranno e peggioreranno, sotto nuovi nomi e nuove bandiere, l’eterno fascismo italiano”. Straordinaria analisi, questa di Levi, che si fa profezia, scritta ancora prima che il regime fascista di Mussolini crollasse, prima che nel nostro Paese tornasse la democrazia. Consapevolmente o inconsapevolmente, Pasolini, nel ’75, a pochi mesi dalla sua tragica morte, in quell’articolo delle “lucciole”, apparso sul “Corriere della sera”, riecheggiava Carlo Levi nell’affermare la perfetta continuità tra il fascismo fascista e il fascismo democristiano. Fascismo democristiano che aveva provocato “la scomparsa delle lucciole”, metafora di quella radicale mutazione antropologica, culturale, linguistica, che il nostro Paese aveva avuto a cavallo degli anni Sessanta con il cosiddetto miracolo economico, con l’ingigantirsi dei mezzi di comunicazione di massa, della televisione soprattutto, che avrebbe portato poi in forma totalizzante al berlusconiano fascismo pubblicitario.
Eterno fascismo culturale italiano, sì, ma, subito a partire dal Secondo dopoguerra, il riinsorgere del fascismo politico, retaggio di quello storico crollato con la Resistenza e la guerra di Liberazione, ma neofascismo anche di fascinazione e di proselitismo giovanilistico, violento e stragista, fomentato e gestito da occulte forze inserite anche nei gangli del nuovo stato democratico.
Ma dagli antifascisti clandestini e perseguitati, confinati, carcerati, uccisi, ancora sotto il fascismo mussoliniano, dalla Resistenza è nato, sappiamo, nel Secondo dopoguerra, sul pensiero di Marx e di Gramsci, un forte partito comunista italiano. Partito che guardava sì alla Russia sovietica, ma che era anche, soprattutto, argine, in questo nostro Paese malato di “eterno fascismo”, all’insorgere di nuove dittature fasciste. E si sono giocati, fino al crollo del muro di Berlino, in questa nostra Italia-confine del mondo sovietico, da parte delle forze più occulte, nazionali e no, tutti i giochi più torbidi, più oscuri, più tragici.
Il PCI, il partito comunista italiano, ha fatto sì che la nuova democrazia conquistata con dolore e sangue non venisse ulteriormente distrutta. Il partito comunista di Togliatti e quello socialista di Nenni sono stati in Italia la militanza e la speranza non solo di intellettuali, ma soprattutto di masse di uomini e donne, di proletari, operai,contadini, che aspiravano al riscatto della loro condizione, al riconoscimento dei loro diritti al rispetto della loro dignità.
Questa storia italiana è stata letta con intelligenza, è stata rappresentata da un regista belga, Hugues Le Paige, con il film documentario intitolato Il fare politica – Cronaca della Toscana Rossa (1982-2004). La Toscana rossa, e precisamente un paese toscano di 3.000 abitanti, Mercatale, rimasto intatto nella sua architettura e natura di antica Toscana. “Bellissima Toscana contadina. Le cascine in pietra dalla pura, severa linea giottesca, le brune tegole muschiate. Ancora i bianchi buoi appaiati a tirare l’aratro, il fiocco rosso tra le corna, sulla fronte larga…Contadina, civilissima Toscana del lavoro, della fatica umana”.
A Mercatale Le Paige, dall’ ’82 incontra e dialoga con quattro paesani, vecchi militanti del PCI , partito che era per loro scuola e famiglia: Fabiana Falcioni (insegnante), Vincenzo Bartoli (ceramista), Claudio Bagnolesi (operaio), Carlo Giuntini (pensionato).
Nell’arco di vent’anni Le Paige ritorna di tempo in tempo a Mercatale e interroga questi protagonisti-testimoni. I quali dicono che cosa era il partito per loro, cosa significava l’impegno, l’attività politica: la speranza di una società giusta, armonica. E scorrono, sulle loro parole, immagini del passato, le riunioni nella Casa del Popolo, il comizio di Enrico Berlinguer; riecheggiano le note dell’Internazionale, di Bella ciao…e la Festa dell’Unità, del 1° Maggio, i funerali a Roma di Berlinguer…” Enrico, siamo qui, siamo qui!..” Urlano i militanti ai lati del corteo.
Passano gli anni e man mano tutto cambia, cambia il nome del partito, cambia la bandiera…Dice il vecchio calzolaio, padre di Giuntini: “I giovani oggi sono cresciuti nel benessere, non è più come prima. Come dice il proverbio, ‘il bisogno fa trottare la vecchia’” Ma crediamo che non sia solo questione di bisogno e di benessere, ma di mutazione politica, culturale, etica…
Nelle elezioni del ’94 vince la destra, Berlusconi e i suoi alleati fascisti e leghisti: rispunta nel governo “l’eterno fascismo italiano.” Ma la televisione…” canta Lucio Dalla.
I nostri quattro testimoni hanno reazioni diverse di fronte alla nuova realtà: si dimettono dal nuovo DS o vi rimangono, vanno con Rifondazione Comunista, oppure, come Fabiana s’impegnano nel sociale con opere di beneficenza. Ci sono due scene emblematiche in questo straordinario documentario-documento: lo spegnimento delle luci nella Casa del Popolo e lo sconquasso dei tendoni della Festa dell’Unità per un temporale.
Mercatale, la sua storia dal Secondo dopoguerra fino ad oggi è la metafora di questo nostro sventurato Paese. Rappresenta la dignità, la nobiltà dell’impegno di molti uomini di prima e lo squallore, il vuoto, la stupidità ne la volgarità di questo nostro Paese telestupefatto. Rappresenta il ritorno dell’ “eterno fascismo italiano”.
Vincenzo Consolo
Milano, 21.11.2006
Quanto ci mancano la penna e la spada di Sciascia.
di Vincenzo Consolo
«Chi sei?» domanda Danilo Dolci a Leonardo Sciascia durante il dibattito tenutosi al Circolo Culturale di Palermo il 15 aprile 1965. E Sciascia risponde: <<Sono un maestro delle elementari che si è messo a scrivere libri. Forse perché non riuscivo ad essere un buon maestro delle elementari. Questa può essere una battuta, ma per me è una cosa seria>>.
No, non è una battuta, perché sappiamo dalle sue Cronache scolastiche, pubblicate nel1955 nel numero 12 di “Nuovi Argomenti”, la malinconia, la pena, lo smarrimento e l’indignazione per le condizioni di quei suoi alunni di 5″ elementare, alunni poveri, figli di contadini e zolfatari. Pena e indignazione per le condizioni di Racalmuto, della Sicilia di allora e di sempre, sfruttata e umiliata dai “galantuomini”, oppressa dalla mafia. Inadeguato, incisivo, come si sente, nell’ insegnare, si mette a scrivere (ma Sciascia aveva già pubblicato, le Favole della dittatura nel 1950 e La Sicilia, il suo cuore nel 1952) e scrivere per lui, impugnare la penna, è come impugnare la spada, L’affilata, lucida e luminosa spada della ragione per dire, denunciare e quindi combattere i mali della società, le ingiustizie, le offese all’uomo, alla sua dignità. Aveva scritto Sciascia, nella premessa a Le parrocchie di Regalpetra, pubblicato nel 1956, parlando del suo paese, di Racalmuto: <<La povera gente di questo paese ha una gran fede nella scrittura, dice – basta un colpo di penna – come dicesse un colpo di spada – e crede che un colpo vibratile ed esatto della penna basti a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso. Paolo Luigi Courier vignaiolo della Turenna e membro della legion d’onore, sapeva dare colpi di penna che erano colpi di spada; mi piacerebbe avere il polso di Paolo Luigi per dare qualche buon colpo di penna.,.>>, e ribadisce, nella conversazione con Dolci: «Io concepisco la letteratura come una buona azione. Il mio ideale letterario, la mia bibbia è Courier, l’autore dei libelli. Courier definì il libello una buona azione.,.>>. Anch’io <<in effetti non ho scritto che libelli». Il libello o pamphlet. E siamo nel ’65, quando già Sciascia aveva pubblicato vari libri di narrativa, fra cui Gli zii di Sicilia, Morte dell’inquisitore, Il giorno della civetta, Il consiglio d’Egitto. Ma libello, dice, nel senso di buona azione, di impegno civile, vale a dire, sia in campo narrativo che in campo saggistico o giornalistico. Dice, ancora in quell’incontro con Dolci: <<Ho scritto libri di storia locale, in un certo modo, nel tentativo di raggiungere un pubblico anche popolare. Cosa che parzialmente mi è riuscita. E il mio impegno – ormai è diventato quasi ridicolo palare di impegno – ma io continuo a ritenermi uno scrittore impegnato. Perché fin quando c’è una realtà che si deve mutare, pena proprio la morte, come il caso nostro della Sicilia, io ritengo che esiste l’impegno dello scrittore>>. Scrittura narrativa, dunque, e scrittura libellistica, e scrittura saggistica e scrittura. giornalistica. E in tutte le scritture Sciascia ha come principio, come cifra stilistica la chiarezza. <<Il problema della chiarezza è per me come se lo può porre un giornalista, non come se lo può porre un letterato>>. E qui, in tema di chiarezza, di scrittura chiara ed estremamente comunicativa, siamo nel problema dello stile. Scrive Roland Barthes ne Il grado zero della scrittura: <<Lo sconfinare dei fatti politici e sociali nel campo di coscienza della letteratura. ha prodotto un nuovo tipo, diciamo, di scrittore situato a metà strada tra il militante e lo scrittore vero e proprio (…) Nel momento in cui l’intellettuale si sostituisce allo scrittore, nelle riviste e nei saggi nasce una scrittura militante interamente liberata dallo stile e che è come il linguaggio professionale della “presenza”>>. E ancora: «Nelle scritture intellettuali si tratta di scritture etiche, in cui la coscienza di chi scrive trova
l’immagine confortante di una salvezza collettiva.
Ora, crediamo che la distinzione barthesiana tra scrittore e intellettuale la si possa applicare a tanti scrittori, a partire dall’ Émile Zola del caso Dreyfus, ma nel caso di Sciascia non è possibile vedere quella dicotomia. Perché in Sicilia, in Italia, i fatti politici e sociali sconfinano con una tale irruenza, costanza e urgenza nella coscienza della letteratura che non è più possibile, per uno scrittore come Sciascia, praticare una lingua, uno stile per la scrittura narrativa e un altro per la scrittura di “presenza” o militante. <<Sono le grandi cose da dire che fanno la lingua>> afferma Sciascia. E anche; «Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla ragione scaturiscono>>. La ragione che dalla buia miniera di Racalmuto, dalla Sicilia, lo porta alla luce di quella regione, di quella città dove la lingua ha avuto la sua più alta e limpida declinazione, a quelle rive dell’Arno in cui Manzoni volle sciacquare i panni. Manzoni fino ai rondisti. «Debbo confessare che proprio dagli scrittori “rondisti” – Savarese, Cecchi, Barilli – ho imparato a scrivere. E per quanto i miei intendimenti siano maturati in tutt’altra direzione, anche intimamente in me restano tracce di tale esercizio>> scrive il Nostro nella prefazione alla seconda edizione del’67 delle parrocchie di Regalpetra. La fiorentina lingua dei rondisti, sì, ma scavalcando poi le Alpi e trovando più robusta consistenza in quella lingua “geometrizzata”, come la definisce Leopardi, che è il francese, la lingua dei suoi illuministi, degli amati Diderot, Voltaire e Courier, la lingua del suo “adorabile” Stendhal. Scrive Italo Calvino a Sciascia, in data 26 ottobre 1964 (la lettera è pubblicata nel numero 77 della rivista francese “LArc”, dedicato a Sciascia): <<Tu sei molto più rigoroso “filosofo” di me, le tue opere hanno un carattere di battaglia civile che le mie non hanno mai avuto, esse hanno una univocità che è loro propria nel pieno del pamphlet. (…) Ma tu hai, dietro di te, il relativismo di Pirandello, e Gogol tramite Brancati, e, continuamente tenuta presente, la continuità Spagna-Sicilia, Una serie di cariche esplosive sotto i pilastri dello spirito filosofico. Io m’aspetto sempre che tu dia fuoco alle polveri, le polveri tragico-barocco-grottesche che tu hai accumulato”. E questo potrà difficilmente prodursi senza una esplosione formale, della levigatezza della tua scrittura>>. Ma mai e poi mai Sciascia avrebbe dato fuoco alle polveri, avrebbe fatto esplodere il suo stile, la sua lingua illuministico-comunicativa. Poiché polveri, esplosioni e tragici continui crolli, caligini e disordini erano già nella realtà storicosociale della Sicilia, dell’Italia; libertà e giustizia erano in quelle realtà continuamente offese, offeso era il cittadino, l’uomo nei suoi diritti, nella sua dignità. E allora Sciascia, tagliente penna-spada, con quella limpida, luminosa lingua “geometrizzata” scrisse i suoi romanzi, racconti. pamphlet, articoli di giornale, con la barthesiana scrittura di “presenza” o militante. I fatti poi, i fatti siciliani, italiani erano (e, ahinoi, sono tuttavia, direbbe Manzoni) così gravi e urgenti da spingere Sciascia a scrivere, a intervenire sulle pagine dei giornali, a spingerlo a dire, a denunziare, a indicare là dove un male civile era in atto o avrebbe potuto manifestarsi. Ma in lui gli intellettuali giornalistici erano anche occasione di ripercorrere la storia, rivisitare episodi, indicare personaggi, libri, autori che quegli episodi ci fanno capire, di cui ci indicano la soluzione. Già, da anni lontani. dalla metà degli anni Quaranta, Sciascia comincia a scrivere sui “giornali, sulla “Sicilia del Popolo” e quindi sul ‘Corriere del Ticino”. la “Gazzetta del Mezzogiorno”. sul “Corriere della Sera”. “La Stampa”, oltre che su varie riviste italiane e straniere. Ma il suo rapporto più assiduo, costante e direi più connaturale, è stato con il giornale “L’Ora”.
Inizia nel 1955) con un articolo su Micio Tempio, la collaborazione se pure saltuaria, con quel glorioso giornale di frontiera. Ma è dal ’64 al ’67 che Sciascia tiene sul quel giornale la rubrica settimanale “Quaderno”. E il nuovo direttore del giornale, Vittorio Nisticò. approdato a Palermo nel 1955, per restare alla direzione di quel giornale fino al ’75, a invitare Sciascia, tramite Gino Cortese e Mario Farinella. A collaborare col giornale. E lo farà, Sciascia, fino agli ultimi suoi anni, fino a dettare alla figlia, poco prima di morire, una nota su Giuseppe Antonio Borgese. La grande firma di Sciascia si affiancava nella gloriosa storia dell’ “Ora”, Fondato nel 1900 da Ignazio Florio e diretto da Vincenzo Morello (Rastignac), a quella di Verga, Capuana, Borgese, Rosso di San Secondo, Serao, Scarfoglio, Brocca, Di Giacomo, Guglielminetti, Ojetti; e, alla grande firma di Sciascia, si affiancavano firme di scrittori e intellettuali a lui vicini: Guttuso, Caruso, Addamo, Renda, Marck Smith, Sapegno, Sanguineti, Lanza Tomasi, Franco Grasso, Dolci, Giarrizzo, Pantaleone, lo stesso che qui vi parla, ed altri ed altri ancora: per non dire di intellettuali entrati come giornalisti a “L’Ora”: Farinella, Cimino, Saladino. Perriera, Nicastro e altri. Il rapporto più stretto, più assiduo di Sciascia con “L’Ora” è stato, come dicevo, attraverso la rubrica settimanale “Quaderno”, che va dal 24 ottobre 1964 al 27 giugno 1967. Rubrica poi raccolta in volume, pubblicato nel ’91 dalla stessa editrice “L’Ora”. Nella introduzione da me scritta per quel volume, definivo Sciascia “scrittore di pensiero”, in contrapposizione a quello scrittore di sentimento che era Verga. E l’uno e l’altro quindi, con due visioni del mondo e con due stili, con due lingue diverse: l’uno, ripetiamo, con una chiara ed estremamente comunicativa lingua centrale” o illuministica; l’altro con un italiano “irradiato di dialettalità”, come l’ha definito Pasolini. L’uno con una lingua articolata, dialettica; l’altro con una lingua chiusa, circolare, come di versetti biblici o sure del Corano. E cosa più importante, dietro Sciascia e Verga vi erano due biblioteche. Dietro Sciascia vi furono quei dieci importanti libri in cui s’imbattè nella sua infanzia, e quindi la sterminata biblioteca del suo vasto, inesauribile sapere. Per cui la lineare chiara scrittura di Sciascia, aveva in sé delle vaste e profonde risonanze; era la sua, in modo esplicito o implicito una scrittura palinsestica (di riscrittura egli parlava). In Verga, invece, non c’era nessuna biblioteca (ci poteva essere, sì, Zola o Flaubert), c’era solo in luì la memoria di Acitrezza o di Vizzini, la memoria dei proverbi e dei modi di dire siciliani che egli traduceva appena, in italiano.
La Spagna, innanzitutto. La Francia, abbiamo detto, nel pensiero, ma, com’egli ha scritto, <<La Spagna nel cuore>>. La Spagna della Guerra civile, la Spagna di Cervantes e di Unamuno, quella dei poeti della generazione del ’27, antologizzati da Gerardo Diego, di Lorca, di Alberti, di Guillén, Cernuda. Machado, Salinas, Aleixandre, Alonso .,. La Spagna di Manuel Azana, l’ultimo presidente della repubblica spagnola, l’autore de La veglia a Benicarlò, che Sciascia aveva tradotto e introdotto per Einaudi. La Spagna ancora di Hemingwy e di Malraux, della città martire di Guernica e di Picasso dell’architetto Gaudì e di Robert Capa, della sconfitta dell’esercito fascista italiano a Gudalajara. Spagna e quanto di Spagna, attraverso lo schema del grande storico Américo Castro, è rimasto in Sicilia. Rimasto nelIa sua storia, nei costumi, nel modo di essere. Rimasto in quell’atroce fenomeno dell’lnquisizione. Inquisizione che è sì quella del Santo Uffizio a Palermo, del suo carcere qui. in questo palazzo dello Steri, dei messaggi degli inquisiti, dei Palinsesti del carcere. Quella Spagna e quella Sicilia di dolore e di orrore da cui sono scaturiti i racconti L’antimonio, Morte all’inquisitore, il Consiglio D’Egitto. Si chiude sì il Santo Uffizio a Palermo e il suo carcere, il giorno 27 marzo 1782, viene abbattuto l’orribile mostro”, come scrive il marchese Caracciolo al suo amico d’Alambert, ma le inquisizioni e le carceri continuano in Italia e nel mondo, là dove impera il “sonno della ragione” e si commettono ludibri, oscene vergognose violenze di uomini contro altri uomini, Di questo parlano, per esempio, le pareti delle carceri naziste o staliniste le carceri di via Tasso a Roma, così le pareti delle carceri argentine o cilene o greche, delle dittature dei colonnelli o di Pinochet; così oggi, e ancora con maggior ludibrio palano le pareti delle carceri americane in Iraq, di Abu Ghraib e quelle di Guantanamo. E, a proposito dell’Inquisizione a Palermo, Sciascia scrive ancora sul “Quaderno” del 21 novembre 1964: << II 19 agosto del 1953 incappò foco a due dammusi di polveri» nel castello a mare di Palermo: <<et essendo vicine le carceri, tutte le scacciò>>. Tra quei prigionieri di Castellamare perirono Argisto Giuffredi, autore di quel libretto (che precorre Beccaria) contro la tortura e la pena di morte intitolato Avvertimenti Cristiani, e il poeta Antonio Veneziano, che, nei bagni di Algeri, aveva conosciuto e stretto amicizia con Cervantes.
Tanti, tanti sono i tempi svolti da Sciascia in quei 125 articoli, scritti trai,’64 eil’67 per il “Quaderno”. Articoli che prendono spunto di volta in volta da fatti di cronaca – di mafia soprattutto -, da letture, viaggi, incontri, accadimenti politici, polemiche. Fra queste ultime vogliamo ricordare quella del 21 febbraio col giornalista dell’“Avanti!” Fidia Sassano. Il quale rimproverava a Sciascia di essere pessimista nei confronti del futuro della Sicilia, nonostante la miracolosa scoperta del petrolio in Sicilia, la presenza del “colosso europeo” del petrolchimico di Priolo, Melilli, Gela. E, dice Sassano a Sciascia: <<Questi benedetti letterati!». Ma benedetto letterato non era Sciascia allora, lo è stato invece, e ci dispiace dirlo, Vittorini, che in quel “petrolio siciliano” aveva visto il risveglio e il riscatto dei siciliani ed era stato indotto a scrivere Le città del mondo, uscito postumo. Del disastro, dello sfacelo di quell’utopia industriale che era stato il petrolio siciliano, Sciascia ne vede, profeticamente, il fallimento, così come profeticamente vede il fallimento del Psi, il Partito socialista italiano, cui Fidia Sassano appartiene. Quel partito socialista che alla sua fine, come frutto avvelenato, ci avrebbe lasciato in eredità un uomo e un partito: Berlusconi e Forza Italia, del cui potere o strapotere tutti soffriamo e di cui ci vergogniamo. Scriveva Sciascia: <<Sassano appartiene a quella categoria di socialisti che io chiamo soddisfatti: talmente soddisfatti che dalle loro soddisfatte viscere si possono trarre auspici non del tutto rassicuranti per il nostro immediato e lontano avvenire >>. Potrei ancora dire d’altri temi e d’altri spunti. Dire che questo illuminista interviene sempre là dove la ragione è offuscata, la libertà conculcata, il cittadino, l’uomo offeso. Ed è certo che la sua “conversazione” sempre dalla Sicilia parte e alla Sicilia si riduce, a quest’isola che duole al siciliano Sciascia, a questa regione in cui i siciliani onesti si ritrovano sempre “con la faccia per terra”, quei siciliani di “alta dignità e di tenace concetto” che non hanno meritato tutti i malgoverni locali e nazionali del passato, non meritano quelli nefasti e vergognosi di oggi, a Palermo e a Roma. Ci è mancato dal 1989 e ci manca ancora oggi e ogni giorno di più uno scrittore e un intellettuale come Leonardo Sciascia. Ci manca la sua penna, la sua spada. Come ci è mancata e ci manca quella di un suo confrère, di Pier Paolo Pasolini, il Pasolini delle Lucciole, del Palazzo, il Pasolini corsaro e luterano. Luterano come Sciascia, come pochi altri in questo Paese segnato da sempre da viltà e conformismo. Nel deserto e nella malinconia di questo nostro attuale Paese, di questo nostro contesto occidentale, ci conforta sapere che è stato qui con noi, per noi, un uomo come Leonardo Sciascia. Ci conforta sapere che possiamo tornare a rileggere le sue forti e luminose parole.
da Kalos “Sciascia il romanzo quotidiano”
2005 Gruppo editoriale Kalos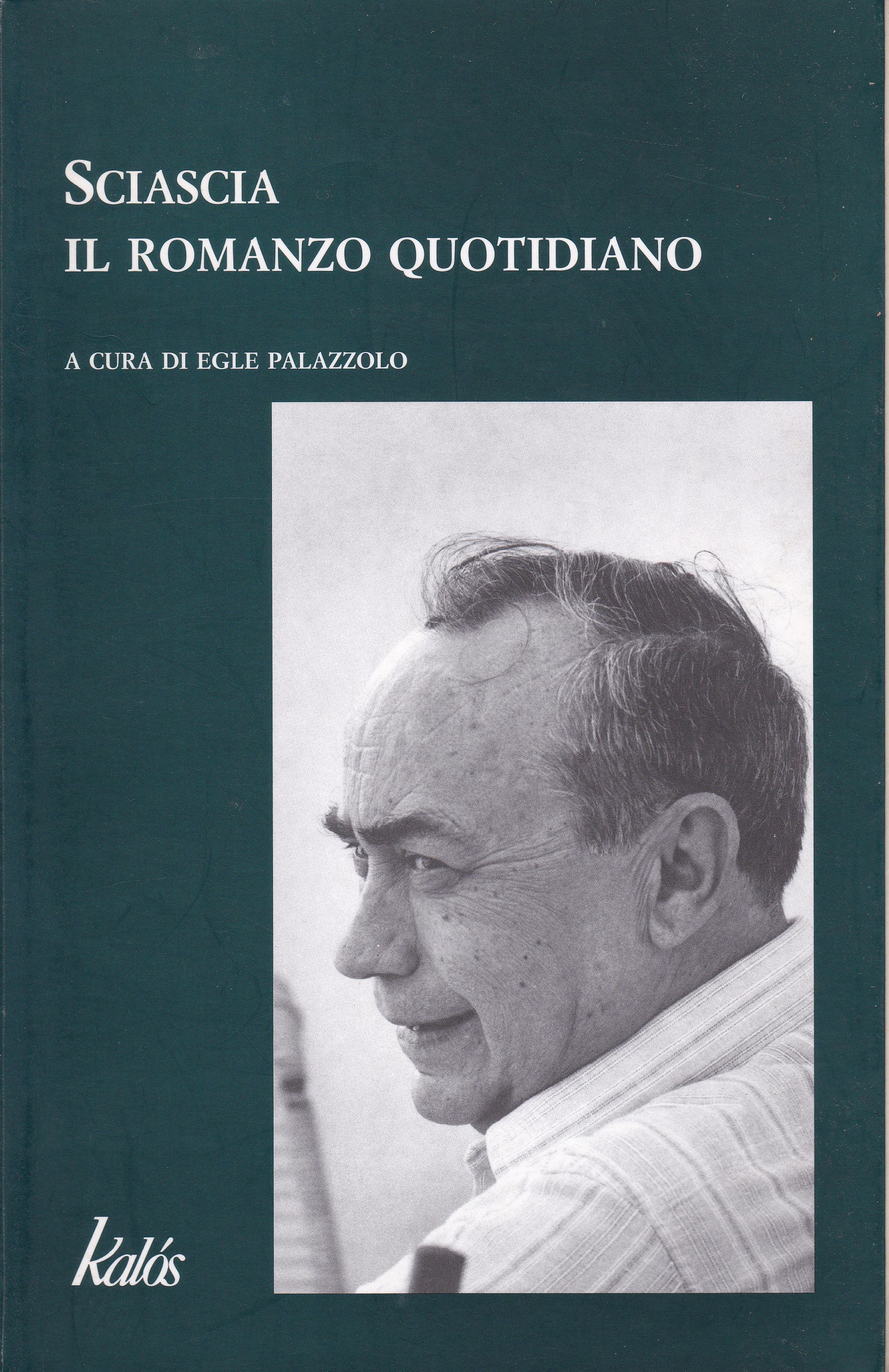
A Scuola per recuperare l’identità
La domenica, Arabo
a lezione di arabo in una scuola media statale del nordest:
dall’integrazione al recupero delle radici
Nella zona a sud est di Verona, che comprende il Comune di Legnago e altri limitrofi, c’è una forte presenza di immigrati marocchini, occupati nei comparti del mobile, dell’edilizia e dell’industria meccanica e dell’agricoltura: è un’immigrazione che risale agli ultimi anni 80 e ha ormai prodotto una discreta integrazione e condizioni economiche abbastanza confortevoli. I figli frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo. Ma l’integrazione anche linguistica non cancella il bisogno di mantenere viva la parola tradizionale, la comunicazione in arabo con i parenti rimasti in Marocco, la possibilità di accedere ai testi della patria e particolarmente al Corano.
La scuola media statale Frattini di Legnago, complice la passione di alcuni insegnanti italiani e la sensibilità dell’amministrazione comunale, ospita, la domenica mattina, tre insegnanti marocchini, che tengono un corso di lingua araba in tre classi per un totale di circa 60 iscritti di varie età dai 5-6 ai 13-14 anni.
Vincenzo Cottinelli ha lavorato in queste classi per due domeniche mettendo in risalto anzitutto le personalità degli insegnanti.
Ilham Mayate scomparsa in un tragico incidente, era operaia in una ditta di confezioni; di bellezza spigliata e quasi veneta, insegnava con entusiasmo e tenerezza, faceva da mamma ai più piccoli e con abilità suggeriva la tecnica di produzione dei complessi suoni della lingua araba.
Fatiha Tauriri (già bracciante in campagna) sembra una maestra di stile più tradizionale e pacato: veste secondo le regole tradizionali marocchine (porta il velo) ed è molto accurata nell’insegnamento della grafia.
Mustapha Benchiha (saldatore in una officina meccanica) è energico e appassionato, anche quando, come gli altri due, al termine della lezione insegna il Corano, di cui sottolinea anche i valori testuali e letterari.
Il racconto di Cottinelli è poi rivolto agli allievi, che sono vivaci, disciplinati, attenti (soprattutto le femmine, delle quali solo due o tre portano il velo tradizionale: le altre vestono in modi sobri ma perfettamente integrati); usano dei bellissimi sillabari e quaderni figurati, da riempire con le parole, che sono quelli ufficiali delle scuole marocchine.
Le immagini di Cottinelli mostrano tipiche aule di una scuola media italiana, con il classico crocefisso sopra la cattedra e le grandi carte geografiche fisiche di Italia, o Europa, o Africa. Ma la lavagna si riempie dei segni misteriosi e affascinanti dell’arabo classico del Corano, mentre insegnanti e allievi sono impegnati, appassionati, attenti. E’ un messaggio di pacificazione e integrazione, nel rispetto per l’identità e la cultura di origine di un popolo.
Cottinelli da questo suo lavoro ha prodotto un libro (appunto “La Domenica, Arabo”) e una mostra, presentati nel 2005 al Teatro Salieri di Legnago, con l’On. Livia Turco, il Prof. Claudio Marra e Vincenzo Consolo, che aveva scritto come introduzione il testo che segue.
https://www.vincenzocottinelli.it/
Vincenzo Consolo
A Scuola per recuperare l’identità
Ottobre / Novembre 2005
Antiche e frequenti erano le emigrazioni che avvenivano, attraverso il Canale di Sicilia, dal Meridione d’Italia nel Maghreb, nelle ricche terre degli “in fedeli’. Erano, quelle, delle emigrazioni di contadini, muratori, “tonnaroti” (lavoratori delle tonnare), pescatori di spugne e di coralli. Nel Decamerone Boccaccio ce ne dà un’immagine nella Novella Seconda della giornata quinta, in cui una giovane dell’isola di Lipari, Costanza, alla ricerca del suo innamorato Martuccio, sbarca a Susa di Barberia e s’imbatte in una donna che parlava la “favella latina”. La donna, Carapresa, spiega allora a Costanza che era là a servire “certi pescatori cristiani”.
Finì questa emigrazione con quella che lo storico spagnolo Américo Castro chiama L’età dei conflitti, con la dominazione ottomana sulle coste africane e quella castigliana sulla Spagna e la Sicilia, con l’insorgere della guerra corsara: lunga e feroce guerra tra Musulmani e Cristiani. Scrive Fernand Braudel in Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari”.
Finisce questa guerra nel 1830 con la conquista di Algeri da parte dei Francesi. E riprende quindi l’emigrazione italiana nel Maghreb.
Prima è, negli anni Quaranta dell’Ottocento, un’emigrazione politica di fuorusciti: liberali, giacobini e carbonari che si rifugiano in Tunisia, Algeria, Marocco. Scrive Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli: “Erano quelli regni barbari i soli in questa età civile che dessero cortese rifugio ai fuorusciti”.
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento riprende l’emigrazione di bracciantato nel Maghreb a causa di una grave crisi economica che investe soprattutto il nostro Meridione. Tra quegli emigrati c’è h povera famiglia Scalesi di Trapani, che si stabilisce a Tunisi.
Un figlio di questa famiglia, Mario, frequenta le scuole gratuite francesi (il trattato del Bardo del 1881 stabiliva il protettorato francese sulla Tunisia) e così non ha possibilità di imparare l’italiano (le scuole italiane erano solo private e a pagamento). Mario Scalesi, divenuto poeta, il primo poeta francofono dal Maghreb, scrive le sue opere in francese, fra cui Les poemes d’un maudit, e finanche il suo nome viene francesizzato: diviene Marius Scalesi. Scrive Pasolini in un articolo su Il Giorno del 3 marzo1965: “Sono andato l’altro ieri, domenica, a ‘visitare’ un campo profughi, ex campo di concentramento, vicino ad Alatri: un luogo tremendo (.,.) dove vive un gruppo di italiani espatriati dalla Tunisia. Ebbene, ho avuto modo di accorgermi come la loro ‘francesizzazione’ non consistesse solo in una francofonia abbastanza ortodossa (.,.), ma in una commovente francesizzazione culturale.,.”
È un esempio questo di migrazione linguistica, di cancellazione delle origini linguistiche e culturali del Paese da cui si proviene.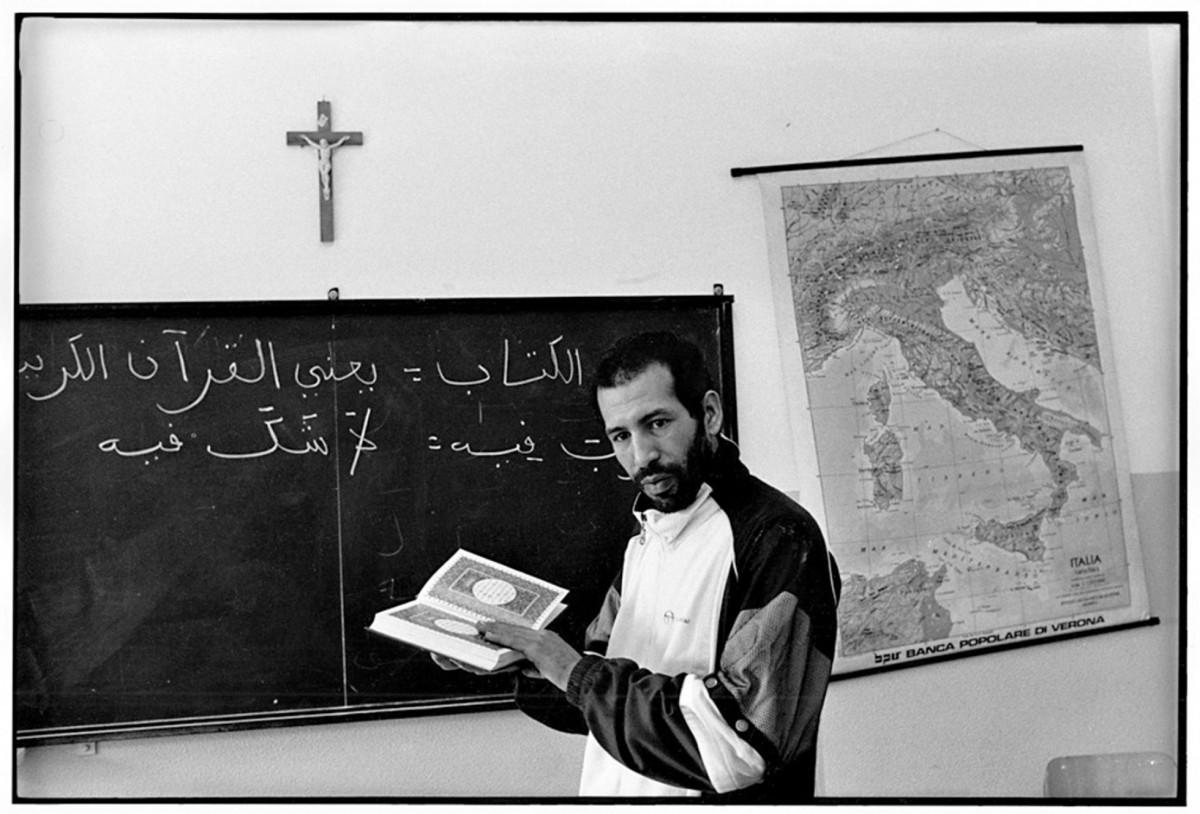
Sorte che tocca spesso ai figli e ai nipoti degli emigrati da un Paese a un altro. Un caso ce lo racconta Tahar Ben Jelloun in A occhi bassi, un romanzo del distacco e della lontananza, dell’emigrazione, dello sradicamento da una cultura, profonda, arcaica, religiosa, che mutila e separa, e del reinserimento di un’altra, laica, moderna, superficiale, che violenta, omologa e annienta ogni diversità. La pastorella berbera Fatima, emigrata dal Marocco a Parigi con la famiglia, frequenta qui la scuola ed ha un sogno-incubo. “Ci fu una breve guerra, ma efficace, tra le parole berbere e quelle francesi, lo fui difesa con fermezza e coraggio. Le parole berbere non si lasciavano mettere sotto. Avevano costituito una linea di difesa contro gli invasori. La battaglia fu rude (…) Le rare parole arabe che sapevo si erano buttate nella battaglia. Rinforzando la linea di difesa…”
Ma non tutti, tutti i bambini emigrati qui nel nostro Paese hanno avuto, come Fatima, questa linea di difesa, ma sono stati vinti dalla nostra lingua, dalla nostra cultura, cancellando in loro ogni cognizione, ogni memoria della cultura, della lingua del loro Paese d’origine.
Abbiamo detto sopra dell’emigrazione italiana nel Maghreb. A metà degli anni Sessanta del secolo passato comincia invece l’emigrazione di Maghrebini nel nostro Paese. E sono per primi i Tunisini che attraversano quel breve braccio di mare che separa la Tunisia dalla Sicilia, Tunisi da Trapani, i si stabiliscono a Mazara del Vallo abitando quel quartiere della cittadina, abbandonato dai mazaresi, chiamato Casbah, il quartiere dei loro antenati arabi, quelli che erano sbarcati in Sicilia nell’827 d.C. e avevano conquistato l’Isola. Il ritorno felice ha intitolato il suo libro su questa prima emigrazione “extracomunitaria” lo studioso mazarese Antonino Cusimano. Da quegli anni Sessanta sappiamo quanto massiccia e varia sia stata e sia ancora oggi l’immigrazione nel nostro Paese, quanto avventuroso, spesso atroce, tragico l’attraversamento, da parte dei cosiddetti “clandestini”, di quel fatale Canale di Sicilia divenuto equorea tomba di morti annegati. E ancora questa estate appena trascorsa, questo tempo della vacanza, dopo l’inverno del nostro scontento, per dirla con Shakespeare, è stata turbata dalle notizie e dalle immagini che i media ci riversano addosso di guerre, guerriglie, terrorismo, devastanti uragani, carestie e fame, di morti annegati, come quei poveri undici africani che il mare ha gettato sulla spiaggia di Gela in mezzo ai bagnanti, ultime vittime dello scialo di questo nostro Occidente insensato.
Abbiamo un po’ divagato, ma ci è sembrato giusto farlo, prima di giungere all’argomento che qui vogliamo trattare. Dicendo subito che non per tutti i maghrebini il “ritorno” nel nostro Paese è stato infelice. Che molti, giunti in Italia da tempo, prima che il nostro Parlamento votasse quell’infausta legge sull’immigrazione che va sotto il nome di Bossi-Fini, molti hanno trovato da noi accoglienza, lavoro e speranza per il futuro dei loro figli: si sono, come si dice, integrati. Un chiaro, luminoso esempio, è quello della comunità marocchina del comune di Legnago nel Veronese, i cui bambini hanno frequentato e frequentano la scuola statale italiana. Hanno imparato naturalmente l’italiano, questi scolari, ma hanno ignorato la lingua dei loro padri e dei loro nonni, e, con la lingua, la storia, la cultura, la religione del Marocco, il Paese delle loro origini. Hanno rischiato di divenire, loro, immigrati senza passato, senza memoria, così come è accaduto al poeta Mario Scalesi.
E già dal 1997, nel paese di Legnago, nella scuola media Frattini, la domenica mattina, i figli di operai i braccianti marocchini frequentano il corso di lingua araba tenuto da tre insegnanti volontari, imparano la lingua dei loro padri. Il fotografo Vincenzo Cottinelli, attento e appassionato documentarista di eventi sociali, ha fissato in magnifiche, toccanti immagini ciò che avviene in quell’aula scolastica: avviene di anticipazione e di esempio, alla luce della recente chiusura della scuola islamica di via Quaranta a Milano e delle polemiche che ne sono seguite.
Ci colpisce subito, fin dalle prime foto. l’insegnante llham Mayate con la sua lunga treccia di capelli, che Lalla Romano, ne La treccia di Tatiana, avrebbe letto come segno e aforisma. La bella Ilham, ora rimpianta per la sua inopinata e prematura scomparsa, la vediamo quindi nell’aula contro la nera lavagna con i bianchi segni dell’ornata scrittura araba, il crocefisso, le carte geografiche, Ilham che, si capisce dai gesti, insegna la pronuncia di quella lingua “altra”, piena di aspirate e gutturali. Un’insegnante, lei, amorosa e materna, che guida con la sua la mano del bambino che scrive, bacia la bambina che ha saputo leggere bene le parole sulla lavagna. I bambini sono allegri, vivaci. Ci n’è uno chi si gira verso Cottinelli che fotografa e scherzosamente lo mima portando davanti agli occhi il suo astuccio per le penne.
Fatiha Taouriri, l’altra maestra (bracciante agricola) insegna la giusta e bella grafia delle parole arabe. Gli alunni la seguono e scrivono sulla lavagna e sui loro quaderni figurati. Mustapha Benchiha (saldatore in una officina meccanica) è il terzo insegnante, il quale, al termine della lezione, insegna il Corano, la lingua aulica, classica di questo libro sacro, come la lingua attica dei greci e il latino di Tacito o di Virgilio per i romani. In una foto, Mustapha tiene in mano il libro del Corano e si staglia contro il nero della lavagna con i segni arabi; sopra, vi è il crocefisso; a destra, la carta geografica della penisola italiana con in basso l’isola di Sicilia, il mare Mediterraneo e il capo Bon della Tunisia. E ci sembra, questa fotografia di Cottinelli, la sintesi del discorso che qui abbiamo voluto svolgere; e la metafora, ci sembra, di ciò che dovrebbe essere, come è stato sempre nel cammino della storia, il riconoscimento, il rispetto, lo scambio e l’arricchimento di civiltà e culture diverse tra loro. Rispetto e scambio di cui la scuola di arabo di Legnago è un bellissimo esempio.

Conferenza all’Accademia di Belle Arti di Perugia1
Vincenzo Consolo
Metto le mani avanti dicendo che non sono addetto ai lavori, non sono un esperto d’arte, come ha detto il professor Caruso, sono uno scrittore. Uno scrittore che però nella stesura di quasi tutti i suoi libri (Caruso ha citato Lunaria, ma forse fin dal primo libro) ricorre sempre a una citazione pittorica. Anche Calvino, che sembra meno implicato con la pittura, ha dichiarato che da sempre l’immagine di un dipinto lo ispirava nella scrittura dei suoi libri. Allora comincio teoricamente col dire che la letteratura è un discorso assolutamente lineare che ha una sua dinamica temporale nella quale bisogna saper leggere anche la sua verticalità, cioè la complessità. Bisogna dunque nella linearità del discorso letterario saper individuare le molteplicità dei significati oltre naturalmente dei significanti, cioè oltre al significato della parola bisogna anche ascoltarne il suono e comprendere che si propaga nel tempo.
Significante che si riporta ancora nella dimensione temporale: la scrittura si svolge nel tempo. Nell’arte figurativa, pittura o scultura, al contrario il discorso non è lineare, si svolge non nel tempo, ma nello spazio: sono due dimensioni diverse. Le due arti hanno essenze diverse. Ora cito un illuminista che non è il Lessing filosofo che conosciamo, ma un illuminista tedesco di nome Lessing che aveva analizzato la differenza tra letteratura e pittura. Egli afferma che la pittura usa figure e colori nello spazio, mentre la letteratura suoni articolati nel tempo, la pittura rappresenta oggetti che esistono uno accanto all’altro e sono colti con la loro proprietà visibile. È chiaro che qui si parla di pittura figurativa, non della pittura astratta, e quindi di figure di corpi, mentre la letteratura rappresenta oggetti1 che si susseguono uno dopo l’altro, la letteratura rappresenta un’azione nella quale gli oggetti o i corpi sono uno accanto all’altro e nella rappresentazione si segue una sintassi; questi oggetti o corpi sono legati, appunto come dice la parola, da una sintassi che regola la rappresentazione. Sia la pittura che la letteratura ubbidiscono alla legge della sintassi e dei legami. C’è però da osservare che spesso la sintassi pittorica e la sintassi letteraria si possono incrociare, si possono incontrare, e questo significa che vi può essere in pittura una componente temporale e dicendo questo non voglio riferirmi ai quadri medievali dove vi sono delle parole scritte. Mi riferisco soprattutto alle Annunciazioni dove l’angelo che annunzia ha le parole che escono dalla bocca e la Madonna risponde. Credo che le scritte dipinte si chiamassero filatteri. C’è una tradizione altissima di testi letterari dipinti da grandi pittori; basta pensare alle illustrazioni della Divina Commedia, ma anche per esempio al Boccaccio illustrato da Botticelli e in particolare ai due quadri famosi della novella di Nastagio degli Onesti. Vi sono delle pitture in cui vengono affiancati momenti successivi di un’azione e questo è evidente in quel genere di pittura soprattutto religiosa che si chiama Retablo. Il Retablo è un racconto pittorico che si svolge in più quadri, così come nelle narrazioni letterarie dei romanzi o racconti sono inserite narrazioni implicite, esplicite di esempi pittorici, pitture che possono fare da motivo ispiratore o da leitmotiv di una narrazione. Fatta questa premessa teorica facile e scontata voglio dire di me come scrittore, come la pittura mi ha influenzato, quali sono stati i temi pittorici che mi hanno segnato e mi hanno portato a scrivere. Devo iniziare dai primi passi che ho mosso in campo letterario e questo risale a parecchi anni fa, al primo libro La ferita dell’aprile, del 1963 pubblicato in una collana sperimentale, di ricerca letteraria. A quei tempi gli editori si permettevano di mantenere delle collane di ricerca che non avevano fine di profitto, così come le grandi aziende hanno il laboratorio di ricerca. Vittorini dirigeva la collana dei Gettoni presso Einaudi e cercava le nuove voci della letteratura italiana; per mezzo delle collane di ricerca si scoprirono grandi scrittori come Primo Levi, Giorgio Bassani, Leonardo Sciascia e tantissimi altri. Mondadori ha voluto con la chiusura della collana dei Gettoni di Einaudi continuare questa esperienza aprendo una collana che si chiamava il Tornasole, diretta dal poeta Vittorio Sereni e da un grande critico che si chiamava Niccolò Gallo. Quando ho scritto il mio primo libro sapevo già che il libro si sarebbe potuto collocare benissimo in quella collana. Credo che quando si opera in qualsiasi campo letterario, pittorico o musicale, chi comincia deve avere consapevolezza di quello che si è svolto prima che lui nascesse come artista, come autore, quindi conoscere la tradizione letteraria nel momento in cui comincia ad operare, essere consapevole degli autori contemporanei e soprattutto della grande letteratura italiana ed europea, ma anche degli autori che immediatamente lo hanno preceduto e sapere cosa stava succedendo negli anni ‘60 in campo letterario in Italia. Questi autori, Moravia, Morante, Bassani, Calvino, Sciascia e moltissimi altri, in massima parte avevano scelto di scrivere in un registro assolutamente comunicativo, razionalista o illuministico. Io mi sono sempre chiesto perché loro avevano scelto questo registro, questo stile illuministico o razionalistico e mi sono dato una risposta. Ho pensato che le persone che avevano vissuto l’esperienza del fascismo e della guerra, da Primo Levi a Nuto Revelli, a Rigoni Stern e a tantissimi altri che hanno scritto sulla guerra partigiana e sulla campagna di Russia e che hanno restituito la loro esperienza in forma referenziale e comunicativa, avevano scelto quel registro proprio perché speravano che con la fine del fascismo, con la fine della guerra si sarebbe potuta formare in Italia una società civile con la quale comunicare, per cui questi scrittori avevano adottato un registro di speranza, lo stesso registro di speranza che aveva teorizzato e che aveva voluto il padre sacramentale della narrativa italiana, Alessandro Manzoni. Manzoni scrivendo la seconda stesura dei Promessi Sposi, aveva adottato appunto il linguaggio toscano – ricordiamo la famosa frase “sciacquare i panni in Arno” – dopo aver scritto Fermo e Lucia con ancora dei dialettismi, dei localismi lombardi, perché sperava che con l’unità d’Italia gli italiani avrebbero potuto avere anche un’unità linguistica. È stata un’utopia molto generosa, però nonostante l’opera di Manzoni evidentemente questa unità linguistica non si è raggiunta. Per tornare a me, nato dopo le generazioni di scrittori che avevano nutrito questa speranza, nascendo come scrittore nel ’63 ho trovato i giochi politici già fatti. In Italia era avvenuto un profondo mutamento, una mutazione possiamo dire antropologica che nessun paese europeo aveva avuto. Era finito il millenario mondo contadino, c’erano stati spostamenti di massa, di braccianti meridionali verso il mondo industriale, c’era stato il processo di industrializzazione del Nord, un processo rapido che ha portato dei cambiamenti straordinari. Naturalmente il cosiddetto miracolo economico ha liberato il meridione dalla fatica contadina, ma nel contempo ha costretto i contadini a trasformarsi in operai, minatori, carpentieri. Miracolo economico è stato chiamato, (in un paese dove c’è il Papato tutto diventa miracolistico). C’è stata la fine del nostro mondo contadino e della cultura contadina alla quale è succeduta la cultura industriale. Intellettuali come Vittorini e Calvino da una rivista che si chiamava «Il Menabò» invitavano i giovani autori a lasciare i vecchi mestieri, i mestieri liberali dell’insegnamento o dell’avvocatura e di inurbarsi per cercare di spiegare da vicino, nei centri come Milano, o Torino, soprattutto Torino, dove c’era la Fiat, il mondo industriale. Studiare il fenomeno dell’Olivetti dove molti scrittori e poeti sono entrati, come Franco Fortini, Paolo Volponi, Ottiero Ottieri e studiare proprio dentro l’industria, quella che Vittorini chiamò l’industria a misura d’uomo, le strutture per una condizione sociale dignitosa per gli stessi operai. Dicevo che questo nostro paese è cambiato profondamente anche nella lingua, nel senso che la vecchia lingua italiana, quella unica ipotizzata da Manzoni che era stata ripercorsa dagli scrittori della generazione che mi aveva preceduto, quella si era assolutamente trasformata. Pasolini nel 1964 aveva scritto un saggio intitolato Nuove questioni linguistiche dove aveva analizzato il cambiamento profondo della nostra lingua italiana perché col “miracolo economico” era avvenuto quel fenomeno nuovo della esplosione dei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto della televisione. I due affluenti che avevano arricchito la nostra lingua, cioè la lingua popolare dal basso e la lingua colta dall’alto, si erano quasi prosciugati, si era formata una lingua media di comunicazione dove si perdevano le radici memoriali della lingua stessa. Sul problema della lingua italiana, oltre Pasolini, andando indietro nel tempo ci sono stati molti scrittori che ne hanno scritto. Ma ci sono stati anche scrittori che non avevano sentito il bisogno di riflettere su questo strumento che erano obbligati a usare. Non credo che ci siano stati nella storia della pittura pittori che abbiano sentito il bisogno di analizzare i colori che dovevano usare, io credo che solo in letteratura questo sia avvenuto, cioè che gli scrit- tori abbiano sentito il bisogno di riflettere sulla lingua che di volta in volta devono usare. La riflessione sulla lingua parte da Dante che sente il bisogno di scrivere un saggio, il De vulgari eloquentia, che è il primo saggio di linguistica italiana e di poetica personale, dove Dante parla di una lingua di primo grado, che è la lingua che noi parliamo da bambini quando noi sentiamo i primi suoni e della lingua grammaticale, cioè della lingua colta. Dopo Dante ci sono stati tantissimi altri scrittori che si sono occupati del problema della lingua, ma quello che l’ha analizzata profondamente è stato Leopardi. Nello Zibaldone scrive un saggio di linguistica in cui studia il rapporto tra società e letteratura, e fa un continuo confronto tra la lingua italiana e la lingua francese. Leopardi sostiene che la lingua francese è una lingua geometrizzata, cioè racchiusa in una serie di regole già dal tempo di Luigi XIV, e quindi lamentava la perdita di infinito che questa lingua aveva prima dell’avvento di Luigi XIV. Con questo sovrano in Francia si era formata una società, ancora prima della rivoluzione, e quindi si aveva bisogno di uno strumento linguistico che fosse estremamente comunicativo. Leopardi invece esalta la ricchezza e la profondità della lingua italiana e naturalmente dice che l’unico momento di unità linguistica nel nostro paese, parliamo di lingua letteraria, non di lingua strumentale, è stato quello del Rinascimento toscano. Il momento in cui tutti gli scrittori da tutte le periferie italiane, sia dai conventi sia dalle accademie si attenevano e usavano la lingua ideale, cioè il toscano. Con la Controriforma l’unità linguistica si disgrega e si comincia di nuovo a ritornare a quelle che erano le espressioni localistiche dialettali: quindi c’è una grande fioritura soprattutto in poesia, poesia dialettale con i grandi nomi di Belli, di Porta o di un narratore napoletano il Basile, autore de Lo cunto de li’ cunti. Si possono fare tantissimi altri nomi. Comunque in Italia non c’era mai stata fino ai nostri anni ’60 una lingua unica che poteva chiamarsi lingua nazionale e Pasolini alla fine del suo saggio Nuove questioni linguistiche porta come esempio di questa nuova lingua italiana, di questa lingua ormai tecnologizzata, assolutamente rigida e orizzontale, un brano del discorso di Aldo Moro nel momento significativo della inaugurazione dell’autostrada del sole. E riporta questo brano in un italiano che sino a quel momento non era stato scritto, infarcito di tecnologismi, quasi impenetrabile, in un registro linguistico pseudo afasico, che non raggiunge il suo referente, cioè l’oggetto della parola. E Pasolini conclude con ironia e amarezza «Che finalmente è nata la lingua italiana come lingua nazionale». Era una lingua nazionale assolutamente impoverita ed è quella che ascoltiamo alla televisione, che non è solo una lingua di comunicazione quotidiana, non è una lingua che sentiamo soltanto nei media, ma è una lingua che viene anche praticata nella scrittura letteraria. Dopo questa lunga riflessione voglio tornare a dire di me. Quando appunto ho cominciato a scrivere ho pensato che non avrei mai potuto scegliere quella lingua comunicativa, lingua assolutamente impraticabile in letteratura e quindi la scelta consapevole e in qualche modo anche istintiva è stata di scegliere un registro altro, diverso, che non fosse la lingua coniata dal potere. Ho scelto un contro codice linguistico che fosse appunto di difesa della memoria linguistica del nostro paese. E quindi il registro che si chiama sperimentale, espressivo; questa scelta mi metteva fatalmente in una linea che era sempre esistita (accanto alla linea razionalistica illuministica), che partiva da Verga, perché il primo che aveva rovesciato l’assunto della lingua ideale del Manzoni era stato Verga che aveva scritto in una lingua fino a quel momento mai scritta. L’italiano che Pasolini definisce irradiato di dialettalità era l’italiano con cui Verga faceva parlare i pescatori di Aci Trezza e i contadini di Vizzini, che non era l’italiano centrale toscano, ma che esprimeva il modo di essere, di sentire, di pensare delle classi non borghesi, delle classi popolari, delle classi umili, quindi il periodare, l’esprimersi per proverbi dei personaggi dei Malavoglia. Ma da Verga in poi naturalmente c’era tutto un filone di scrittori espressivi sperimentali che passava attraverso il grande Gadda, che appunto aveva orchestrato nel modo più vasto e polifonico tutti i dialetti italiani per dare proprio un’ immagine di quella che era l’Italia prima del miracolo economico, prima del processo di industrializzazione, specialmente nel libro Il pasticciaccio brutto di Via Merulana. Nel filone gaddiano si erano mossi poi tanti altri scrittori sperimentali da Lucio Mastronardi a D’Arrigo a Meneghello fino a Pasolini. Pasolini era uno scrittore sperimentale che era partito da un’esperienza dialettale, quella della poesia friulana scritta, in questa lingua-dialetto, e poi arrivando a Roma scrive i romanzi, ma non la poesia, nel romanesco del sottoproletariato romano. Anch’io mi colloco subito in questo filone. Scrivo in un mistilinguismo o quello che Cesare Segre ha definito plurivocità, per una difesa della memoria, perché la letteratura è memoria, memoria linguistica nel cercare di non far seppellire e cancellare tutti i giacimenti linguistici della terra dove mi ero trovato a nascere e a vivere e a capire i suoni, perché la Sicilia che citava il professor Caruso, che ci accomuna, è una terra dove sono passate tutte le civiltà, dagli antichi fenici, ai greci, ai romani, agli arabi. È inutile fare della retorica sulla Sicilia in un luogo come Perugia, in questa Umbria e Toscana, luoghi di grande civiltà. Gli antichi hanno lasciato i monumenti, templi greci, chiese arabo-normanne, ma anche giacimenti linguistici molto preziosi. Io ho fatto un lavoro da archeologo, ho cercato di disseppellire parole che provenivano da queste lingue ormai dimenticate, che erano di volta in volta il greco, l’arabo, il latino, lo spagnolo, il francese, immettendo, innestando nel codice linguistico italiano vocaboli che avessero un loro significato, molto più vasto che il termine italiano poteva darmi, ma anche che avesse una sua valenza di significante, cioè di sonorità, che si potesse incastrare nella frase,
nel discorso per creare un’armonia sonora, che si svolge nel tempo, come dicevo poco fa. La mia scrittura, per la mia ricerca, è contras segnata da questa organizzazione della frase in prosa che ha un suo metro, un suo ritmo che l’accosta un po’ al ritmo della poesia. Ho diffidenza verso la comunicazione, verso la comunicazione che ha in sé la narrazione. La scrittura in prosa è una scrittura ibrida perché la letteratura è nata in forma poetica: i grandi narratori dell’antica Grecia erano poeti orali. I poemi omerici prima erano poemi orali e poi con i grammatici alessandrini sono stati portati sulla carta. Anche la Bibbia era un racconto orale. L’oralità comportava l’organizzazione della frase sia per un fatto mnemonico e sia per un fatto di seduzione degli ascoltatori e le frasi avevano una loro componente ritmica e poetica. In questa epoca, in questa nostra civiltà di massa penso che l’elemento comunicativo che in sé fatalmente ha la scrittura in prosa debba essere sempre più ridotto, che il registro della scrittura debba spostarsi verso la parte ritmica, verso la parte espressiva. Uno scrittore sud americano dice che la scrittura in prosa ha una parte logica e una parte magica, la parte magica è la parte espressivo poetica; parliamo di forma, non di sostanza poetica. Mi sono perso in molti rivoli. Voglio tornare alle citazioni, e alle ispirazioni della pittura nei miei libri. Parlo del mio secondo libro Il sorriso dell’ignoto marinaio dove l’elemento ispiratore è il ritratto di ignoto di Antonello da Messina. Racconto un aneddoto per quanto riguarda questo titolo. Avevo scritto i primi capitoli di questo mio romanzo a metà degli anni ‘70, nel ’73-’74. Per l’ispirazione pittorica che aveva il libro avevo man dato i primi due capitoli alla signora Banti la direttrice della rivista «Paragone», e il cui marito era Roberto Longhi, che dirigeva anche lui la rivista, in parte di critica letteraria e in parte di critica d’arte. Mi sembrava quindi la sede più giusta per avere un riscontro su questi due primi capitoli. Non ho avuto risposta dalla rivista. Un giorno Roberto Longhi è venuto a Milano per presentare la ristampa del suo libro Me pinxit e quesiti caravaggeschi. Sono andato alla presentazione e alla fine gli ho detto con molta timidezza: «Professore le ho mandato due capitoli del mio romanzo. Mi chiamo Consolo. Non ho avuto risposta». Longhi mi ha guardato severamente e mi ha risposto: «Sì, mi ricordo perfettamente, mi ricordo dei bei racconti, mi ricordo il suo nome. Non voglio assolutamente entrare nel merito letterario dei racconti, però questa storia dell’ignoto marinaio deve finire». Sapevo quello che lui aveva scritto nei suoi saggi su Antonello da Messina. Longhi diceva che popolarmente era detto L’ignoto marinaio il ritratto che si conserva al museo Mandralisca di Cefalù, ma Longhi sosteneva che Antonello non era un pittore che faceva quadri di genere, era un pittore molto affermato e che si faceva pagare profumatamente, e quello era un ritratto di un signore, di un proprietario terriero, di un barone, ecc. Io sapevo bene quello che il critico d’arte aveva scritto, ma a me serviva la dizione popolare, la vulgata dell’ignoto marinaio, perché volevo svolgere il tema proprio in questo senso. Naturalmente avevo molta dimestichezza con questo quadro: mi aveva molto incuriosito perché il ritratto dell’uomo aveva un’espressione a me familiare che riscontravo in molti visi di persone che mi stavano intorno, insieme familiare e sfuggente. Ma quando pensai di rimettere insieme vari elementi per scrivere questo romanzo, da una parte il ritratto che avrebbe fatto da filo conduttore, poi la scoperta dei cavatori di pomice delle isole Eolie che si ammalavano di silicosi, e le rivolte popolari del 1860, il personaggio storico di Mandralisca, il protagonista Giovanni Interdonato, erano tutti elementi che mi hanno portato a unire i fatti storici secondo la lezione manzoniana: attingere alla storia e inventare altri personaggi che avessero i colori del tempo. Devo aggiungere che in questo libro ho mancato un’occasione, che sarebbe stata straordinaria, dell’incontro, che ho scoperto dopo la pubblicazione del libro, del barone Mandralisca con il Cavalcaselle. Il Cavalcaselle era anche lui un rivoluzionario risorgimentale che per ragioni politiche era stato costretto a rifugiarsi in Inghilterra. Lo straordinario critico d’arte clandestinamente proprio negli anni delle rivolte era andato a Cefalù alla ricerca delle opere di Antonello da Messina. A Cefalù si era incontrato con il barone Mandralisca e aveva steso uno schizzo di questo ritratto dipinto da Antonello. Volevo leggere il brano in cui racconto del quadro portato dall’isola di Lipari nella casa di Cefalù del barone Mandralisca e di quando viene presentato agli amici. Il barone oltre ad essere uno scienziato e uno studioso di malacologia, cioè studiava lumache, era anche un collezionista di opere d’arte, ma la gemma del suo privato museo era il ritratto di Antonello da Messina.
Apparve la figura di un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. Un indumento scuro staccava il chiaro del forte collo dal basso e un copricapo a calotta, del colore del vestito, tagliava a mezzo la fronte. L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso interrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini. 2

Ecco qui la descrizione dove lo scrittore diventò un po’ critico d’arte, ma naturalmente questo mi serviva per fare della metafora. Il libro che è ispirato a un genere pittorico che si chiama retablo è appunto Retablo, dove la struttura del libro è come fosse un polittico. C’è un primo pannello, un pannello centrale e poi un altro pannello. In tutti e tre i pannelli si racconta la storia. Retablo è un termine catalano che viene dal latino retro tabulo. Nel retablo non c’è più la fissità, ma un’azione che si svolge pittoricamente.2 Il Sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 143-144. Questo libro nasce da un’occasione: era venuto in Sicilia il pittore Fabrizio Clerici, testimone in un matrimonio a Palermo dove anch’ io ero testimone. Dopo questo matrimonio avevamo fatto un viaggio nella Sicilia classica, il famoso tour che facevano i viaggiatori stranieri da Goethe a Brydone a un’infinità di altri viaggiatori che partendo da Napoli, arrivando a Palermo facevano poi il giro della Sicilia da Segesta a Mozia a Selinunte ad Agrigento a Siracusa e spesso facevano l’ascensione sull’Etna e poi s’imbarcavano a Messina per fare il viaggio di ritorno. Durante questa escursione nei luoghi classici della Sicilia occidentale vedevo Fabrizio Clerici che prendeva degli appunti, faceva dei disegni. Clerici era un pittore surreale, metafisico, era già diventato un personaggio di un romanzo di Alberto Savinio nel libro Ascolto il tuo cuore, città. Di lui Savinio diceva che era un personaggio stendhaliano e che si chiamava appunto Fabrizio come Fabrizio del Dongo, poi addirittura che potevano essere parenti perché lui si chiamava De Chirico e il pittore Clerici, quindi tutti e due avevano una matrice clericale. Da questo pittore straordinario, intelligente e raffinato mi è venuta l’idea di trasferire nel ’700 il mio Fabrizio Clerici e il trasferimento significava che volevo scrivere un libro che non avesse una matrice storica, ma che fosse una fantasia, fosse un viaggio in una Sicilia ideale. Un pittore del ‘700,
Fabrizio Clerici, lascia la Milano illuministica di Beccaria e dei Verri, innamorato e non corrisposto di una fanciulla, Teresa Blasco, che sposerà poi Cesare Beccaria l’autore Dei delitti e delle pene. Da questa unione nasce Giulia Beccaria, che sarà la madre di Alessandro Manzoni. Faccio muovere Fabrizio Clerici dalla Milano illuminista per andare in Sicilia, non solo perché il suo è un amore infelice e quindi compie un viaggio alla ricerca delle tracce della bellezza della donna di cui è innamorato, ma per fare un omaggio alla letteratura. Negli anni in cui scrivevo il libro, a Milano c’era un’accensione politica molto forte, non c’era spazio per la dimensione umana, per i sentimenti. Io rivendicavo il primato della letteratura attraverso questo libro, passando dall’illuminismo al romanticismo manzoniano attraverso Teresa Blasco e il pittore Fabrizio Clerici. Clerici arriva nei luoghi classici con i suoi metri, come faceva Goethe, arriva in Sicilia pensandola come una sorta di eterna arcadia dove vi erano soltanto monumenti greci, i templi di Segesta e di Selinunte, di Agrigento. I viaggiatori avevano l’idea romantica di trovare i satiri e le ninfe. Senonché viaggiando per le zone della Sicilia occidentale Fabrizio Clerici insieme al suo accompagnatore siciliano, frate Isidoro, che aveva gettato il saio alle ortiche proprio perché sconvolto da una passione d’amore per una fanciulla, Rosalia, si accorge che la Sicilia non era soltanto arcadia. L’arcadia non c’era più. La Sicilia era una terra di forti contraddizioni, di grande miseria, di afflizione, di sopraffazione, di violenza. Clerici incontra banditi, corsari saraceni, ma scopre una dimensione che lui non sospettava, incontra persone dai sentimenti profondi e di grande umanità. Attraverso l’immagine pittorica del retablo ho voluto scrivere una rivendicazione del primato della letteratura nei confronti della politica, ho voluto descrivere la complessità dell’uomo, i suoi sentimenti, le sue passioni. Nel libro c’è l’ironizzazione di certa pittura imbrogliona, prendendo spunto dall’opera teatrale di Cervantes che si chiama appunto El Retablo de las meravillas. In Spagna la parola retablo è un termine che indica sia un’opera pittorica, sia un’opera teatrale. Nel Don Chisciotte c’è il “retablo del maestro don Pedro”, che è un teatrino di marionette portato in giro per la Mancha da don Pedro e che don Chisciotte nella sua follia distrugge. Cervantes mette in ridicolo il
conflitto di allora tra cristiani vecchi e cristiani nuovi, tra spagnoli ed ebrei, e mori convertiti. Questo intermezzo, o atto unico teatrale, lo riprendo nel mio libro Retablo, dove il conflitto questa volta è tra persone ingenue, oneste e fedeli alla chiesa e disonesti, infedeli o traditori:
Irreali come il retablo delle meraviglie che lo scoltor d’effimeri Crisèmalo e il poeta vernacolo Chinigò facean vedere sopra un palco. Un trittico a rilievo basso di cartapesta o stucco coperto d’una polvere dorata (terribilmente baluginava al sole come l’occhio adirato del padre Giove o quello pietrificante di Gorgonia), privo di significato e di figure vere, ma con increspature, rialzi e avvallamenti, spuntoni e buchi, e tutto nell’apparenza d’una arcaica scrittura, di civiltà estinta per tremuoto, diluvio o eruzione di vulcano, e sotto le ruine, in fondo all’acque o nella lava ardente si perse la chiave di sua lettura.
Vide chi pote e vole e sape
dentro il retablo de le maraviglie
magia del grande artefice Crisèmalo,
vide le più maravigliose maraviglie:
vide lontani mondi sconosciuti,
cittate d’oro, giardini di delizie,
[…].
Vide solamente il bravo cristiano,
l’omo che fu tradito mai dalla sua sposa,
la donna onesta che mai tradì il suo sposo…3
3 Retablo, pp. 395-396.
Nella mia scrittura, nello spostamento della prosa comunicativa verso la prosa espressiva ci sono dei momenti di arresto della narrazione, ci sono delle digressioni che io chiamo cantica, come fosse una parte corale, quella dei cori greci. La mia idea oggi di letteratura, di scrittura in prosa, è di una
scrittura dove, come nella tragedia greca non appare sulla scena il messaggero o l’anghelos, cioè il personaggio che comunicava con il pubblico che sedeva nella cavea, che raccontava di un fatto avvenuto prima, in un altro luogo, e da quel momento, dopo questa comunicazione, con un linguaggio assolutamente comunicativo, poteva incominciare la rappresentazione della tragedia, potevano agire i personaggi e intervenire il coro. Credo che oggi in questa nostra civiltà di massa il Messaggero, cioè lo scrittore che comunica con il lettore non può più apparire sulla scena e quindi la scrittura si riduce alla parte corale, alla parte poetica in cui si commenta, si lamenta la tragedia… Diciamo è una rappresentazione priva di catarsi. Ora vi leggo un brano di un altro mio romanzo Nottetempo casa per casa dove con la memoria descrivo un luogo sotterraneo nel quale
sono stati scoperti affreschi romani. Questo brano mi è stato ispirato da una mostra che ha fatto Ruggero Savinio anni fa. Le figure di Ruggero Savinio mi apparivano come venute fuori da una profondità, da un ipogeo, come nelle scoperte di scavi archeologici, e quindi nel racconto del romanzo ci sono interruzioni per raccontare un viaggio dentro un mondo antico:
Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati
(dimenticammo l’ora, il punto del passaggio, la consistenza, la figura
d’ogni altro, dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete, al
confine bevemmo il nostro lete).
Ora in questa luce nuova – privazione d’essa o luce stessa rovesciata, frantumo d’una lastra, rovinìo di superficie, sfondo infinito, abissitade –, in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. O ignote forme, presenze vaghe, febbrili assenze, noi aneliamo verso dimore perse, la fonte dove s’abbevera il passero, la quaglia, l’antica età se polta,
immemorabile.
In questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichio
di quell’oro, è possibile ancora la scansione, l’ordine, il racconto ? È
possibile dire dei segni, dei colori, dei bui e dei lucori, dei grumi e degli strati, delle apparenze deboli, delle forme che oscillano all’ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono? E tuttavia per frasi monche, parole difettive, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione. Viene e sovrasta un Nunzio lampante, una lama, un angelo abbagliante. Da quale empireo scende, da quale paradiso? O risale prepotente da quale abisso? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai portenti, si dichiara vessillo, simbolo e preambolo d’ogni altro spettro. Da sfondi calmi, da quiete lontananze, dagli ocra, dai rosa, dai bru ni, da strati sopra strati, chiazze, da scialbature lievi, da squarci in cui traspare l’azzurro tenero o il viola d’antico parasceve, lo Scriba affaccia, in bianca tunica, virginea come la sua fronte o come il libro poggiato sui ginocchi. Venne poi il crepuscolo, la sera. Una sera azzurra e bruna, vermiglia e gialla. Con un reticolo d’ombre, di caligini, un turbine di braci. È l’ora questa degli scoramenti, delle inerzie, degli smarrimenti, delle malinconie senza rimedio, l’ora delle geometrie perfette, delle misure inesorabili, la sfera il compasso la clessidra la bilancia…(la luna suscita muffe fiori di salnitro…) l’ora della luce bianca, della luce nera, sospesa e infinita. Oltre sono i foschi cieli e le chiome degli alberi impietrati, gli scuri ingressi degli antri delle vuote dimore, del volo di vespertili, verso della civetta.
Oltre sono le Rovine. Che non consumi tu Tempo vorace. 4 Che non consumi tu…Che non consu…”5
È la poesia delle rovine, delle vestigia del nostro passato che ci
commuovono ogni volta che le vediamo.
Prof. Caruso. Volevo ringraziare. È qualcosa di più di una conferenza, è anche una confessione stupenda e soprattutto hai dato una prova di come la pittura e la letteratura siano strettamente connesse, fraterne e vicine. Poi hai parlato delle rovine che ci commuovono tanto: ci commuovono perché sono il nostro passato, i nostri ricordi. 4
«Riprende una frase che “i paesaggisti del Cinque-Seicento scrivevano
dietro i paesaggi con rovine” (Villa, p. 177)». Così nel dattiloscritto. D.
O’Connell da parte sua commenta questa frase come segue: « A detta dello
scrittore questa frase è ripresa dagli incisori dell’Ottocento che la lasciavano scritta sopra le rovine riprodotte. Ma ci sembra di sentire qui anche un’eco del latino, in particolare da Ovidio (Metamorphoses XV, 234-236): Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, / Omnia destruitis vitiataque dentibus aevi / Paulatim lenta consumitis omnia morte! (Id., Consolo narratore e scrittore palincestuoso, cit., p. 173). 5 Nottetempo, casa per casa, pp. 686-687.
Hai anche detto che i pittori non analizzano i loro strumenti. Non è assolutamente vero. Purtroppo i vari strumenti linguistici dell’arte figurativa, dell’arte visiva vengono fin troppo analizzati. Questa è una puntualizzazione. Poi io direi a proposito del tuo ritmo di scrittura e anche di come tu parlavi delle origini della letteratura che la grande matrice di tutte le arti è la musica; anche le prime parole nascono da un ritmo musicale. Il ritmo musicale in qualche modo ci guida in qualsiasi attività artistica, perché se non c’è ritmo non c’è scansione e non c’è parola, né pagine, né spazio. Hai parlato in modo da provocare una quantità di associazioni. Ti ringrazio. Consolo. Mi scuso per l’errore che ho fatto, data la mia ignoranza pensavo che i pittori trovassero i colori a portata di mano, che andassero in un colorificio e in modo rapido comprassero i loro colori. Sono stati tanti i pittori che mi hanno ispirato. Però mi hanno ispirato anche molti libri o pagine di libri, ma c’è un pittore che più degli altri mi ha impressionato e che compare nel Sorriso dell’ignoto marinaio, è Goya. Goya dei Disastri della guerra, Nel mio libro c’è la descrizione di una strage che hanno fatto i rivoltosi popolani di un paesino dove appunto mi servo delle didascalie delle incisioni di Goya per scandire la tragedia. E insieme c’è anche la malinconia del Dürer. Ho parlato di un altro pittore, Caravaggio, ne L’olivo e l’olivastro, che non è un libro di invenzione narrativa, è un viaggio nella realtà siciliana, dove sono inseriti frammenti narrativi, tra cui la sosta di Caravaggio a Siracusa dopo la fuga da Malta, e la commissione che gli viene data dal senato di Siracusa tramite un erudito locale, Mirabella, del quadro del seppellimento di S. Lucia. Volevo leggere il brano dove descrivo il quadro:
Effigiò la santa come una luce che s’è spenta, una Lucia mutata in Euskìa, un puro corpo esanime di fanciulla trafitta o annegata, disposto a terra, riversa la testa, un braccio divergente, avanti a donne in lacrime, uomini dolenti, stretti, schiacciati contro la parete alta della latomia, avanti alla corazza bruna del soldato, la mitria biancastra, aperta a becco di cornacchia, del vescovo assolvente, dietro le quinte dei corpi vigorosi e ottusi dei necrofori, cordari delle cave o facchini del porto, che scavano la fossa. La luce su Lucia giunge da fuori il quadro, dalla pietà, dall’amore dei fedeli astanti, da quel corpo riverbera e si spande per la catacomba, a cerchi, a onde, parca come fiammella di cera dietro la pergamena. Nel sentimento della morte che ormai l’ha invaso e lo possiede, Michelangelo è oltre la violenza, l’assassinio, è alla resa, alla remissione, al ritorno ineluttabile, al cammino verso la notte immota. 6
Il vescovo di Siracusa, dicono i documenti, non ha trovato questo quadro di suo gradimento e glielo ha fatto correggere; sempre secondo i documenti, la testa di Santa Lucia era staccata dal corpo, la santa era stata decapitata, e il vescovo gli ha fatto congiungere la testa con il corpo, lasciando una piccola ferita nel collo. Nel quadro oggi si vede soltanto questo piccolo squarcio. Dicevo che c’è il passaggio, da questa lama di luce che c’è nella pittura caravaggesca che squarcia le tenebre controriformistiche, alla forma necrofila di arte del ceroplasta siracusano Gaetano Zumbo, il quale componeva dei teatrini rappresentanti la morte e la corruzione del corpo umano. Il cereo corpo di Lucia si decompone insomma negli ipogei della
morte, negli avelli, nelle catacombe dei liquami; nella ferita del collo
bianco s’è insinuato il bacillo della peste che cova e germina nelle
volute, nei ghirigori del barocco».
6 L’olivo e l’olivastro, pp. 828-829.
Il testo di questa Conferenza, tenuta all’Accademia di Belle Arti di Perugia il 23 maggio 2003, mi era stato affidato alcuni anni orsono da Caterina Pilenga, vedova dello scrittore, come un prezioso inedito che io ho gelosamente custodito. In calce al testo dattiloscritto, sotto la firma di Vincenzo Consolo, si legge la data: Milano, 19.3.2004, verosimilmente apposta da chi ha dattilografato il manoscritto, forse la stessa Caterina 
Vincenzo Consolo : l’alchimie du logos
Chroniques italiennes n. 73/74 (2-3 2004), M. GIACOMO-MARCELLESI
Vincenzo Consolo : l’alchimie du logos
Femmine, che sono sti lamenti e queste grida con la schiuma in bocca ?
La transposition narrative du monde de Vincenzo Consolo, ce « Finistère » dont les frontières sont sans cesse repoussées dans l’espace et dans le temps, comporte une telle force dans les évocations langagière, qu’on a parfois l’impression de ne pas pouvoir comprendre le texte si on ne le lit pas à voix haute.
Il est sans doute difficile de trouver une production littéraire où la voix humaine aux mille parlers occupe autant de place que dans cet univers dont la dimension chorale exprime l’infinitude de la souffrance humaine. L’extrême richesse de la narration se développe dans la cristallisation métaphorique des mots, expressions, formules nées de la mémoire individuelle de l’écrivain qui renvoient à une culture populaire et savante, ainsi qu’à une sensibilité et une éthique forgées dans ce contexte.
Consolo définit lui-même la genèse de son oeuvre littéraire comme le projet d’une écriture de type sociologique, à la Carlo Levi, qui s’est inscrite dans la perspective d’une écriture expressive ou sentimentale quand il a compris que l’esthétique littéraire généralement qualifiée de néo-réalisme était dépassée. Son choix se porte donc sur cette écriture expressive, dont il voit l’archétype en Giovanni Verga, « il primo grande rivoluzionario stilistico nella letteratura moderna ».
Le critique Enzo Papa signale enfin une autre influence invoquée par Consolo, celle du groupe allemand ’47:
Vi resistono an cora gli echi della poetica neorealistica, già in congedo… ma vi appare evidente la lezione del tedesco gruppo ‘47, di quegli scrittori tedeschi che Consolo definisce analisti, come anche quella delle sperimentazioni linguistiche di Gadda e di Pasolini. 1
Dans cette lignée, Consolo manifeste dès son premier ouvrage La ferita dell’aprile ( bien qu’il ait fallu attendre Il sorriso dell’ignoto marinaio pour que la critique s’en aperçoive) une maîtrise des ressources de la langue et une originalité de style qui permettent de le reconnaître dès la première lecture, ad apertura di pagina, dit un critique2.
Nous verrons comment les voix populaires résonnent dans l’oeuvre de Vincenzo Consolo, les mots, les dialogues, mais aussi les interjections, les murmures, les balbutiements, les bruits. Il n’est pas jusqu’aux cris et au silence qui ne prennent une signification métaphorique dans cet univers.
1.Langue(s) et dialecte(s) :
1.1 La musique de l’inflexion dialectale:
La langue italienne dans ses inflexions dialectales diverses est évoquée avec émotion par l’écrivain Giacchino Martinez, héros du roman Lo Spasimo di Palermo (en partie autobiographique) quand il l’entend résonner dans le train, au retour d’un exil de plusieurs années : les voyageurs descendent à Florence et à Rome relayés par d’autres qui montent, le couloir est envahi par les soldats en permission qui hurlent, s’interpellent, se moquent les uns des autres d’un bout à l’autre du wagon dans un joyeux brouhaha, la baraonda : l’intellectuel se complaît à entendre résonner ces parlers qui ne sont plus le dialecte mais ne sont pas encore « la terrible nouvelle langue nationale que le malheureux Pasolini avait prophétisé pour le pays.
1 Enzo Papa, « Vincenzo Consolo : », in Id., « Ritratti critici di contemporanei», in: Belfagor, Firenze, Olschki, marzo 2003, LVIII, n.2, p. 179-198 : « on y trouve encore les échos de la poétique néoréaliste, …mais déjà apparaît en pleine évidence l’influence des écrivains du groupe allemand ’47…de ces écrivains que Consolo définit comme analystes, et aussi celle des expériences linguistiques de Gadda et de Pasolini ».
N.B. Cette traduction, comme toutes celles qui suivront, en note ou dans le texte, sauf mention spécifique, a été établie par l’auteure de la présente étude.
2 Gianni Turchetta, « Introduction » in : Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori, 1988, p. V-XII
Vincenzo Consolo : l’alchimie du logos 199
Oltre l’eterna melodia napoletana, cercava di distinguere i suoni di Calabria, quello aspro dei monti e quello piano di Vibo e di Lamezia. Nelle parlate poi della sua isola, indovinava facilmente, nelle sue varianti, le città e i paesi da cui i ragazzi provenivano. Sentiva l’incolore e aggirante messinese, il rotondo e iattante palermitano, l’allusivo e cantilenante catanese, il pietroso e aspirato agrigentino, e l’antico lombardo di Piazza, Nicosia o San Fratello3.
1.2 Le sicilien
Le premier roman La ferita dell’aprile4, propose, dès 1963, une langue de ce type, italienne souvent fortement infléchie par le dialecte tandis que le dernier roman (à ce jour), Lo spasimo di Palermo, sépare la langue italienne académique des énoncés en sicilien qui sont le plus souvent des noms de lieux ou des proverbes. Il sorriso dell’ignoto marinaio5 et Retablo6 se rapprochent plutôt de cette deuxième solution, tandis que Le pietre di Pantalica7 accorde une place beaucoup plus importante au dialecte puisque ce livre évoque l’occupation des terres par les journaliers agricoles, I braccianti. Enfin le livre consacré au Baroque en Sicile présente de longs passages en sicilien, les récits de témoins du tremblement de terre d’Acireale et de celui qui a détruit Syracuse en 16938.
Le sicilien proprement dit résonne à travers les dialogues, les proverbes, les rituels des travaux des champs, les insultes, les slogans politiques, les joutes poétiques de la vie quotidienne, les chansons du « folklore », et de nombreux textes sont eux-mêmes en dialecte.
Les caractéristiques phonologiques et morphologiques du sicilien sont présentes aussi bien dans La ferita dell’aprile que dans d’autres teste de Consolo.
– Vocalisme : l’absence de diphtongue dans le suffixe –ère « -ièri » (cavalere « cavaliere » sciarmère, « mèi « miei », sui « suoi »), -les voyelles fermées en syllabe tonique (chisti « questi », sunno « sono », signuri « signore », vui « voi »), les voyelles semi-ouvertes en syllabe atone (sicolo « siculo », scoltori « scultori »)
– Consonantisme : le rhotacisme (Arcamo « Alcamo », ascortate « Ascoltate »), la séquence –nn- correspondant à la séquence italienne –nd- : (monno « mondo », granne « grande »), l’absence de l’élément labio-vélaire (chisti « questi »), la présence de la fricative palatale dans la séquence consonantique –str- (nosctro « nostro »), la non-assimilation du groupe –ntpour l’italien –tt- (pintori « pittori »)
En revanche, la morphosyntaxe du sicilien est plus particulièrement présente dans la prose italienne de La ferita dell’aprile, qui reprend le rythme de la langue dialectale, sicilienne mais aussi plus généralement méridionale : emploi systématique du passato remoto là où la langue emploie le passato prossimo, postposition systématique du verbe, soli restammo, cavaliere è, essa fu, io sono, etc., emploi systématique de l’indicatif dans des subordonnée introduites par des verbes exprimant
Le lexique sicilien apparaît dans La ferita dell’aprile, certains mots connus comme caruso, picciotto, d’autres moins répandus dans la péninsule : il dubotti (due colpi en italien, (« deux coups » en français ), d‘autres enfin si obscurs qu’ils sont éludés dans les traductions françaises, comme le balate9, « les roches lisses qui donnent un accès facile à la mer », « les dalles ».
3 Vincenzo Consolo, La spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, 1998, p.94-95 :Au-delà de l’étzrnelle mélodie du napolitain, ilessayait de discerner les sons de Calabre, l’âpre calabrais des monts et de la plaine de Vibo et de Lamezia. Dans les parlers de son île, il devinait facilement, à travers ses diverses variantes, les cités et les bourgs dont provenaient les jeunes gens. Il entendait l’incolore et insinuant parler de Messine, le palermitain sonore e glapissant, le parler de Catania comme une cantilène discrète, le parler âpre et pierreux d’Agrigente, et l’ancien lombard de Piazza, Nicosia ou San Fratello. »
4 Id., La ferita dell’aprile, Torino, Einaudi, 1963
5 Id., Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1976
6 Id., Retablo, Torino, Einaudi, 1998
7 Id., Le pietre di Pantalica, 1988
8 Id., Il barocco in Sicilia : la rinascita del Val di Noto, Milano, Bompiani, 1991
9 Id., La ferita dell’aprile, p. 122
- 3 La différence linguistique comme vécu:
Cette expérience est autobiographique. Vincenzo Consolo tout en assumant son destin de grand intellectuel européen n’en finit pas de donner à entendre la différence linguistique qu’il a vécue dès son enfance. Comme le jeune héros de La ferita dell’aprile il est né dans un bourg en province de Messine, où on parle, aujourd’hui encore, un idiome « gallo-italique » qu’il appelle antico lombardo, qui s’est rapproché au cours des siècles du sicilien, tout en gardant de nombreux traits spécifiques. L’enfant prend conscience de cette singularité quand sa mère l’emmène vivre dans une autre localité, où la population le traite, lui et les siens, comme des étrangers, zanglé, zerabuini, « anglais », « arabes », êtres possédés du diable, affligés de tous les vices que même Mussolini n’avait pu convertir au christianisme. Alors que le paysage qu’il voit de l’institut où il est scolarisé lui donne l’impression rassurante de se rapprocher de son village, les collines entrevues comme un lion protecteur au repos, l’enfant se trouve confronté aux moqueries de ses camarades, pour sa différence de langue, celle d’un bourg « vieux comme le monde, où on parle d’une façon telle que personne ne nous comprend, et les illettrés, quand ils parlent, semblent être originaires du Nord » :
Don Sergio me lo chiese, un giorno che dicevo la lezione.- Di’ un po’ : non sarai mica settentrionale ?
– E le risate di que’ stronzi mi fecero affocare. Glielo dissero che ero uno zanglé, che avevo una lingua speciale. Don Sergio volle sapere e fece la scoperta che poteva esse colonia francese, che zanglé storpiava lesanglé, non inglesi, ma normanno.
Ma non sono neanche uno zanglé, un civile di casino, facce smorte e pertiche di faggio, zarabuino, se ci tiene tanto.
-Zarabuini sono gli arabi, disse don Sergio.10
L’altercation donne lieu à une leçon d’instruction civique empirique, une leçon de tolérance et de respect de l’autre « étranger ». Don Sergio se risque à une analyse hasardeuse de la différence entre « les arabes zarabuini et les normands, deux races, deux classes bien distinctes » dit-il, « la seconde s’étant imposée sur la première provoquant une fracture nette qui dure encore aujourd’hui ». Puis il propose à l’enfant un échange métalinguistique qui montre les correspondances entre les deux idiomes, pen « il pane », mer « il mare », travai « il lavoro » et d’où il ressort que la différence n’est pas un problème :
Vedete, vedete ! Che c’è da vergognarsi, è storia, storia.11
Le camarade de classe Mùstica devient alors un ami, lui qui avait été le premier à l’appeler zanglé , et il reconnaît à son tour « que chacun est fils de son père, un point c’est tout, et que tous nous sortons du même terrier ». Un des prêtres de l’institut, Don Baraglio lui suggère fort judicieusement d’opposer des insultes de sa propre langue à ceux qui l’appellent zanglé.
La coexistence de plusieurs idiomes dans la narration est illustrée notamment par le récit de l’arrivée du voyageur lombard, le peintre Fabrizio Clerici, à la cour princière de Alcamo :
« Venisse, venisse… » soggiunse, facendo segno d’ascendere alla loggia.
« Ben vinuto, ben vinuto ad Arcamo ! » disse quando gli fui di fronte, e m’abbracciò e mi baciò sulle guance.
« L’amici di Sepporta sunno amici mèi. E chisti » disse quando gli fui di fronte presentandomi gli altri ch’avea s ‘intorno « sunno mèi amici, e dunca vosctri. »
« Vino, vino al cavalère di Milano ! » gridò il Soldano. E mi si offrì nel cristallo una bevanda spessa e giulebbosa che dopo il primo assaggio, rifiutai
10 Id., La ferita dell’aprile, Torino, Einaudi, 1963, p. 25-26 : « Don Sergio me le demanda, un jour où je récitais la leçon. –Dis-moi un peu, tu ne serais pas septentrional, par hasard ?. – Les éclats de rires de ces cons ont failli me faire suffoquer. Ils lui ont dit que j’étais un zanglé, que j’avais une langue spéciale. Don Sergio voulut en savoir davantage et il découvrit que c’était peut-être une colonie française, que zanglé était une déformation de lesanglé, non pas des anglais, mais des normands. Mais je ne suis pas non plus un zanglé, un clients de bordel, avec un visage livide et des cannes de hêtre, plutôt zarabuini, si vous y tenez tant à anglé – Zarabuini, ce sont les arabes, dit Don Sergio. »
11 Id., Ibid. p. 26 : Vous voyez, vous voyez ! De quoi avoir honte, c’est de l’histoire, de l’histoire. »
« si contrstava…se sia opportuno, nel poetare o pure rivolgere al sicolo idioma tragedia antiqua oppur poema, sia opportuno dicimo per nui nativi d’Arcamo , patria del primo e granne, onore de la cosca de’poeto e luce di cinnàca, di Ciullo intenno, chiaro al monno intero, e surtuto per nui de l’Academia ardente che al nome suo s’impenne, far crescere la cima sicola da ràdica toscana o puramente far sbocciare in aura toscana la semente sicola. Giudicate vui, vah, giudicate vui »
« Ma veramente, » balbettai vergognoso « mi so nient di lingua e di poesia»
« Checchecchè ? ! »fece il Soldano.
« Non m’intendo, non m’intendo » dissi allungando le braccia » 12
Cet épisode prend toute sa signification si on donne une valeur anaphorique à un paragraphe postérieur où l’auteur évoque avec soulagement, et même une allégresse qui n’est pas due seulement à la limpidité de l’aube et de l’ora antelucana, son départ de la cour d’Alcamo. Cette évocation confirme qu’il s’agit bien de Frédéric II:
Gai giannetti e novi letticari, nell’aere lieve dell’ora antelucana, presto ci portarono lontani dalle mura turrite del paese d’Alcamo, madre di lingua e cuna di poesia, dal grasso amante d’ogni lusso e arte, il castellano e ospite Soldano, dal protervo satiro suo figlio, dalla corte de’bardi, scoltori, pintori e teatranti servi, sciarmèri e questuanti13.
L’ensemble de la rencontre illustre en fait, de façon parodique, le ontraste entre l’apparence orientale et mauresque du Sultan et l’identité du souverain d’origine anglo-saxonne, germanique par son père Henri fils de Frédéric Barberousse, et normande par sa mère Constance de Lecce. L’intérêt de Frédéric II pour les langues, sa maîtrise de la langue arabe, sapassion pour l’astronomie e plus généralement, pour une experimentation scientifique linguistique mais aussi biologique, qui ne recule pas devant la cruauté, sont suggérés ici dans un anachronisme parodique. Le sicilien est utilisé dans une dimension caricaturale, mais il présente des traits intrinsèques, vocaliques, consonantiques, morphologiques, presents également chez les protagonistes populaires du roman.
En contraste avec la générosité princière et linguistiquement sicilienne du Sultan, la formule lombarde mi non so nient exprime l’émotion du peintre lombard Fabrizio Clerici, déjà fortement éprouvé par la dégustation forcée de fruits artificiels, surtout par la vue des foetus monstrueux macérant dans de bocaux, et terrorisé à la perspective de la nouvelle épreuve.
Le même effet comique et parodique naît du plurilinguisme qui se dégage également des allocutions des deux bardes en « contraste », nouvelle allusion aux joutes poétiques médiévales en usage à la cour de Sicile comme dans d’autres régions de Méditerranée où elles sont encore vivantes. Le premier barde, Don Emilio Chinigò, in Accademia inteso Abelio Zenòdotto, s’exprime sans doute dans l’idiome gallo-italique des anciennes coloniespiémontaises :
12 Id., Ibid., p. 40 : « Venez, venez », suggérait-il en nous faisant signe de monter dans la loggia. Bienvenu, bienvenu, » dit-il quand je fus en face de lui, et il me serra contre lui et m’embrassa sur les joues. –« Les amis de Sepporta sont mes amis. Et ceux-ci, dit-il quand je fus en face de lui, en me présentant ceux qui l’entouraient, ce sont mes amis et donc les vôtres.- Du vin, du vin pour le chevalier de Milan ! » cria le Sultan. Et il m’offrit dans un verre de cristal une boisson épaisse que je repoussai dès la première gorgée. – Nous débattions, pour savoir s’il est opportun de rédiger une poésie ou une tragédie en sicilien, pour nous natifs d’Alcamo, patrie du premier, le grand, l’orgueil de la compagnie des poète, je veux parler de Ciullo, célèbre dans le monde entier, et surtout pour nous de l’Académie ardente, faut-il cultiver les sommets siciliens avec une racine toscane, ou bien faire s’épanouir dans l’atmosphère toscane la semence sicilienne. Donnez votre jugement, allez, donnez votre jugement. – « Mais vraiment, balbutiais-je, plein de honte, – je ne sais rien en langue et en poésie.- Quoi, quoi, fit le Sultan. – Je n’y connais rien, je n’y connais rien, » dis-je en allongeant les bras.
13 Id., Ibid., p. 53 :De joyeux guides et de nouveaux jeunes porteurs nous emmenèrent, dans l’air léger de l’aube, loin des remparts crénelés de la ville d’Alcamo, mère de la langue et berceau de la poésie, loin de l’amant de tous les luxes et de tous les arts, le châtelain notre hôte, le Sultan, et loin de son arrogant satire de fils, loin de la cour des bardes, des sculpteurs, des peintres, des comédiens, des jongleurs et des mendiants.
Esultante quindi l’accademico, con voce forte, chiara, si mise a recitare versi oscuri, incomprensibili a me, a voi, a chicchessia, mi credo, non fusse nato in Alcamo, che rumorosi applausi si ebbero, e numerosi brindisi, di tutta l’adunanza14.
Le second barde, padre don Getulio Camàro, in Accademia Aristeo Apollonio, use d’une langue artificielle et ampoulée, peut-être celle du trobar clus et des poètes définis comme siculo-toscans :
Poscia seguì il prete, grevio, untuoso, che pur poetando nel più cercato e prezioso italico linguaggio, tanto dolz e pien di sghiribizz, di pess, e pazz, e pozz, e puzz, e pizz, come ridendo dice il nostro Maggi, erano i versi suoi gonfi di metafore e di immagini e di concetti sùi peregrini e falsi, e manierato il tono, e il ritmo artefatto…15
Dans la diversité des langues, il faut inclure l’argot, il gergo, gergo adolescenziale revendiqué par Consolo, l’emploi des mots fottere, minchione, etc.
Certains mots sont difficiles à comprendre parce qu’ils correspondent à une époque où se situe le roman, ainsi serraglio e mentòla pour les cigarettes « légères »
D’autres idiomes sont conviés, grec, arabe, espagnol, français, anglais, allemand, et même une langue inconnue, dans une comptine que le prêtre fait chanter aux enfants pour exorciser leur peur pendant les bombardements16 Ces idiomes apparaissent à travers des répliques ou mots isolés, souvent des toponymes, qui sont « la dent et la griffe de l’histoire dans la langue » comme disait un illustre géographe. Ces insertions prennent une valeur symbolique dans le déroulement de la narration que nous nous proposons d’évoquer plus longuement dans la troisième partie de notre étude.
- Le choix du genre : roman, poème narratif ?
A travers la série d’interviews organisées à Rome, le 25 juin 1993, par l’Imes, l’Istituto meridionale di storia e scienze meridionali, et publiées dans le recueil Fuga dall’Etna17, Vincenzo Consolo affirme un point de vue selon lequel, dans les conditions actuelles de l’Italie, la fonction de l’écrivain connaît une grave mutation. Cette situation est due à l’absence d’ancrage national des intellectuels italiens, à la rupture du rapport entre la société et les intellectuels :
Gli scrittori italiani hanno sempre dovuto andare all’estero per poter scrivere in prosa, da Manzoni a Calvino, a Sciascia, mutuare cioè la loro dalla prosa francese, o adottare una sorta di koiné funzionale di tipo transnazionale come Pirandello o Morzavi18.
Cette analyse correspond, de manière significative, aux remarques d’Antonio Gramsci sur le clivage entre les intellectuels italiens et le peuple, leur éloignement de la vie « nationale-populaire »19. C’est dans le vide de cette relation entre la société et les intellectuels que s’est installé, selon Consolo, un type de communication qui est, en fait, une véritable imposture.
14 Id., Ibid. p. 41 : « Exultant, l’académicien se mit d’une voix forte et claire, à réciter des vers obscurs et incompréhensibles pour vous, pour moi, pour qui que ce soit croyez-moi, qui ne serait pas né à Alcamo, et il recueillit bon nombre d’applaudissements et de toasts »
15 Id., Ibid. p.41 : Puis le prêtre, d’une contenance grave et onctueuse, débitza des poesies dans le plus précieux et recherché des idiomes italiques, tout en dolz et plein de sghiribizz, de pess, de pazz, de pozz, et puzz, et pizz comme dit en riant notre Maggi, et ses vers étaient gonflés de métaphores , d’images , d’idées étranges et fausses, le ton maniéré, le rythme artificiel .»
16 Id., Lo spasimo di Palermo : p. 14
17 Fuga dall’Etna (La Sicilia e Milano, la memoria e la storia) Roma, Donzelli, 1993.
18 Ibid., p. 53-54 : « Les écrivains italiens ont toujours du se rendre à l’étranger pour pouvoir écrire en prose, de Manzoni à Calvino et à Sciascia, changer leur prose avec la prose française ou bien adopter une sorte de koiné fonctionnelle, de type transversal, comme Pirandello ou Moravia. ».
19 Gramsci Antonio, Quaderni del Carcere, Torino, Einaudi, 1975, 4 vol. , plus particulièrement, dans le volume II, le cahier 8, « Note sparse e appunti per una storia degli intellettuali » , p. 922 et suivantes.
Il explique avoir adhéré au Manifesto per la difesa della lingua italiana parce qu’il estime que la langue italienne est menacée par la langue du pouvoir, langue « absolument horizontale », un pouvoir qui n’est pas seulement politique, mais aussi économique et technologique avec le développement d’une communication de masse dominée par Internet et Monsieur Gates. Seule la pratique de codes linguistiques qui plongent dans les couches profondes de la langue italienne, « le langage vertical » – dit-il- , peut sauver la langue italienne. Dans la même logique, il revendique le choix d’une forme d’écriture qui s’inscrit dans le refus de la forme romanesque, refus affirmé au cours de son itinéraire intellectuel et porté à l’extrême par son dernier ouvrage, Lo Spasimo di Palermo, tandis que l’ouvrage précédent, Il Sorriso dell’ignoto Marinaio, accueilli triomphalement par la critique, témoignant d’un langage prodigieusement inventif, mêlant étroitement langue et dialecte, tradition cultivée et tradition populaire, avait été classé comme « poème narratif ».
Voglio essere radicale per una volta, credo che nel nostro contesto non si possa più praticare questa forma narrativa che è stata di nobilissima tradizione in Europa20
Pourtant, Vincenzo Consolo écrira de nouveau au moins un roman, sa dernière oeuvre jusqu’à présent. Il y exprime quelques justifications par rapport à son impossibilité d’écrire quand son fils lui reproche son silence et lui donne en exemple « le castor ligure, l’indifférent romain, son ami l’amer sicilien », et le père écrivain répond ceci :
Hanno la forza, loro, della ragione, la chiarità, la geometria civile dei francesi. Meno, meno talento, e poi mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono21
et dans les entretiens de 1999-2001 avec Fabio Gambaro, il rapproche les deux formes, roman et poème narratif et il développe de façon encore plus nette sa position par rapport aux deux lignées d’écrivains italiens.
Ainsi, le résultat final rappelle souvent le poème narratif. A ce propos, il faut rappeler que nous n’avons jamais eu de langue unitaire de communication, les particularismes ayant toujours gagné à tous les niveaux. Par conséquent, les écrivains ont toujours dû se poser la question de la langue et s’inventer un langage pour leurs ouvrages. D’un coté, certains écrivains – de Manzoni à Moravia, de Calvino à Sciascia- ont choisi une langue rationnelle et communicative, qui exprimait l’espoir de la naissance d’une société plus civilisée. D’autres écrivains ont préféré s’exprimer dans une langue que j’appelle « du désespoir », une langue très expressionniste. De Verga jusqu’à Gadda, en passant par Pasolini, Meneghello ou d’Arrigo, les écrivains qui ont choisi cette option forment une tradition à laquelle je suis heureux d’appartenir.22
C’est la lecture de Retablo qui a imposé à l’auteure de la présente étude le sentiment d’une étonnante solution narrative symbolisée par la métaphore de l’ « alchimie », impliquant à la fois la relation entre la langue et le monde qu’elle représente, et la fusion entre langue(s) et dialecte(s), expression employée lorsque l‘auteure a interrogé sur ce mystère23.
Vincenzo Consolo qui a alors récusé l’étiquette « dialecte », indigne de cette noble langue qu’est le sicilien24. Il a évoqué, en revanche, le processus de ré-appropriation des mots qu’il avait, enfant, entendu prononcer par sa mère et dont il a découvert, à l’âge adulte, qu’ils remontaient souvent au grec, ou à l’arabe, ou à l’espagnol. Le travail sur le matériau sonore des premières années de la vie convoque la recherche étymologique, mais il suppose aussi un rapport vivant, émotionnel avec la langue maternelle, opposée à « l’hypothétique code linguistique de la langue nationale ». Le parti pris d’écriture résulte d’un choix expérimental, intuitif et conscient à la fois, déjà à l’oeuvre dès son premier roman, La ferita dell’aprile :
20 Fuga dall’Etna, « Je veux être radical au moins une fois, je crois que dans le contexte qui est le nôtre, on ne peut plus pratiquer cette forme narrative qui relève de la plus noble tradition européenne. »
21 Id., Lo spasimodi Palermo, p. 88 : E ux, ils ont la force de la raison, la clarté, la géométrie civile des français. J’ai beaucoup moins de talent, et puis je me perds dans les eaux stagnantes de l’affection, l’opacité du lexique, la vanité du son. »
22 Fabio Gambaro, L’Italie par ses écrivains, Paris, Liana Levi, 2002
23 L’auteure de cette étude a posé à Vincenzo Consolo une question relative à ces problèmes de la présente étude au cours du débat au Colloque international qui lui a été consacré, organisé par Dominique Budor & Denis Ferraris, Ethique et écriture, 25-26 ottobre 2002, Sorbonne-Nouvelle-Paris III (Actes sous presse).
Mi ponevo con esso subito, un po’ consapevolmente, un po’ intuitivamente, sul crinale della sperimentazione, mettendo in campo una scrittura fortemente segnata dall’impatto linguistico, dal recupero non solo degli stilemi e del glossario popolari e dialettali, ma anche, dato l’argomento, di un certo gergo adolescenziale. Gergo quanto mai parodistico, sarcastico, quanto mai oppositivo ad un ipotetico codice linguistico nazionale, a una lingua paterna, comunicabile25 .
L’univers narratif de Vincenzo Consolo offre des solutions originales à l’ancienne interrogation qui hante l’histoire linguistique et culturelle de l’Italie : la questione della lingua, et la problématique de la mimesis, la résonance dans la trame du texte des voix populaires et dialectales C’est en tant qu’auteur du roman historique, pour la métaphore et non pour ses choix linguistiques, qu’Alessandro Manzoni est défini comme un auteur de référence 26 :
« La lezione del Manzoni è proprio la metafora. Ci siamo chiesto perché abbia ambientato il suo romanzo nel Seicento e non nell’Ottocento. Proprio per dare distanza alla sua inarrestabile metafora. L’Italia del Manzoni sembra davvero eterna, inestinguibile ».
Consolo évoque aussi comme référents Sciascia e Piccolo, qui représentent respectivement ses deux Siciles, la Sicile orientale et la Sicile occidentale.
Dalla mia Finisterra, potevo muovere verso il Centro del Caos, verso il Vulcano o verso lo iatto dello Stretto, verso le fate morgane e i terremoti o muovere verso l’occidente dei segni della storia profondi e affollati… E mi sembrò poi, questo movimento, questo partire ogni volta da lontano, dal profondo e approdare al presente alla superficie, l’essenza della narrativa : un ibrido, un incrocio di comunicazione ed espressione, di logico e di magico27.
Dans cet univers « hybride », entre logique et magie, les mots étrangers, les mots étranges, le « parole peregrine » contribuent au processus créatif de cette oeuvre.
- Le parole peregrine : le mystère des mots dans la métaphore:
La diversité des langues comme malédiction est évoquée par le spectacle que découvre le romancier à son retour à Palermo : ses livres ont été rangés par la vigoureuse et dynamique Michela, la fille des fidale Delfio et Cristina, en fonction de leur couleur (ils auraient pu l’être en fonction de leur taille !). Le babelico assemblaggio 28, insupportable pour un intellectuel qui utilise les livres en fonction de leur contenu et non en fonction de la couleur de la couverture, préfigure la tragédie finale puisque c’est le mari aussi mafieux que vulgaire de cette même Michela qui organise l’attentat contre le juge.
24 La même interrogation est formulée par le coordinateur de l’interview dans Fuga dall’Etna,. Après un assez long développement sur la mémoire historique et la mémoire personnelle, Renato Nicastò évoque le rôle du dialecte dans la mémoire personnelle et conclut par la question suivante : « Ecco, l’alchimia di tutto questo come succede, come nasce ? »
25 Vincenzo Consolo, Per una metrica della memoria, 1997.» Je me suis immédiatement situé sur la ligne de l’expérimentation, en mettant en oeuvre une écriture marquée par l’impact linguistique, par la récupération non seulement des stylèmes et des glossaires populaires et dialectaux, mais aussi, vu le thème de l’ouvrage, un certain argot d’adolescent. Un argot parodique, sarcastique, en contraste avec un hypothétique code linguistique national, et une langue paternelle, véhiculaire. »
26 Id . , Fuga dall’Etna, p. 46-47. « La leçon de Manzoni réside justement dans la métaphore. Nous nous sommes demandé pourquoi il a situé son roman au XVIIème siècle et non au XIXème. Justement pour donner une distance à l’incontournable métaphore. L’Italie de Manzoni est vraiment éternelle, indestructible. »
27 Id., Per una metrica della memoria: « De mon Finistère, je pouvais me déplacer vers le centre du Chaos, vers le Volcan et vers la fracture du Détroit, vers les fées Morgane et les tremblements de terre, ou avancer vers l’occident les signes profonds de l’histoire. Par la suite, ce mouvement, ce départ chaque fois renouvelé depuis l’éloignement, depuis la profondeur, jusqu’à la surface m’est apparu comme l’essence du récit : un hybride, un croisement dans la communication et l’expression, de la logique et de la magie. »
28 Id. Lo spasimo di Palermo, p. 102.
L’écriture de Consolo est profondément métaphorique, dans le sens où de nombreux mots, de nombreuses évocations ont une signification qui n’est pas liée au seul contexte immédiat, mais s’inscrit dans la relation anaphorique et cataphorique qu’un passage entretient avec l’ensemble du texte, parfois de façon très fugitive, de sorte que seules des relectures successives peuvent en révéler le mystère. Cet arrière-plan multiple s’inscrit dans la discrétion et le minimalisme chers à Consolo, et qui n’ont d’égal que l’extrême densité sémantique.
Dans La ferita dell’aprile, la « blessure » qui donne son titre au roman est évoquée, au détour du récit, à la fin du chapitre 10, presque à la fin de l’ouvrage qui en comporte 12 d’importance à peu près égale.
N’ammazzarono tanti in una piazza (c’erano madri e c’erano bambini) come pecore chiuse nel recinto, sprangata la porta. Girarono come pazzi in cerca di riparo ma li buttò buttò buttò riversi sulle pietre una rosa maligna nel petto e nella tempia : negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lava, di deserto29.
Le récit pourrait être celui de bien des hécatombes passées ou des hécatombes à venir que prophétise, nouvelle Cassandre sicilienne, la vieille femme encore debout sur le lieu du massacre :
Femmine, che sono sti lamenti e queste grida con la schoiuma in bocca ? Non è la fine : sparagnate il fiato e la vestina per quella manica di morti che verranno appresso !30
Le véritable message est suggéré par la couleur du tissu du drapeau rouge, toujours plus rouge au fur et à mesure qu’il s’imprègne du sang des victimes :
La pezza s’inzuppò e rosso sopra rosso è un’illusione, ancore un’illusione31.
Le drapeau rouge, le « superbe drapeau rouge, rouge du sang des fusillés »32 retrouve sa signification réactualisée au moment où s’évanouissent les illusions sur la démocratie, une démocratie italienne don’t on sait aujourd’hui que son gouvernement a organisé le massacre d’une innocente, dans une mise en scène qui permet d’en imputer la responsabilità au populaire bandit Salvatore Giuliano. Cette signification ne peut être comprise que si on met en relation ce passage avec celui qui précède, les cris d’une manifestation populaire de 1er mai : « Con la bandiera rossa gridano, al Primo Maggio, ai Lavoratori evviva ! » mêlée à l’évocation statuaire d’un monument aux morts, un soldat qui s’élance pour la patrie de Piémont-Sardaigne, une liste de noms révoquant l’appel des recrues, etc.:
Vicino al fante verderame slanciato avanti, Savoja !, le balate e i nomi, presente !, scoloriti per il tempo che ci è passato sopra: le ruote grandi e i raggi neri mangiati dalla ruggine e i fusti dei cannoni, con la bandiera rossa gridano, al Primo Maggio, ai Lavoratori, evviva !33
La ruelle qui relie l’intérieur des terres à la mer, via Rotolo, dont le nom revient dans d’autres ouvrages, au bout de laquelle se trouve cette statue est elle-même précédée d’une description du paysage, voir comme un tableau de peintre à travers les yeux décillés d’un narrateur le héros luimême caruso, bastaso, devenu désormais jeune homme qui fume sa première cigarette en compagnie d’un jeune maçon, fixé dans la position du jeune désoeuvré qui « tient le mur » dans une attitude qui exprime l’ascendant qu’ont pu avoir les mafiosi sur la jeunesse34 (il ne faut pas oublier que mafioso est une appellation à l’origine positive, comme ‘ndrangheta ‘la société des hommes debout).
29 Id., La ferita dell’aprile, p. 122 : « Ils en ont tué beaucoup sur place (il y avait des mères et des enfants) comme des brebis enfermées dans l’enclos, la barrière fermée. Ils ont tourney comme des fous en quête d’un abri mais ils ont été jetés à la renverse sur les pierres, les uns après les autres, par une rose mauvaise qui les frappés à la poitrine et à la tempe : dans leurs yeux, un soleil jaune comme les genêts, un soleil vert, un soleil noir de poudre, de lave, de désert. ».
30 Id. Ibid. « Femmes, qu’est ce que ces lamentations et ces cris ? Epargnez votre souffle et votre robe en prévision des nombreux morts qui vont suivre ! »
31 Id., Ibid., « le tissu s’imbiba et rouge sur rouge c’est une illusion, encore une illusion .»
32 Chant de la Commune de Paris.
33 Id., Ibid., :: « Près du fantassin vert-de-gris qui s’élance, en avant, Savoie !, les balata, les noms, présent !, décolorés par le temps qui est passé dessus, les grandes roues et les rayons noirs rongés par la rouille ainsi quet les fûts des canons, avec le drapeau rouge, ils crient : vive le 1er mai, vive les Travailleurs ! »
Un nom étranger relie la signification immédiate que le mot prend dans le texte à d’autres significations, qui se superposent à elle dans le déroulement du texte. Nous ne donnons ici que quelques exemples :
-Il packet-boat :
L’insistance avec laquelle ce mot revient dans plusieurs ouvrages ne peut être fortuite, même s’il s’agit d’une façon sicilienne de désigner le navire. Les mots d’origine anglaise passé par le français, il packet-boat, symbolise l’éloignement de l’île, la distance qui le sépare du monde européen.
-Il marabutto :
Ce mot d’origine arabe est prononcé par le père de Gioacchino (Chino), en réponse à une question de son entourage, il dit où il va pour cacher un Polonais évadé de l’armée allemande. L’enfant ne peut s’empêcher de le ressortir quand les Allemands torturent Delfio pour le faire parler. Il occulte plus ou moins ce mot qui symbolise sa culpabilité pour n’avoir pas pu se taire, car son imprudence langagière a déterminé le destin tragique de ses parents, et peut-être celui de son propre fils, pense-t-il, car l’attitude rebelle celui-ci à l’égard de la société, à l’égard de son propre père incarne au-delà du problème oedipien, une punition pour la faute qu’il a commise enfant. Mais au-delà de cette névrose, c’est la signification même du mot que le romancier découvre à la fin du roman, puisqu’il apprend, au hasard de ses enquête sur l’histoire de la Sicile, que le mot marabutto est une adaptation du mot arabe qui signifie ermite, un religieux qui s’est luimême enfermé dans le silence.
-Il monello :
Bien que ce mot soit un mot italien, il est aussi significatif de la valeur métaphorique de la différence de langue. Ce nom est celui par lequel le film de Chaplin The Kid, est désigné en italien. Lorsque Gioacchino Martinez arrive dans son hôtel parisien, qui a été rénové sous le signe du cinéma, il voit immédiatement une affiche du film. Est-ce un hasard ? En français, le titre anglais n’est pas traduit. Or, le mot monello a une histoire significative : c’est à l’origine un mot d’argot, parola gergale, désignant celui qui doit être réprimandé35, fortement, un voyou, même, puis le mot a pris une signification moins forte, par euphémisme, celui qui n’est pas très sage et doit être grondé. Mais le rapport conflictuel entre le fils du romancier et la société, avec le père symbolisant la société, rapport difficile qui était déjà celui de Chino avec son propre père.
Les insultes en langue étrangère sont une forme de défense, que suggère un enseignant au jeune héros de La ferita dell’aprile et dans Lo spasimo di Palermo. Autre épisode significatif : Dans Lo spasimo di Palermo, pendant un bombardement, le prêtre propose aux enfants une comptine en langue inconnue, une arme contre la peur, mais aussi, peut-être symboliquement, l’arme des mots contre les armes de la guerre
« Fermi, fermi ! Tutti sotto le panche, le mani sulla testa » si mise a vociare il prete. E nella breve pausa, dopo le prime raffiche, ordinò di cantare l’aria con parole senza senso, ch’erano forse parodia, scherno d’una lingue :
Sukkerlain suttreklain
Kulì jutek ansamadain
Ma sei ni kuskei dublei
Kulì brudak mundai mundei
Suleik dindi moni dindindin
Suelik dindi moni dindindind36…
34 Id., Lo spasimo di Palermo
35 Gianfranco Folena, Semantica e Storia di « monello », in Lingua Nostra, XVII, 1956, p.
65-77, et Id., « Ancora maonello-famiglie », ibid., XVIII, p. 33-35
36 Id., Lo spasimo di Palermo : p. 14 : « « Arrêtez, arrêtez! Tous sous les bancs, les mains
sur la tête » se mit à crier le prêtre. Et dans la brève pause, a^rès les premières rafales, il
odronna de chanter l’air avec de sparoles dépourvues de sens, qui étaient peut-être une
parodie, la dérision d’une langue. – Sukkerlain suttrekalin… »
Le silence même suggère les cris, hurlements si terribles qu’ils sont muets, de toutes les victimes des catastrophes « naturelles » ou provoquées par la folie meurtrière des sociétés humaines, cris silencieux sortis de la bouche grande ouverte des victimes, dans un visage aux yeux exorbités par la peur que représentent tableaux, fresques et sculptures de l’art baroque :
Un cielo livido come nelle Crocefissioni di Antonello, piane colli monti privi d’ombre, sfumature, d’una insopportabile evidenza ; un tempo immobile, sospeso, e un silenzio attonito, rotto da ulular di cani, strider d’uccelli, nitriti di cavalli : un mondo che sembra attendere da un momento all’altro la sua fine : l’uomo, di consegnarsi ineluttibilmente all’ultima certezza. Il cui panico Michelangelo ha rappresentato nel Giudizio in un personaggio (in basso, sul lato dei dannati, un occhio reso cieco da una mano, l’altro sbarrato, con dentro lo sgomento)37.
Les cris se confondent avec les grondements terribles de la mer déchaînée et des ouragans en furie et des volcans et de la terre dans les éruptions et les secousses sismiques, sifflements des sirènes et des bombes, etc. A la fin du Spasimo di Palermo, est évoqué le tableau La montée au Calvaire, que Raphaël a peint à la demande des prêtres ulivetani, qui a ensuite été offert au roi d’Espagne de sorte qu’il est maintenant à l’Alcazar de Madrid38
La métaphorique, c’est aussi celle du cri muet de Munch, l’horreur de l’éruption du champignon atomique.
Mathée GIACOMO-MARCELLESI
,37 Id & Giuseppe Leone, Il barocco in Sicilia : l a rinascita del Val di Noto, Milano, Bompiani, 1991, p. v. : « Un ciel livide comme dans les crucifixions d’Antonello, platine collines montagnes sans ombre, sans nuances, d’une évidence insupportable ; un temps immobile, suspendu ; et un silence étouffé, interrompu par des hululements de chiens, des cris stridents d’oiseaux, des hennissements de chevaux ; un monde qui semble attendre d’un moment à l’autre sa propre fin ; l’homme qui semble attendre de pouvoir se confier inéluctablement à l’ultime certitude et dont la panique est représentée par Michelange, chez l’un des personnages de la fresque du Jugement, (en bas, du coté des damnés, un oeil obturé par une main, l’autre oeil exorbité reflétant l’effroi) ».
38 Id. La Spasimo, p.
Pasolini il corpo della città
Presentazione di Vincenzo Consolo
di introduzione al volume “Pasolini. Il corpo della città”
di Gianni Biondillo, ed Unicopli, 2001, pagg. 7-12
*
Presentazione
di Vincenzo Consolo
di introduzione al volume “Pasolini. Il corpo della città” di Gianni Biondino. ed Unicopli. 2001. pagg. 7-12
Cesare Garboli, Federico Zeri ed altri hanno voluto giustamente vedere in Pasolini e Caravaggio due personaggi simili: simile la loro tragica vita e ancor più la loro tragica morte; simile il loro scandalo artistico, la loro innovativa, dirompente forza poetica. Scrive Carbon: “E’ difficile scindere tutta l’esperienza eversiva del Pasolini -romano” degli anni Cinquanta dall’immagine del Caravaggio che ci è stata a più riprese offerta dal Longhi fino alla grande mostra caravaggesca da lui organizzata nel ’51. Proprio in quegli anni il Pasolini scendeva dal Nord a Roma, cambiando la giovanile e lirica vena friulana in tragedia, nella direzione del drammatico realismo religioso e plebeo de Le ceneri di Granisci, dei Ragazzi di vita e di Una vita violenta”. E Zeri: “C’è una forte affinità fra la fine di Pasolini e la fine di Caravaggio perché in tutti e due mi sembra che questa fine sia stata inventata, sceneggiata, diretta e interpretata da loro stessi”. Roma dunque, e la -vita violenta” per le sue strade, per le sue borgate; e i litorali squallidi, desertici di Ostia e di Porto Ercole, su cui due corpi esanimi, disfatti rivela la livida luce dell’alba. C’è uno scarto di 365 anni nella conclusione delle due vicende umane. Ma c’è, nel tempo storico del Merisi c in quello di Pasolini. e. se si vuole. nel tempo di Pasolini e la nostra attualità, c’è l’immobilità di questo nostro cattolico Paese, eternamente secentesco, controriformistico, c’è la dura tenebra dell’ignoranza e della protervia del potere. Ancora una privata ferita, un dolore iniziale e sempre vivo affratella il pittore e il poeta. e insieme l’orrore di fronte alla terribilità del mondo, l’infinita loro disperazione. Più chiaramente: calano, i due artisti, da un Nord di lunghi, gelidi inverni, calano rispettivamente dal borgo Caravaggio e da Milano. da Casarsa e da Giunge a Roma, Pasolini, durante il Giubileo del 1950. “Qual falange di Cristo Redentore / la Gioventù cattolica è in cammino …” cantano i “baschi verdi” per le vie di quella che era stata la città fascista e ora divenuta papale. Le elezioni nazionali del 1948 avevano dato la maggioranza assoluta del potere al partito della Democrazia cristiana, il contropotere al Partito comunista. Le due chiese avrebbero disegnato il nuovo assetto o il volto del Paese, lo avrebbero mutato antropologicamente, culturalmente, linguisticamente e. soprattutto. urbanisticamente. Pasolini soffre fin nelle più intime fibre questa mutazione. Soffre per la repentina distruzione, per il crollo, delrarchitettura”, del mondo rurale, dei verdi suoi prati, delle acque delle sue fontane. Fontàne d’àghe del mie pais A no è àghe pi frescie che tal mè pais… aveva cantato. Ora anche le lucciole sono scomparse. Ora non è che inquinamento, degrado urbano. non è che triste, anonima periferia. squallida borgata. uniforme agglomerato dove i ragazzetti del sottoproletariato. ancora dialettale, consumano rapidamente la loro vitalità. innocenza, grazia, la loro tragedia. Biondillo segue con sapienza, capitolo dopo capitolo lo sguardo di Pasolini sul corpo della città, dal Friuli, da Casarsa, alla Roma di Monteverde. Pietralata, Garbatella, Testaccio, Portuense. a Ode, Orvieto, a Napoli, Matera, Sabaudia. a Bombay. a San’a, fino al Marocco, all’Uganda… Segue. Biondillo, lo sguardo sul corpo della città, del mondo, che Pasolini volge dalle poesie, dai romanzi, dai saggi, dai film, dai documentari, da Poesie a Casarsa e La meglio gioventù fino al grande testo, alla grande costruzione, all’opera-cattedrale che è Petrolio, romanzo postumo e incompiuto come la Sagrada Familia di Gaudi. E’ certo che nel Secondo dopoguerra nessun poeta o scrittore, né il Pavese delle colline e della città, né il Vittorini de Le città del mondo, né il Calvino de Le città invisibili è stato cosi “architetto” come Pasolini, vale a dire come lui ha pianto e rimpianto un mondo sepolto un’umanità e un umanesimo violentemente cancellati (lo sono una forza del Passato./ Solo nella tradizione è il mio amore”), nessuno come lui ha dolorato e inveito per la repentina distruzione della grande bellezza italiana, la bellezza di questo Paese eternamente controrifonnistico divenuto una immensa, squallida borgata. un Agrigento di abusivismo, “una Atene di cemento”. Bologna, calano in una Roma solare, in una città in preda al fervore edilizio, nel pullulare del pellegrinaggio giubilare (1600-1950). Caravaggio si porta dentro il ricordo del padre morto di peste. della giovane madre morta pochi anni dopo. Pasolini, il ricordo del fratello Guido, il partigiano azionista Ermes, assassinato da “una banda di garibaldini degeneri”, dai Gap della brigata Garibaldi. E’ segnato anche dall’accusa infamante di corruttore di minorenni, dall’espulsione dal PCI e dall’allontanamento dalla scuola. “… fuggii con mia madre a Roma, come in un romanzo”. Non sappiamo se dallo stesso scandalo fu investito Caravaggio, se la sua fuga a Roma, in compagnia di Francesco Boneri, il “Cesso del Caravaggio”, il modello tante volte effiggiato, fu dovuta a una simile cacciata. Per il Giubileo del 1600, Roma si presenta ai pellegrini nel nuovo, aulico volto urbanistico voluto da Sisto V, e quindi ancora, con Clemente VIII e Urbano VIII. l’Urbe avrà l’imponente e definitiva scenografia barocca. Ma dietro le quinte c i fondali fastosi, dietro i palazzi di principi e cardinali, sono i ruderi antichi, i medioevali borghi e le strade del degrado e del malaffare. dove circolano poveri, prostitute. bari, ragazzi di vita, squadracce di bravi… non sappiamo se Caravaggio, frequentando a Milano la bottega del Peterzano, andando con questi per chiese e abbazie fuori mano, guardando la pittura del Foppa. Bergognone, Lotto, Moretto, Savoldo, abbia steso le sue “Poesie a Casarsa”, dipinto vale a dire, il suo dialettale idillio lombardo. A Roma però, con un incontenibile empito eversivo, a sciabolate di luce squarcia le buie cortine controriforrnistiche. sconvolge la grammatica manieristica, porta in primo piano i “sacri corpi di cortigiane, zingarelle, ragazzotti, castrati. efebi vestiti da Madonne e Maddalene, suonatori, angeli, Narcisi, Bacchi. Giovanni Battisti… Lo spazio, l’ambiente, la cui mancanza lamenta Berenson, compare soltanto negli ultimi e più drammatici suoi quadri: compare l’esterno della prigione nella Decollazione del Battista di Malta e la latomia o catacomba nel Seppellimento di Santa Liscia di Siracusa. Ma lasciamo questo seicentesco fratello di Pasolini, lasciamolo nella grandezza sua luminosa che squarcia le tenebre controriformistiche di ogni secolo, il nostro compreso, e seguiamo il poeta contemporaneo, il Pasolini dell’idillio e della furia, della perorazione e dell’invettiva, dell’amore e del dolore, del rapimento e della disperazione. Seguiamolo in questo originale, puntuale bel saggio di Gianni Biondillo, Pasolint il corpo della città. Uno degli ultimi quadri di Caravaggio, un quadro-messaggio che il pittore invia da Napoli al cardinal Del Monte, fu il tristissimo David-Cecco Boneri che regge la testa di Golia-Caravaggio. Ed è anche questo l’ultimo messaggio di Pasolini, la sua atroce fine per il vagheggiamento, la nostalgia della verità e della bellezza.
Vincenzo Consolo

La Lingua della scrittura a Vincenzo Consolo
a cura di Annagrazia D’Oria
La pubblicazione di Oratorio presso le edizioni Manni e un incontro a Milano in un’atmosfera tutta siciliana (la signora Caterina ha gentilmente offerto autentico latte di mandorla preparato in casa; sulla scrivania palpitavano pagine di appunti su una donna della Sicilia) sono state occasioni per questa breve intervista a Vincenzo Consolo. Di seguito anticipiamo il “Prologo” da Catarsi in Oratorio, a giorni in libreria.
Oggi la lingua letteraria è quella nazionale del linguaggio televisivo. Viene comunque usata dalla maggior parte degli scrittori: alcuni (pochi) la usano in maniera strumentale con un chiaro intento di opposizione, altri l’accettano per conformismo, come unica possibilità di esistere nel mercato. Tu che cosa pensi? Quali sono le tue idee sulla narrativa italiana?
In questo nostro tempo si è rotto il rapporto tra testo letterario e contesto situazionale e quindi non è più possibile adottare le forme de romanzo tradizionale (oggi si producono e si consumano cosiddetti “romanzi” che non hanno più nulla da spartire con la letteratura); non è più possibile raccontare in una prosa comunicativa, usare una lingua che è divenuta povera, rigida (la famosa nuova lingua italiana come lingua nazionale di cui ci ha detto Pasolini), una lingua priva di profondità storica, invasa dal potere dei media e del mercato.
C’è una soluzione per continuare a scrivere?
Oggi, l’unico modo per rimanere nello spazio letterario da parte di uno scrittore è quello di scrivere non più romanzi, ma narrazioni. Dico narrazione nel senso in cui l’ha definito Walter Benjamin. In Angelus Novus, nel saggio sull’opera di Nicola Leskov, Benjamin fa una precisa distinzione tra romanzo e narrazione. La narrazione, dice, è un genere letterario preborghese affidato all’oralità (racconti orali erano la Bibbia, i poemi omerici). Per ragioni mnemoniche, la prosa allora prendeva man mano forma ritmica, poetica. Nella narrazione insomma è assente quello che Nietzsche chiama “spirito socratico”.
Che cosa intende per “spirito socratico”?
Cos’è? È la riflessione, il ragionamento, la “filosofia” che l’autore mette in campo interrompendo il racconto. Questo è avvenuto, cioè l’irruzione dello spirito socratico, ci dice Nietzsche, nel passaggio dalla tragedia antica di Eschilo e di Sofocle alla moderna tragedia di Euripide. Questo è avvenuto nella nascita del primo grande romanzo della nostra civiltà occidentale, nel Don Chisciotte. “Il povero don Chisciotte aspira a un’esistenza mitica, ma Sancio lo riporta coi piedi per terra, introducendolo violentemente nella sua realtà, grazie alla quale era nato un nuovo genere: ‘il romanzo” scrive Américo Castro in Il pensiero di Cervantes. Ora, nella narrazione moderna o postmoderna, non è che si ritorni all’antica tragedia o al mondo mitico, ma si riflette, si commenta o si lamenta non in forma diretta, comunicativa, ma in forma espressiva, vale a dire indirettamente, vale a dire metaforicamente. Questo significa accostare la prosa alla forma poetica, contraendo la sintassi, verticalizzando la scrittura, caricando di significati le parole e caricando la frase di significante, di sonorità.
Ho espresso questa mia concezione della narrativa nel saggio La metrica della memoria e l’ho messa in pratica in tutti i miei libri narrativi, ma soprattutto nell’ultimo, Lo spasimo di Palermo ed anche, in senso metaforico, nell’opera teatrale Catarsi.
Parlaci di Catarsi…
E’ messo in scena, in quest’opera, un Empedocle contemporaneo (con riferimento, certo, a quello di Hölderlin) nel momento estremo del suicidio e nell’estremità spaziale del cratere dell’Etna. Momento e spazio che non permettono più comunicazione, frasi, parole, ma soltanto urla o suoni bestiali. Antagonista di Empedocle, il giovane suo allievo Pausania, ipocritamente invece continua a comunicare con un immaginario pubblico della cavea, si fa insomma falso messaggero, impostore. In tutti i miei libri, dicevo sopra, a partire da La ferita dell’aprile, e quindi ne Il sorriso dell’ignoto marinaio e negli altri vi sono degli “a parte”, brani in cui s’interrompe il racconto, il tono si alza, la prosa si fa ritmica.
Insomma un cantuccio come i cori della tragedia manzoniana, un intervento liberatorio della poesia che ha ancora una forza…
Sì, sono questi insomma dei cantica o Cori, digressioni lirico-poetiche, commenti non filosofici ma lirici. La filosofia per me consiste nel creare un testo che sia un iper-testo, che abbia cioè in sé rimandi, citazioni, espliciti o no. Ne Il gran teatro del mundo di Calderon, gli attori, all’inizio del dramma, indossano in scena i costumi e quindi cominciano a recitare. Questa invenzione mi aveva colpito e quindi in Lunaria, un’altra mia opera teatrale, ho capovolto li gesto: gli attori alla fine della rappresentazione si spogliano dei costumi in scena. Il senso è la fine dell’illusione. Dell’illusione necessaria, che dura il tempo di una rappresentazione teatrale o della lettura d’una poesia e che ci difende dall’angoscia dell’esistenza e dalla malinconia della storia. Finita l’illusione, c’è il ripiombare nella dura realtà. Che per noi moderni è diventata insopportabile, e scivoliamo quindi nell’alienazione o nella violenza. Soltanto i greci avevano una grande capacità di sopportazione della realtà.
Torniamo agli scrittori, al linguaggio, ma soprattutto al legame con la propria terra. Nel tuoi libri a Sicilia è una realtà viva e concreta, metafora del mondo e delle sue leggi ingiuste e violente…
Allora ci sono scrittori che chiamerei di tipo orizzontale, nel senso che essi possono parlare indifferentemente di qualsiasi luogo. E sono spesso anche grandi scrittori come Stevenson, Conrad, Hemingway o Graham Greene, per fare solo alcuni nomi. Ci sono scrittori invece che non sanno o non possono staccarsi dal luogo della propria memoria, con questo luogo devono fare i conti, di questo luogo fanno metafora. Per tanti scrittori, ed anche per me, questo luogo è la Sicilia. La quale è un’isola terribilmente complessa. Ha una complessità storico-culturale dovuta alle varie civilizzazioni che in essa si sono succedute. La presa di coscienza della sua complessità è stata la ricchezza e insieme la dannazione degli scrittori siciliani.
C’è un esempio importante dell’ineludibilità del tema Sicilia, ed è quello di Verga. Lo scrittore divaga per meta della sua vita, affronta temi cosiddetti mondani e scrive in un impacciato italiano. A Milano, nel 1872, avviene la sua famosa crisi e, nella crisi, “sente il bisogno di risalire alle origini e risuscitare le memorie pure della sua infanzia”., Il bisogno al ritornare con la memoria “al mondo intatto e solido della sua terra” scrive Sapegno. E inventa un “italiano irradiato di dialettalità”
, come dice Pasolini. Ogni scrittore siciliano ha declinato dunque la Sicilia in modo diverso. Detto semplicisticamente, in modo storicistico o esistenziale. Verga ha una concezione metastorica, una visione fatalistica della condizione umana, e si è parlato quindi di fato greco, ma in Verga non avviene assoluzione della colpa, non c’è liberazione. Per verga, bisognerebbe piuttosto parlare di fatalismo islamico. “Quel che è scritto è scritto” recita il Corano.
E la Sicilia di Pirandello?
Pirandello ha interpretato la complessità della condizione siciliana, complessità che provoca smarrimento, perdita di identità. Riguardo a Pirandello bisognerebbe piuttosto parlare di grecità. Nel teatro greco c’era il Prosopeion o Prosopon, ch’era insieme la maschera e la faccia, ma anche il modo come gli altri ti vedono.
Il Prosopon Pirandello l’ha trasferito nel mondo siciliano: non sai chi sei, sei di volta in volta colui che gli altri decidono, sei uno, nessuno e centomila; sei poi costretto, nel gioco sociale, a portare la maschera…
E negli altri scrittori siciliani?
La concezione esistenziale e insieme determinista che, partendo da Verga passa per Pirandello contraddetta da una versi fino a Lampedusa, è contraddetta da una forte linea storicistica, che da De Roberto, per Brancati e Vittorini, arriva fino a Sciascia. Nella concezione metastorica di
Lampedusa c’è una forte ambiguità. L’autore del Gattopardo doveva chiudere i conti, secondo me, con De Roberto, con Viceré (De Roberto dice, contraddicendo Verga: non ce nessun mondo dei vinti. Nella storia siciliana ha vinto sempre il cinismo. l’opportunismo, il trasformismo della classe dominante, dei nobili. vincitori sono sempre loro, mentre i perdenti e gli eternamente ingannati e sfruttati sono i popolani). Lampedusa dunque scrive un romanzo storico con una visione positivista del mondo. Afferma che dalle classi sociali di volta in volta ne emerge una, si raffina man mano nel tempo, arriva alla perfezione (estetica, culturale), quindi decade, tramonta, si spegne come si spengono le stelle in cielo. E quindi emerge un’altra classe (ineluttabilmente insomma alla nobiltà succede la borghesia). C’è una sorta di meccanicismo, di determinismo in questa concezione. Ai leoni e ai gattopardi devono necessariamente succedere gli sciacalli (che diverranno gattopardi a oro volta), ai Salina devono succedere i Sedara. Con questa sua concezione, Lampedusa assolve la classe a cui apparteneva, la nobiltà feudale, principale responsabile di tutti i mali della Sicilia. E assolve anche i borghesi mafiosi alla Sedara: era ineluttabile che questi arrivassero a potere, il loro emergere, è un esito del determinismo storico (con buona pace di “quell’ebreuccio”, di Marx, di cui Salina non ricorda il nome).
E Sciascia?
Sciascia, da illuminista, non accetta nessun meccanicismo nella storia, storia in cui le responsabilità dei mali sociali sono da attribuire al potere, alla sua volontà. Da qui i suoi primi temi illuministi sulla pena di morte, sulla tortura o l’impostura de ll consiglio d’Egitto e di Morte dell’inquisitore, da qui i suoi romanzi polizieschi, necessitati dalla contingenza in Sicilia, in Italia, del potere politico degenerato, dei legami tra potere politico e mafia, dei delitti e dele. stragi del potere politico-mafioso. Ma i romanzi polizieschi di Sciascia sono singolari, opposi ai romanzi polizieschi classici: non vi si arriva mai all’individuazione dell’assassino o degli assassini perché i romanzi di Sciascia sono polizieschi politici. L’individuazione degli assassini comporterebbe l’indagine e quindi la condanna del potere di se stesso. S’e mai visto un potere politico che condanna se stesso? Parliamo dei tuoi libri. In tutti ci sono dei temi fissi: la storia, la riflessione sul potere, sull’emarginazione, sull’oppressione dei deboli, sull’impegno politico e civile dell’intellettuale e usi sempre una lingua particolare, ricca di metafore. Quali sono le tue radici culturali?
Dopo questa lunga premessa parliamo anche di me, un poco, non tanto, come invece vuole di sé Zavattini.
Sono nato come scrittore nel ’63 e già dal primo libro mi sono mosso con la consapevolezza della letteratura, soprattutto della siciliana, di cui abbiamo sopra discorso, che mi aveva preceduto e di quella che si stava svolgendo intorno a me. Mi sono mosso con una precisa scelta degli argomenti da narrare (stori-co-sociali) e del modo in cui narrarli.
Sono nato, biologicamente, in una zona di confluenza del mondo orientale e del mondo occidentale della Sicilia, di incrocio vale a dire tra natura e storia. Potevo quindi optare per l’oriente, per i disastri dei terremoti dello stretto di Messina e delle eruzioni dell’Etna, optare per la violenza della natura ed affrontare temi metastorici, esistenziali, temi verghiani insomma. Ho optato invece per il mondo occidentale, dove sulla natura prevalgono i segni forti della storia. E sono approdato a Cefalù (con I sorriso dell’ignoto marinaio), che era per me la porta del gran mondo palermitano, del mondo occidentale.
Ho voluto narrare argomenti o temi storico-sociali e lo stile da me scelto non è stato comunicativo, non ho adottato una scrittura di tipo illuministico o razionalistico, ma lirico-espressiva con l’assunzione o innesto di parole o formule di lingue del passato che nel dialetto siciliano si sono conservate (dico del greco, latino, arabo, francese o spagnolo). Al contrario degli scrittori che immediatamente mi precedevano, scrittori illuministi o razionalisti (Moravia, Morante, Calvino o Sciascia, quest’ultimo a me più vicino), mi collocavo nella linea sperimentale, quella che, partendo da Verga, giungeva a Gadda, Pasolini, Mastronardi, Meneghello, D’Arrigo..
Ho voluto compiere insomma un azzardo, far convivere cioè argomenti storico-sociali con un linguaggio lirico-espressivo. Questa convivenza era nella realtà rappresentata da due personaggi, un poeta e uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia.
Hai scritto: “Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e si articola come la storia di una continua sconfitta della ragione”.
Ma, alla fine, i tuoi libri non comunicano una sconfitta al lettore, bensì una passione civile, l’esortazione ad usare sempre di più, anche se amaramente, anche se sconfitta, la ragione.
E questo fin dal primo romanzo… ” primo mio romanzo, La ferita dell’aprile, di formazione o iniziazione, è di personale memoria (il Dopoguerra, la ricostituzione dei partiti, le prime elezioni regionali in Sicilia, la vittoria del Blocco del popolo, la strage di Portella della Ginestra, le elezioni del 48 e la vittoria della Democrazia cristiana…), un racconto scritto in una prima persona che non ho mai più ripreso.
Ho quindi immaginato e attuato il mio progetto letterario che è rappresentato principalmente da una trilogia – Il sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo- che riguarda tre momenti cruciali della nostra storia, il Risorgimento, il Fascismo, gli anni Settanta, con la contestazione e il terrorismo, fino agli anni Novanta, con le due stragị politico-mafiose di Palermo, le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Stragi di cui quest’anno, in questo bel nostro tempo di governo di centro-destra, ricorre il decennale. Anno e governo che s’inaugurano con gli atroci fatti di Genova.
Vincenzo Consolo
Prologo
Un velo d’illusione, di pietà,
come il sipario del teatro,
come ogni schermo, ogni sudario
copre la realtà, il dolore,
copre la volontà.
La tragedia è la meno convenzionale,
la meno compromessa delle arti,
la parola poetica e teatrale,
la parola scritta e pronunciata.’
Al di là è la musica. E al di là è il silenzio.
Il silenzio tra uno strepito e l’altro
del vento, tra un boato e l’altro
del vulcano. Al di là è il gesto.
O il grigio scoramento,
il crepuscolo, il brivido del freddo,
l’ala del pipistrello; è il dolore nero,
senza scampo, l’abisso smisurato;
è l’arresto oppositivo, l’impietrimento.
Così agli estremi si congiungono
gli estremi: le forze naturali
il deserto di ceneri, di lave
e la parola che squarcia ogni velame,
valica la siepe, risuona
oltre la storia, oltre l’orizzonte.
In questo viaggio estremo d’un Empedocle
vorremmo ci accompagnasse l’Empedokles
malinconico e ribelle d’Agrigento,
ci accompagnasse Hölderlin, Leopardi.
Per la nostra inanità, impotenza,
per la dura sordità del mondo,
la sua ottusa indifferenza,
come alle nove figlie di Giove
e di Memoria, alle Muse trapassate,
chiediamo aiuto a tanti, a molti,
poiché crediamo che nonostante
noi, voi, il rito sia necessario,
necessaria più che mai la catarsi.
Tremende sono le colpe nostre
e il rimorso è un segno oscuro
o chiaro che in questa notte spessa
tutto non è perduto ancora.
In questo viaggio estremo d’un Empedocle
vorremmo ci accompagnasse Pasolini,
il suo entusiasmo, il suo oracolo, la sua invettiva.
Ci accompagnasse l’urlo di Jacopone,
la chiara nudità, il gesto largo,
che tutto l’aere abbraccia, l’armonia,
del soave mimo, del santo mattaccino.
1 Pasolini, Affabulazione
da Catarsi in Oratorio, 2002
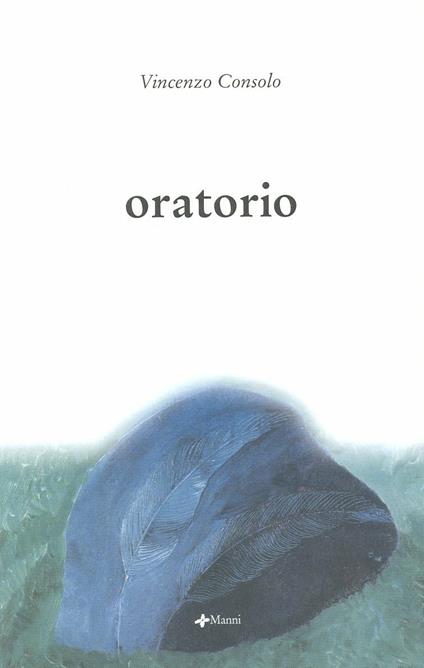
Dalla Sicilia alla luna
Come la rosa, il mare o l’intimo usignolo, la Luna – «sole delle statue», come la definisce Cocteau – è stata una fonte inesauribile di ispirazione in tutte le letterature. E se – come afferma Consolo – quel giorno dell’estate 1969, in cui l’astronave Apollo profano la Luna, è stato un giorno nefasto per la poesia, nulla ci impedisce di pensare che l’astro ha riconquistato tutti i suoi poteri dal momento in cui uno degli astronauti ha dichiarato che, vista dalla Luna, la Terra è una piccola scintillante sfera blu. Di colpo, l’immagine di Paul Eluard – la Terra è blu come un’arancia»- è sembrata profetica. Se è vero che in Ariosto la Luna è oggetto della più memorabile delle invenzioni (con il paladino che vi scopre tutto quello che gli uomini banno perduto nel corso dei secoli, e in particolare gli slanci e i sospiri degli innamorati), è pur vero che la Luna non ha ispirato soltanto i poeti. Nel secondo secolo della nostra era, Luciano di Samosata aveva descritto i Seleniti come esseri che filavano e tessevano vetro e metalli nutrendosi di -estratti d’aria; allo stesso modo Swift li ricorda nei Gulliver’ Travels: considerazione dalla quale possiamo concludere che la cosiddetta science-fiction si trovava già nella Storia vera del Greco. Ma nel diciassettesimo secolo, ispirandosi alle idee di Copernico e attingendo soprattutto al Somnium Astronomicum di Keplero (opera sulla topografia della Luna e la natura dei suoi abitanti, che l’autore finge letta in sogno), Cyrano de Bergerac scriveva /Histoire comique des Etats et Empires de la Lune. In quest’opera gli abitanti della Luna – cacciatori di allodole che, raggiunte da frecce infuocate, cadono già arrostite – credono che Cyrano sia una sorta di scimmia e come tale lo trattano. In seguito, la fantasia degli scrittori ha continuato a popolare l’amato satellite e ha perseverato nel considerarlo irraggiungibile meta di un viaggio impossibile. Non ultimo André Malraux, che nella sua prima opera – Lunes de papier (1921) – sognava lune-palla che s’involavano verso il Regno della Morte. Da parte sua, Roger Caillois osservava che Newton non ha scoperto la legge di gravita, come si crede, vedendo cadere delle mele da un albero, ma notando che, mentre la mela cadeva, la Luna non cadeva affatto. Oggi, il siciliano Vincenzo Consolo sogna la caduta della Luna in un dialogo poetico-filosofico, mascherato da libretto d’opera barocca, che si intitola appunto Lunaria. Questo testo ha una genesi curiosa: il punto di partenza è un lavoro del barone Lucio Piccolo di Calanovella, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a sua volta autore de Il Gattopardo. Il barone Piccolo, benché ricchissimo, credendo di essere improvvisamente caduto in miseria, volle porvi rimedio scrivendo un testo destinato alla scena… Nacque così L’esequie della Luna, che Pasolini – dal fiuto sempre inquieto e infallibile – pubblicò sulla rivista Nuovi Argomenti nel 1967, e che, alcuni anni dopo, un giovane regista decise di mettere in scena. Poiché il poema in prosa di Piccolo era diabolicamente ermetico, fu chiesto a Consolo di farne l’adattamento. Cammin facendo, preso dall’avventura della creazione letteraria, Consolo si allontano talmente, e talmente bene, dal testo di Lucio Piccolo, da dar vita a un nuovo testo, Lunaria appunto, che di quello originario conserva solo il germe. Cosi come, d’altronde, certe pagine di Leopardi – che per primo aveva sognato la caduta della Luna – erano state il germe delle Esequie del barone. Il lettore è trasportato nella Sicilia del diciottesimo secolo in cui un viceré – che apostrofa il sole trattandolo da tiranno e da barbaro perché oltraggia i loculi del sonno» – non crede né al suo potere né alla sua missione, convinto com’è che malinconica è la Storia» e che esiste solo il tutto, ossia l’universo, «questo incessante cataclisma armonico, quest’immensa anarchia equilibrata». Non sarà che il viceré è uno iettatore? In effetti, la notte in cui sogna la caduta della Luna, quella si stacca; se ne ritrovano pezzi, qua e là nella campagna circostante, il più piccolo dei quali è sufficiente a fare impallidire tutti i lumi del palazzo… Si pensi, tra la letteratura contemporanea, quelle opere teatrali ibride, solitarie, quali Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas o The Antiphon di Djunta Barnes: come quelle, Lunaria non sembra possa essere rappresentata in teatro, ma riserva alla lettura abbacinanti bellezze.
Un palinsesto filosofico
Paolo Mauri
Rubare i sogni non è reato e Leopardi fece una volta un sogno bellissimo, che era quasi un incubo (anche gli incubi possono essere belli). Nel sogno .[.. ] il poeta vede la luna staccarsi improvvisamente dal cielo, diventare via via più grande man mano che precipita, e rovinare di colpo in mezzo a un prato. In cielo soltanto un barlume, al posto dell’ astro caduto, anzi una nicchia. Visione tale da recare non poco tur-bamento, in cotal guisa / Ch’io n’ agghiacciava; e ancor non m’assicuro. Svanito il sogno, il turbamento rimase. Racconta Vincenzo Consolo che tentò di dargli forma teatrale, un giorno, il barone Lucio Piccolo: che era anche, come non tutti sanno, un raffinato poeta. Ma non gli riuscì. Ci ha riprovato ora Consolo stesso, che forse deve a Piccolo l’idea di trasferire il sogno in Sicilia. Lunaria, questo il titolo dell’operina di Consolo …], è infatti una messinscena siciliana, proiettata in un Settecento non ben precisato e animato da un Viceré abulico che guarda il suo tempo senza troppo apprezzarlo, mentre volentieri tende l’orecchio ai più grandi ed eterni dilemmi umani. …. Lo abbiamo detto all’inizio: rubare un sogno non è reato e meno che mai lo è in letteratura. Se ha certamente ragione Gérard Genette quando dice che ogni testo letterario è in realtà un palinsesto, nel senso che ogni storia, ogni libro, viene riscritto sulla base di un libro precedente, Consolo sembra dargli doppiamente ragione Lunaria […] è un palinsesto i cui strati sono in bella evidenza. Non tanto, o meglio non solo, per il dichiarato prestito leopardiano; in tutta la costruzione di Consolo circola un’aria iperletteraria, erudita, avverti un controllatissimo gioco di incastri. A cominciare dalla lingua: un italiano (quando non è dialetto o spagnolo), tornito, sapientissimo, musicale, un mosaico in cui s’incastonano autentiche rarità, da speleologo dei dizionari. Questa lingua, più mossa, più increspata di quella impiegata a suo tempo nel romanzo ha la funzione di rendere l’azione astratta e quindi (qui sì) dichiaratamente teatrale, simbolica. E un mondo, quello della luna che cade, che non scende a noi, ma al quale dobbiamo salire. Tocca a noi, lettori-spettatori, carpire il segreto musicale di un incubo da favola e adattarvi le nostre orecchie, disabituate al frastuono di una sintassi e di un lessico avari di concessioni al già detto. Restituendo al parlato quella patina d’antico di cui (dato il tempo in cui si svolge l’azione) ha bisogno, Consolo si rivela dunque “falsario” abilissimo.
Ma c’è di più. Resuscitando questo antico e fanciullesco sogno, Consolo vuole anche dirci che esso non troverebbe posto nello smagato mondo di oggi, che sulla luna addirittura ci è andato. Squisitamente para-leopardiana è la conclusione filosofica. La felicità, se la si vuol provare, bisogna recitarla, magari in un teatrino bizzarro e mentale come questo. Rovescio notturno del mito di Fetonte che rovinò con il carro del sole, il sogno della caduta della luna non può appartenere a una civiltà agreste. L’ultima che si è concessa un rapporto irripetibile con la notte e che a luci spente ha concepito favole, idilli e umano terrore.
(la Repubblica, 2 luglio 1985)
Quando la luna cadde alla corte del Viceré
Antonio Prete
Leggo Lunaria, l’operetta di Vincenzo Consolo che ha per “protagonista” la luna, a distanza di qualche mese da alcune mie – come chiamarle? – meditazioni esegetiche attorno alla luna leopardiana, alla sua teofania nei Canti, alla sua luce che insieme vela e rivela il paesaggio naturale, dischiudendo, nella notte un altro paesaggio, quello dell’interiorità. Che cammini velata di nubi viola, o che tremi di solitudine e di bagliore in un cielo di ghiaccio, la luna leopardiana illumina quel limitare della coscienza sul quale l’impensato dialoga con le forme del pensiero, ciò ch’è perduto cerca una nuova lingua. La luce lunare racconta in Leopardi l’essenza stessa della poesia. Così, è stato forse questo mio recente vagabondare critico (e lunatico) nei Canti, fino al Tramonto della luna, a farmi da appassionata guida nel racconto dialogato di Lunaria, in questo cuntu che .[..] ruota attorno al sogno leopardiano che narra la caduta della luna […]. Oppure è stato l’improvviso ritorno di immagini che avevano accompagnato, nell’estate del 76, proprio nelle trasparenze di alcuni meriggi siciliani, la lettura del Sorriso dell’ignoto marinaio, a introdurmi nel nuovo racconto […].
Il racconto raccoglie, così mi sembra, sovrapponendoli con delicata arguzia, frammenti di generi non più frequenti, anzi polverosi di letterario oblio: il Trauerspiel, tuttavia spogliato dei suoi emblemi funerei e delle sue allegorie di cenere incastonate nel fulgore della corona, insomma rivisitato più dalla parte della Torre hofmannsthaliana che dei suoi barocchi luttuosi modelli: l’operetta morale, riscritta con una dilatazione degli scenari e della partiture linguistiche della visualità e della coralità; la favola teatrale, aperta a ritmi popolari, a cadenza di proverbi, sospesa tra documento etnografico ed evocazione magica, tra fonti descrittive e levità di narrazione. Ma quel che unisce questi frammenti, e allontana i generi nel loro esile e circoscritto compito di stimolo, è la lingua, vero oggetto di questa narrazione. Una lingua che contamina flessuose e immaginose movenze barocche con insistenze “stralunate”, da lessico lussurioso e tuttavia straniato. Più che l’intrico dell’arabesco, c’è la sua ossessione di luce, attraverso la complicità tra ripetizione e variazione. Una lingua fatta di calchi, mimetismi libreschi, citazioni, ridondanze tornite e autoironiche. L’elencazione è insieme tecnica che ravviva e ritmo adeguato alla teatralità eccessiva e malinconica della favola. La lingua artificiale e musicale, parlata da villani e villanelle della Contrada e dal messaggero Mondo, irrompe, metafora d’una primordialità contemplativa perduta, nei linguaggi declamatori della corte. Nel finale, deposte le insegne del potere, il Viceré recita l’amplificazione gnomica che portava il pubblico del teatro barocco nel cuore del gran teatro del mondo: la sua vanitas: «Vero re è il Sole, tiranno indifferente, occhio che abbaglia, che guarda e che non vede. È finzione la vita, melanconico teatro, eterno mutamento. Unica salda la cangiante Terra, e quell’Astro immacolato là, cuore di chiara luce, serena anima, tenera face, allusione, segno, sipario dell’eterno». Che il vero testo d’avvio, non dichiarato, della favola di Consolo, e di L’esequie della luna di Piccolo, non sia il leopardiano Spavento notturno, ma il bellissimo verso de Il tramonto della luna, dove nella cesura si raccoglie l’evento e l’allegoria del vivere: «Scende la luna; e si scolora il mondo»? Con l’assenza della luna, sul paesaggio scende la notte d’un immensa vanitas, ma il silenzio che sopravviene allo scenico reclino della luna dischiude l’invisibile, come accadrà, dopo Leopardi, ai notturni di Rilke. Ma qui, chiusa la picciola favoletta» di Lunaria, eccomi tornato a quel meditare lunatico…
(Il Manifesto, 1 agosto 1985)
Non ci si allontana dalla Sicilia con Retablo, romanzo che, in Francia, esce contemporaneamente a Lunaria. Di primo acchito Retablo può essere considerato come appartenente allo stesso filone del Concierto barocco di Alejo Carpentier, ma in più possiede quelle malinconiche digressioni metafisiche che non hanno mai tentato il grande romanziere cubano. L’argomento trattato è il viaggio intrapreso da Fabrizio Clerici, pittore di anticaglie», nelle estreme terre della penisola: va in cerca di rovine e di vestigia del passato, sulle orme di quel monaco Fazello che «basandosi sulla parola antica di Diodoro» scopri «circondata dalla macchia e dalla palude, la defunta Selinunte». Gli fa da guida un fraticello. Briganti che sono monaci che hanno gettato la tonaca alle ortiche, pastori e cantastorie che salvaguardano la memoria dell’isola, contadini occupati a ripulire i campi da quelle antichità contro le quali urta il vomere dell’aratro: ecco i personaggi che popolano questo racconto il cui tempo è, senza sosta, “allegro con brio”. Le parole sono come perni sui quali la frase ondula, scende, risale, si attarda chiamandone altre che accorrono, si alternano, si snodano, vibrano, scintillanti di metafore. Il lettore è riportato in un passato trasfigurato, a quella prima meraviglia incredula e reciproca che dovettero provare, messe a confronto, la Lombardia illuminista (impersonata dal cavalier Clerici) e quella Sicilia dalla quale i Greci e gli Arabi non sono mai partiti. Retablo ha il tono brioso di un divertissement in cui anche l’erudizione si presta al gioco. Ma, come in Lunaria, dietro il sorriso si cela lo stesso pianto; sì: «malinconica è la Storia». E la mirabile statua che scivola dalla barca del cavaliere, forse – tutta incrostata di madrepore – un giorno sarà ritrovata. Agli occhi della divinità, al di là del tempo, non ci sarà alcuna differenza tra la Nike di Samotracia e la conchiglia prodotta da una bestiola mucosa che porta in sé una riserva di sale e di madreperla, destinata ad essere versata in uno stampo di geometrica perfezione. Va notato, per concludere, che Fabrizio Clerici è il nome di un grande pittore italiano contemporaneo, i cui soggetti prediletti sono città immaginarie, labirinti sventrati, insomma: ogni pietra scolpita ed erosa. Rendiamo omaggio, infine, all’arduo lavoro dei traduttori. […]
(Hector Bianciotti, Le Monde, 22 aprile 1988; traduzione di Marina Di Leo)
da Nuove Effemeridi, rassegna trimestrale di cultura. pagine -107 – 108 – 109