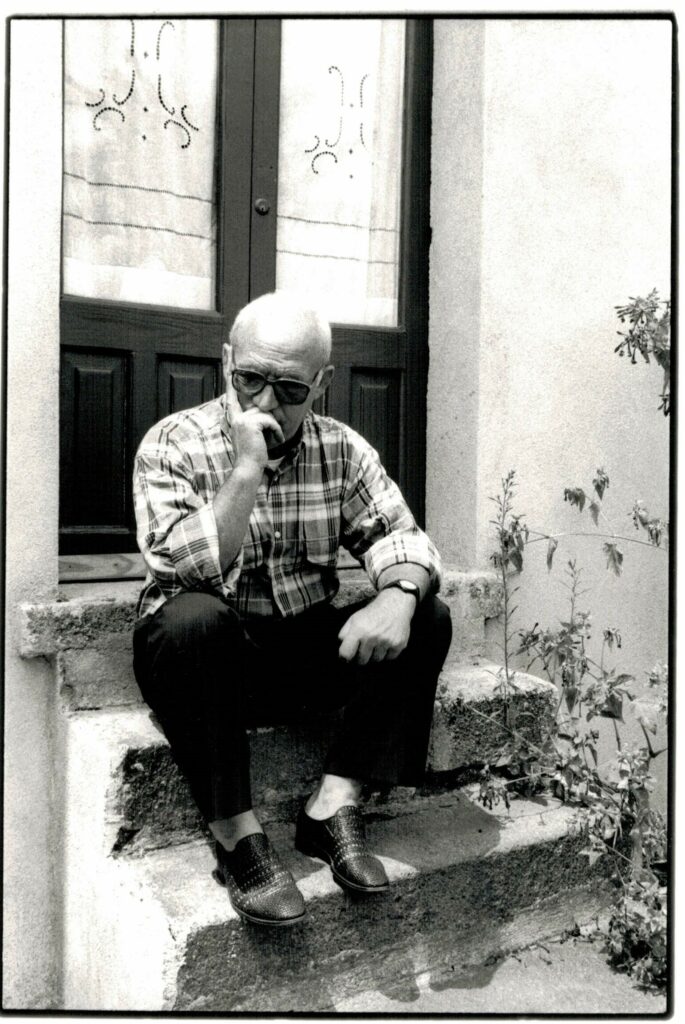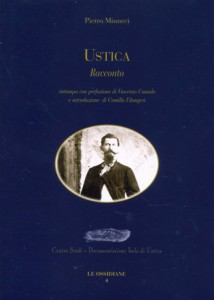Daragh O’Connell
University College Cork, Ireland
Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Éire
Il contributo tenta di delineare la poetica di Vincenzo Consolo attraverso i suoi interventi giornalistici e saggistici e attraverso momenti «testuali» della sua trilogia narrativa: Il sorriso dell’ignoto marinaio; Nottetempo, casa per casa; Lo Spasimo di Palermo. Introduzione Non c’è pagina in Consolo in cui egli non decida di entrare nel merito del maneggio delle parole e non si confermi ricercatore verbale e poeta di primaria destrezza. Per cominciare, è d’obbligo dire qualcosa sul titolo scelto per queste pagine, un titolo abbastanza ambiguo e forse troppo ambizioso: «Consolo narratore e scrittore», oppure avrei forse dovuto proporre «Consolo narratore o scrittore»? I due termini hanno, infatti, una funzione alquanto importante per il modo in cui il nostro autore cerca di delineare la sua poetica. In un racconto-chiave pubblicato per la prima volta nel 1981 e intitolato Un giorno come gli altri, Consolo fa una netta distinzione fra il narrare e lo scrivere. Vi si legge: * Un ringraziamento particolare a Caterina Pilenga Consolo per l’aiuto prestatomi e i materiali fornitimi, non certo di facile reperibilità. È che il narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, a quella lenta edimentazione su cui germina la memoria, è sempre un’operazione vecchia, arretrata, regressiva. Diverso è lo scrivere […] mera operazione di scrittura, impoetica, estranea alla memoria, che è madre della poesia, come si dice. E allora è questo il dilemma, se bisogna scrivere o narrare. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perché il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta. […] Però il narratore dalla testa stravolta e procedente a ritroso, da quel mago che è, può fare dei salti mortali, volare e cadere più avanti dello scrittore, anticiparlo… Questo salto mortale si chiama metafora.1 Qui Consolo trae spunto dalle idee di Walter Benjamin raccolte in Angelus Novus e, in particolare, dal saggio su Nicolaj Semënovicˇ Leskov.2 L’immagine del narratore «dalla testa stravolta» ci rimanda non soltanto alla famosa icona di Paul Klee, cara a Benjamin, ma anche al Tiresia dantesco condannato a camminare con la testa rivolta indietro proprio perché ha guardato troppo in avanti.3 Consolo si identifica nel ruolo di narratore, quindi di artefice non più di romanzi ma di narrazioni; laddove narrazione è da intendere nel senso più arcaico del termine, quello dei poemi narrativi, per cui dai suoi libri vengono bandite tutte quelle forme di intreccio, di plot, tutte quelle forme intrattenitorie vive nel romanzo, e si ha invece la restituzione di un’esperienza. Molto spesso quest’esperienza è un’esperienza di viaggio, il viaggio nella memoria, o il viaggio reale nello spazio o nel tempo.4 Tuttavia, sebbene Consolo si autodefinisca narratore prima che scrittore, è pure necessario entrare nel suo scriptorium, cioè mettere prima a fuoco il Consolo scrittore, se vogliamo intendere le procedure sottese alla gestazione dei suoi testi, al loro divenire «narrazioni». Adesso, è il caso di chiarire il terzo elemento del titolo: palincestuoso. Con la divulgazione dei lavori di Michail Bachtin sulla lurivocità e la polifonia abbiamo tutti appreso che nel genere romanzesco s’intrecciano molte voci e molti linguaggi. Ci sono anzitutto, nella parte non dialogica, i vari linguaggi sociali, espressione di ideologie, classi, mestieri, ambienti: l’uso dei termini che vi afferiscono costituisce una concentrata allusione alla vicinanza e alle eventuali tensioni fra i vari strati. Cesare Segre nel suo famoso saggio sul Sorriso afferma che il plurilinguismo di Consolo è anche nettamente plurivocità e che l’autore siciliano va avvicinato all’altro grande del Novecento, Carlo Emilio Gadda.5 Ma nel caso di Consolo la definizione ha un ulteriore senso, se si considera che tra le «voci» della sua grande polifonia una, spesso dimenticata nel suo funzionamento, è proprio la voce «letteraria»: i rimandi alla tradizione che precede le sue opere. È questa la voce che mi interessa di piú nella complessiva polifonia di Consolo, perché porta alla sua poetica della ri-scrittura o, meglio, della soprascrittura, cioè al carattere palinsestico della sua scrittura. Nel saggio Lo spazio in letteratura scrive Consolo: «Omeros in Greco antico significa ostaggio: il poeta vale a dire è ostaggio della tradizione, della memoria, e della memoria letteraria soprattutto», ed è proprio su questa «memoria letteraria» che vorrei soffermarmi in questo articolo.6 Questa duplicità d’oggetto può venir rappresentata, nel campo delle relazioni testuali, dall’antica immagine del palinsesto. Un palinsesto —si sa— è una pergamena che contiene due testi sovrapposti, e in cui l’originale non è del tutto cancellato ma rimane visibile in trasparenza.7 La loro relazione, volendo ricorrere a Gérard Genette, è ipertestuale: ipertesti derivati da ipotesti. Per Genette, nel campo della transtestualità, l’ipertesto è un testo B messo in relazione con un testo anteriore, testo A, da lui chiamato ipotesto. Perciò, ipertestuale è ogni relazione che unisca l’ipertesto all’ipotesto, ma nella quale il primo s’innesti sul secondo in una 5. Cesare Segre, «La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo», in ID., Intrecci di voci: La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino: Einaudi, 1991, p. 71-86. 6. Vincenzo CONSOLO, «Lo spazio in letteratura», in ID., Di qua dal faro, Milano: Mondadori, 1999, p. 266. 7. Esiste un lunga tradizione sulla nozione di palinsesto (παλµψηστ ς) nel campo della letteratura e del pensiero occidentale. Il termine veniva usato da Plutarco nei Moralia (504D, 779C) per denotare metaforicamente il manifestarsi di un aspetto del carattere. Nelle speculazioni storiche dell’Ottocento il termine aveva un ruolo trascrittivo. Nel saggio «On History» [1830] Thomas Carlyle postula un’investigazione del passato, che sia capace d’illuminare sia il presente sia il futuro, e continua: «For though the whole meaning lies beyond our ken; yet in that complex Manuscript, covered over with formless inextricably-entangled unknown characters, —nay which is a Palimpsest, and had once prophetic writing, still dimly legible there, —some letters, some words, may be deciphered» (Thomas CARLYLE, Works, V, London: Chapman and Hall, 1906, p. 500). Da Thomas De Quincey il termine viene abbinato al cervello umano. Nel suo Suspira de Profundis [1845] scrive: «What else than a natural and mighty palimpsest is the human brain?… Everlasting layers of ideas, images, feelings, have fallen upon your brain softly as light. Each succession has seemed to bury all that went before. And yet, in reality, not one has been extinguished». De Quincey nota anche che nella vecchiaia in modo particolare gli «endless strata» della mente umana sono presenti, ma non come una successione «but as parts of coexistence». Cfr. T. DE QUINCEY, «The Palimpsest of the Human Brain», The Collected Writings of Thomas De Quincey, ed. David MASSON, Edinburgh: Adam & Charles Black, 1890, p. 346 e 348. Non dimentichiamo poi l’uso del termine adoperato da Niccolò Tommaseo per stigmatizzare lo Zibaldone di Giacomo Leopardi, come peraltro ci ricorda Consolo: «Leopardi stesso, pur adottando il codice toscano, ha una «infinita» espressività interna, rimanda ai classici; c’è, nelle sue liriche, una continua citazione dei classici italiani, latini, greci, al punto che Tommaseo dice, e lo dice in senso critico, che la scrittura di Leopardi è un palinsesto mal cancellato» (Vincenzo CONSOLO, «Per una metrica della memoria», Cuadernos de Filologia Italiana, 3, 1996, p. 252). maniera che non sia quella del commento.8 Questa è la base della scrittura palinsestica. Pastiche e parodia, è stato giustamente affermato, «designano la letteratura come palinsesto»; e ciò vale per qualunque ipertesto ed è quanto Borges già diceva del rapporto fra il testo e i suoi avantesti.9 Quindi, l’ipertesto ci invita a una lettura relazionale. Ed è pure interessante che in uno dei suoi ultimi interventi in Spagna Consolo così sintetizzava: La vera scrittura è una scrittura palinsestica, una scrittura che scrive su altre scritture. Dicevo sopra che la vera scrittura è per me quella palinsestica, la scrittura vale a dire che scrive su altre scritture, la scrittura che poggia sulla memoria letteraria soprattutto.10 Consolo è certamente uno scrittore palinsestico, ma per ragioni che spero queste pagine chiariranno, possiamo anche andare oltre ed applicare un termine molto felice, e forse un po’ perverso, coniato da Philippe Lejeune nel suo Moi aussi: in un deliberato gioco di parole e di grafie, si potrebbe dire che, anzichè palinsestico, Consolo è invece uno scrittore palincestuoso, «palimpsestueuse», giacché il suo rapporto con i testi anteriori ci sembra molto più intenso e più stretto rispetto ad altri scrittori, ed è un rapporto quasi famigliare.11 Consolo ci pone costantemente di fronte a una poetica intensamente iperletteraria, un ricco mosaico di intertestualità, le cui tessere sono fatte di testi sia antichi sia moderni. Tale interesse per nozioni puramente letterarie, quali la tradizione e la ricerca di materializzazione di espressioni letterarie, può far pensare a un atteggiamento reazionario o fuori dal tempo da parte dell’autore e rischia di distoglierci dalla questione centrale: l’intera produzione narrativa di Consolo tende alla realizzazione della sintesi tra poetica ed etica e, nonostante le sue difficoltà, offre al lettore esempi letterari unici ben lontani dalle mode e dalle correnti culturali a lui contemporanee. Le procedure poetiche di Consolo, presenti all’interno di tutta la sua produzione narrativa, lo costringono a un innesto di intertesti, l’autore inoltre seleziona e pone gomito a gomito linguaggi e dialetti diversi e spesso stridenti tra di loro, oscilla tra registro alto e basso e fonde forme metriche all’interno della sua prosa narrativa. 8. Cfr. Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, trad. Raffaella Novità, Torino: Einaudi, 1997, p. 7-8. 9. Ruth Amossy e Elisheva Rosen, «La dame aux catleyas: fonction du pastiche et de la parodie dans A la Recherche du Temps Perdu», in Littérature, 14: maggio 1974, p. 55-64. Nel racconto «Pierre Menard, autor del Quijote» (El jardín de los senderos que se bifurcan, 1941) Borges scrive: «He reflexionado que es lícito ver en el Quijote «final» una especie de palimpsesto, en el que deben traslucirse los rastros —tenues pero no indescifrables— de la «previa» escritura de nuestro amigo [si tratta del Menard del titolo]». Cfr. Jorge L. Borges, Ficciones, in ID., Obras Completas I. 1923-1949, Buenos Aires: Emecé, 1996, p. 450. 10. Vincenzo Consolo, «Ma la luna, la luna…», in Irene Romera Pintor (ed.), «Lunaria» vent’anni dopo, València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2006, p. 71-72. 11. Philippe Lejeune, Moi aussi, Paris: Editions du Seuil, 1986, p. 115. Il termine originale è quello tra virgolette. Cfr. inoltre Gérard Genette, Palinsesti, cit., p. 469. Consolo narratore e scrittore Palincestuoso Quaderns d’Italià 13, 2008 165 2. Il sorriso dell’ignoto marinaio. Tra letterarietà ed erudizione Per ovvie ragioni di spazio non mi dilungherò su Il sorriso dell’ignoto marinaio, ma vorrei sottoporre all’attenzione critica almeno due esempi di intertestualità che nel libro mi sembrano rilevanti, non solo per quel che richiamano a livello testuale, ma anche perché costituiscono, diciamo, i due poli estremi dell’approccio intertestuale di Consolo. Gli esempi sono ambedue desumibili dal capitolo I del capolavoro consoliano. Il primo si può leggere nel paragrafo 3 del capitolo e costituisce una sorta di rottura narrativa, un movimento all’interno di un reame storico/immaginario. L’aver nominato, nel paragrafo precedente, la città di Brolo genera questa rottura o movimento: in effetti, fu proprio al castello di Brolo che, secondo la leggenda, Bianca Lancia fu l’amante dell’Imperatore Federico II di Svevia. Scrive Consolo: Al castello de’ Lancia, sul verone, Madonna Bianca sta nauseata. Sospira e sputa, guata l’orizzonte. Il vento di Soave la contorce.12 L’evidente rimando è a Dante, in cui il riferimento a Federico II è cosí contestualizzato: «Quest’è la luce de la gran Costanza/ che del secondo vento di Soave/ generò‘l terzo e l’ultima possanza» (Paradiso, III 118-120). Inoltre, l’uso della forma verbale «guata» rinvia direttamente alla prima similitudine della Commedia: «E come quei che con lena affannata,/ uscito fuor del pelago a la riva,/ si volge a l’acqua perigliosa e guata,/ così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,/ si volse a retro a rimirar lo passo/ che non lasciò già mai persona viva» (Inferno, I 22-27).13 Ma il «vento di Soave» consoliano è una forma doppia di intertestualità, perché allude anche a Lucio Piccolo e al suo modo di figurarsi poeticamente la costa tirrenica siciliana. Ne Le pietre di Pantalica, infatti, Consolo racconta la storia di Piccolo e riferisce il suo modo di parlare di questa zona: O Federico di Svevia, che al castello de’ Lancia, in Brolo, ama Bianca e genera Manfredi («biondo era e bello e di gentile aspetto»). E Piccolo chiedeva: «Non nota lei, non nota che da queste parti aleggia ancora il vento di Soave?».14 Questa forma di intertestualità suggerisce una sorta di tecnica di trapianto, per mezzo della quale elementi del testo precedente vengono innestati sul 12. Vincenzo CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio [1976], Milano: Mondadori, 1997, p. 12. Tutte le successive citazioni da quest’opera rimandano a questa edizione e saranno seguite dall’abbreviazione Sim. 13. Per una lettura del Sorriso in chiave dantesca cfr. Daragh O’Connell, «Consolo’s “trista conca”: Dantean anagnorisis and echo in Il sorriso dell’ignoto marinaio», in Echi danteschi / Dantean Echoes, ed. R. Bertoni, Torino: Trauben, 2003, p. 85-105. Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori, 1988, p. 145. Il corsivo è dell’originale. Insomma, Consolo e Piccolo «si incontrano sul sintagma dantesco», come glossa Nicolò MESSINA, «Lunaria dietro le quinte», in I. Romera Pintor (ed.), «Lunaria» vent’anni dopo, cit., p. 188.166 nuovo, nel quale sono presenti sotto veste sia di aperta citazione, sia di dissimulata figurazione. In questo stadio iniziale del capitolo è chiaro che Consolo sta facendo uso di una struttura narrativa altamente stilizzata e complessa. Da un lato, ci sono testi all’interno dei testi, prestiti allusivi o citazioni dirette; dall’altro, viene utilizzata una tecnica del rinvio che non usa procedure narrative formali o stratagemmi d’intreccio, bensì opta per un sovraccarico semantico ed uno stile di prosa poeticizzata che gode del nominare le cose stesse. Il secondo esempio è riscontrabile nel paragrafo 19 dello stesso capitolo I ed spicca specialmente proprio per quel che rivela delle procedure narrative impiegate da Consolo nei suoi testi multiformi. Il paragrafo, presentato per la sua maggior parte in corsivo, suggerisce una citazione o, almeno, una situazione narrante alternativa, una voce o un punto di vista diversi. Nel romanzo, l’unico altro luogo in cui una vasta porzione di testo è riportata in corsivo è nel capitolo V, «Il Vespero», in cui il testo incastonato non in tondo è mutuato direttamente da I promessi Sposi di Alessandro Manzoni: è la descrizione del momento della conversione dell’Innominato piegata da Consolo a tratteggiare il «tempo» e le sensazioni del personaggio Peppe Sirna.15 Nessuna indicazione, né note a pie’ di pagina né richiami all’autore, soccorre il lettore, il quale non può far altro che accettare la stranezza del passo ed andare avanti con la narrazione. Il brano è interrotto dall’improvviso cambiamento di registro impresso da Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, che dice: «Uh, ah, cazzo, le bellezze!» (Sim, p. 20), poichè la sua immaginazione prende il sopravvento sul resto del paragrafo. Ciò che precedeva in corsivo, però, non è un parto dei rimuginii del protagonista del Sorriso, ma un qualcosa di abbastanza strano ed estraneo, è il frutto del pensare altrui, benchè sia la mente del barone Mandralisca a rievocarlo. Si dà un indizio nella frase finale del paragrafo: Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il Cardinale, il Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina (Sim, p. 20). Questo «forse il Landolina» è l’unica allusione, nel testo, ad una possibile fonte, anche se il lettore medio non ha modo né è in grado di saperlo. La parte in corsivo del brano, cioè i tre quinti del paragrafo, è, in effetti, una citazione diretta da una fonte che non sarebbe stata familiare per il Mandralisca, sebbene Consolo la abbia consultata come campione di stile di prosa degli intellettuali siciliani del tardo Settecento e del primo Ottocento del secolo scorso. La fonte è proprio il Cavalier Saverio Landolina (1753-1814), figura dominante dell’archeologia siciliana all’inizio del XIX secolo. La sua fama e la sua posizione di rilievo si dovevano alla scoperta della famosa Venere Anadiomene, che egli 15. Cfr. Alessandro Manzoni, I promessi sposi (1840), ed. Salvatore Silvano Nigro, Milano: Mondadori, 2002, p. 409; e Vincenzo CONSOLO, Sim, p. 106. Tranne il corsivo non c’è nel testo nessuna indicazione che si tratti di una citazione manzoniana. Consolo narratore e scrittore Palincestuoso Quaderns d’Italià 13, 2008 167 fece nel 1803.16 Il testo in questione è da ricercare in una lettera datata 29 gennaio 1807 e indirizzata all’allora «Sopraintendente generale alle antichità», un certo Soratti: Passando a visitare li monumenti del Tindaro ebbi il dispiacere di non ritrovare il più bel pezzo, che l’altra volta vi avevo ammirato. Erano due piedi con le gambe fino alle cosce di un giovane ignudo di elegantissimo greco lavoro, con un’ara dal lato sinistro ben ornata, di marmo alabastro bianco. Osservai ancora due grossi pezzi di marmo statuario, che insieme formavano il busto di un uomo di statura gigantesca; in uno dei detti pezzi si vede la corazza ornata di bassi rilievi, tra i quali si distinguano una bulla pendente sul petto con una testa molto crinita come si osserva in molte nostre medaglie. Dalla spalla destra era pendente sopra la mammella una fettuccia lavorata. Su la spalla sinistra era elegantemente rilevato il gruppo del pallio che doveva coprire le spalle. Sopra il ventre erano due ippogrifi. L’altro pezzo di marmo era il rimanente della corazza, cioè le fibule e le bulle pendenti sopra il sago che copriva le cosce le quali si vedono tagliate. Le bulle erano tutte figurate con varie teste di animali e qualcuna umana. L’esistenza di questi pezzi nel Tìndaro mi fa sospettare che potevano appartenere ad una statua dei Dioscuri, descritti sempre dai poeti in abito militare.17 Nel Sorriso leggiamo invece: Gli altri marmi dietro le statue erano due piedi con le gambe sino alle cosce di un giovane ignudo di elegantissimo greco lavoro, con un’ara dal lato sinistro ben ornata, di marmo alabastro bianco. Ancora due grossi pezzi di marmo statuario, che insieme formavano il busto di un uomo di statura gigantesca; in uno dei detti pezzi si vedeva la corazza ornata di bassi rilievi, tra i quali si distingueva una bulla pendente sul petto con una testa molto crinita che si osserva in molte medaglie. Dalla spalla destra era pendente sopra la mammella una fettuccia lavorata. Su la spalla sinistra era elegantemente rilevato il gruppo del pallio che doveva coprire le spalle. Sopra il ventre erano due ippogrifi. L’altro pezzo di marmo era il rimanente della corazza, cioè le fibule e le bulle pendenti sopra il sago che copriva le cosce le quali si vedevano tagliate. Le bulle erano figurate con varie teste di animali e qualcuna umana. L’esistenza di questi pezzi nel Tìndaro faceva sospettare che potevano appartenere ad una statua dei Dioscuri, descritti dai poeti in abito militare. Uh, ah, cazzo, le bellezze! […] Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale, il Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina .18 Il brano di Landolina è citato pressoché alla lettera e le sole inter/estrapolazioni eseguite da Consolo vanno individuate nei tempi verbali ed in quei 16. Dizionario dei Siciliani illustri, ristampa anastatica, Palermo: F. Ciuni Libraio Editore, 1939. 17. Giuseppe Agnello (ed.), Le antichità di Tindari nel carteggio inedito di Saverio e Mario Landolina, in Estratto dall’Archivio Storico Siciliano Serie III – Vol. XX, Palermo: Presso la Società Siciliana per la Storia Patria, 1972, p. 218-219. 18. Sim, p. 19-20. Il grassetto in entrambi i brani indica le varianti. segmenti del brano che si riferiscono al Landolina stesso. Questo tipo di intertestualità è abbastanza sconcertante per il lettore e, una volta rivelato, mostra il modo in cui si forgia lo stile di Consolo: testi dentro i testi, siano essi citazioni poetiche di scrittori canonici o citazioni dirette da oscuri testi archeologici del XIX secolo. La citazione letteraria diretta può essere considerata ammissibile, se accettiamo che il punto di vista narrativo sia qui quello del Mandralisca, com’è peraltro accertabile nel resto di questo capitolo iniziale, ma la citazione diretta da lettere di argomento archeologico è più problematica. Al riguardo i commenti di Bachtin sull’enciclopedismo nel genere del romanzo sono rilevanti, specialmente in quelli da lui definiti «romanzi della seconda linea». Questo tipo di romanzo dimostra la tendenza all’enciclopedicità dei generi, ed anche l’uso dei generi inseriti. Il fine principale è introdurre nel romanzo la pluridiscorsività, la varietà delle lingue di un’epoca. Scrive Bachtin che i «generi extraletterari sono introdotti non per «nobilitarli» e «letteraturizzarli» ma proprio perché sono extraletterari, perché era possibile introdurre nel romanzo una lingua extraletteraria (persino un dialetto). La molteplicità delle lingue dell’epoca deve essere rappresentata nel romanzo».19 Ed è proprio ciò che avviene nel secondo passo del Sorriso preso in esame. Nottetempo, casa per casa. Genesi e avantesti Spostiamo ora l’attenzione dal Sorriso a Nottetempo, casa per casa. Pubblicato nel 1992, questo romanzo è la seconda parte della trilogia consoliana: il libro ha sfondo storico ed è ambientato nei primi anni Venti, ossia il periodo dell’insorgere del fascismo, tra Cefalù e Palermo; il tutto è visto attraverso le vicende di una famiglia, i Marano. In realtà, Nottetempo parla dell’Italia degli anni Novanta, della caduta di tutte le tensioni sociali, dell’avvento della destra, della prima volta che in Italia i fascisti sono arrivati al governo dopo la loro condanna storica. Inoltre, Consolo collegava il mondo culturale di quegli anni Venti con il mondo culturale dei tempi recenti, e presenti: l’insorgere di nuove metafisiche, di misticismi, delle forme aberranti dei satanismi e delle sette misteriche. Messe da parte queste considerazioni generali, vorrei adesso incentrarmi sulla genesi testuale di Nottetempo e fare qualche riflessione sulla critica-genetica e su come questo tipo d’approccio può essere utile per meglio intendere il tormentato divenire del testo. L’opera letteraria non è un dato, ma un processo, non un’entità stabile, fissata una volta e per tutte, ma invece una variabile, o meglio un complesso dinamico di variabili in perpetuo divenire.20 19. Michail BACHTIN, «La parola nel romanzo», in ID., Estetica e romanzo, trad. Clara STRADA JANOVICˇ, Torino: Einaudi, 2001, p. 218. Esiste una vasta bibliografia sulla critica-genetica i cui i testi canonici sono: Louis HAY (ed.), Essais de critique génétique, Paris: Flammarion, 1979; Amos SEGALA (ed.), Littérature Latino-américaine et des Caraïbes du XXe siècle. Théorie et pratique de l’édition critique, Roma: Bulzoni, 1988; Almuth GRÉSILLON, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, Paris: p. U.F., 1994; Giuseppe TAVANI, «Filologia e genetica», Cuadernos de Filología Italiana, 3, 1996, p. 63-90; Michel CONTAT e Daniel FERRER (ed.), Pourquoi la critique L’opera letteraria è, per dirla con il Contini della critica delle varianti, «un lavoro perennemente mobile e non finibile».21 Qui vorrei basarmi su quattro avantesti che vanno situati in quella zona grigia dell’ecdotica che è a metà fra l’emerso (edizioni a stampa) e il sommerso (manoscritti, dattiloscritti, abbozzi, appunti, ecc.).22 Questi quattro avantesti mi sembrano molto interessanti e dovrebbero rivelare qualcosa della gestazione di Nottetempo. Sedici anni separano Nottetempo dal Sorriso, ma la genesi di Nottetempo può essere collocata negli anni Settanta, ovvero proprio in quel periodo in cui Consolo andava scrivendo Il sorriso dell’ignoto marinaio. Il primo presagio del romanzo che sarebbe venuto può rintracciarsi in un testo che Consolo scrisse per il catalogo della mostra di Luciano Gussoni alla Villa Reale di Monza nel 1971. Il testo non è lungo, la prosa è fortemente poeticizzata, e sembra a prima vista una specie di abbozzo. Tuttavia, due elementi del testo sono decisivi per intendere i metodi di Consolo. Il primo è che successivamente esso viene ritoccato e in qualche modo rimodellato e infine incorporato nel Sorriso proprio in quella sequenza da incubo quasi alla fine del capitolo VII, «La memoria».23 Il secondo elemento è il titolo dato al testo del catalogo: Nottetempo, casa per casa. In qualche modo si può quindi affermare che Nottetempo, nel suo stato embrionale, faceva inizialmente parte del Sorriso. Sempre nel 1971, Consolo scrisse un articolo per Tempo Illustrato intitolato «C’era Mussolini e il diavolo si fermò a Cefalù».24 L’articolo tratta del soggiorno in Sicilia del mago-satanista inglese Aleister Crowley con i suoi seguaci negli anni Venti. Di solito la critica spiega Nottetempo, casa per casa nei termini di un libro che traeva spunto dal racconto «Apocrifi sul caso Crowley» pubblicato nel 1973 da Leonardo Sciascia nella raccolta Il mare colore del vino. 25 Ma la data del 1971 dimostra chiaramente che è stato Consolo con questo articolo a suggerire a Sciascia l’idea di Crowley. Nel romanzo consoliano Crowley funge da phármakon, una figura inquietante ed emblematica della decadenza perversa. Inoltre, l’articolo prova che Consolo aveva già iniziato la sue ricerche storiche sulle vicende cefaludesi degli anni Venti.26 génétique? Méthodes, théories, Paris: CNRS Éditions, 1998. Inoltre, nel campo della critica-genetica applicata specificamente a Consolo, cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo: «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Madrid: Universidad Complutense, 2006. 21. Gianfranco Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino: Einaudi, 1970, p. 5. 22. La distinzione «emerso» e «sommerso» è stata adoperata da Messina nel suo saggio «Per una storia di Il sorriso dell’ignoto marinaio», 23. Vincenzo CONSOLO, «Nottetempo, casa per casa», in Luciano Gussoni, Villa Reale di Monza, 10-30 novembre 1971; ID., Sim, p. 136-138. 24. Vincenzo CONSOLO, «C’era Mussolini e il diavolo si fermò a Cefalù», Tempo illustrato, 2 ottobre 1971. 25. Leonardo SCIASCIA, Il mare colore del vino, Torino: Einaudi, 1973. Cfr., inoltre Giuseppe QUATRIGLIO, «Il diavolo a Cefalù», in ID., L’uomo-orologio e altre storie, Palermo: Sellerio, 1995. 26. Appunti autografi, con dati raccolti dalla viva voce di cefaludesi che avevano conosciuto Crowley e la sua setta, addirittura una piantina della dimora da essi occupata a Cefalú e Il terzo avantesto è ancora una volta un articolo giornalistico. Intitolato «Paesaggio metafisico di una folla pietrificata», è apparso nel Corriere della Sera nell’ottobre del 1977.27 Di spiccato interesse è il fatto che l’incipit del articolo anticipa, o almeno cosí sembra, la forma imbrionale dell’incipit di Nottetempo, casa per casa. Entrambi descrivono una notte di luna piena e l’ululare dolente della figura simbolica e metaforica del lupo mannaro, ossia il licantropo. L’intertesto è la novella pirandelliana Male di luna. 28 In Consolo, tuttavia, a questa malattia viene dato il suo nome siciliano: male catubbo, derivato dall’arabo catrab o cutubu, che significano canino o lupino.29 Il quarto e più importante avantesto è la presentazione redatta da Consolo per il catalogo della mostra di Ruggero Savinio (Ex Convento di San Francesco, Sciacca 8 luglio-15 agosto 1989) e intitolata L’ora sospesa. Lo stesso testo viene fatto poi confluire in Nottetempo, casa per casa con alcune varianti.30 Riporto qui il testo di L’ora sospesa: Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati (dimenticammo l’ora, il punto del passaggio, la consistenza, la figura d’ogni altro; dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete: al confine bevemmo il nostro lete). Ora, in questa luce nuova —privazione d’essa o luce stessa rovesciata, frantumo d’una lastra, rovinìo di superficie, sfondo infinito, abissitade , in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. O ignote forme, presenze vaghe, febbrili assenze, noi neliamo verso dimore perse, la fonte ove si bagna il passero, la quaglia, l’antica età sepolta, immemorabile. […] E in questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichìo di quell’oro, è possibile ancora la scansione, l’ordine, il racconto? È possibile dire dei segni, dei colori, dei bui e dei lucori, dei grumi e degli strati, delle apparenze deboli, delle forme che oscillano all’ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono? E tuttavia per frasi monche, parole inadeguate, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione. Viene e sovrasta un nunzio lampante, una lama bianca, un angelo abbagliante. Da quale empireo scende, da quali paradisi? O risale prepotente da quali abissi? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai miracoli; si dichiara vessillo, simbolo e preambolo d’ogni altro spettro. l’esergo del Cap. I di Nottetempo, si ritrovano nel quaderno Ms 2 che tramanda excerpta del Cap. I del Sorriso insieme ad altri materiali «allotri» risalenti agli anni 1968, 1969, 1970. Cfr. Nicolò Messina, Per un’edizione critico-genetica, cit., p. 60-65. 27. Vincenzo Consolo, «Paesaggio metafisico di una folla pietrificata», Corriere della Sera, 19 ottobre 1977. 28. Pubblicato la prima volta con il titolo Quintadecima in Corriere della Sera, 22 settembre 1913, poi con il nuovo titolo nel 1925. Luigi Pirandello, «Male di luna», Novelle per un anno, ed. Mario Costanzo, vol. II, tomo I, Milano: Mondadori, 1987, p. 486-495. 29. Cfr. Giuseppe Pitré, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, rist., vol. IV, Catania: Clio, 1993, p. 237-243. 30. «L’ora sospesa» corrisponde a Vincenzo CONSOLO, Nottetempo, casa per casa, Milano: Mondadori, 1992, p. 64-67. «E un mattino d’aprile lasciammo la dimora alta e luminosa, lasciammo i templi, le piazze, le arnie e le vigne, abbandonammo la patria nostra, la superba città che s’alza sopra il fiume…» così racconta l’allievo del filosofo, del mago, dell’uomo venerato, così racconta il giovane «… Spogli ed esposti, solitari, per boschi e per deserti, giunsimo, dopo giorni e giorni, all’oriente estremo, all’altro mare di quest’isola vasta, alla montagna immensa, alla scaturigine del fuoco, del fragore, della minaccia. E più che andavamo su per l’aspro suolo, per le impietrate lave, risonanti, oltre ogni verde, ogni ginestra lenta, su per le nere lande, le gelide tormente, più egli s’ammutiva, si staccava da me, da tutto il mondo. O profferiva entusiasta, come preso dal Dio e dalle Furie, frammenti dei poemi. —… Ánthropoi therés te kai ichthúes…— diceva —… Tutto alterna così, e così dura eternamente… Per la virtù d’amore si unisce, ed ora per la frattura dell’odio si separa…—». E infine lacrimando disse del nero delle sabbie, dei lapilli in cui lo scorse infine, disse dell’indicibile terrore, dei boati e dell’incandescenza, dell’immenso rosso che l’avvolse, bruciò e che dissolse. Ma da sfondi calmi, da quiete lontananze, dagli ocra, dai rosa, dai bruni, da strati sopra strati, chiazze, da perenti scialbature, da squarci in cui traspare l’azzurro tenero o il viola d’antico parasceve, Johannes s’affaccia, in bianca tunica, virginea come la sua fronte e come il Libro poggiato sui ginocchi: rimemora e trascrive, con parole chiare e d’oro, una storia, la Storia unica, terribile e sublime. «—Tutto è compiuto!— disse». […] E oltre sono i foschi cieli e le chiome degli alberi impietrati, gli scuri ingressi degli antri, delle vuote dimore dei vespertili, delle civette. Oltre sono le Rovine. Che non consumi tu Tempo vorace. Che non consumi tu. Che non consu… […] Tentiamo intanto esili passaggi sopra gli abissi, i vuoti, il nulla che s’è aperto ai nostri piedi. Tentiamo nella sera —ora calmi, arresi, stesi nel grembo tenero di Cuma, del Palatino— d’accendere il dialogo, la conversazione, sacra per il calore, raro, per i semi di luce, il polline, le lucciole che sparge sopra arbusti, foglie, il cielo che s’imbruna sopra noi. «Oh se per tutti un legame / un eros vago lontano…». Oh in questo silenzio assorto, in questo fresco di sera abbrividente vorrei sentire i vostri toni, accenti. «Che non consumi tu…». […] E tu, e noi chi siamo? Figure emergenti o svanenti, agonici spettri, palpiti, aneliti, graffi indecifrati. Sussurro, parola fioca nel mare del silenzio.31 Tutto questo brano può essere letto in versi. Prevalgono endecasillabi e settenari. Ma non mancano versi brevi o medi (quinari, senari) o più lunghi (ottonari, novenari). Bisogna lasciarsi guidare dal ritmo accentuale, ma anche dalla scansione sintagmatica e semantica. Se prendiamo come esempio l’attacco, vi 31. Vincenzo CONSOLO, «L’ora sospesa», in Ruggero Savinio. Con uno scritto di Vincenzo Consolo e un testo dell’artista, Palermo: Sellerio, 1989, p. 9-10. Le frasi sottolineate indicano le parti del testo espunte da Nottetempo e le parole in corsivo delle leggere varianti. leggiamo la seguente sequenza metrica: 11+11+7+7+5+7+11+7+11, più l’explicit con rima – «ete»: Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati (dimenticammo l’ora, il punto del passaggio, la consistenza la figura d’ogni altro, dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete, al confine bevemmo il nostro lete).32 Inoltre, il brano è anche uno squisito esempio di ekphrasis nella sua descrizione del «nunzio lampante», ovvero un rinvio alla Melancholia I (1514) di Albrecht Dürer.33 L’icona di Dürer ci rimanda di nuovo a Walter Benjamin e alle sue teorie sulla malinconia in Ursprung des deutschen Trauerspiel (1925).34 Intervistato sull’uso dell’arte figurativa e dell’ekphrasis come modalità narrativa che dimostra un’intensa immaginazione pittorica, Consolo ha affermato che c’è «un bisogno di bilanciare il suono, la parola con una concretezza di tipo visivo, di bilanciare l’orecchio con l’occhio. C’è sempre un riferimento ad un’icona, ad un’icona pittorica». E ha proseguito così: «Sempre ho avvertito l’esigenza di equilibrare la seduzione del suono, della musica, della parola con la visualità, con la visione di una concretezza visiva; di rendere meno sfuggente e dissolvente la parola nel silenzio, perché il suono fatalmente si dissolve nel silenzio».35 Questo modus componendi di Consolo, il suo pubblicare testi poetici in cataloghi d’arte prima della loro apparizione «integrata» nelle sue narrazioni, è un fatto interessante dal punto di vista della critica-genetica. Consolo stesso ci spiega anche le ragioni di questi fenomeni testuali e ci fornisce un termine alquanto peculiare per definirli: […] io non ho mai scritto una recensione di tipo logico critico dei pittori. I pittori mi interessavano quando mi davano lo spunto per scrivere delle pagine di tipo lirico narrativo, ed allora poi utilizzavo queste presentazioni per scrivere quelli che io chiamo gli «a parte», la parte del coro quando s’interrompe la narrazione. Queste digressioni di tipo lirico espressivo che i latini chiamavano «cantica».36 32. Ringrazio il collega Nicolò Messina per l’aiuto prestatomi per questa «traduzione» in versi. 33. Non possiamo neanche dimenticare I cipressi, la pialla, il compasso di Fabrizio Clerici (1980 – olio su tela, collezione privata) che riprende e raffigura l’icona dell’angelo della malinconia di Dürer. 34. Walter Bemjamin, Il dramma barocco Tedesco, Torino: Einaudi, 1971. Daragh O’Connell, «Il dovere del racconto: Interview with Vincenzo Consolo», cit., p. 251. Vincenzo Consolo, «Clausura de las jornadas», in Irene Romera Pintor (ed.), Lunaria vent’anni dopo, cit., p. 235. Come abbiamo visto con il testo «Nottetempo, casa per casa» del 1971, e vedremo con un altro esempio tratto da Lo Spasimo di Palermo, questi «a parte» rientrano cosí in una singolare categoria testuale. Nel testo del catalogo «L’ora sospesa» non mancano peraltro allusioni letterarie. Per esempio, «Oh se per tutti un legame/ un eros vago lontano…» è una citazione diretta da Fosfeni di Andrea Zanzotto: Oh se per tutti un legame Un eros vago lontano Come una stretta di mano Perenta in un’alba grigia… (Silicio, carbonio)37 Inoltre, «Che non consumi tu Tempo vorace. Che non consumi tu… Che non consu…» suggerisce icasticamente il consumarsi delle parole stesse per effetto del passare del tempo. A detta dello scrittore questa frase è ripresa dagli incisori dell’Ottocento che la lasciavano scritta sopra le rovine riprodotte. Ma ci sembra di sentire qui anche un’eco del latino, in particolare da Ovidio (Metamorphoses XV, 234-236): Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, Omnia destruitis vitiataque dentibus aevi Paulatim lenta consumitis omnia morte! 4. Lo Spasimo di Palermo. Urlo e silenzio Lo Spasimo di Palermo, pannello finale del trittico siciliano di Vincenzo Consolo, è un’opera complessa, non facilmente categorizzabile: non è un romanzo nel senso tradizionale del termine, ma con la sua articolazione tratta criticamente questioni e interventi relativi al 174 Quaderns d’Italià 13, 2008 Daragh O’Connell All’interno del romanzo, il protagonista consoliano, Gioacchino Martinez, scrittore di romanzi difficili che sta invecchiando ed è, in ultima analisi, uno sconfitto, riflette sul suo lavoro e su dove esso l’ha condotto: Aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto, impraticabile. Se mai ne aveva scritti, erano i suoi in una lingua diversa, dissonante, in una furia verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio.39 Il racconto dello Spasimo rappresenta al contempo la mediazione verso questa impasse e la risposta ad essa. Paradossalmente, le strategie adottate da Consolo sfiorano appena le forme popolari di espressione culturale, interrogandole criticamente e mettendo a nudo la loro natura «complice», poiché esse supportano e partecipano di quella che Consolo considera una situazione intollerabile per la società italiana contemporanea e per la funzione dell’arte. La scelta del linguaggio è per Consolo un tentativo di dare nuova sacralità alla parola, la sua narrativa è un esempio singolare di movimento verso la poesia, il suo messaggio etico è un messaggio di disperazione ma non di disfatta —non come il silenzio che affligge Gioacchino Martinez. Per Consolo, l’unico modo di contrapporsi a una crescente perdita di fiducia nelle possibilità comunicative del romanzo, è quello di poeticizzarne la forma.Nonostante i quattro anni che separano lo Spasimo da L’olivo e l’olivastro, Consolo era chiaramente impegnato a scriverlo già da molti anni. Com’era ormai suo modus componendi, momenti testuali dal futuro romanzo erano apparsi per la prima volta in altri testi brevi, in guise diverse. Come già per gli esempi estrapolati dal Sorriso e da Nottetempo, sono stati cataloghi e mostre d’arte a dare a Consolo l’occasione di dispiegare e meditare su queste digressioni liriche, quei passi da lui definiti «a parte». Riferendosi a questi testi scritti da Consolo per cataloghi o per libri di fotografie, Joseph Francese li considera come delle «investigazioni collaborative ed ecfrastiche delle vestigia civiche e naturali del passato siciliano».40 Sono d’accordo con lo studioso riguardo alla loro funzione, ma quel che ci interessa maggiormente è che tanti di questi testi —e Francese non lo nota— confluiscono successivamente nei romanzi come digressioni corali-poetiche, e quindi il loro status testuale è più problematico. Non si tratta di una forma di semplice autocitazione o auto-plagio, ma di uno spostamento radicale dei materiali testuali pieno di notevoli potenzialità poetiche. La poetica di Consolo implica anche l’accumulazione e l’espunzione di testi di provenienze diverse, siano essi scritti giornalistici, creativi o saggistici, generando uno spazio polifonico-palinsestico singolare. Ne abbiamo un impressionante esempio, sul versante giornalistico ed ecfrastico, in un testo intitolato I barboni scritto da Consolo nel 1995 per il catalogo dell’artista Ottavio Sgubin. Il dato significativo è che esso viene incorporato nello Spasimo in un 39. Vincenzo CONSOLO, Lo Spasimo di Palermo, Milano: Mondadori, 1998, p. 105. Tutte le successive citazioni dal romanzo saranno seguite dall’abbreviazione SP. 40. Joseph FRANCESE, «Vincenzo Consolo’s Poetics of Memory», Italica, 82: 1, 2005, p. 44: «[…] collaborative ekphrastic investigations of the civic and natural vestiges of the Island’s past». punto cruciale.41 Di questo testo poi —altro dato da sottolineare— esistono, oltre a quella valorizzata nello Spasimo, altre sei versioni in vari articoli di giornali ed ulteriori mostre dell’opera di Sgubin fra il 1995 e il 2003.42 Stanno nel tempo loro, ell’immota notte, chiusi nel sudario bruno, ermetici e remoti, negli antri delle sibille, nelle celle dei vati, stanno come vessilli gravi sui confini, nel varco breve tra il conato e la stasi, la somma e infinita quiete metafisica. Proni, supini, acchiocciolati contro balaustre, scale, piedistalli, sagome che in volute di drappi, spiegamento d’ali, torsioni, slanci, gonfiori e incavi, fantasie barocche, fingono o figurano il moto, l’estro della vita, sono masse ironiche contro le nostre illusioni, i nostri inganni, cumuli beffardi, monito fermo del destino umano, dell’esito fatale in fissità pietrosa, lento sfaldamento, dispersione in granuli, pulviscolo. E la luna, la tenera sorella delle statue, degli angeli, imbianca groppe, balze, intenebra pieghe, anfratti, scanalature, vortici, il tellurico gioco di vesti, manti. Da dove giungono questi pellegrini affranti, quale giorno li vide camminare, quale luce scoprì le crepe, le frane, il velo sopra l’occhio, la patina sul volto, segni bassi, sgradevoli del sembiante? Sono proiezioni, ombre, creature delle nostre paure, delle nostre angosce? Sono gli abitatori dei margini, le sentinelle dell’abisso, i testimoni del cedimento, gli assertori del rifiuto, del distacco. Sono, lontani muti assoluti, il richiamo costante della precarietà, dell’equilibrio instabile, dell’assurdo spasmo dell’esistere, del vivere cieco e affannoso, formicoloso moto, ottuso vagolare per cunicoli e tane, dimore grasse, labirinti d’isteria, d’oltraggio, nostro d’illusi dominanti su questa crosta procellosa, su questa landa del mondo, «su l’arida schiena/ del formidabil monte», su questo Vesuvio o Etna che in ogni istante, all’istante, per volere del Caso, stermina e pietrifica, vanifica ogni vita, cancella ogni memoria. Sono, questi profeti mesti, queste argillose statue, questa teoria antropomorfa di sarcofagi sepolti nella notte, il canto malioso o, ancor più forte, il silenzio che attrae noi vaganti, ulissi senza bussola, privati d’ogni approdo. Ora affiora dal groviglio delle pieghe, dalla piramide brumosa dell’orbace il lampo chiaro d’una mano, l’accenno d’una fronte, sboccia il gesto di rifiuto o di difesa. II mucchio penoso del distacco e dell’oblio ha ora bave di colore, vermiglie striature, violacee, è bagnato dalla luce mercuriale, dalla livida lampa nell’immenso vano dell’assenza e del silenzio. Si disegna d’intorno la fredda geografia della storia, la quinta, il fondale inesorabile del teatro sociale, cantone di palazzo, incrocio di vie senza nome, griglia di vetrata, rampa di scala mobile, acciaio, plastica di deserte stazioni, anditi dei transiti sospesi. 41. Il passo in questione corrisponde a «Stanno nel tempo loro […] il tritume delle ossa», per cui cfr. SP. , p. 70-71. 42. Vincenzo CONSOLO, «Barboni, simbolo inquietante del nuovo medioevo», Il Messaggero, 3 marzo 1996; ID., «Barboni e Natura morte», in Sgubin: Opere 1988-1997, ed. Marco Goldin, Venezia: Marsilio, 1997. Il testo viene riproposto dalla copertina del catalogo Ottavio Sgubin Mario Jerone, Centro Espositivo S. Agostino, 28 agosto – 30 ottobre 1999; ed è successivamente apparso col titolo «Barboni, segno dei nostri fallimenti», L’Unità, 29 Ottobre 2003, per segnalare un’altra mostra di Sgubin e ripubblicato infine come «I barboni di Ottavio Sgubin», in Ottavio Sgubin pittore, Museo Civico del Patriarcato, Aquileia Via Popone, 6-27 aprile 2003, p. 5. Vengono questi ribelli, questi dimissionari della convivenza, questi emarginati dalla ipocrita decenza, questi esiliati dal potere mercantile —la banale civiltà, l’angustia sociale che nomina barboni o in altri modi uguali questi che hanno abbandonato il campo, violato la dura legge dell’avere— vengono da lontano nella storia, da oscuri medioevi di carestie e pesti, d’empietà e di violenza, vengono dalle piazze di Londra o di Parigi, da sotto arcate di ponti, da corti dei miracoli, breugheliane quaresime, cortei di cenci, di cecità e di piaghe, da Alberghi di Carità, ghetti di decenza. Sono i barboni, nella trionfante storia nostra d’oggi, incongrue presenze, segno dei nostri ritardi, dei nostri fallimenti. Sono simbolo, nelle interne fratture, della più vasta, crudele frattura nel mondo, profezia inquietante d’un medioevo incombente.43 Il testo I barboni ha tutte le caratteristiche degli altri «a parte»: la prevalenza di endecasillabi, un registro alto, o meglio altamente poetico, ricercato, e inoltre la mancanza di una voce narrante identificabile. Esso sembra svolgere la funzione di quello che Norma Bouchard, in un altro contesto, chiama il «monologo lirico drammatico», specialmente nella sua condizione di unica voce possibile per il narratore, a un passo dal grido di disperazione e dagli abissi del silenzio.44 Inoltre, si scorgono nel testo diverse allusioni letterarie che ne fanno un testo ibrido. In primo luogo, la citazione diretta da La ginestra leopardiana (vv. 1-2): «[…] su l’arida schiena/ Del formidabil monte».45 Nel paragrafo successivo, un’allusione a Franz Kafka: il «canto malioso» è, infatti, il canto delle sirene, ma, come il narratore precisa, è il silenzio delle sirene ad attrarre di piú e a distruggere infine il moderno Ulisse, di cui la voce narrante è una delle ipostasi («noi»): «o ancora più forte, il silenzio che attrae noi vaganti, ulissi senza bussola, privati d’ogni approdo». Il silenzio enfatizzato di queste figure mitiche rimanda al racconto Il silenzio delle sirene di Kafka pubblicato per la prima volta nel 1934.46 Nella traduzione italiana si legge: Ma le sirene hanno un’arma ancora più terribile del loro canto, ed è il loro silenzio. Non è mai accaduto, ma forse non è del tutto inconcepibile che qualcuno si possa salvare dal loro canto, ma dal loro silenzio certo no. Alla sensazione di averle vinte con la propria forza, all’orgoglio che ne consegue e che tutto travolge, nessun mortale può resistere. 43. Vincenzo CONSOLO, I barboni, in Sgubin: Opere 1988-1995, Milano: Electa, 1995, p. 15-16. 44. Norma BOUCHARD, «Vincenzo Consolo and the Postmodern Writing of Melancholy», Italica, 82: 1, 2005, p. 5. 45. Giacomo LEOPARDI, Poesie e prose, ed. Mario Andrea RIGONI, Milano: Mondadori, 1987, p. 124. 46. Il racconto apparve postumo in Beim Bau der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen und Prosa aus dem Nachlass, hrsg. Max BROD und Hans Joachim SCHOEPS, Berlin: Schocken Verlag, 1934. Consolo certamente conosceva il racconto kafkiano e, infatti, questo stesso brano serviva da epigrafe allo studio junghiano di Basilio Reale su Lighea di Tomasi di lampedusa, per il quale Consolo aveva scritto una prefazione assai rilevante, perché vi appare definita per la prima volta la sua concezione della tradizione letteraria siciliana.47 Nella sua trasposizione in forma narrativa nel capitolo VI dello Spasimo, il brano subisce dei ritocchi: viene abbreviato e odificato radicalmente. Espunge per esempio i riferimenti a Leopardi e Kafka, e invece, nel suo nuovo stato rientra in una lunga digressione poetica che finirà con una citazione aperta dall’Odissea: l’unica citazione diretta da Omero di tutta l’opera. Il passo omerico è riprodotto in italiano senza alcuna indicazione del numero del libro né dei versi,48 ma corrisponde al Libro 1, versi 577-578: ε
π δ� � τι κλαεις κα� �δρεαι νδ
θι θυµ�
’Aργεων ∆ανα#$ ν %δ� ’Iλ
ν
‘τ
ν (κ
ων.
L’importanza di questa citazione va misurata sulla base del contesto dell’Odissea da cui è stata mutuata e della funzione che essa svolge nello Spasimo. Nell’Odissea verso la fine del Libro VIII, al banchetto efferto in suo onore, Odisseo ascolta il racconto di Demodoco che canta il sacco di Troia. Il re Alcinoo si accorge del dolore del suo ospite ancora senza nome e gli chiede come si chiami e la ragione della sua sofferenza (VIII, 550 ss.). All’inizio del Libro IX Odisseo cede alle pressioni del re e si rivela a tutti i presenti con le parole: ε’µ’ ’)δυσε*ς Λαερτι,δης. (IX, 19: «Io sono Odisseo, figlio di Laerte»), e così comincia a raccontare le alterne vicissitudini che l’hanno sospinto fino alla terra dei Feaci, nell’isola di Scheria. In altre parole, questo momento segna, con tale anagnorisis, l’inizio della narrazione vera e propria. Infatti, ne L’olivo e l’olivastro Consolo cita questi stessi versi (Od. IX, 19-21; 34-35) e ne sottolinea l’importanza per lui in termini della narrazione pura, una forma, o meglio un genere a cui egli aspira: Consolo narratore e scrittore Palincestuoso Quaderns d’Italià 13, 2008 177 47. Cfr. Vincenzo Consolo, «Prefazione» a Basilio Reale, Sirene siciliane. L’anima esiliata in «Lighea» di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Palermo: Sellerio, 1986, p. 9-14. Il saggio di Reale e la prefazione di Consolo sono stati ripubblicati nel 2001 per i tipi della casa editrice Moretti & Vitali di Bergamo. Il brano riportato di Kafka è ripreso proprio da questa riedizione (p. 25). In una fase intermedia, il testo, con il titolo cambiato in «Sirene siciliane», era stato incluso in Vincenzo CONSOLO, Di qua dal faro, Milano: Mondadori, 1999, p. 175-181. 48. Cfr. «Di’ perché piangi e nel tuo animo gemi/ quando odi la sorte» (SP, p. 72). Come dichiara nella postfazione, Consolo cita dalla versione di G. Aurelio Privitera («Fondazione Lorenzo Valla», Milano: Mondadori, 1986). Sono Odisseo, figlio di Laerte, noto agli uomini per tutte le astuzie, la mia fama va fino al cielo. Abito ad Itaca chiara nel sole… Non so vedere altra cosa piú dolce, per uno, della sua terra. Narra, narra fluente la sua odissea, come avesse varcato la soglia magica, la bocca dell’ipogeo dell’anima. E diventa Ulisse, ahi!, l’aedo e il poema, il cantore e il canto, il narrante e il narrato, l’artefice e il giudice, diventa l’inventore di ogni fola, menzogna, l’espositore impudico e coatto d’ogni suo terrore, delitto, rimorso.49 Consolo ha spiegato in varie occasioni la sua concezione della «narrazione poematica», una forma letteraria in opposizione al genere del romanzo, e non di rado l’ha fatta trapelare da diversi incisi delle sue opere.50 In questo, come ricordato all’inizio, Consolo trae spunto dal saggio del 1936 di Walter Benjamin, nel quale il filosofo si riferisce alla restituzione di un’esperienza come uno dei componenti fondamentali del raccontare —ovvero quella che egli definisce «la capacità di scambiare esperienze»: «L’esperienza che passa di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto tutti i narratori».51 Allora, per Benjamin, e Consolo lo segue, il raccontare va inteso in diretta opposizione al genere borghese del romanzo. Per Benjamin, alla «rimembranza» [Eingedenken] —il principio formale del romanzo— va aggiunta la memoria [Gedächtnis], «elemento musale» del racconto.52 La narrazione benjaminiana è per Consolo soprattutto la restituzione dell’esperienza di un viaggio, come si evince inequivocabilmente da questo passo del quasi leopardiano Dialogo di Consolo e Nicolao, prefato da Maria Corti: È, la narrazione, canto e incanto, rivelazione e occultamento, verità e menzogna, musa e sirena, memoria e oblio: ricreazione vale a dire di una verità altra, la verità della poesia. E la poesia —ricordiamolo—, nella forma più alta è anche entusiasmo, è en theò, vaticinio, perveggenza di una realtà a venire. Odisseo, con il suo racconto, melodioso come quello di un aedo, incanta gli ascoltatori.53 Adesso, tornando al citato Di’ perché piangi e nel tuo animo gemi/ quando odi la sorte dello Spasimo, ciò che segue nella narrazione non è costituito dalle famose parole di auto-rivelazione di Odisseo che inaugurano il suo racconto, bensí da quelle pessimistiche di Consolo: «Io sono… no, no, l’aridità, la lingua 49. Vincenzo CONSOLO, L’olivo e l’olivastro, Milano: Mondadori, 1994, p. 19. I versi sono sempre nella versione cit. di G. Aaurelia Privitera. 50. La forte vocazione metaletteraria di alcuni passi del corpus consoliano è studiata da Miguel Ángel Cuevas, «La constante metaficcional en la obra de Vincenzo Consolo», in Hans Felten & David Nelting (edd.), Una veritade ascosa sotto bella menzogna… Zur italienischen Erzählliteratur der Gegenwart, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2000, p. 129-35. 51. Walter. Benjamin, Angelus Novus, cit., p. 248. 52. Ibid., p. 262-263. 53. Vincenzo Consolo & Mario Nicolao, Il viaggio di Odisseo, intr. Maria CORTI, Milano: Bompiani, 1999, p. 38. spessa, l’oblio d’ogni nesso… illuso ancora dell’ascolto, tu procedi» (SP,p. 72): ossia l’impossibilità della narrazione; l’esito estremo della poetica di Consolo. Ricorrendo alle riflessioni dello stesso Consolo, la simbologia è questa: il narratore, l’anghelos, il messaggero, non appare più nella narrazione. È rimasto solo il coro, il poeta, che in tono alto, lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi.54 Per Massimo Onofri Lo Spasimo di Palermo è un’opera senza precedenti in Consolo. Il critico afferma che la narrazione contiene gli abbozzi di parecchi altri romanzi e di fatto ne conta ben cinque: un romanzo sul rapporto Italia-Sicilia; un romanzo sul rapporto padre e figlio (il padre di Gioacchino/Chino e Chino); un secondo romanzo padre-figlio (Chino e Mauro); inoltre un romanzo d’amore (Chino e Lucia); e infine, un romanzo di «oblìo e dimenticanza».55 A questi cinque pseudo-romanzi se ne potrebbero aggiungere anche altri, se non romanzi, almeno fili di possibili romanzi: per esempio, il romanzo sulla mafia; un giallo (ma qui giallo va inteso nel senso della critica severa fatta da Consolo alla letteratura di consumo, giallo incluso); e infine, un romanzo-nostos alla Vittorini. Una delle difficoltà della narrazione di Consolo risiede esattamente in questa molteplicità di fili romanzeschi, nessuno dei quali è predominante, ma che accoppiati producono una narrazione che ci sembra unica nell’attuale panorama letterario italiano. Tuttavia, quest’idea di Onofri dei tanti romanzi all’interno della narrazione è interessante anche per vari altri aspetti: innanzittutto, nessuno dei romanzi che elenca è completo; in secondo luogo, è altrettanto vero che lo Spasimo contiene in sé i momenti testuali di tutta l’opera consoliana. Quindi ci sembra che lo Spasimo costituisca quello che potremmo chiamare l’autobiografia estetica di Consolo, ovvero una sorta di autoritratto artistico di Consolo-autore: non nel senso che Consolo abbia scritto un’autobiografia tout court, ne siamo ben lontani, ma in quanto ha invece immaginato una narrativa che è fondata sui propri testi. La grandezza e l’importanza dello Spasimo si basano in parte sulla presenza delle altre narrazioni consoliane all’interno dell’opera, che proprio per il loro coabitarci offrono una specie di critica della poetica dell’autore e ne danno anche qualche spiegazione. Non è soltanto una forma ludica di autoplagio, né un riesame della sua poetica, ma una specie di summa, in cui le scelte ideologiche ed estetiche sono portate alla loro naturale conclusione. Quel che intendo dire è che la narrazione rivela tracce dei romanzi precedenti; il che ci suggerisce che lo Spasimo è sovra-scritto, un doveroso palinsesto che ci porta indietro nel tempo fino a La ferita dell’aprile del 1963. Quindi, se accettiamo che lo Spasimo è l’ultimo episodio della trilogia consoliana, dovremo ammettere che l’autore vi implica e problematizza anche tutta l’opera pubblicata fino a quella data. In breve, oltre alla solita presenza di altri poeti e autori, sia antichi che moderni, la presenza letteraria più forte nello Spasimo è Consolo stesso. Consolo narratore e scrittore Palincestuoso Quaderns d’Italià 13, 2008 179 54. Cfr. Vincenzo CONSOLO, «Per una metrica della memoria» cit., p. 258. 55. Massimo ONOFRI, Il sospetto della realtà, cit., p. 183. Non mi soffermerò sui legami formali e tematici fra lo Spasimo e gli altri due romanzi storico-metaforici della trilogia: Il sorriso e Nottetempo. Vorrei qui segnalare, invece, come gli altri testi consoliani influiscano sulla poetica dello Spasimo e ne partecipino. Un interessante esempio ci è fornito dal primo romanzo consoliano: La ferita dell’aprile. In entrambe le opere, la prima e l’ultima, si evoca lo stesso mondo del secondo dopoguerra. Le nuove scelte per l’Italia appena liberata costituiscono una tematica importante nei due romanzi. Inoltre, in entrambi, questi eventi vengono visti attraverso gli occhi di due ragazzi irriverenti: nello Spasimo da Chino e nella Ferita dallo sparginchiostro», il giovane Scavone. Infine, i due ragazzi sono allevati dai loro zii, da zio Beppe nel caso di Scavone e nel caso di Chino, dopo la morte del padre per mano dei soldati tedeschi, da quella figura derobertiana e pirandelliana che è suo zio Mauro. Un altro importante avantesto è un racconto del 1981. Quel che importa è che in ben due occasioni nello Spasimo Consolo ci rimanda a questo racconto, ma adoperando un titolo diverso: La perquisizione. Il racconto va infatti identificato, per ragioni sia testuali che tematiche, con «Un giorno come gli altri» che, come dimostrato sopra, è uno dei testi chiave di Consolo, specialmente in quel suo distinguere fra lo «scrivere» e il «narrare». Ma nel racconto c’è inoltre un livello tematico che spazia tra gli «anni di piombo», le incursioni poliziesche nelle case, e anche i dibattiti ideologici più ampi del periodo e gli effetti reali della guerra fredda. Alla fine la casa dello scrittore è violata dalla polizia: Irrompono, mitra spianati, modi feroci; si dirigono subito nel mio studio. Mi appiattisco, mani in alto, contro la parete, sotto il disegno di San Gerolamo. Mentre uno mi sta a guardia, con l’arma contro il petto, gli altri si mettono a buttare giù i libri, loro vi passano sopra con gli scarponi. Nuvolette di polvere vengono su dai mucchi come da piccoli vulcani. Finita la perquisizione, sulla porta, il capo, ghignando, mi consegna il foglio. Lo afferro, leggo: «Procura della Repubblica in Milano. Il PM letto il rapporto … in data… della Tigos…». «Lo conosco, quest’ordine, lo conosco …» dico balbettando. «Lo sappiamo» risponde quello. «E sappiamo che tu scrivi, che narri di Milano … Mannaggia, ci mancano le prove!» e con la mano, scendendo le scale, mi fa capire di non dubitare, che prima o dopo le troveranno, le prove. Sul pianerottolo, affacciandomi, grido giù nella tromba delle scale: «Non è vero, io non so scrivere di Milano, non ho memoria …».56 Nello Spasimo il protagonista ricorda un racconto che aveva scritto su un glottologo che leggeva la storia di un re che narrava e governava: solo il Re che narra è un narratore perfetto perché lui non ha bisogno della metafora, lui governa, comanda e nello stesso momento scrive. Ma poi questo sogno letterario -archeologico si scioglie per via dell’«incubo dei colpi fragorosi dei poliziotti sulla porta, mitra spianati, che irrompono, sconvolgono la casa. […] Termi56. «Un giorno come gli altri», cit., p. 1441-1442. nato il racconto La perquisizione, aveva lasciato i fogli sopra il tavolo» (SP, p. 83-84). Un po’ prima Consolo aveva scritto: Ricordò il racconto La perquisizione che appena scritto aveva lasciato sopra il tavolo. Mentre i militi, venuti per il figlio, buttavano giù libri, rovistavano cassetti, armadi, il poliziotto lo leggeva. «Mi sembra di sognare» disse. A lui, privo di metafore, correlativi obbiettivi, puntelli di rovine. Il boemo dimesso, cupo, guardava intorno, dietro, traversava le rotaie, saltava il tram che dal Sempione portava verso l’Arco, il Parco, si credeva pedinato. «Lo Scherzo» disse, «la sua traduzione in Francia, in Italia…» Si sedette contro il muro, bevve il vino, assalì maldestro gli spaghetti, spiò l’uscio, la finestra. Signore in seriche casacche orientali andavano e venivano, il branzino sul piatto, rivolgevano domande a Saul Bellow, chiedevano di Singer, Malamud. L’ospite parlava solo di Cuba, della Bolivia, dell’amico Gabo, fra gli intellettuali la discussione s’era accesa sopra Praga, cosa pretendevano infine, e noi, le basi aree, le corazzate dentro i porti? «Merde, merde!» fece il boemo paonazzo, sbatté il piatto, uscì furioso dal salotto, da quella ricca casa. (SP, p. 66) La fonte di questo brano è ancora una volta «Un giorno come gli altri», in cui si racconta la storia di un’esperienza fatta da Consolo ad una festa organizzata nel 1969 a casa di un editore in onore di Saul Bellow. Nel passo si può inoltre ravvisare un’allusione a T.S. Eliot e in particolare a The Love Song of J. Alfred Prufrock. L’immagine delle «Signore in seriche casacche orientali» che «andavano e venivano» ricorda i versi: «In the room the women come and go/ Talking of Michelangelo». Anche il riferimento ai «correlativi obbiettivi» rimanda decisamente a Eliot, che è senz’altro uno dei poeti preferiti di Consolo e tra quelli da lui piú spesso citati. Per esempio nell’incipit dello Spasimo Consolo rimaneggia i versi ormai canonici di Prufrock: «Let us go then you and I». Vi si legge difatti: Allora tu, i doni fatui degli ospiti beffardi, l’inganno del viatico, l’assillo della meta (nella gabbia dell’acqua, nella voliera del vento hai chiuso i tuoi rimorsi), ed io, voce fioca nell’aria clamorosa, relatore manco del lungo tuo viaggio, ndiamo» (SP, p. 9).57 Ma torniamo a «Un giorno come gli altri», al passo in cui si racconta: M’ero portato appresso un mite e dimesso poeta cecoslovacco, anche lui di passaggio in quei giorni a Milano. Si chiamava Vladimir … (il cognome lo taccio, non si sa mai… Anzi, si sa). […] Ci passavano davanti bellissime donne, eleganti, vestite alla russa, alla cinese. Ci scorse poi la padrona di casa, la moglie dell’editore […]. Poi fa, rivolta a me: «Lei è sudamericano?» «No» dico, e lei si allontana, delusa. Fu verso la mezzanotte che successe il fattaccio. Vladimir, 57. In corsivo nell’originale. 182 Quaderns d’Italià 13, 2008 Daragh O’Connell oltre ad avere mangiato, aveva anche molto bevuto. Ma egli era mite e mite rimaneva, triste anzi, anche con tutto l’alcool che aveva in corpo. Non fosse stato per quello scultore. Si siede vicino a noi e, quando scopre che Vladimir è cecoslovacco, si mette a dire che bene avevano fatto i russi ad arrivare a Praga coi carri armati: cosa voleva questo Svoboda, questo traditore di Dubcek? Vladimir diveniva una furia. Afferrò lo scultore per il petto, cominciò a scuoterlo, a picchiarlo, urlando nella sua lingua insultandolo. Tutti accorsero, si ammassarono attorno a quei due che si picchiavano e a me che cercavo di separarli. Poi, rosso di ergogna come fossi stato io la causa di tutto, riuscii a trascinare per la giacca il poeta praghese, a passare in mezzo a tutti nel grande salone (scorsi un attimo Bellow, roseo, bianco, le mani in tasca, che ci guardava e sorrideva divertito), a guadagnare la porta.58 Quindi, La perquisizione è una specie di doppio testo per lo Spasimo e rafforza sempre di più il binomio Consolo – Martinez. Retablo del 1987 è un altro romanzo consoliano che ha un ruolo notevole nello Spasimo, anche se ambientato nel Settecento. Il suo protagonista milanese, Fabrizio Clerici (l’ennesimo doppio nell’opera di Consolo), è in realtà una figura molto moderna e il suo presente va visto attraverso le lenti del passato. Ad un certo punto del romanzo Clerici scrive a Maria Teresa Blasco (la nonna di Alessandro Manzoni) implorandola di lasciare Milano tra un’imprecazione e l’altra contro la città: O gran pochezza, o inanità dell’uomo, o sua fralezza e nullità assoluta! O sua ferocia e ferina costumanza! O Secol nostro superbo di conquiste e di scienza, secolo illuso, sciocco e involuto! Arrasso, arrasso, mia nobile signora, arrasso dalla Milano attiva, mercatora, dalla stupida e volgare mia città che ha fede solamente nel danee, ove impara e trionfa l’impostore, il bauscia, il ciarlatan, il falso artista, el teatrant vacant e pien de vanitaa, il governatore ladro, il prete trafficone, il gazzettier potente, il fanatico credente e il poeta della putrida grascia brianzola. Arrasso dalla mia terra e dal mio tempo, via, via, lontan!59 Questa è la stessa Milano che il narratore evoca all’inizio del capitolo VIII dello Spasimo. Una volta luogo di speranza, «approdo della fuga» in cui si concentravano le qualità della società civile —«orgoglio popolare, civile convivenza, magnanimità e umore e tolleranza»— questa Milano è per il narratore un sogno diventato incubo: Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino 58. «Un giorno come gli altri», cit., p. 1438-1439. Il nome del poeta ceco è Vladimir Mikesch. Nello Spasimo viene trasformato in Milan Kundera. 59. Vincenzo CONSOLO, Retablo, Palermo: Sellerio, 1987, p. 103-104. Al riguardo, cfr. inoltre ID., Fuga dall’Etna, Roma: Donzelli, 1993, p. 61-62. «Arrasso» significa «lontano». È un sicilianismo utilizzato da Consolo per la prima volta ne La ferita dell’aprile ([1963] Torino: Einaudi, 1977, p. 110): «arrasso di qua». Consolo narratore e scrittore Palincestuoso Quaderns d’Italià 13, 2008 183 e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità. Città perduta, città irreale, d’ombre senz’ombra che vanno e vanno sopra ponti, banchine della darsena, mattatoi e scali, sesto e cinisello disertate, tennologico ingranaggio, dallas dello svuotamento e del metallo. Addio. (SP, p. 91)60 Se in Retablo Milano era in realtà la Milano craxiana degli anni Ottanta, la Milano dello Spasimo è la Milano berlusconiana, la Milano della Lega Nord. Un’altra opera che al di fuori della trilogia è molto visibile nello Spasimo è la silloge Le pietre di Pantalica e in particolare il racconto eponimo. Nello Spasimo Gioacchino incontra un giudice dopo il suo ritorno in Sicilia: l’opera costituisce per certi versi un punto di rottura entro la tradizione siciliana, è uno dei primi esempi nella letteratura siciliana in cui un magistrato rappresenta valori positivi e diviene simbolo di una condizione eroica. Nella figura del «Giudice» di Consolo il personaggio rimane anonimo, ma risulta tratteggiata la persona di Paolo Borsellino, il cui assassinio alla fine del romanzo rappresenta la morte dello Stato italiano e segna il rifiuto stesso del genere romanzo. Questo giudice riconosce lo scrittore Martinez e l’accompagna a casa con la scorta. In macchina, il giudice sciolse un poco l’espressione rigida, sorrise appena sotto i baffi brizzolati. «Ho letto i suoi libri… difficili, dicono. Di uno mi sono rimaste impresse frasi su Palermo» socchiuse gli occhi, recitò: «Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido esala odore dolciastro di sangue e gelsomino …» «Sono passati da allora un po’ di anni …» disse Gioacchino. «Ma nulla è cambiato, creda. Vedrà, il prossimo luglio sarà uguale … o forse peggio.» (SP, p. 115) In realtà la personificazione di Borsellino sta citando da Le pietre di Pantalica e quindi l’intertestualità del brano è resa più problematica, diviene una forma curiosa di auto-plagio: Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido, esala odore dolciastro di sangue e gelsomino, odore pungente di creolina e olio fritto. […] Questa città è un macello, le strade sono carnezzerie con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati, legati mani e piedi come capret60. «tennologico» è un milanesismo che serviva a Consolo come ammiccamento al linguaggio berlusconiano. Secondo chi lo traduce in francese con «tennologique», è un termine «que renvoie aux logiques du tennis et, plus largement, à la banalisation inhérent aux choses: aussi tous les nom propres (Sesto, Cinisello, etc.) deviennent des noms communs, transcripts en caractères minuscules». Cfr. Vincenzo CONSOLO, La Palmier du Palerme, trad. Jean-Paul Manganaro, Paris: Éditions du Seuil, 2000, p. 108. 184 ti, strozzati, decapitati, evirati, chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta.61 Nello Spasimo il brano serve inoltre ad identificare sia Borsellino che Consolo come protagonisti di questa tragedia narrativa. Quindi, è proprio vero che l’opera costituisce una sorta di autobiografia intellettuale ed estetica dell’autore: in queste pagine confluiscono frammenti, stralci o estratti, temi, scelte ed esperienze delle precedenti narrazioni di Consolo, come attrattivi da una forza centripeta. Lo Spasimo è anzi un ipertesto, forse il lavoro più ipertestuale di Consolo, nel senso che si viene formando sui suoi tanti ipotesti autoriali. Di conseguenza, ci sembra un testo intensamente palinsestico, realizzato attraverso un meditato processo di riscrittura, o sovrascrittura, e autocitazioni d’autore. La narrazione che ne risulta è un’opera narrativa ibrida in cui le tante forme delle opere precedenti trovano spazio e per certi versi sono riviste, riscritte e re-iscritte. In breve, ribadendo la definizione già data, Lo Spasimo di Palermo è la summa della poetica consoliana. In ultima analisi, questi sono alcuni dei motivi per cui penso che sia giusto parlare di Consolo come di un narratore palincestuoso. 61. Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., p. 170. Il corsivo è dell’autore
Quaderns d’Italià 13, 2008 161-184