LUNARIA LUNEDÌ 5 LUGLIO ORE 21.15 PIAZZA SAN MATTEO GENOVA
di Vincenzo Consolo
con Pietro Montandon tecnico luci e fonica Luca Nasciuti costumi Maria Angela Cerruti scene Giorgio Panni Giacomo Rigalza
regia Daniela Ardini
Lunaria Teatro Genova
Uno dei testi più ricchi di suggestione della drammaturgia contemporanea e insieme un capolavoro della letteratura del Novecento. Questo è Lunaria, favola scritta da Vincenzo Consolo, vincitrice nel 1985 del Premio Pirandello, realizzata in prima nazionale da Daniela Ardini e Giorgio Panni nel 1986 e successivamente realizzata in molte versioni in Italia e all’estero. La storia. In una Palermo di fine Settecento, una mattina il Viceré si sveglia madido e tremante: ha sognato che la Luna è caduta dal cielo e, una volta raggiunto il terreno, si è spenta, lasciando nel cielo un buco nero. La giornata del Viceré prosegue nella sala delle udienze dove arriva Messer Lunato, uno strambo viaggiatore in mongolfiera. A conclusione dell’udienza i ministri srotolano una mappa sulla quale sono indicati i possedimenti vicereali sul quale il Viceré fa scorrere il suo scettro che inspiegabilmente si impunta su una estrema Contrada senza nome. A questo punto la scena si apre sulla Contrada senza nome, dove alcuni villani guardano sorpresi la Luna che sta per sorgere e che appare insolitamente grande e colorata di rosso scarlatto. Dopo un po’ la Luna ritorna ad essere bianca e luminosa, ma comincia a creparsi e falde di luna cominciano a piovere a terra. Un Caporale ubriaco intima ai villani di raccogliere i cocci di Luna e di metterli in una giara, quindi ordina ad uno di loro, Mondo, di andare dal Viceré per riferire l’accaduto e chiedere istruzioni sul da farsi. La scena torna quindi a Palazzo Reale, dove è riunita l’Accademia dei Platoni Redivivi per disputare circa la malattia, lo sfaldamento e la conseguente caduta sub specie pluviae della Luna. Tra loro arriva Mondo che racconta l’accaduto, portando con se una falda di Luna come prova. Posto il coccio in uno scrigno, Mondo viene congedato e ciascuno degli accademici esprime la propria opinione sull’accaduto. Finita la disputa, nell’Accademia deserta dalle ante di un armadio esce il Teatro delle Bizzarrie: geni, fate, folletti, astri, pianeti, allegorie; quindi i personaggi fantastici spariscono a mano a mano, lasciando solo la Luna. Nell’epilogo si torna nuovamente nella Contrada senza nome, dove uomini e donne vestiti di nero seppelliscono i resti della Luna nella fontana e, di li a poco, assistono alla ricomparsa in cielo della Luna che, pero, tra i due corni della falce mostra una macchia nera. Giunge allora il Caporale il quale, deluso di ritrovare la Luna al proprio posto, inveisce contro i villani; viene pero interrotto dal sopraggiungere del Viceré, il quale sale una scala a pioli e incastra nella Luna il pezzo mancante, decretando che da allora in poi la Contrada senza nome si chiamerà “Lunaria”. La lingua e lo stile. Dal punto di vista linguistico Lunaria accosta stili diversi: dal narrativo al dialogico, dal lirico-poetico al linguaggio scientifico o pseudo scientifico degli usato dagli Accademici. Inoltre Lunaria, pur nella sua brevità, si configura come un crogiolo di lingue e dialetti. Sono facilmente riconoscibili l’uso dell’italiano nei suoi diversi registri: da quello accademico-scientifico, a quello visionario, mimetico, letterario, lirico, popolare; l’uso del siciliano, del dialetto gallo-italico, dello spagnolo di Dona Sol e degli inquisitori, del latino nonché di latinismi vari. Il Viceré e ricorre saltuariamente a tutti questi idiomi, compreso il dialetto gallo- romanzo, ossia il sanfratellano, tanto che a Mondo risponde parlando nella sua stessa lingua. Interi brani di poesia e versi “nascosti” compaiono in Lunaria. Lo stile si avvicina alla poesia come mai prima era avvenuto: il testo pullula di anafore, allitterazioni, rime interne. Si assiste cosi a una sorta di tendenza mimetica per cui al tema dell’intima necessita per il mondo della poesia (simboleggiata dalla Luna) corrisponde uno stile che si fa poesia. Il linguaggio si presenta talvolta oracolare, la forma espressiva risulta nervosa, essenziale: la parola si fa incantatrice e trascina il lettore nella “poesia” della vita. La critica letteraria. Cosi Cesare Segre: “Uno dei lavori più mirabili di Consolo, Lunaria (1985). In esso c’è un abbandono pieno all’invenzione. Invenzione tematica e invenzione formale. Il libro non è certo un romanzo, ma appartiene piuttosto a un “genere che non esiste”, a un conato di teatralità divertita fra entremes alla spagnola e teatrino delle marionette. Si sa che molta dell’elaborazione di Consolo è “letteratura sulla letteratura”. Ebbene, in Lunaria la falsariga è costituita da un racconto di Lucio Piccolo, L’esequie della luna(1967), con cui Consolo si pone felicemente in gara, non dimenticando naturalmente Leopardi. Voglio evocare un aneddoto sintomatico. Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procuro la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore”. La regia. Lunaria è sempre una favola, la favola della luna, che vuole far sognare il pubblico affascinato da sempre dall’astro poetico. Per Consolo la sua caduta “rappresenta l’allontanamento della poesia dal mondo”, poesia che è invece illusione necessaria contro la precarietà della storia e della vita (Scende la luna; e si scolora il mondo, aveva scritto Leopardi ne Il tramonto della Luna).La regia di questo allestimento punta a riportare Lunaria ad alcune delle sue matrici originarie: il cunto e l’opera dei pupi. La tradizione infatti in Consolo si mescola arditamente all’elaborazione poetica e all’artificio letterario. Un solo attore, Pietro Montandon, da voce e gesto a tutti i personaggi, partendo dall’essere in primo luogo il narratore-cuntista dell’opera. Un baule da teatro, un leggio e un praticabile palcoscenico su cui si “interpretano” i vari personaggi e la storia, citano insieme narrazione e teatro. Consolo stesso asseriva che “le didascalie, pur conservando in qualche modo la loro funzione di indicazione mimetica e ambientale, vogliono assumere anche dignità di testo, sono insomma didascalie che ambiscono ad essere recitate da un eventuale personaggio (il Narratore)”. Montandon prende per mano il suo pubblico e lo guida con ironia, ma anche con mano ferma e mente fredda nei meandri non sempre facili dell’opera di Consolo, facendolo assistere ad un gioco letterario, ma anche teatrale, che diverte con l’astrusità dei vari linguaggi, il paradosso di alcune situazioni (l’Accademia dei Platoni Redivivi che cercano di dare “spiegazione” alla caduta della luna), l’ironia di alcuni personaggi (Messer Lunato, Cerusici, Dona Sol, e altri), da emozioni con il linguaggio poetico del Viceré e la versificazione dei Villani e delle Villanelle, ultimi baluardi di un mondo dove rimane ancora la poesia. La scenografia disegna in modo astratto la corte del Viceré di Sicilia e la contrada senza nome. Il gioco musicale è arricchito da effetti sonori sulle tante voci di Montandon. L’attore PIETRO MONTANDON per lunghi anni interprete nella compagnia Mummenshanz, con Lunaria Teatro straordinario interprete di Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri e de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.
www.lunariateatro.it info@lunariateatro.it 
Tag: Lucio PIccolo
Leone di Sicilia, epopea di un’isola in 500mila scatti
Un archivio monumentale. Per raccontare la fine della civiltà agricola, gli scempi edilizi, le feste patronali. E quella celebre foto che ritrae Bufalino, Consolo e Sciascia (foto di Giuseppe Leone)
di Concetto Prestifilippo

29 GIUGNO 2021
«Caro Andreose, mi permetta di segnalarle un fotografo con bottega a Ragusa che sembra scivolato da una pagina di Brancati». Giuseppe Leone è il nome del fotografo citato. La bizzarra lettera di patronage reca la firma di Leonardo Sciascia. Destinatario della missiva, Mario Andreose, direttore editoriale della Bompiani. Milano, era il 1986. Seguì una serie di elegantissimi libri fotografici di grande successo. Dopo trentacinque anni, Andreose ha inviato la stessa eccentrica fideiussione a Elisabetta Sgarbi. Questa volta l’invito trova realizzazione nella mostra fotografica “Metafore”, appena inaugurata a Bergamo presso la galleria Ceribelli, evento inserito nel palinsesto delle manifestazioni di “Milanesiana 2021”.
«Non andrò mai più in Sicilia», scrive nella sua introduzione al catalogo della mostra Elisabetta Sgarbi. Un proposito doloroso legato alla scomparsa dei suoi amici Claudio Perroni e Franco Battiato. Mentre si arrovellava tra questi pensieri, è giunta la proposta della retrospettiva. «La mia adesione è stata istantanea, la mostra fotografica di Giuseppe Leone è stato un rimbalzo nel passato», sottolinea lei con trasporto: «A lui mi legano i primi ricordi da giovane editor, quando Mario Andreose, direttore dell’allora gruppo editoriale Fabbri Bompiani, mi portava in Sicilia, per sedurre i due massimi scrittori siciliani: Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino».
Giuseppe Leone, 84 anni, custodisce nel suo archivio più di 500 mila scatti, sessanta i libri fotografici con testi firmati dai grandi autori della letteratura del Novecento. Trovarlo è semplicissimo. Chiedi informazioni nel centro storico di Ragusa e tutti rispondono con un’esclamazione: «Ah, Peppino», e indicano il suo studio-galleria che troneggia sulla salita di corso Vittorio Veneto a pochi metri della cattedrale di San Giovanni Battista, la chiesa dove per quasi sessanta anni fu maestro d’organo il padre. Voleva fare il pittore ma si ritrovò a fare il ragazzo di bottega nello studio del fotografo Antoci. Giusto il tempo di apprendere l’arte della foto di studio e di comprare una prima macchina fotografica a soffietto, una Voigtlander Bessa 6×9. La stessa macchina che gli consentì, appena sedicenne, di immortalare uno dei suoi più celebri scatti: un treno che attraversa ansimante il ponte della vallata San Leonardo e Ragusa Ibla sullo sfondo.
A dispetto della sua età, il dopo Covid per il fotografo siciliano è un tripudio di iniziative. Oltre l’esposizione bergamasca, a Ragusa è stata inaugurata una mostra dedicata agli scrittori Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e Leonardo Sciascia. In Campania, a luglio, si inaugura una mostra dedicata alle meraviglie della Costiera amalfitana. In autunno è prevista l’uscita del libro “La Sicilia passeggiata” con un testo di Vincenzo Consolo, curato dal critico letterario Gianni Turchetta. Altri due libri in uscita per il prossimo Natale.
Leone è un bracconiere di epifanie. Nel corso di quasi settanta anni di attività ha percorso in lunga e largo la Sicilia. Non c’è villaggio dell’entroterra o paesino della costa che non abbia fotografato, prima che uno dei due sparisse, definitivamente, per dirla con le parole del suo grande amico, lo scrittore Vincenzo Consolo. Scattando, senza sosta, ha messo in salvo, condotto a riva i relitti di un naufragio culturale. Immagini che testimoniano una trasformazione sociale epocale, la fine della civiltà contadina. Alberga ormai solo in questo mezzo milione di fotogrammi la Sicilia della grande emigrazione. Tra il 1960 e il 1970, 700 mila siciliani lasciarono l’isola. Duecentomila nella sola Germania. Il treno del Sud, che di solare aveva solo il nome, era una tradotta con tanfo di creolina. Scaricava nelle gelide stazioni padane eserciti di braccianti trasformati in operai utili al nascente triangolo industriale del nord. Seguendo il monito inascoltato di Pier Paolo Pasolini, Leone ha continuato a fermare questi attimi. Mentre l’Italia si omologava inesorabilmente, ha registrato l’abbandono delle campagne, lo spopolamento dei centri storici, lo stravolgimento del paesaggio, la distruzione del patrimonio archeologico, la sistematica spoliazione delle chiese, la speculazione edilizia, il deturpamento delle coste, l’imbarbarimento dei costumi. Un casellario fotografico che vale un intero museo antropologico. Nei suoi classificatori albergano le sequenze delle feste patronali, quelle delle confraternite dolenti e degli incappucciati spagnoleggianti. Il mare vagheggiato immortalato guadagnando promontori sospesi. Svelato il fasto d’antan varcando la soglia di palazzi nobiliari. Mostrato le ritualità dei contadini scapicollando per colline ineffabili. Rianimato l’atmosfera sospesa delle botteghe artigianali. Catturato scorci sconosciuti agguattato nei conventi e nelle chiese. I suoi scatti sono stati pubblicati sulle copertine delle riviste più prestigiose. Ha ritratto i grandi intellettuali e gli artisti più affermati. Fotografie che continuano a disvelare la Sicilia bramata dai viaggiatori del Grand Tour. Vengono a intervistarlo le troupe delle Bbc, giungono collezionisti da tutto il mondo, grandi couturier come Dolce & Gabbana utilizzano le sue foto per le loro campagne pubblicitarie mondiali, ma la Sicilia non ha mai trovato il tempo di dedicargli un’antologica.
L a sua carriera muove dall’incontro di due straordinari artisti, Leonardo Sciascia ed Enzo Sellerio. Fu una strana coincidenza. Una di quelle stranezze misteriose che Sciascia amava tanto. Il loro primo incontro ebbe come scenario la sede palermitana della casa editrice Sellerio. Leone aveva chiuso l’impaginazione del suo primo libro “La pietra vissuta”. Enzo Sellerio, maestro di tutti i maestri della fotografia siciliana, gli chiese di seguirlo, voleva presentargli una persona. Il fotografo di Ragusa si trovò al cospetto di Sciascia, seduto su un divano mentre fumava l’eterna sigaretta. A colpirlo fu l’immediata domanda del maestro di Regalpetra che gli chiese se conoscesse la prefettura di Ragusa. Leone, intimorito, rispose ingenuamente di sì. Sciascia rincalzò, divertito, spiegando che il riferimento era alle tempere realizzate da Duilio Cambellotti. Pitture che adornavano il palazzo della prefettura. Lo scrittore aveva già in mente un lavoro dedicato a una pagina rimossa della storia italiana. Paradossalmente quella sua prima domanda, dopo qualche anno, si trasformò nel loro ultimo libro: “Invenzioni di una prefettura”, edito da Bompiani. Il libro fu pubblicato proprio dal direttore editoriale Mario Andreose, dopo la bizzarra lettera di presentazione sciasciana. A Ragusa, Sciascia riuscì a visitare i saloni della prefettura. Le pareti erano state foderate, per anni, da teloni scuri che coprivano le pitture di Cambellotti. Fu dunque un autentico disvelamento. Realizzarono un libro autenticamente sciasciano. Contraddistinto dalla sua cifra stilistica: la spasmodica ricerca della verità. Anche la verità scomoda, come quella del regime fascista.
Dunque misteriosamente, la prima cosa che Sciascia aveva chiesto a Leone, fu l’ultimo libro della loro lunga collaborazione. Dopo il primo incontro palermitano, i due entrarono subito in sintonia. Sciascia si recò a Ragusa, più volte. Batterono la Sicilia in lungo e largo per mostre, convegni, feste di piazza. Ma in tanti anni di amicizia, il fotografo non osò mai dare del tu all’autore del “Giorno della civetta”. Sciascia è stato una persona determinante, per la carriera di Leone. Le sue parole, le sue indicazioni, gli hanno aperto orizzonti inesplorati, conferendo metodo al suo lavoro di fotografo. Il loro primo libro fu “La Contea di Modica”. In quell’occasione, ricorda Leone, ebbe modo di conoscere il grande valore dell’uomo e dello scrittore. Quando gli chiese, intimidito, come procedere, Sciascia gli rispose che dovevamo agire in piena autonomia. Al fotografo lasciava l’autonomia di sviluppare il suo racconto per immagini, Sciascia avrebbe tratteggiato la sua narrazione con le parole. Quando Sciascia arrivava a Ragusa, non mancava l’appuntamento a Scicli, nello studio del pittore Piero Guccione che lo scrittore stimava e apprezzava per la sua maestria e per il suo riserbo, una taciturna discrezione che sembrava accomunarli. La conversazione con Leone è un continuo affastellarsi di aneddoti legati al carosello di ritratti che affollano le pareti del suo studio. Osserva le immagini che tratteggiano i volti di Enzo Sellerio, Danilo Dolci, Ignazio Buttitta, Franco Battiato, Piero Guccione, Elvira Sellerio e mille altri artisti. Ma una spicca su tutte.
Una fotografia che ormai diventata una foto simbolo, quella che ritrae i tre scrittori Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo e Leonardo Sciascia. Un frammento in bianco e nero dell’intensa intimità che si registrava in contrada Noce, la tenuta estiva di Leonardo Sciascia. Lo scatto è del 1982 e segna non solo la fine del Novecento letterario, ma anche il tramonto della cultura eccentrica. Quella incarnata da tre intellettuali che operarono lontano dai centri del potere della cultura ufficiale. Scrittori di provincia ma non provinciali. Artisti di levatura europea, nati in tre minuscoli paesi siciliani: Racalmuto, Sant’Agata di Militello e Comiso. Ad organizzare il rendez-vous a Racalmuto fu Aldo Scimè, intellettuale e giornalista della Rai. Una circostanza memorabile, per il tenore della conversazione e per gli argomenti trattati, permeato da un clima di meravigliosa complicità. La risata immortalata nella sequenza fotografica smonta anche un altro abusato assunto, quello che vedeva i tre grandi autori siciliani tratteggiati come tristi e inguaribili pessimisti. A scatenare l’incontenibile e fragorosa risata fu il riferimento ad altri due grandi autori isolani: Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Lucio Piccolo. Sciascia raccontò del loro arrivo a Milano, invitati dall’organizzatore del premio San Pellegrino, Eugenio Montale. Il poeta aveva convocato i due cugini siciliani che accompagnati da un valletto, si presentarono infagottati in pesanti pastrani, bizzarri come Totò e Peppino nella celebre sequenza cinematografica. Mentre Sciascia raccontava l’episodio e si appalesò la scena dei due cugini a Milano curiosamente intabarrati, scoppiò la fragorosa risata dei tre scrittori, eternizzata dal bianco e nero della sequenza fotografica.
A conclusione della lunga conversazione, Giuseppe Leone racconta un episodio accaduto alla fine degli anni Ottanta, l’arrivo in Sicilia proprio del direttore editoriale della Bompiani Mario Andreose, personaggio dal quale muove questa conversazione. Uomo elegante, colto e raffinato, si ritrovò smarrito al cospetto delle complessità della Sicilia. Leone e Andreose partono alla volta di Racalmuto. Ad attenderli lo scrittore e la moglie Maria. Nel caldo di un’estate siciliana infuocata, non vengono risparmiati all’inappuntabile intellettuale veneto, ragù ribollenti e succulenti manicaretti. Con lo stesso smarrimento che attanagliava il buon Chevalley tra le pagine de “Il Gattopardo”, Andreose rivolgendosi di soppiatto al vicino Leone, chiese furtivamente se il numero delle portate fosse destinato ad aumentare. Ricevuto, per tutta risposta, che si era solo all’inizio, allentò con discrezione il nodo della cravatta, estraendo un fazzoletto dal taschino della giacca, asciugando con altrettanta discrezione la fronte dalle minuscole gocce di sudore che imperlavano la sua fronte.
L’Espresso del 29 giugno 2021
LA SEDUZIONE: DALLA SIRENA A RETABLO
di Giovanna Di Marco

È il 1985 quando Vincenzo Consolo scrive la prefazione al saggio Sirene siciliane. L’anima esiliata di Lighea di Basilio Reale, uno studio che, seguendo i precetti del pensiero junghiano, analizza l’ultimo racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, La sirena. In poche pagine, Consolo delinea una sorta di geografia della letteratura siciliana, non prima però di espletarne un’altra: quella di alcuni suoi esuli. Ricorda infatti il suo primo incontro con Reale, avvenuto a Milano nel 1953: i due esuli dalla terra del mito, la Sicilia, provengono della stessa provincia (di Sant’Agata di Militello, Consolo, di Capo d’Orlando, Reale). Ma in questi esili ci fa ricordare quello di Vittorini e quello più antico di Verga.
“Scoprimmo subito, io e Reale, d’avere le stesse aspirazioni e ispirazioni, che da una parte si declinavano in prosa, dall’altra in poesia”.
Dal mito e dai vagheggiamenti sulla loro terra del mito, passano entrambi alla storia, alla necessità dell’impegno. Da qui parte la divisione ideale della letteratura siciliana in due indirizzi: “quello della storia e quello dell’esistenza (o della natura o del mito). Filoni che possono coincidere con le due parti dell’Isola”, dove a Occidente si riscontra il primo, a Oriente il secondo, con numerose e straordinarie eccezioni:
“E questa idealità è subito contraddetta fatalmente dalla realtà, da spostamenti di autori da una parte verso l’altra: di un poeta come l’abate Meli, per esempio, verso l’Arcadia, verso la mitologia dell’Oriente, o del grande De Roberto verso la storia e lo storicismo d’Occidente”.
E, da quella Finisterre, ‘di qua dal faro’, la Sicilia, Consolo intercetta un luogo, incrocio tra le due anime dell’Isola: Capo d’Orlando, che significa Lucio Piccolo. A lui è dedicata una sua opera, Lunaria, divagazione nel sogno con queste parole: “A Lucio Piccolo, primo ispiratore, con L’esequie della Luna. Ai poeti lunari. Ai poeti”.

Piccolo tra l’altro fu figura di riferimento anche per Reale, ed è individuato da Consolo come l’ispiratore della sirena per il cugino Tomasi di Lampedusa. Quest’ultimo alla storia aveva dedicato Il Gattopardo, ma si spostò nella Sicilia orientale per scrivere di Lighea e, appunto, per rivisitare il mito. La sirena di Piccolo appartiene più a quelle entità di “ninfe campestri, boscherecce, sia pure in apparenza stregonesche il senso panico della natura”. Ma certamente l’influsso di Piccolo determinò sul cugino la deposizione “dell’armatura teutonica del Principe Fabrizio di Salina” per l’approdo alla seduzione e a un ricongiungimento con lo spirito della Natura. Ma cosa è dunque Lighea per Consolo? Alla fine della prefazione al saggio ci dice che Lighea è un ipogeo, un profondo scavo archeologico. E tra questo andare e tornare tra storia e mito, Lighea è dunque la ricerca dell’originario, attraverso l’eterno femminino. Come i dialetti greci del professor La Ciura, protagonista del racconto La sirena di Tomasi, tutta l’opera consoliana è una ricerca continua dell’arcaico e dell’originario. Lo si riscontra anche nelle sue scelte linguistiche.

La ricerca di questo ipogeo, prima che nella Sicilia orientale de Le pietre di Pantalica – indimenticabile quell’incipit: “Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca” – possiamo riscontrarla nell’unica opera consoliana, pubblicata nel 1987, che ha come tema la seduzione erotica e conoscitiva: Retablo. La seduzione, in quest’opera ambientata nella Sicilia del Settecento – e che racconta due storie di amori infelici – è rappresentata da due donne: Teresa Blasco, nonna del Manzoni, amata da Fabrizio Clerici e Rosalia, la bella popolana per cui fugge il monaco Isidoro. Fabrizio Clerici, lombardo, discende in Sicilia per conoscere la terra degli antenati di Teresa, in un viaggio iniziatico che lo riporta al mito. Proprio le Sirene vengono evocate nell’ascolto del canto di alcune donne al bagno di Segesta nell’episodio centrale del romanzo tripartito:
“o chi si perse ascoltando una volta il canto stregato di Sirene, come mi persi anch’io nel vacuo smemorante, nel vago vorticare, nella felicità senza sorgente e nome, nel profondo jato che disgiunge il futuro dal passato”.

Ma è nella sezione iniziale e nella storia di Isidoro che l’eterno femminino prende forma. Da tensione irrazionale si fa monumento e si fa storia sotto l’effigie della bella Rosalia, prima presagita nelle forme muliebri della santa patrona palermitana, di cui la donna porta il nome: “Lo sai, uguale a la Santuzza, sei marmore finissimo, lucore alabastrino, ambra e perla scaramazza, màndola e vaniglia, pasta martorana fatta carne”, poi nel riconoscimento (una vera e propria agnizione) che avviene nell’Oratorio di San Lorenzo di Palermo: la statua in gesso della Virtù della Veritas, realizzata da Giacomo Serpotta, viene riconosciuta da Isidoro come l’amata Rosalia, che dello scultore era stata modella: “Davanti a una di quelle dame astanti, una fanciulla bellissima, una dìa, m’arrestai. VERITAS portava scritto sotto il piedistallo. Era scalza e ignude avea le gambe, su fino a cosce piene, dove una tunichetta trasparente saliva e s’aggruppava maliziosa al centro del suo ventre, e su velava un seno e l’altro denudava, al pari delle spalle, delle braccia… Il viso era vago, beato, sorridente… Mi sentii strozzare il gargarozzo, confondere la testa, mancare i sentimenti”.

La figura archetipica e la tensione erotica si trasformano per sempre, passando dalla Natura alla storia e consolidando in Consolo ciò che aveva anticipato nella prefazione al saggio di Reale: “un andare e tornare, un perenne oscillare, è un sondare e riattivare il sepolto e riportarlo alla luce”. Diventa dunque sintesi di movimenti opposti e incontro tra il primigenio e istintuale mito e la storia.
11 maggio 2021
Morel – Voci dall’isola
La luna di Consolo, tra passato e presente
di Irene Di Mauro
Lunaria, opera multiforme, come l’astro cui è dedicata la narrazione, si presenta come sintesi della sfiducia di Consolo nei confronti del genere letterario del romanzo, e della scrittura prosastica cui esso è collegato. È un esperimento poetico, teatrale, un ritorno alla tradizione siciliana del cuntu, in una prospettiva settecentesca, che risulta ricca di stimoli per una rilettura critica del presente, in quanto «la stessa metafora portante della Luna, proprio perché rimanda alla poesia e a valori di autenticità e umanità, conferisce uno spessore etico-politico a un testo che a prima vista parrebbe tutto fantastico, svagato, quasi dimentico della realtà».[1] Il linguaggio che dà forma e corpo allo scenario arcaico e immaginifico della narrazione, è quanto mai ‘verticale’, arricchito da continui rimandi poetici, resi espliciti in diversa misura e saturi di echi visionari:
Lo stile si avvicina alla poesia come mai prima era avvenuto: il testo pullula di anafore, allitterazioni, rime interne. Si assiste così a una sorta di tendenza mimetica per cui al tema dell’intima necessità per il mondo della poesia (simboleggiata dalla Luna) corrisponde uno stile che si fa poesia. Il linguaggio si presenta talvolta oracolare, la forma espressiva risulta nervosa, essenziale: la parola si fa incantatrice e trascina il lettore nella “poesia” della vita.[2]
Risulta quindi imprescindibile la comprensione di questa molteplicità di forme, linguaggi e riecheggiamenti, come l’eredità letteraria a cui l’autore ha attinto nella composizione della ‘favola teatrale’ della caduta e rinascita della luna. Quest’ultima, ‘astro’ da sempre presente nell’immaginario popolare, ha influenzato con la sua languida evanescenza poeti e scrittori, fin dal sesto libro della Farsaglia di Lucano, la cui rappresentazione nelle vesti di divinità funesta e ingannevole durante il celebre scontro tra Cesare e Pompeo, appare come la summa di un retaggio immaginifico proveniente dal pantheon greco. L’accezione magico-misterica della figura della dea, correlata all’inquietudine e alla melanconia sepolcrale delle ore notturne, per cui spesso viene associata all’oltretomba, è assimilata nella cultura latina alla figura delle «femmine tessale che svelgono la luna dal cielo»[3], descritte da Platone nel Gorgia. Sono molte le testimonianze di autori classici, segnalate da Leopardi nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, che attribuiscono poteri magici ad alcune donne risiedenti nella regione greca ed in particolar modo Virgilio, Seneca, Orazio, Ovidio, Tibullo, Stazio fanno riferimento all’operazione magica narrata da Platone. Non stupisce la rassegna di Leopardi, la cui produzione letteraria mostra come la luna sia un topos onnipresente nel panorama letterario, in cui vengono analizzate le ricorrenze nei testi antichi dell’immagine della caduta dell’astro, nei capitoli quarto e decimo Della magia e Degli astri nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi:«fu un nulla per gli antichi, dopo aver divinizzati gli astri, il supporre che qualcuno tra essi precipitasse talvolta dal cielo, con pericolo evidente di rompersi il collo».[4] Il retaggio popolare e letterario correlato alla luna viene ereditato da Lucano e filtrato attraverso la personale lente del poeta romano, che connota la narrazione della Farsaglia di sfumature grottesche e misteriche, dando forma ad uno dei più affascinanti temi letterari. Le suggestioni popolari sulla luna, trasformate in poesia da Lucano, saranno spunto per scrittori come Baudelaire e Goethe, che ne richiameranno l’accezione sepolcrale, nella formulazione di chiari rimandi alla letteratura latina. La luna delle visioni del poeta francese, sembra quasi la stessa che secoli prima era stata strappata dalla sua nicchia celeste dalla maga Erichto:
non la luna placida e discreta che visita il sonno degli uomini puri,
ma la luna strappata dal cielo, vinta e ribelle, che le Streghe della
Tessaglia costringono spietatamente a ballare sull’erba atterrita![5]
Baudelaire risente del fascino della «sinistra luna inebriante», a cui fa corrispondere la personificazione della donna, che la luna ha segnato «con il suo temibile influsso»[6] e la cui effimera immagine ha suscitato nel poeta il desiderio di imprimerla perpetuamente. Tuttavia, la donna ‘lunatica’ di Baudelaire, a differenza delle temibili incantatrici tessale, è in qualche misura ella stessa vittima del sortilegio lunare e fautrice dell’inganno dell’astro esclusivamente per potere riflesso. La luna conferisce alla donna amata la medesima forza attrattiva che l’uomo le ha, nei secoli, riservato:
Tu sarai bella alla mia maniera. Amerai quello che io amo e quello che mi ama: l’acqua, le nuvole, il silenzio e la notte; il mare immenso e verde; l’acqua informe e al contempo multiforme; il luogo in cui non sarai; l’amante che non potrai conoscere; i fiori mostruosi; i profumi che danno il delirio; i gatti che spasimano sui pianoforti gemendo come delle donne con voce roca e dolce!
“Sarai amata dai miei amanti, corteggiata dai miei cortigiani. […] di quelli che amano il mare, il mare immenso, tumultuoso e verde, l’acqua informe e al contempo multiforme; il luogo in cui non sono, la donna che non conoscono; i fiori sinistri che assomigliano ai turiboli di una sconosciuta religione, i profumi che sconvolgono la volontà, gli animali selvaggi e voluttuosi che sono gli emblemi della loro follia”.
Ed è per questo, maledetta fanciulla viziata, che ora sono ai tuoi piedi, cercando in tutto il tuo corpo il riflesso della temibile Divinità, della fatidica madrina, della velenosa nutrice di tutti i lunatici.[7]
È ormai evidente il distacco dalle violente immagini della Farsaglia, distacco suggerito e in qualche misura anticipato dal Faust di Goethe nel 1831:
Oh, fosse questa l’ultima volta, o Luna, che tu guardi sopra di me travagliato! quante volte dinanzi a questo leggio io ho vegliato tardi nella notte aspettandoti: e tu, mesta amica, sei pur sempre apparsa, a me su libri e su carte! Oh, potessi in sulle cime dei monti aggirarmi per entro la tua amabile luce, starmi sospeso cogli Spiriti in sui burroni, divagarmi, avvolto da’ tuoi taciti albori, sui prati, e, sgombro da tutte le vanità della scienza, bagnarmi e rinfrancarmi nella tua rugiada.[8]
Il corollario di immagini che accompagnano la comparsa della luna appare in ogni caso imprescindibilmente legato alla sfera orfica, immaginifica e dell’inconscio, tradizionalmente associata alle ore notturne. L’astro diviene strumento poetico per esaltare i dissidi dell’animo, «i quali, pur non conciliandosi, sembrano confondersi nell’alternanza in un unico sentimento che esprime la condizione esistenziale dell’uomo».[9] Questa accezione empatica, introdotta dai poeti romantici, trasmuta la luna in un essere non più vessillo di vendetta, brutalità e immonda crudezza, come era stata per Erichto, la maga che «asperge di abbondante umore lunare»[10] le sue vittime, dopo averne squarciato il petto e il ventre. La luna ora ha una dimensione più empatica, si presenta al poeta « soave come l’occhio dell’amico/ sul mio destino »[11] Gli epiteti a lei rivolti però, appaiono in qualche modo gli stessi, la luna che suscita i sospiri nei poeti romantici, è lo stesso astro che illuminava la notte precedente allo scontro di Cesare e Pompeo:
O tu, lassù, perennemente immune da vecchiaia, dai tre nomi e dalle tre forme, te invoco io, nella calamità del mio popolo, Diana, Luna, Ecate! Tu che i cuori sollevi, tu, assorta nei pensieri più profondi, tu tranquilla splendi, in te stessa ascosa e violenta, apri l’orribile abisso delle tue ombre, l’antica potenza si manifesti senza aiuto di magia.[12]
Dei Canti leopardiani, nel trentasettesimo inequivocabilmente, troviamo il cardine, la congiunzione tra il percorso evolutivo fin qui analizzato e l’opera di Vincenzo Consolo, che riassume e rielabora tutte le accezioni che la luna, nei secoli, ha assunto in ambito letterario. Il tema del sogno della luna caduta, è assimilato, in entrambi gli autori, dalle reminiscenze popolari classiche, in entrambi è spunto per la narrazione dialogica e teatrale, la cui voce più veritiera è affidata ai pastori, nel Canto leopardiano tratti dalla Favola pastorale di Guidobaldo Bonarelli:
ALCETA
Odi, Melisso: io vo’ contarti un sogno
di questa notte, che mi torna a mente
in riveder la luna. Io me ne stava
alla finestra che risponde al prato,
guardando in alto: ed ecco all’improvviso
distaccasi la luna; e mi parea
che quanto nel cader s’approssimava,
tanto crescesse al guardo; infin che venne
a dar di colpo in mezzo al prato; ed era
grande quanto una secchia, e di scintille
vomitava una nebbia, che stridea
sí forte come quando un carbon vivo
nell’acqua immergi e spegni. Anzi a quel modo
la luna, come ho detto, in mezzo al prato
si spegneva annerando a poco a poco,
e ne fumavan l’erbe intorno intorno.
Allor mirando in ciel, vidi rimaso
come un barlune, o un’orma, anzi una nicchia
ond’ella fosse svèlta; in cotal guisa,
ch’io n’agghiacciava; e ancor non m’assicuro.[13]
Ed è proprio ai pastori, i «villani della Contrada Senza Nome, che Consolo consegna il potere della «memoria, l’antica lingua, i gesti essenziali»[14] in grado, attraverso antichi rituali di sapore arcardico, di far rinascere in cielo la luna, e con essa «il sogno che lenisce e che consola»[15] e imprescindibilmente, la poesia. Il rito compiuto dai contadini con i cocci della luna infranta, richiama alla memoria la luna ancestrale latina, che risorge dall’oblio, insieme al retaggio mistico degli epiteti ad essa correlati:
PRIMA DONNA
Così è finita, così è stata
seppellita la Regina.
SECONDA DONNA
La Signora, la Sibilla,
la Ninfa Oceanina.
[…]
QUARTA DONNA
Ecate dei parti,
Kore risorgente,
QUINTA DONNA
Malòfora celeste,
Vergine beata.[16]
La danza delle contadine, con le litanie, «muta lamentazione di prefiche»[17], le vesti nere e i capelli sciolti, i «gesti essenziali» dei quali unico depositario sembra essere il popolo, che, custode delle diversità culturali, del variegato corollario di influenze ormai perduto altrove dalla campagna, si mostra unico artefice, grazie alle ‘esequie della luna’, della rinascita dell’astro. Solo il Viceré Casimiro, non a caso punto di contatto tra l’arcadico mondo contadino della Contrada Senza Nome e la Palermo settecentesca, mostra di percepire il lascito classico del prodigio lunare in atto, cadendo in una sorta di estasi visionaria in cui rivolge alla luna il suo lamento, che diviene supplica e invocazione:
Luna, Lucina, Artemide divina, possente Astarte, Thanit crudele, Baalet, Militta, Elissa, Athara, Tiratha, Regina degli Umori, Selene eterna dalle ali distese e celebrate, Signora, Dea dalle bianche braccia, perché abbandoni il luminoso scettro? […] Deh madre, sorella, sposa, guida della notte, méntore, virgilia, dimmi, parlami, insegnami la via.[18]
Divinità che richiamano la fertilità, la fecondità, l’amore, ma anche la guerra, la morte la bramosia di sacrifici. Consolo include tutte le sfumature e le accezioni dell’astro, richiamando gli aspetti più grotteschi e crudi, rispettando quelli più morbidi e romantici; la «letteratura sulla letteratura»[19] di cui parla Cesare Segre, si fa più che mai evidente, adempiendo alla verticalità da sempre caratterizzante la scrittura dell’autore, che si mostra consapevole e attento agli echi che la narrazione suscita:
Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su sé stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.[20]
La stessa attenzione dipinge di sfumature rossastre la luna che rischiara la notte dei villani della Contrada Senza Nome, mentre ammirano il fenomeno che ne anticipa la caduta, speculando, al pari degli antichi, sulla reale motivazione. Il particolare fenomeno introduce l’elemento magico-misterico della caduta, gettando la campagna sottostante in un’atmosfera tragica in cui si insinua l’ululato ultraterreno, a cui i contadini pronti rispondono parando i forconi. La luna rossa diventa condizione necessaria e anticipatrice della magia, come per Orazio nel Sermo VIII, segnalato da Leopardi:
Serpentes, atque videres
Infernas errare canes, lunamque rubentem,
Ne foret his testis, post magna latere sepulchra.
Orazio dà l’epiteto di rubentem alla luna, perchè questa appare infatti rossa al suo levarsi; e il poeta avea detto poco prima che le maghe per dar principio ai loro incantesimi aveano aspettato il sorger della luna:
Nec prohibere….(possum) modo simul ac vaga luna decorum
Protulit os, quin ossa legant, herbasque nocentes.[21]
L’incanto è introdotto dall’aleatoria presenza del lupo mannaro, percepibile dall’ululato che, sempre più forte, scatena le reazioni atterrite degli astanti:
OLIVA Mamma, il lupo mannaro!…
[…]
MELO Basta un graffio, in fronte…
PIETRO Una stilla di sangue…
VENERA Ma non c’è quadrivio, non c’è incrocio…
La tradizione a cui attinge Consolo per la composizione di questa spettrale atmosfera, torna ad essere nostrana, seguendo il filone delle leggende popolari da lui già esaminate nel 1977:
Un urlo bestiale rompeva il silenzio nella notte di luna piena. Ed era uno svegliarsi, un origliare dietro le porte serrate, uno spiare dietro le finestre socchiuse, un porsi in salvo al centro dei crocicchi o impugnare la lama per ferire alla fronte e far sgorgare gocce di nero sangue. […] Il lupo mannaro era l’incubo, lo spavento notturno, nella vecchia cultura contadina, carico di male e malefizio, contro il quale opponeva crudeli gesti esorcistici.[22]
L’attestazione di questa credenza popolare è lungamente descritta da Cervantes ne Los trabajos de Persiles y Sigismunda, dimostrando l’arcaica permanenza nell’immaginario siciliano della figura del lupo mannaro, e la definizione dialettale della patologia ad esso correlata è di indubbia provenienza araba: «male catubbo, derivato dall’arabo catrab o cutubu, che significano canino o lupino».[23] Cervantes mostra di essere a conoscenza della forte presenza in Sicilia di questa superstizione, costituendo una testimonianza seicentesca le cui reminiscenze appaiono nell’immaginario consoliano, così come nella pirandelliana novella Mal di luna:
Lo que se ha de entender desto de convertirse en lobos es que hay una enfermedad, a quien los médicos llaman manía lupina, que es de calidad que, al que la padece, le parece que se haya convertido en lobo, […] y hoy día sé yo que hay en la isla de Sicilia (que es la mayor del Mediterráneo) gentes deste género, a quienes los sicilianos laman lobos menar, los cuales, antes que les dé tan pestífera enfermedad lo sienten y dicen a los que están junto a ellos que se aparten y huyan dellos, o que los aten o encierren, porque si no se guardan, los hacen pedazos a bocados y los desmenuzan, si pueden, con las uñas, dando terribles y espantosos ladridos.[24]
Gli individui affetti da «manía lupina» avvertono i loro cari in prossimità dell’esternarsi dei sintomi, «que se aparten y huyan dellos, o que los aten o encierren», similmente al Batà di Pirandello, che si premura di mettere al sicuro la moglie dall’irruenza della sua trasformazione: «–Dentro… chiuditi dentro… bene… Non ti spaventare… Se batto, se scuoto la porta e la graffio e grido… non ti spaventare… non aprire… Niente… va’! va’!»[25]. Pirandello, rispetto alla precedente descrizione di Cervantes, introduce come elemento imprescindibile la luna, che diviene, come in Consolo, causa della trasformazione, ritratta, ancora una volta, in rossastre sfumature:
Batà mugolò di nuovo, si scrollò tutto per un possente sussulto convulsivo, che parve gli moltiplicasse le membra; poi, col guizzo d’un braccio indicò il cielo, e urlò:
– La luna!
Sidora, nel voltarsi per correre alla roba, difatti intravide nello spavento la luna in quintadecima, affocata, violacea, enorme, appena sorta dalle livide alture della Crocea.[26]
La luna interagisce e dialoga con i personaggi, intervenendo essa stessa nell’intreccio della vicenda, al pari di Lunaria, la cui influenza sui personaggi fa sì che possa essere annoverata «tra gli eroi e gli antagonisti, ‘oggetto del desiderio’ ricco di valenze simboliche, sognata, contemplata, persa, rimpianta e infine riconquistata».[27] La sequenza del racconto di Batà della contrazione del ‘male’ ricalca l’immaginario romantico del dialogo notturno con l’astro, richiamando gli scenari ritratti dai poeti ‘lunari’ e la stessa tipologia di interazione che si riscontra, tra le altre, in Claire de lune di Hugo, «la lune était sereine et jouait sur les flots»:[28]
che la madre da giovane, andata a spighe, dormendo su un’aja al sereno, lo aveva tenuto bambino tutta la notte esposto alla luna; e tutta quella notte, lui povero innocente, con la pancina all’aria, mentre gli occhi gli vagellavano, ci aveva giocato, con la bella luna, dimenando le gambette, i braccìni. E la luna lo aveva «incantato».[29]
Il Viceré di Lunaria risente a tal punto della sua influenza, da trasmutarsi in luna egli stesso, intonando una cantilena, o supplica, ricca di allitterazioni e assonanze, «in cui la quantità di sillabe si fa progressivamente più esigua fino a culminare, con geniale intuizione poetica, in un’unica sillaba, ampia e limpida, con un’assonanza nella ‘a’ che significa ‘luna’ in quella lingua antica e pura che ancora oggi si parla in Iran: il persiano classico»:[30]
Lena lennicula,
lemma lavicula,
làmula,
lémura,
màmula.
Létula,
màlia,
Mah.[31]
Ogni personaggio del microcosmo di Lunaria risente in qualche misura dell’influsso della rossastra luna in «quintadècima», il cui aspetto inconsueto genera un dibattito e le goffe argomentazioni avanzate dal dottor Elia, rimandano anch’esse in qualche modo alle arcaiche credenze popolari, che da sempre hanno cercato di colmare i vuoti del sapere, fornendo pittoresche spiegazioni ai fenomeni atmosferici:
DOTTOR ELIA Nessun prodigio. È solo morbo o fiotto per caso scivolato dal diurno Astro in su l’occaso, quand’è rosso scarlatto, ingallando l’argentea sembianza, la pallida sostanza della vergine, la solitaria pellegrina della notte…[32]
L’ironica caricatura del dottor Elia, che si affanna dietro il rudimentale cannocchiale nell’analisi delle inconsuete condizioni dell’astro, affiancato dall’aromatario Alì, che produce un’analisi meno accademica, ma più calzante in quanto supportata dall’osservazione diretta della natura, e le loro dissertazioni animate, diventano un esempio letterario della figura dell’uomo ignorante ritratta da Leopardi:
La credulità è, e sarà sempre, come sempre è stata, una sorgente inesauribile di pregiudizi popolari. […] Un uomo ignorante, e che nella maggior parte delle cose non presume di sapere più di un altro crederà sempre tutto ciò che gli verrà detto, e stimerà effetto di folle arroganza ed anche di stupidità il dubitarne. Si sarà sempre credulo finchè non si saprà esaminare, o almeno non si ardirà tentare di farlo, […] Accade però bene spesso che gl’ignoranti non siano assai docili, e non prestino fede facilmente a chi vuol persuaderli di qualche verità. […] L’affezione che quell’uomo ha per le antichissime opinioni e per le vecchie costumanze delle genti di villa; la profonda venerazione che conserva per i suoi maggiori che gliele hanno trasmesse e raccomandate caldamente; […] altrettante sorgenti di errori popolari inespugnabili; renderanno inutili le cure di chi travaglierà a disingannarlo.[33]
La «profonda», ma spesso fuorviante, «venerazione», di cui parla Leopardi, viene espressa con vigore macchiettistico dal dottor Elia, che con estrema confusione mette a tacere mastr’Alì, tacciandolo di mancanza di spessore culturale, elencando una sequela di luminari di svariate discipline, allo scopo di conferire dignità alle proprie credenze, nonostante l’identità di alcuni di loro sia ignota: «Tacete, pratico! Voi non avete letto- voi non sapete leggere- in libri autorevoli. Voi non conoscete Ippocrate, Galeno, Avicenna, Bellèo, Alàimo, Petronillo…».[34] La lacuna generata da una parziale mancanza di supporto scientifico, viene colmata dall’uomo con l’immaginazione, che genera, tra le altre, le astruse teorie dell’Accademia dei Platoni Redivivi, spunto per Consolo di una caustica satira sul sapere, i cui protagonisti sono ridotti ad astratte categorie. L’Accademico Anziano, l’ Astronomo, il Fisico, il Metafisico, il Protomedico, si ritrovano a «pontificare sulla luna, coscienti della loro importanza e sapienza, mostrando conoscenze scientifiche e idee preconcette del Settecento»[35], creando un’ulteriore legame con le riflessioni leopardiane sull’approccio ai fenomeni astronomici:
Si vede un effetto meraviglioso, e come avviene bene spesso, se ne ignora la cagione. […] Ciò bastava per far nascere un pregiudizio, poichè l’uomo non si contenta di osservare un effetto, rimanendo nella sua mente affatto incerto intorno alla causa di esso. Sovente egli si forma subito nel suo intelletto un’idea ordinariamente falsa di ciò che può produrlo. […] Le stelle si vedevano muoversi regolarmente e con ordine invariabile: esse si crederono animate. […] Da che sono nati tutti questi errori, se non dall’ignoranza delle cause?[36]
In antitesi, questa «idea ordinariamente falsa», a patto di formarsi negli animi incontrovertibilmente inclini alla scrittura, che non attribuiscono ai doni dell’immaginazione dignità scientifica, genera poesia, mito, che fin dagli albori della civiltà umana è intervenuto là dove la scienza coeva era manchevole. E il mito della luna sembra aver avuto un crollo, al pari della luna di Lunaria, in un preciso momento individuato da Consolo nelle considerazioni conclusive sulla genesi dell’opera stessa, conferendo a Piccolo il primato di aver anticipato,
(o l’aveva anticipato Leopardi?) quello che sarebbe effettivamente accaduto da lì a qualche anno- la caduta del mito della luna, appunto-, che il 21 luglio del 1969 un’astronave di nome Apollo-il fratello gemello di Diana- approdasse sulla superficie di quell’astro e che degli uomini lo profanassero danzandovi sopra con i loro scarponi di metallo (ah, fu quello un giorno fatale per i poeti, ma Piccolo fece in tempo a non viverlo, era scomparso nel maggio di quello stesso anno).[37]
L’amara, ma profondamente ironica, considerazione di Consolo, sembra estendersi, attraverso il generico appellativo di ‘poeti’, a chi abbia sognato la luna e abbia trasformato questo sogno in poesia. Il viaggio sulla luna, astro prima d’ora irraggiungibile, ha incantato poeti e scrittori, che hanno tentato di colmare il divario tecnologico con l’assegnazione di connotazioni sempre diverse all’ipotetica conquista della stessa: a partire da Dante, fino a Calvino, la luna ha cambiato il proprio volto, ma è rimasta sempre, pur sotto diversi aspetti, specchio dell’umano. E l’impavido paladino di Ariosto, il poeta «cosmico e lunare»[38] viene richiamato alla memoria da Consolo in forma diretta all’interno dell’opera, a suggellare la connessione che, attraverso i secoli, perdura nella letteratura di chi omaggia la luna:
Là, dove giunse Astolfo in groppa all’Ippogrifo per cercarvi il senno del folle Paladino, là, come canta il Poeta, è dammuso, catoio, pozzo nero di tutte le carenze, le pazzie, i sonni, gli oblii, gli errori della Terra.
Dall’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro difetto
o per colpa di tempo o di fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.[39]
Ariosto assegna alla luna il ruolo di detentrice di ciò che sulla terra è stato perso e la descrizione operatane risulta reduce di precedenti lezioni, alcune accolte, altre riprese ironicamente. Tra di esse troviamo l’esempio più illustre, il viaggio dantesco, i cui versi sono esplicitamente riportati nell’opera di Consolo, che affronta, tra le questioni dottrinali, quella delle macchie lunari, spunto di dissertazione sulle caratteristiche dell’astro:
La concreata e perpetüa sete
del deïforme regno cen portava
veloci quasi come ’l ciel vedete.
[…]
Parev’ a me che nube ne coprisse
lucida, spessa, solida e pulita,
quasi adamante che lo sol ferisse.
Per entro sé l’etterna margarita
ne ricevette, com’ acqua recepe
raggio di luce permanendo unita.[40]
La superficie lunare viene indagata da un punto di vista astronomico, con particolare attenzione alla presenza di imperfezioni sulla sua superficie, sulla cui origine Dante interroga Beatrice:
Ma ditemi: che son li segni bui
di questo corpo, che là giuso in terra
fan di Cain favoleggiare altrui?».[41]
La luna di Ariosto, al contrario, ironicamente «non ha macchia alcuna», pur presentando un paesaggio speculare a quello terreno, per sottolinearne il legame con le vicende umane. Il poeta appare d’altro canto accogliere la descrizione presente nel Somnium di Leon Battista Alberti, in cui Libripeta annovera «enormi vesciche piene di adulazione, di menzogne, di flauti e trombe risonanti» accostate ai «benefici: sono ami d’oro e d’argento»[42], costruendo un paesaggio speculare a quello albertiano:
Vide un monte di tumide vesiche,
che dentro parea aver tumulti e grida;
e seppe ch’eran le corone antiche
e degli Assirii e de la terra lida,
e de’ Persi e de’ Greci, che già furo
incliti, et or n’è quasi il nome oscuro.
[…]
Ami d’oro e d’argento appresso vede
in una massa, ch’erano quei doni
che si fan con speranza di mercede
ai re, agli avari principi, ai patroni.[43]
Descrizione ritrovata nell’arringa dell’Accademico Eccentrico in Lunaria, che richiama alla mente degli astanti il volo siderale di Astolfo, e le conseguenti osservazioni sul suolo lunare: «si fe’ allora specchio, retaggio, monito perenne, ricettacolo delle sventure umane, fondaco d’otri, di vessiche, di regni, filosofie, idoli trapassati».[44] Il momento di congiunzione tra la visione letteraria di Ariosto e la valenza che la luna assume nell’opera di Consolo, ultimo baluardo di poesia contro l’inaridimento e l’afasia, si manifesta in Calvino, che, ripristinando tramite la narrazione iconografica del Castello dei destini incrociati il viaggio ariostesco, preannuncia le riflessioni consoliane, immaginando il paladino Astolfo nell’atto di interrogare un solitario poeta, ultimo abitante lunare:
Quale saggezza trarre per norma della Terra da questa Luna del delirio dei poeti? Il cavaliere provò a porre la domanda al primo abitante che incontrò sulla Luna: il personaggio ritratto nell’arcano numero uno, Il Bagatto, nome e immagine di significato controverso ma che qui pure può intendersi — dal calamo che tiene in mano come se scrivesse — un poeta.
Sui bianchi campi della Luna, Astolfo incontra il poeta, intento a interpolare nel suo ordito le rime delle ottave, le fila degli intrecci, le ragioni e sragioni. Se costui abita nel bel mezzo della Luna, — o ne è abitato, come dal suo nucleo più profondo, — ci dirà se è vero che essa contiene il rimario universale delle parole e delle cose, se essa è il mondo pieno di senso, l’opposto della Terra insensata.[45]
La poesia rimane dunque l’ultimo elemento sull’astro ormai spoglio, ben lontano dalla ricchezza paesaggistica in Ariosto e maggiormente affine al sentire di Consolo: «la vita lassù, impraticabile, si fe’ esigua, disparve mano a mano».[46] Nonostante il decorso che l’astro ha avuto in entrambi gli scrittori, la luna continua ad avere un’ incontrastata, probabilmente ineguagliata, valenza poetica:
«No, la Luna è un deserto,» questa era la risposta del poeta, a giudicare dall’ultima carta scesa sul tavolo: la calva circonferenza dell’Asso di Denari, «da questa sfera arida parte ogni discorso e ogni poema; e ogni viaggio attraverso foreste battaglie tesori banchetti alcove ci riporta qui, al centro d’un orizzonte vuoto.»[47]
Il Viceré Casimiro e gli abitanti di Lunaria
I figuranti che ruotano intorno alla luna sono occasione in Consolo per compiere quella critica sociale, onnipresente nelle sue opere, in cui lo scrittore doveva necessariamente impegnarsi per non risultare complice delle incongruenze del presente. Persino un’opera così strettamente legata all’immaginifico mondo settecentesco, grazie alla sapiente caratterizzazione dei personaggi, «figure archetipiche che si elevano a categoria di universali, incarnando realtà ontologiche e qualità permanenti»[48] diviene strumento di lettura dell’umano, prescindendo dal momento storico. Primo fra tutti il Viceré, di cui viene svelato l’inganno già dalle prime pagine attraverso l’espediente del manichino, scudo e alter ego del regnante, inganno confermato dall’epilogo che mostra la profonda consapevolezza di un disilluso Viceré di rappresentare un’effige di un potere fittizio, il cui risveglio, dipinto con sfumature squisitamente ironiche, sembra ricalcare le patetiche rimostranze del Giovin Signore del Giorno di Parini: «No, no, no… Avverso giorno, spietata luce, abbaglio, città di fisso sole, isola incandescente…»[49]. Il Viceré viene pazientemente accudito dal valletto Porfirio, similmente ai servi fedeli, che si affrettano a schermare i raggi del sole per favorire il sonno tardivo del nobile parodiato da Parini:
Già i valetti gentili udìr lo squillo
de’ penduli metalli a cui da lunge
moto improvviso la tua destra impresse;
e corser pronti a spalancar gli opposti
schermi a la luce; e rigidi osservaro
che con tua pena non osasse Febo
entrar diretto a saettarte i lumi.[50]
La caricatura di regnante offerta dal Viceré Casimiro, a cui viene dato maggiore spazio rispetto alla precedente versione di Piccolo, con la quale l’opera di Consolo ha un esplicito rapporto di complementarità, è in origine dipinta dal barone sulla falsa riga del fratello Casimiro, con palesi intenti canzonatori confermati dalla descrizione fattane dallo stesso Consolo, in cui l’ossessione per le bacinelle d’acqua, disseminate in ogni dove all’interno della dimora nobiliare, ricorda l’ossessione del Viceré di Piccolo per la tintura, di cui erano ricolme numerose ciotole, similmente posizionate all’interno dell’abitazione:
Ogni tanto appariva anche il fratello, il barone Casimiro, bello fresco rasato ed elegante come dovesse uscire per qualche festa. Era invece, come mi rivelò una volta in gran confidenza, ch’egli dormiva di giorno e vegliava di notte, e nel tardo pomeriggio, quando s’alzava, faceva toilette perché più tardi sarebbe cominciata la sua grande avventura dell’attesa notturna delle apparenze, delle materializzazioni degli spiriti. Il barone era un cultore di metapsichica e studiava trattati e leggeva riviste come “Luci e ombre”. Mi spiegò una sua teoria sulle materializzazioni, non solo di uomini, ma anche di cani,
di gatti, mi disse che a quelle presenze, per lo sforzo nel materializzarsi, veniva una gran sete ed era per questo che per tutta la casa, negli angoli, sotto i tavoli, faceva disporre ciotole piene d’acqua.[51]
Il processo di rielaborazione del reale, innestato alle componenti storico-immaginifiche su cui affonda le radici l’intreccio della narrazione, viene puntualmente esaminato da Sciascia, le cui riflessioni sullo stile di Piccolo sono estendibili al sentire poetico di Consolo, essendo entrambi fautori di uno stile barocco e verticale:
Ma la realtà è, per un poeta barocco specialmente, insufficientemente poetica: e viene perciò sottoposta a un processo di «degnificazione». Vale a dire che la realtà viene per troppo amore soppressa, liquidata, nel punto stesso della massima esaltazione.[52]
I due autori, specchio di due modi diversi di intendere la scrittura barocca e il proprio apporto alla società, di aristocratico distacco in uno, di convinto e profondo intervento nell’altro, hanno in comune la piena adesione al sostrato spagnolo da cui la cultura palermitana in special modo è stata profondamente influenzata:
Il macabro, nello stesso tempo fastoso, caratteristico di certi ambienti e di certe mentalità di Palermo (che ora non ci sono più, credo) proviene dalla Spagna, proviene dall’elemento spagnolo che noi palermitani abbiamo subìto molto.[53]
Non è un caso che Cesare Segre assimili la figura del Viceré a quella del Principe Sigismondo de La vida es sueño di Calderòn de la Barca[54], in quanto i due nobili condividono entrambi i volti della speranza: il sogno e l’illusione. L’intera esistenza per Sigismondo è sogno, dominata dall’illusorietà, intrinseca nella sfera onirica, in cui illusorio è persino il tempo, realtà fugace e velleitaria, del cui sentire il Viceré Casimiro si mostra in qualche misura erede:
Tutto è macèria, sabbia, polvere, erbe e arbusti ch’hanno coperto i loro resti. Malinconia è la storia. Non c’è che l’universo, questo cerchio il cui centro è ovunque e la circonferenza da nessuna parte, questo incessante cataclisma armonico, quest’immensa anarchia equilibrata. Ma se malinconia è la storia, l’infinito, l’eterno sono ansia, vertigine, panico, terrore. Contro i quali costruimmo gli scenari, i teatri finiti e familiari, gli inganni, le illusioni, le barriere dell’angoscia.[55]
Tuttavia l’epilogo della medesima inferenza è differente: la morte come unica realtà possibile per il principe polacco, disvelatrice delle illusioni dell’esistenza e dell’inconsistenza dell’universo sensibile, la luna per il Viceré palermitano, «questa mite, visibile sembianza, questa vicina apparenza consolante, questo schermo pietoso, questa sommessa allegoria dell’eterno ritorno. Lei ci salvò e ci diede la parola, Lei schiarì la notte primordiale, fugò la dura tenebra finale».[56] L’inganno della realtà teatrante viene svelato e Sigismondo, divenuto Principe, non è più Sigismondo, d’altro canto Casimiro non è più il Viceré, ammette con amarezza di averlo malvolentieri impersonato e teatralmente si sveste delle effigi del potere, abbandonando scettro e mantello. È proprio nei momenti essenziali del racconto, il prologo e l’epilogo, che Consolo denuncia la natura metateatrale di Lunaria, in cui i confini tra realtà e finzione vengono consapevolmente e visibilmente intrecciati, per restituire al lettore un ordito di sensibile profondità critica:
Dal “Preludio”, il Viceré, collocato dietro il suo manichino che chiama “quel muto commediante di quest’Opra”, presenta lo scenario dove si sviluppa la favola, spogliato della sua personalità come fosse un attore mentre recita il suo proemio: “E qui è il corpo grande, la maschera della giovine disfatta, la rossa, la palmosa, la bugiarda…”. Al termine dell’opera, nel suo “Epilogo”, Consolo è ancora più esplicito: “Non sono più il Viceré. Io l’ho rappresentato solamente (depone lo scettro, si toglie la corona e il mantello). E anche voi avete recitato una felicità che non avete. Così Porfirio (Porfirio si spoglia della livrea, degli scarpini, del turbante)”.[57]
Il lascito di entrambe le sceneggiature teatrali, è ancora una volta speculare: «è finzione la vita, malinconico teatro, eterno mutamento»[58], «Qué es la vida? Una ilusiòn, una sombra, una ficciòn…»[59], in quanto l’esplicito impianto teatrale diviene spunto per polemizzare, attraverso i due periodi storici in cui operano gli autori, barocco per Calderon de la Barça e moderno per Consolo, sulla vuotezza dei ruoli societari, rovesciando i rapporti di potere attraverso l’intreccio della narrazione. In Consolo l’esasperazione delle dicotomie negli exempla di accademici, la cui ironica categorizzazione riflette la staticità del ruolo e la cristallizzazione del pensiero, svela le contraddizioni di chi presumibilmente detiene il sapere, ma sceglie di avvalersene autoreferenzialmente. Ad essi, così come agli ecclesiastici, a cui il Viceré riserva caustici interventi, i quali, irrimediabilmente distanti dalla sostanza ascetica e spirituale cui la loro veste dovrebbe tendere, digradano verso le bassezze della gola, dell’avarizia e dell’abuso di potere, Consolo contrappone la saggezza popolare dei villani della Contrada Senza Nome. Essi, provenienti da una contrada spogliata dai nomi dei luoghi, e quindi in qualche modo dalla propria storia, recuperano i gesti essenziali e la memoria dell’antica lingua, dei rituali atavici, in cui risiede la poesia e dunque la rinascita del mito della luna. Sotto un sole «tiranno indifferente, occhio che abbaglia, che guarda e che non vede»[60] si consuma il decadimento di una Palermo che è effige dell’intera società siciliana, al pari della Regalpetra di Sciascia, che è in ogni dove e in nessun luogo, in quanto realtà altra, ma plasmata dallo stampo di tutte le desolanti realtà su cui l’occhio sagace dello scrittore si è posato. E la desolante realtà presentata da Consolo è quella di un mondo «antico e nuovo, carico di memoria, invaso dall’oblio»[61] e nell’ossimoro si consuma la ricchezza del popolo siciliano. La catarsi anelata da Consolo, inquieta supplica alle Muse nell’epiclesi, ha un’unica via per la sua manifestazione: «un velo d’illusione, di pietà, / come questo sipario di teatro»[62] e non è forse la luna, «sipario dell’eterno»[63], l’assoluzione, il riscatto, praticando essa stessa la catarsi rinascendo sopra le contrade siciliane? La poesia, come la storia è imperituro teatro destinato alla malinconia dell’eterno ritorno, ed è nella sua intrinseca attitudine alla rinascita che risiede la salvezza dell’uomo.
«Dopo è l’arresto, l’afasia. È il
silenzio».[64]
[1] Gianni Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, in Vincenzo Consolo, L’opera completa, a cura di Gianni Turchetta, I Meridiani, Milano, Mondadori, 2015, p. LV.
[2] Paola Baratter, Lunaria [di Vincenzo Consolo]: il mondo salvato dalla Luna, «Microprovincia», Stresa, XLVIII, 2010, pp. 85-93.
[3] Platone, Gorgia, citato in Giacomo Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, a cura di Prospero Viani, Firenze, Le Monnier, 1851, p. 47.
[4] G. Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, a cura di Prospero Viani, Firenze, Le Monnier, 1851, pp. 127-128.
[5]Charles Baudelaire, Il desiderio di dipingere, in Lo Spleen di Parigi. Poemetti in prosa, XXXVI, in. Tutte le poesie e i capolavori in prosa, trad. di Claudio Rendina, Roma, Newton & Compton, 1998, pp. 549-551.
[6] Ibidem.
[7]C. Baudelaire, I benefici della luna, XXXVII, Ivi, p.552.
[8] Johann Wolfgang Goethe, Faust, capitolo I, traduzione di G. Scalvini, Milano, Giovanni Silvestri, 1835, p. 22.
[9] Giovanni Carpinelli, Invocazioni poetiche alla luna, «Belfagor», 21 giugno 2014, http://machiave.blogspot.com/2014/06/invocazioni-poetiche-alla-luna.html
[10] Lucano, Farsaglia, cit., vv. 667-669.
[11]J. w. Goethe, An den mond (Alla luna), Vienna, Diabelli, 1850, vv. 7-8.
[12]J.W. Goethe, Faust e Urfaust, traduzione, introduzione e note di G. V. Amoretti, Feltrinelli, Milano, 1965, p. 451.
[13] Ivi, XXXVII Canto, Odi, Melisso o Lo spavento notturno, pp. 141-142, vv. 1-20.
[14] V. Consolo, Lunaria, cit., p. 80.
[15] Ibidem.
[16] Ivi, pp. 71-72.
[17] Ibidem.
[18] Ivi, p. 65.
[19] Cesare Segre, Un profilo di Vincenzo Consolo, in Vincenzo Consolo, L’opera completa, a cura di Gianni Turchetta, I Meridiani, Milano, Mondadori, 2015, pp. XIV-XV.
[20] Ibidem.
[21] Orazio, Sermo VIII, citato in G. Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, cit., p. 37.
[22] V. Consolo, Paesaggio metafisico di una folla pietrificata, «Corriere della Sera», 19 ottobre 1977.
[23] Daragh O’Connell, La notte della ragione – fra politica e poetica in Nottetempo, casa per casa, Milano, Università degli Studi, 6 – 7 marzo 2019, http://vincenzoconsolo.it/?p=1815 [ultimo accesso: 14 novembre 2020]
[24] Miguel de CERVANTES, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, a cura di C. Romero, Madrid, Cátedra, 2002, p. 244.
[25] Pirandello, Male di luna, «Corriere della Sera», 22 settembre 1913, poi in Le due maschere, Quattrini, Firenze 1914, poi nella nuova edizione riveduta della raccolta dal titolo Tu ridi, Milano, Treves, 1920 col titolo Quintadecima, ora in Id. Novelle per un anno, in Opere di Luigi Pirandello, vol I, Milano, Mondadori, 1980, pp. 1297-1298.
[26] Ibidem.
[27] P. Baratter, Lunaria [di Vincenzo Consolo]: il mondo salvato dalla Luna, cit., pp. 85-93.
[28] V. Hugo, Claire de lune, Les Orientales, Parigi, Ollendorf, 1912, p. 670, v. 1.
[29] Pirandello, Male di luna, cit., pp. 1300-1301.
[30] Irene Romera Pintor, Introduzione a Lunara: Consolo versus Calderòn, a cura di G. Adamo, La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, Lecce, Manni, 2006, p.171.
[31] V. Consolo, Lunaria, cit., p.60.
[32] Ivi, p .46.
[33] G. Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, cit., pp. 300-01.
[34] V. Consolo, Lunaria, Milano, Mondadori, 2013, p.45.
[35]Irene Romera Pintor, Introduzione a Lunara: Consolo versus Calderòn, cit., pp.166-167.
[36] G. Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, cit., pp.302-03.
[37] V. Consolo, Lunaria, pp.125-26.
[38] I. Calvino, Una pietra sopra: discorsi di letteratura e società, Torino, Einaudi, p. 183.
[39] V. Consolo, Lunaria, cit., p. 64.
[40] D. Alighieri, Canto II, Paradiso, Commedia, a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio, Firenze, Le Monnier, 1984, vv. 19-36.
[41] Ivi, vv. 49-51.
[42] L. B. Alberti, Intercenales, a cura di Bacchelli e D’Ascia, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 228-241.
[43] L. Ariosto, Orlando Furioso, XXXIV, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 2015, vv. LXXVI-LXXVII.
[44] V. Consolo, Lunaria, cit., p.64.
[45] I. Calvino, Il castello dei destini incrociati, Milano, Mondadori, 2016, p.40.
[46] V. Consolo, Lunaria, cit., p.64.
[47] Ivi, p.41.
[48] I. R. Pintor, La parola scritta e pronunciata, cit., p. 169.
[49] V. Consolo, Lunaria, cit., p.18.
[50] G. Parini, Il mattino, (seconda edizione), Il Giorno, in Id., Il giorno, le odi, dialogo sopra la nobiltà, introduzione e note di Saverio Orlando, Milano, Rizzoli, 1978, vv.70-75.
[51] V. Consolo, Il barone magico, «L’Ora», 17 febbraio 1967.
[52] L. Sciascia, Le “soledades” di Lucio Piccolo, in La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, Torino, Einaudi, 1970, p. 23.
[53] A. Pizzuto, L. Piccolo, L’oboe e il clarino, a cura di A. Fo e A. Pane, Milano, Scheiwiller, 2002, pp. 177-181.
[54] C. Segre, Teatro e racconto su frammenti di luna, in Intrecci di voci, Torino, Einaudi, 1991, pp. 87-102.
[55] V. Consolo, Lunaria, cit., p. 80.
[56] Ibidem.
[57] I. R. Pintor, La parola scritta e pronunciata, cit., pp. 169-170.
[58] V. Consolo, Lunaria, p.85.
[59] Don Pedro Calderon de la Barça, La vida es sueno, II Giornara, scena 19, a cura di C. Morón, Madrid, Catedra, 2005, vv. 2183-4.
[60] V. Consolo, Lunaria, cit., p.85.
[61] Ibidem.
[62] V. Consolo, Catarsi, cit.
[63] V. Consolo, Lunaria, cit., p.85.
[64] V. Consolo, Per una metrica della memoria, Relazione tenuta al Centro di Studi sul Classicismo di Palazzo Pratellesi a San Gimignano in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Milano, 12 gennaio 1996, versione cartacea in «Bollettino ‘900 – Electronic Newsletter of ‘900 Italian Literature», VI-XI, 1997, pp. 25-29.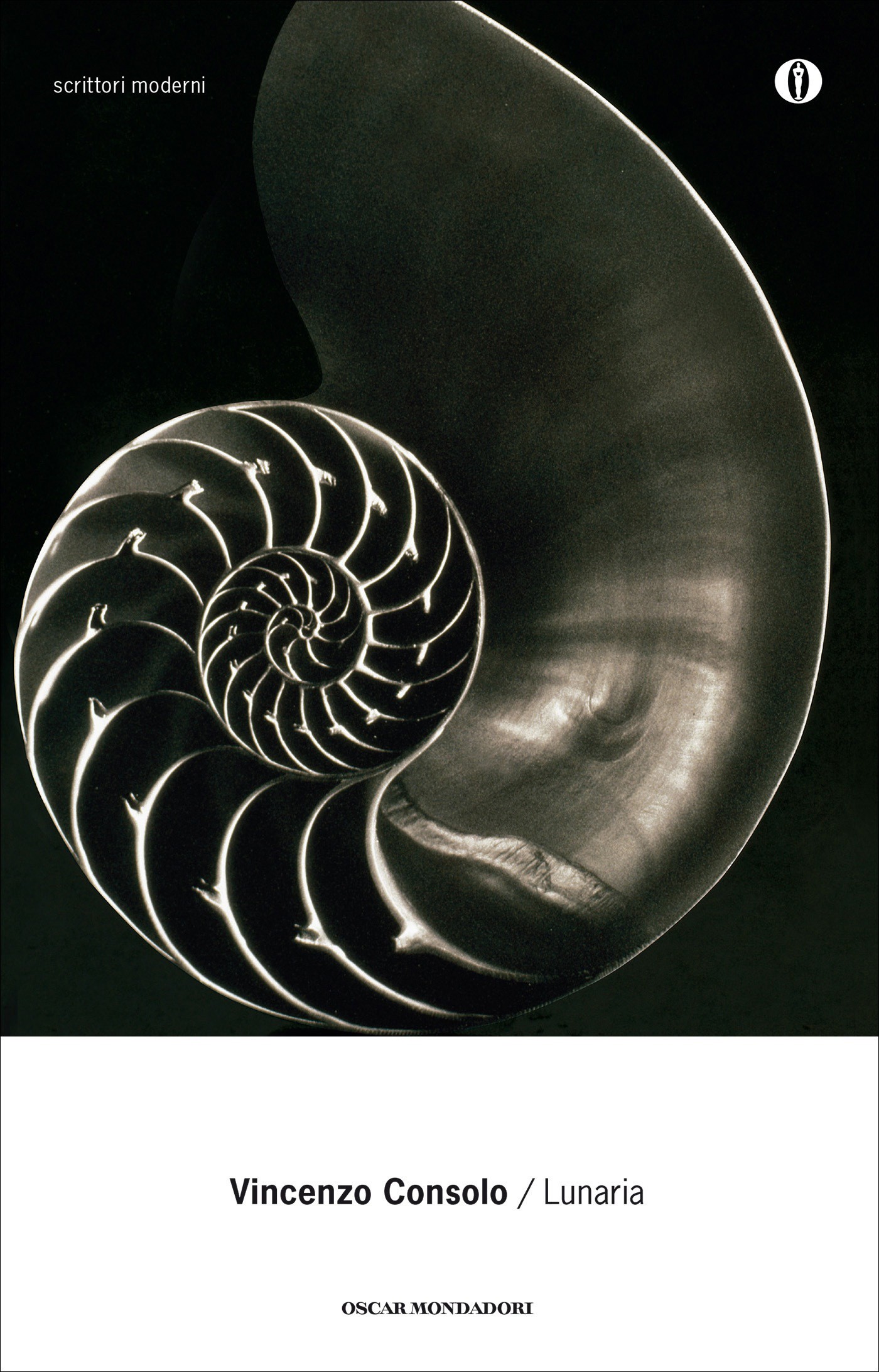
Vincenzo Consolo, Memorie
In memoria di Caterina
Dopo La grande vacanza orientale-occidentale (2001) e Il prodigio (2014), le Edizioni Libreria Dante & Descartes di Napoli, nel piccolo formato che le contraddistingue, consegnano, in questo luglio del 2020, un testo di Vincenzo Consolo intitolato Memorie, già pubblicato nella raccolta di saggi La mia isola è Las Vegas (Milano, Arnoldo Mondadori, 2012).
Questo prezioso libricino gode della prefazione di Claudio Masetta Milone, uno dei soci fondatori dell’associazione «Amici di Vincenzo Consolo», collaboratore anche con il Centro Studi iniziative culturali Pio La Torre, di Palermo. Claudio Masetta Milone è anche uno dei fondatori della «Casa della Letteratura di Vincenzo Consolo» a Sant’Agata Di Militello, paese natio dello scrittore.
A scanso di equivoci e senza nessun compiacimento verso le proprie motivazioni, Vincenzo Consolo chiarisce ciò che intende con il vocabolo «Memorie»:
Avrei potuto, o potrei, giunto alla mia età, riempire pagine e pagine di ricordi, di memorie, ricostruire, al di là d’ogni validità letteraria, un tempo perduto, stendere una mia, un’umile, piccola recherche. Ma non è questo il moto e lo scopo del mio scrivere (p. 5).
Rievocando il rapporto esistenziale che lega lo scrittore al suo paese di origine, Claudio Masetta introduce dialetticamente la tematica memoriale, quasi creasse un dialogo tra sé, il lettore e lo scrittore: «Fare memoria significa essenzialmente narrare» (p.12). Ma come nasce la narrazione? Nasce innanzitutto dal bisogno insaziabile di Consolo di ascoltare di nuovo i minimi particolari della sua zona, che siano geografici, umani, sociali o linguistici. Precisa Claudio Masetta: «L’ascolto dei fatti santagatesi era lo scoglio da cui, ogni volta, la narrazione spiccava il volo, nello spazio e nel tempo» (p.12-13).
Ricorrentemente desideroso di definire la propria identità di uomo e di scrittore (ciò che fece in molti scritti), Vincenzo Consolo evoca la posizione geografica di Sant’Agata Di Militello. Comune sito a mezza strada tra Messina e Cefalù, la zona divide la Sicilia orientale, la Sicilia greca, terra di miti, la cui espressione si svolge prevalentemente «in forme poetiche, in toni lirici, in scansioni musicali (p. 25), dalla Sicilia occidentale, influenzata dagli Arabi, un’area segnata dalla storia, dai molteplici colonizzatori, dai conflitti sociali, e «che si esprime in forme prosaiche, in toni discorsivi, in scansioni logiche» (p. 26).
Su questa «immaginaria linea» (p. 27), data la posizione di Sant’Agata di Militello, su questo crinale, nasce la poetica consoliana.
I ricordi, le memorie legati a Sant’Agata, pur cari che siano, pur essendo il crogiolo di alcuni suoi racconti, non bastano a soddisfare la sua creatività che si estende «alla Sicilia tutta, all’Italia, al Mediterraneo e oltre, (…). Ma [si dispiega] anche dal presente al passato – o sarebbe meglio dire – ai passati dell’isola» (Claudio Masetta, «Prefazione», p. 13).
+
Il tono si fa man mano più grave e le domande incalzanti. Quasi con trepidazione, Vincenzo Consolo chiede a se stesso: «E allora: perché scrivo? Ma perché scrivo in prosa? E perchè scrivo romanzi o racconti di contenuto storico o sociale» (p. 36). Permeato dalla superiorità della poesia, si riferisce a componimenti di poeti maggiori (cita qualche verso della «Ginestra» di Leopardi, allude al poemetto di T. S. Eliot, «La terra desolata», alla raccolta di Eugenio Montale, Ossi di seppia, nonché al suo componimento «La bufera»). Consolo si arrende alla constatazione non priva di rammarico, che non è stato eletto a questo registro:
Scrivo dunque di temi relativi, contingenti, perché non sono poeta, perché non sono un fanciullo, perché non sono re (non faccio parte, voglio dire, non sono detentore del potere). Solo i poeti infatti, i fanciulli e i re possono affrontare gli assoluti, immergersi naufragare nell’infinito mare dell’esistenza (p. 37).
Fra queste linee, traspare la figura del viceré Casimiro, personaggio centrale della favola teatrale Lunaria (1985), opera in cui Vincenzo Consolo si avvicina maggiormente al mito e alla poesia. Casimiro, essere malinconico e lunare, a metà strada tra re-fanciullo e poeta, in grado di capire, fino ad un certo punto, la lingua poetica, edenica di San Fratello (vicino a Sant’Agata), vero baluardo utopico contro il disfacimento della corte palermitana, su cui regna Casimiro da troppo tempo.
Come non pensare agli eccentrici Casimiro e Lucio Piccolo, poeta quest’ultimo che affascinava Consolo?
Sul dritto filo di queste parole, in un altro breve scritto, «Considerazione sulla forma racconto», in Prodigio (Edizioni Dante & Descartes, 2014), ricorda la sua scelta narrativa:
…l’unico racconto praticabile mi sembra quello storico-metaforico (…) ; che un modo per praticare ancora una letteratura non ipotecata dal potere è quello di risacralizzare il linguaggio, di restituirgli memoria, tono e modulazione di poesia : riaccostarlo, per irriducibile, al linguaggio liturgico dei poemi (p. 25).
Consapevole di essere cresciuto e vissuto per anni in bilico tra Oriente ed Occidente, tra mito e storia, tra natura e cultura, Vincenzo Consolo approda al nucleo della sua ricerca letteraria:
E non è questo poi l’essenza della narrazione ? Non è il narrare, come dicevo, quell’incontro miracoloso, di ragione e passione, di logica e di magico, di prosa e di poesia ? Non è questo ibrido sublime, questa chimera affascinante ? (p. 50-51).
Non si può parlare dell’identità letteraria di Vincenzo Consolo senza evocare il terzo polo d’influenza della sua poetica: la città di Milano, dove si trasferisce nel 1969. Andirivieni incessanti tra la capitale lombarda e la sua isola ritmano d’ora in poi la sua vita e la sua produzione. A questa città «progredita, ricca e allettante, ma anche dura, ma anche pretenziosa» (p. 52-53), Consolo oppone un orgoglioso riserbo, pur essendo aperto ai fermenti e alla cultura della metropoli europea. Ma ha continuamente l’attenzione rivolta ai fatti siciliani.
L’attualità di questo ultimo ventennio è prevalentemente segnata dal fenomeno migratorio. È da tempo giunto il momento per l’Europa di aiutare popoli che soffrono per le guerre, per le malattie e la povertà. Le ricchezze si devono oramai condividere con i paesi più poveri e l’ordine mondiale viene totalmente travolto da questa urgente necessità. La Grecia e la Sicilia sono le porte di ingresso verso questo nuovo eldorado. Ventuno anni fa, nel 1999, Vincenzo Consolo era uno tra i pochissimi intellettuali ad affrontare questa questione nella sua raccolta di saggi Di qua dal faro (Milano, Arnaldo Mondadori Editore), nel capitolo «Uomini sotto il sole» (p. 227). Scrive:
Di questi esodi massicci e incessanti le cronache di ogni giorno ci consegnano tragici episodi: di clandestini soffocati dentro stive di navi; d’altri, scoperti, gettati in pasto ai pescicani; di bambini assiderati nei passaggi notturni per valichi montani; di carghi colati a picco con dentro il loro carico umano; di criminali che trasportano su gommoni e abbandonano sulle spiagge masse di disperati.
Claudio Masetta ricorda i momenti trascorsi a parlare con Consolo, in conversazioni in cui la questione, specie
dacché la Libia è in guerra, dei profughi riaffiora. Parlano di cultura greca, ma non solo, e di un presente ostile che provoca l’ira dello scrittore contro il ricordo del tempo dell’ospitalità siciliana che fu:
E della cultura mediterranea che, (…), si è sempre sviluppata sotto il segno dell’accoglienza. I fatti di cronaca odierna, l’innalzamento di barriere laddove un tempo c’erano spiagge d’approdo di innumerevoli naufraghi che, una volta a terra, nella sua Sicilia, potevano dirsi sicuri di trovare accoglienza, lo avrebbero fatto urlare di sdegno e vergogna.
Amava cercare i segni di questa antichissima tradizione di ospitalità siciliana. Si entusiasmava alle prove dell’avvenuta integrazione, sul suolo siciliano, di culture e tradizioni diverse (p. 15-16).
Claudio Masetta riporta, in confidenza, sempre con valore didattico per il lettore, un aneddoto interessante su questo argomento: quello del santuario della Madonna Nera di Tindari che è sito nel grandioso golfo di Patti, in provincia di Messina. Tindari è stata costruita nel 396 A. C. da Dionisio I°, tiranno di Siracusa, al fine di fronteggiare gli attacchi dei Cartaginesi. Il suo nome originario era Tyndaris. A picco sul mare, il santuario raccoglie quella singolare Vergine bizantina nera con il bambino, alto simbolo di accoglienza dei naufraghi, la quale impedì alla nave che la trasportava di ripartire sul mare, così evitando l’inesorabile naufragio dovuto alla tempesta.
E Claudio Masetta, restituendoci lo scrittore Consolo nella sua intera dimensione umana e umanistica: «Aveva una collezione di santi neri, Vincenzo. Amava quella collezione come simbolo di felice integrazione» (p. 18).
Con particolare acuità, Claudio Masetta insiste per ultimo sul bisogno di trasmettere alle nuove generazioni le chiavi del linguaggio così particolare di Vincenzo Consolo: al tempo stesso popolare ed erudito. Non si entra facilmente nella prosa consoliana e lui lo intuiva, lo sapeva. Tanti incontri fece con giovani di liceo o freschi universitari, molto spesso confrontati al suo linguaggio stratificato, complesso, a volte criptato. Ma non era mai semplice esercizio di chiarimento di tale passo, pur studiato nei particolari. Il pubblico liceale o universitario era da lui prediletto perché vergine da alcun a priori sul linguaggio letterario. Si dilettava di questi incontri con il giovane pubblico, quasi dovesse concretizzare la propria vocazione di pedagogo.
Al di là però, si trattava sempre di infondere ai giovani una certa conoscenza della letteratura siciliana. Consolo amava tramandare la memoria, e così scrive Claudio Masetta: «la memoria attraverso la narrazione era per lui fatto da condividere. In modo particolare con i giovani, a cui si rivolgeva, verso i quali amava riversare il racconto della Sicilia, della storia, ma soprattutto della letteratura» (p. 19-20).
Per concludere, il libretto Memorie, racchiude molto del pensiero di Vincenzo Consolo, un pensiero mai uniforme, così come sono molteplici e variegate le forme della sua espressione letteraria e della sua poetica.
Claudio Masetta Milone, nel riproporre la lettura di questo testo, nel sollecito ascolto delle parole dell’amico scrittore, nel trascriverle, ha il merito (tra tanti altri), di contribuire in modo originale, ad una più ampia conoscenza del pensiero universale di Vincenzo Consolo, e a ravvivarne le idee umanistiche con luce odierna.
Maryvonne Briand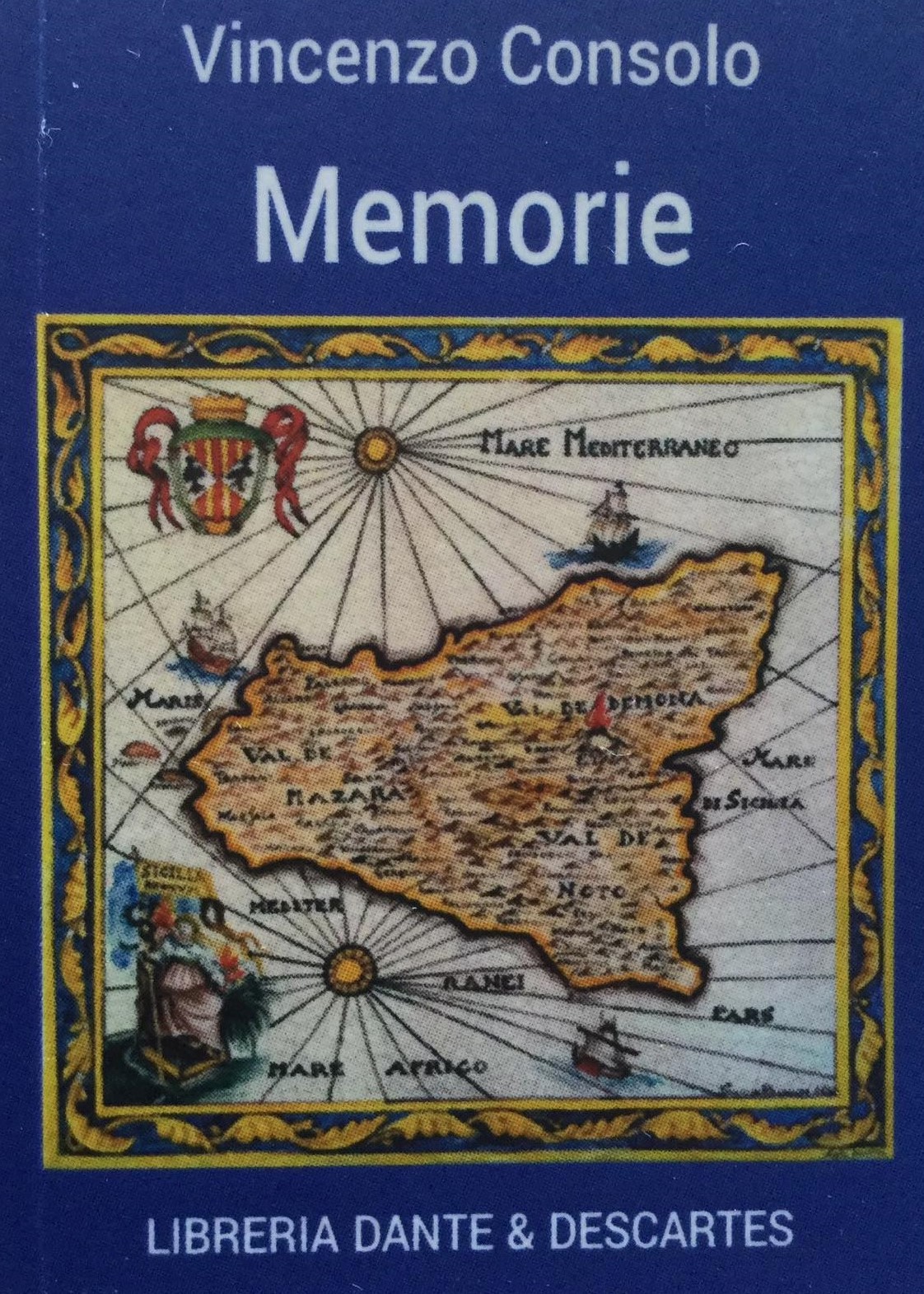
Vincenzo Consolo lettore di Pirandello
CINZIA GALLO
L’attenzione e l’interesse di Consolo per Pirandello sono costanti, come dimostrano i numerosi riferimenti, espliciti od impliciti, allo scrittore agrigentino che Consolo dissemina in gran parte dei suoi lavori. La figura di Pirandello sembra intanto esemplificare la profonda influenza esercitata dai luoghi sugli individui. Infatti, se «si può cadere su questo mondo per caso, […] non si nasce in un luogo impunemente. […] senza essere subito segnati, nella carne, nell’anima da questo stesso luogo» (Consolo 2012: 135)2. In Uomini e paesi dello zolfo, allora, Consolo asserisce: «E, come Pirandello, ogni siciliano credo possa dire “son figlio del Caos”. È il caos prima della formazione del cosmo, la materia informe, la “mescolanza di cose frammiste” di cui parla Empedocle (anch’egli nato nel “caos” d’Agrigento)» (Consolo 1999: 9). Ovviamente Consolo si riferisce alla grandissima varietà della terra siciliana3, dal punto di vista fisico, che gli eventi storici, però, riproducono: Ora qui, per inciso, vogliamo notare che la storia, la storia siciliana, abbia come voluto imitare la natura: un’infinità, un campionario di razze, di civiltà sono passate per l’isola senza mai trovare tra loro amalgama, fusione, composizione, ma lasciando ognuna i suoi segni, qua e là, diversi, distinti dagli altri e in conflitto: 1 Cinzia Gallo, Università di Catania. 2 Consolo ricorda, anche, quanto Pirandello asserisce su se stesso: «Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d’olivi saraceni…» (Consolo 2012: 135). 3 Sottolinea Consolo: «[…] la Sicilia, […] quest’isola in mezzo al Mediterraneo è quanto fisicamente di più vario possa in sé raccogliere una piccola terra. Un vasto campionario di terreni, argille, lave, tufi, rocce, gessi, minerali… E quindi varietà di colture, boschi, giardini, uliveti, vigne, seminativi, pascoli, sabbie, distese desertiche. In questa terra sembra che la natura abbia subìto come un arresto nella sua evoluzione, si sia come cristallizzata nel passaggio dal caos primordiale all’amalgama, all’uniformazione, alla serena ricomposizione, alla benigna quiete. Sì, crediamo che tutta la Sicilia sia rimasta per sempre quel caos fisico come quella campagna di Girgenti in cui vide la luce Pirandello da qui, forse, tutto il malessere, tutta l’infelicità storica della Sicilia, il modo difficile d’essere uomo di quell’isola, e lo smarrimento del siciliano, e il suo sforzo continuo della ricerca d’identità. Ma questi problemi ci porterebbero lontano, nel magma esistenziale o nel procelloso mare pirandelliano, ed è meglio quindi che rimaniamo ancorati alla terra (Consolo 1999: 10). Dunque, proprio perché Pirandello è «Uomo di zolfo» (Consolo 1999: 26), vissuto a stretto contatto con lo zolfo, ne tratta compiutamente nelle sue opere, che assumono carattere di denunzia. Consolo sottolinea così come nella novella Il fumo appaia chiaramente la «distruzione della campagna da parte della zolfara» (Consolo 1999: 18), mentre in Ciàula scopre la luna «la condizione del caruso […] viene fuori in tutta la sua straziante pena; e […] nei vecchi e i giovani […] il tema dello zolfo serpeggia, prima sommessamente, […] fino ad esplodere nel finale con la rivolta degli zolfatari e con l’eccidio dell’ingegner Aurelio Costa e della sua amante […]» (Consolo 1999: 27). Questi temi, attestanti la funzione civile della letteratura, sempre presente in Consolo, si articolano però in una filosofia «che non è sistema chiuso e definitivo, ma progressione verso […] la poesia» (Consolo 1999: 26). Sembrerebbe, questa, una giustificazione, una spiegazione della narrazione poematica a cui Consolo approda, a partire da L’olivo e l’olivastro, anche se già ne Il sorriso dell’ignoto marinaio se ne notano delle avvisaglie. Pirandello, «un certo Pirandello novelliere e romanziere» rappresenterebbe, inoltre, la letteratura della Sicilia occidentale, «zona fortemente implicata con la storia, […] marcata da temi di ordine relativo – la storia, la cultura, la civiltà, la pace o la guerra sociale», mentre Verga simboleggerebbe la letteratura della Sicilia orientale, «contrassegnata […] da temi di ordine assoluto: la vita, la morte, il mito, il fato […]» (Consolo 2012: 134)4. È stato perciò Pirandello – sottolinea Consolo – a dare ai personaggi siciliani «l’arma della dialettica, del sofisma» (Consolo 1999: 121), in sostituzione della violenza, delle passioni istintive che guidavano i contadini di Verga5. Lo spazio ristretto del villaggio di Trezza, allora, «si restringe ancora di più, si riduce alla stanza borghese, in quella che Giovanni Macchia chiama “la stanza della tortura”, dove si compie ogni violenza, lacerazione, crisi, frantumazione della realtà, perdita di identità. Il movimento, in quella stanza, è solo verbale» (Consolo 1999: 269). 4 Consolo aveva espresso queste idee già nel 1986, in Sirene siciliane, considerando, però, questa «Divisione ideale, immaginaria, […]. E questa idealità è subito contraddetta fatalmente dalla realtà, da spostamenti di autori da una parte verso l’altra: di un poeta come l’abate Meli, per esempio, verso l’Arcadia, verso la mitologia dell’Oriente, o del grande De Roberto verso la storia o lo storicismo d’Occidente» (Consolo 1999: 178-179). 5 Queste idee sono confermate nel 1999, ne Lo spazio in letteratura. Pirandello avrebbe rotto «il cerchio linguistico verghiano», portandolo «su una infinita linearità attraverso il processo verbale, la perorazione, la dialettica, i dissoi lógoi: […] squarcia la scena con la lama dell’umorismo, trasforma l’antica tragedia nel moderno dramma» (Consolo 1999: 269). Non stupisce, dunque, che i due autori, Pirandello e Verga, siano posti uno di fronte all’altro ne L’olivo e l’olivastro. E non è certamente un caso che sia Pirandello, in questo testo, a rendersi conto dell’isolamento, dell’estraneità, nel suo stesso ambiente, retrivo, di Verga, estraneità che un sapiente uso dell’aggettivazione, delle figure retoriche (anafore, metafore, enumerazioni) sottolinea, costituendo, appunto, un esempio di scrittura poematica: Pirandello lo osservò ancora e gli sembrò lontano, irraggiungibile, chiuso in un’epoca remota, irrimediabilmente tramontata. Temette che né il suo, né il saggio di Croce, né il vasto studio del giovane Russo avrebbero mai potuto cancellare l’offesa dell’insulsa critica, del mondo stupido e perduto, a quello scrittore grande, a quell’Eschilo e Leopardi della tragedia antica, del dolore, della condanna umana. Pensò che, al di là dell’esterna ricorrenza, delle formali onoranze, in quel tempo di lacerazioni, di violenza, di menzogna, in quel tramonto, in quella notte della pietà e dell’intelligenza, il paese, il mondo, avrebbe ancora e più ignorato, offeso la verità, la poesia dello scrittore. Pensò che quel presente burrascoso e incerto, sordo alla ritrazione, alla castità della parola, ebbro d’eloquio osceno, poteva essere rappresentato solo col sorriso desolato, con l’umorismo straziante, con la parola che incalza e che tortura, la rottura delle forme, delle strutture, la frantumazione delle coscienze, con l’angoscioso smarrimento, il naufragio, la perdita dell’io. Pensò che la Demente, la sua Antonietta, la suor Agata della Capinera, la povera madre, il fratello suicida di San Secondo, ogni pura fragile creatura che s’allontana, che sparisce, non è che un barlume persistente, segno di un’estrema sanità nella malattia generale, nella follia del presente (Consolo 1994: 67). «Follia del presente» (Consolo 1994: 67) è sicuramente anche quella descritta da Consolo in gran parte dei suoi lavori: pensiamo alla realtà distorta, stravolta, frantumata propria di tutti i testi consoliani, da Il sorriso dell’ignoto marinaio a Lo Spasimo di Palermo. Giustamente, quindi, Consolo è, sostiene Anna Frabetti, un «autore di linea pirandelliana […] in cui il sublime precipita in umoristico, il dramma borghese […] degenera nella “vastasata”, nella farsa del mondo rovesciato, privo di centro» (1995: 1). Una «Vastasata» (Consolo 1985: 10), del resto, è presente in Lunaria, in cui il Vicerè recita «la sua parte di sovrano» (Consolo 1985: 26), definisce «finzione la vita» (Consolo 1985: 66), si mostra consapevole, ricorrendo ad interrogative retoriche ed enumerazioni, della vanità, del carattere relativo del reale: «Dov’è Abacena, Apollonia, Agatirno, Entella, Ibla, Selinunte? Dov’è Ninive, Tebe, Babilonia, Menfi, Persepoli, Palmira? Tutto è maceria, sabbia, polvere, erbe e arbusti ch’hanno coperto i loro resti» (Consolo 1985: 61); e Tutti commentano, con sapiente uso delle figure retoriche: «Così è stato e così [anafora] sempre sarà [poliptoto]: rovinano potenze, tramontano imperi regni civiltà [enumerazione], cadono astri, si sfaldano, si spengono [climax], uguale sorte hanno mitologie credenze religioni. Ogni fine è dolore, smarrimento ogni mutazione [chiasmo], stiamo saldi, pazienza, in altri teatri, su nuove illusioni nascono certezze» (Consolo 1985: 34). E la Sesta donna: «Tutto si frantuma, / cade, passa [climax]» (Consolo 1985: 54). Su questa scia, nella prima sezione di Retablo, Isidoro scorge, nella chiesa di S. Lorenzo, una statua, che reca sul piedistallo la parola«VERITAS» (Consolo 1992: 19), dalle fattezze simili a quelle di Rosalia, ad attestare il carattere apparente, relativo del reale. Lo stesso significato ha, nella terza sezione, l’espressione «Bella, la verità» (Consolo 1992: 149)6 ripetuta da Rosalia che, del resto, sottolinea esplicitamente il contrasto fra apparenza e realtà: «Bagascia, sì, all’apparenza, ma per il bene nostro, tuo e mio»; «Fu per questo che scappai, ch’accettai questa parte dell’amante, questa figura della mantenuta» (Consolo 1992: 149, 155). Se pirandelliana è la costrizione dell’individuo in una forma, Pirandello offre pure le coordinate con cui spiegare l’aspirazione ad essere diversi da quello che si è e con cui si ritiene che ciò sia possibile modificando l’aspetto esteriore, la propria forma, a svuotare di consistenza ruoli e funzioni. Ecco che Consolo, ne Le vele apparivano a Mozia, ricorda come l’«autista-inserviente-guardiano» del pittore Guttuso7, «dal bel nome greco dalla Spagna poi donato alla Sicilia d’Isidoro8 […] come nella novella di Pirandello Sua Maestà, in un desiderio di mimesi, di immedesimazione, si vestiva alla stessa maniera del padrone: giacca e pantaloni blu, camicia azzurra, pullover rosso, fazzoletto rosso che trabocca dal taschino» (Consolo 2012: 124). Anche l’importanza data ai nomi si pone, del resto, sulla scia di Pirandello, che – è noto – istituisce uno stretto «rapporto» fra «nome – identità dei personaggi» (De Villi2013: 278), «per affinità o per antifrasi» (De Villi 2013: 277). Analogamente Consolo esclama: «il destino dei nomi!» (Consolo 2012: 128)9. E la parola, il nome è spesso segno di predestinazione o di destino. Dei nomi dati agli uomini, voglio dire, e dei destini degli uomini: il destino dei nomi. Ma non sappiamo se è l’uomo sul nascere, già segnato da un destino, che si versa e assesta dentro il suo giusto e appropriato involucro di nome (e cognome) oppure se sono il nome e il cognome che, capitati per caso sulla pelle di un uomo come maglietta e brache, ne incidono le carni, ne determinano cioè il destino (Consolo 2012: 66). Definisce, così, le poesie della poetessa Assunta Della Musa, «fra le più ispirate, le più eccitate, le più squisite e belle tra le poesie d’amore scritte in tutti i tempi e in tutti i luoghi. […] Può una donna di nome Assunta Della Musa, coniugata ad Apollo Barilà, non scrivere poesie, essere della poesia, essere la poesia? Essere Erato, la poesia erotica?» (Consolo 2012: 69). Perciò, non a caso, con chiara allusione al leopardiano Dialogo di Plotino e Porfirio, in cui quest’ultimo è 6 Cfr., su questo argomento, Galvagno 2015: 39-64. 7 È, questi, l’unico pittore a cui Consolo attribuisce, ne L’enorme realtà, «il dono della capacità del racconto, della rappresentazione […] che hanno avuto scrittori come Verga, come Pirandello, come Sciascia» (Consolo 1999: 271). 8 Con caratteristiche simili, a confermare l’importanza dei nomi, in Lunaria si chiama Isidoro il maestro di cerimonie del Vicerè, attento alle apparenze, «intransigente custode di […] inderogabili forme palatine» (16). 9 In Lunaria, gli abitanti della «selvaggia Contrada senza nome» sono «uomini senza legge, senza lingua, senza storia, anime boschive, […]» (61).
consapevole della «vanità di ogni cosa» (Leopardi 1978: 530), si chiama Porfirio il valletto di Casimiro, il vicerè di Lunaria, che non prende mai la parola, ma è consapevole della «recitazione» (Consolo 1985: 10) del suo signore. Lucia, poi, si chiama – per antifrasi in rapporto all’etimologia del nome –, la sorella di Petro Marano, affetta da disturbi mentali. E il quinto capitolo di Nottetempo, casa per casa, che la mostra, alla fine, pazza, reca, in epigrafe, una battuta di Come tu mi vuoi: «Chiami, chi sa da qual momento lontano… felice…/ della tua vita, a cui sei rimasta sospesa… là…» (Consolo 1992: 59). Erasmo, ancora, con probabile riferimento ad Erasmo da Rotterdam e al suo Elogio della follia – oltre che, a confermare la rilevanza attribuita dal nostro scrittore allo spazio – al piano di sant’Erasmo, nei dintorni di Palermo, si chiama il «vecchietto lindo, bizzarro» (Consolo 1998: 103) de Lo Spasimo di Palermo, a cui è affidato il compito di mettere in evidenza, alla fine del romanzo, l’importanza della letteratura. Costui, infatti, coinvolto nell’attentato al giudice Borsellino, recita, in punto di morte, due versi de La storia di la Baronissa di Carini, ad attestare come, anche se al presente la letteratura non è ascoltata, è da questa, voce della tradizione, della memoria storica, che deve venire la salvezza: O gran mano di Diu, ca tantu pisi, cala, manu di Diu, fatti palisi! (Consolo 1998: 131) E, ancora, Consolo dichiara: «La salvezza è stata solo nel linguaggio. Nella capacità di liberare il mondo dal suo caos, di rinominarlo, ricrearlo in un ordine di necessità e di ragione» (Consolo 1999: 272). Petro Marano, perciò, si aggrappa «alla parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete», desideroso di «rinominare, ricreare il mondo» (Consolo 1992: 42-43). Egli, poi, alla fine si rifugia a Tunisi, così come anche Lando Laurentano avrebbe voluto imbarcarsi per Malta o per Tunisi (Pirandello 1953: 394). Consolo, quindi, mette in relazione, attraverso la figura di Antonio Crisafi de La pallottola in testa, il disagio, l’estraneità dell’intellettuale nella moderna società, sia quella del «Meridione depresso» (Consolo 2012: 157) sia quella legata all’avvento dei mass media, della televisione, all’isolamento del professor Lamis de L’eresia catara di Pirandello. Ed anche in Un giorno come gli altri, discutendo della funzione dell’intellettuale, Consolo si richiama a Pirandello. A proposito, infatti, della differenza, instaurata da Moravia e Vittorini, fra artista e intellettuale, egli asserisce: A me la distinzione sembra vecchia, mi ricorda l’affermazione di Pirandello: “La vita, o la si scrive o la si vive”. Ché l’alternativa, oltre a valere per tutti, non solo per l’artista, dopo Marx non ha più senso. Oggi siamo tutti intellettuali, siamo tutti politici, […]. Il problema mi sembra che stia nel voler essere o no dentro le “regole”, nel voler essere o no, totalmente, incondizionatamente, dentro un partito, dentro la logica “politica” di un partito. Questo mi sembra il punto, il punto di Vittorini (Consolo 2012: 91-92). Arriva, quindi, alla sua celebre distinzione fra scrivere e narrare: Riprendo a lavorare a un articolo per un rotocalco sul poeta Lucio Piccolo. Mi accorgo che l’articolo mi è diventato racconto, che più che parlare di Piccolo […] in termini razionali, critici, parlo di me, della mia adolescenza in Sicilia, di mio nonno, del mio paese: mi sono lasciato prendere la mano dall’onda piacevole del ricordo, della memoria. […] È […] il narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, […]. Diverso è lo scrivere, […] operazione […] impoetica, estranea alla memoria, che è madre della poesia, come si dice. E allora è questo il dilemma, se bisogna scrivere o narrare. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perché il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro sulla carta (Consolo 2012: 92)10. Pirandello simboleggia la Sicilia, insieme a Verga, Meli, Capuana, secondo il mafioso catanese, sottoposto al 41 bis nel carcere di Opera – Milano, dopo aver «fatto un bel po’ di strada negli affari, appalti, commerci vari» (Consolo 2012: 216): Consolo ironizza sulla politica separatista, portata avanti dal Movimento indipendentista siciliano di Finocchiaro Aprile e, di conseguenza, sulla politica della Lega Nord, sottolineando ancora una volta l’importanza della memoria storica. Si pone, ancora, accanto a Pirandello, dichiarando che Il sorriso dell’ignoto marinaio «era d’impianto storico» ma «voleva anche dire metaforicamente del momento che allora si viveva, a Milano e altrove» (Consolo 2012: 119): «(si svolgeva negli anni del Risorgimento e dell’impresa garibaldina: nodo di passaggio storico importante per il Meridione e banco di prova della maggior parte degli scrittori siciliani – Verga, De Roberto, Pirandello, Lampedusa, Sciascia…)» (Consolo 2012: 119)11, accomunati tutti, «da Verga a De Roberto, a Pirandello», da «un costante immobilismo» (Consolo 1999: 169)12, pur nella diversità delle posizioni ideologiche. In particolare, se la rinuncia a rappresentare la rivolta parrebbe accomunare Il sorriso dell’ignoto marinaio a I vecchi e i giovani, le motivazioni dei due scrittori sono differenti. Consolo, consapevole «dei limiti di classe degli intellettuali», nutre «sfiducia nella possibilità, da parte della letteratura, di rendere la visione e il sentire delle classi subalterne senza stravolgimenti mistificatori»; Pirandello, invece, è mosso da un profondo «pessimismo» che lo induce «a svalutare anche gli eventi più tragici ed epocali come frutto di vane illusioni e follie destinate ad essere cancellate dal 10 Nel 1997, richiamandosi alle tesi espresse da Walter Benjamin in Angelus novus, Consolo preciserà: «E c’è, nella narrazione, un’idea pratica di giustezza e di giustizia, un’esigenza di moralità». (Consolo 1999: 144). Per quest’argomento, cfr. Francese 2015. L’influsso di Benjamin su Consolo è stato evidenziato anche da Daragh O’Connell (2008: 161-184), che ricorda la traduzione in italiano de Il narratore di Benjamin effettuata, per Einaudi, da Renato Solmi nel 1962 (162, nota 2). 11 Pure ne Il sorriso, vent’anni dopo, Consolo asserisce che il suo romanzo è nato da una «rilettura della letteratura che investe il Risorgimento, soprattutto siciliana, ch’era sempre critica, antirisorgimentale, che partiva da Verga e, per De Roberto e Pirandello, arrivava allo Sciascia de Il Quarantotto, fino al Lampedusa de Il Gattopardo» (Consolo 1999: 279). 12 Consolo ricorda come i critici di orientamento lukácsiano avessero posto Il Gattopardo accanto a I Vicerè di De Roberto e a I vecchi e i giovani di Pirandello (Consolo 1999: 173). tempo, […]» (Baldi 2014: 254). In entrambi i romanzi, però, il Risorgimento si risolve in una «disillusione del vecchio sogno della terra» (Consolo 2012: 109)13 e nei pensieri di Lando Laurentano si scorge un’eco di quei contrasti di classe che Consolo pone in primo piano14: «Da una parte il costume feudale, l’uso di trattar come bestie i contadini, e l’avarizia e l’usura; dall’altra l’odio inveterato e feroce contro i signori e la sconfidenza assoluta nella giustizia, si paravano come ostacoli insormontabili a ogni tentativo per quella cooperazione» (Pirandello 1953: 392)15. E precedentemente, ascoltando il discorso di Cataldo Sclàfani, considera: «Una buona legge agraria, una lieve riforma dei patti colonici, un lieve miglioramento dei magri salarii, la mezzadria a oneste condizioni, come quelle della Toscana e della Lombardia, come quelle accordate da lui nei suoi possedimenti, sarebbero bastati a soddisfare e a quietare quei miseri […]» (Pirandello 1953: 288). Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio, del resto, anche la figura di Garibaldi, su cui si concentrano le aspettative dei ‘giovani’ (Roberto Auriti, Mauro Mortara, Corrado Selmi, Rosario Trigona), consente di stabilire delle corrispondenze con Pirandello. Consolo, difatti, sottolinea il favore ottenuto da Garibaldi («[…] vanno dicendo che [Garibaldi] gli dà giustizia e terre.»), ritenuto però, al tempo stesso, un «Brigante. Nemico di Dio e di Sua Maestà il Re […] Scanna monache e brucia conventi, rapina chiese, preda i galantuomini e protegge avanzi di galera…» (Consolo 2004: 66). E ribadisce le sue riserve su Garibaldi anche in altri testi. Parlando, nel 1982, della rivolta di Bronte, dell’agosto 1860, Consolo, oltre ad evidenziare la «crudeltà», la «sommarietà di giustizia» (Consolo 2012: 108) di Bixio, afferma riguardo Garibaldi: In questa annata di celebrazione garibaldinesca in chiave post-moderna, in cui tutti gli stili, le citazioni, i repêchages si fanno stile, in cui le pagine chiare e oscure, le glorie e le vergogne, le vittime e gli scheletri, più che nascosti nell’armadio, esibiti si fanno levigato stile eroico, gloriosa epopea da consumo, soffermarsi 13 Scrive Pirandello: «Sì, aveva esposto la verità dei fatti quel deputato siciliano: quei contadini di Sicilia, […] s’erano recati a zappare le terre demaniali usurpate dai maggiorenti del paese, amministratori ladri dei beni patrimoniali del Comune: intimoriti dall’intervento dei soldati, avevano sospeso il lavoro ed erano accorsi a reclamare al Municipio la divisione di quelle terre; […]» (Pirandello 1953: 238). 14 Pensiamo a quest’episodio, che trova corrispondenza nella terza scritta al nono capitolo: «“Ah ah, puzzo di merda, papà, ah ah” sentirono ancora alle spalle che faceva Salvatorino, grasso come ‘na femmina, babbalèo, mammolino, ancora a quindici anni sempre col dito in bocca, la bava e il moccio, unico erede, presciutto tesoro calasìa, al padre professore Ignazio e al nonno sindaco, il notaio Bàrtolo. / Tanticchia girò la testa sopra il tronco e lo guatò sbieco. / “Garrusello e figlio di garruso alletterato!” disse, e poi sputò per terra, bianco e sodo, tondo come un’onza» (Consolo 2004: 95-96). 15 Lo stesso Consolo ricorda le «Insurrezioni che spesso non sono solo contro i borbonici, ma di contadini e braccianti contro i loro nemici di sempre, i nobili e i borghesi che quasi dappertutto avevano usurpato terre demaniali» (Consolo 2012: 107). 178 su un episodio come quello di Bronte, estrapolarlo dal contesto post-moderno, appunto, può farci apparire fuori moda, arretrati, forse striduli (Consolo 2012: 107) Ma che Consolo consideri in modo non del tutto positivo Garibaldi e il suo influsso è dimostrato, ancora, dai giudizi formulati nell’articolo Il più bel monumento: Questo ironico (speriamo) e autoironico personaggio, nella sua campagna d’Italia, non fece che imitare, nel dire, nel fare e nel posare, il monumento di sé ch’era già idealmente eretto, in uno spassoso scambio tra l’immagine e il reale, in gara di esaltazione e in doppio accrescimento senza fine. Tutti rimasero vittime del giuoco, e ogni città e villa non poté che innalzargli il monumento. […] Ed era questo che Garibaldi in fondo desiderava: volare, volare in un teatrino d’invenzione per dimenticare le colpe e sopire i rimorsi che dentro gli rodevano (Consolo 2012: 70-71). Analogamente, nella novella pirandelliana L’altro figlio, Garibaldi è colui che «fece ribellare a ogni legge degli uomini e di Dio campagne e città» (Pirandello 1955: 242). E Maragrazia prosegue, servendosi di enumerazioni, metafore, esclamazioni, paragoni, puntini di sospensione, per coinvolgere emotivamente il lettore e rendere il suo racconto più persuasivo: […] vossignoria deve sapere che questo Canebardo diede ordine, quando venne, che fossero aperte tutte le carceri di tutti i paesi. Ora, si figuri vossignoria che ira di Dio si scatenò allora per le nostre campagne! I peggiori ladri, i peggiori assassini, bestie selvagge, sanguinarie, arrabbiate da tanti anni di catena… Tra gli altri, ce n’era uno, il più feroce, un certo Cola Camizzi, capo-brigante, che ammazzava le povere creature di Dio, così, per piacere, come se fossero mosche, per provare la polvere, – diceva – per vedere se la carabina era parata bene. […] Ah, che vidi! […] Giocavano… là, in quel cortile… alle bocce… ma con teste d’uomini… nere, piene di terra… le tenevano acciuffate pei capelli… e una, quella di mio marito… la teneva lui, Cola Camizzi… e me la mostrò. […] cane assassino! (Pirandello 1955: 242-244). Pirandello è per Consolo, ancora, il termine di paragone attraverso cui giudicare i testi della contemporaneità, a metterne in evidenza la vitalità, il carattere paradigmatico. Asserisce così: «La storia di Creatura di sabbia [di Tahar Ben Jelloun] è una delle più felici invenzioni letterarie del romanzo contemporaneo, uguale forse, per la metafora, per la verità profonda che riesce a liberare, a quella de Il fu Mattia Pascal di Pirandello» (Consolo 1999: 232-233). Analogamente, pure vari aspetti della produzione di Sciascia sono spiegati in rapporto a Pirandello. Nella prefazione a Le epigrafi di Leonardo Sciascia di Pino Di Silvestro, Consolo considera quale «più grande epigrafe di tutta l’opera di Sciascia, non scritta ma vistosamente implicita, […] la stanza della tortura pirandelliana declinata sul piano della storia, sul palcoscenico della violenza, della sconfitta» (Consolo 1999: 202). Tre anni più tardi, nel 1999, Consolo, evidenziando la funzione civile sottesa all’opera di Sciascia, gli attribuisce il merito di avere spostato «la dialettica pirandelliana dalla stanza alla piazza, nella civile agorà» (Consolo 1999: 269). Sciascia, allora, in questa sua «conversazione loica e laica sui fatti sociali e politici» si rivela «figlio di Pirandello» (Consolo 1999: 186), al punto tale che il personaggio narrante di Todo modo è «nato e per anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi pirandelliani – al punto [dice] che tra le pagine dello scrittore e la vita che avevo vissuto fin oltre la giovinezza, non c’era più scarto, e nella memoria e nei sentimenti» (Consolo 1999: 187-188). Quest’interesse, questa consonanza di idee con Pirandello, porta Consolo a riunire in Di qua dal faro, con il titolo di Asterischi su Pirandello, alcuni saggi dedicati allo scrittore agrigentino, pubblicati fra il 1986 e il 1997. In Album Pirandello Consolo ribadisce la funzione modellizzante che lo spazio ha esercitato su tutta la famiglia dello scrittore agrigentino: «quell’albero genealogico […] dispiega i suoi rami contro un cielo di luce crudele, affonda le sue radici in quell’asperrimo terreno che è la Sicilia, in quel caos di marne e di zolfi che è Girgenti» (Consolo 1999: 150). E così anche l’eclissi di sole a cui assistette «graverà sul mondo dello scrittore» (Consolo 1999: 150) e si combinerà con «quella […] della città in cui si trovò a vivere, di Girgenti. Una città dove è morta la storia, la civiltà, lasciando il vuoto, il deserto, […] la stasi, l’immobilità» (Consolo 1999: 150-151). Ricordiamo, difatti, che Consolo, ne L’olivo e l’olivastro e ne Lo Spasimo di Palermo, per esempio, individua, nella perdita della memoria storica, la causa della crisi del presente. Scrive così: «si può mai narrare senza la memoria?»; «Non è vero, io non so scrivere di Milano, non ho memoria» (Consolo 2012: 88, 97). Unica soluzione, allora, l’evasione, come quelle di Mattia Pascal o di Enrico IV, oppure rivestire delle forme, difenderle con le armi della dialettica, del sofisma, della retorica. L’operazione di Pirandello sembra perciò trovare dei riscontri nell’età contemporanea, in cui «l’io s’è perso nell’indistinta massa, la vita nelle prigioni sempre più disumane delle forme imposte dal potere, l’essere nell’apparire fantasmatico dei media» (Consolo 1999: 152). E non dimentichiamo che pure Consolo considera negativamente l’omologazione. Gioacchino Martinez, per esempio, sul treno che lo conduce a Palermo, prova piacere «a risentire quei suoni, quelle cadenze meridionali, quelle parlate che non erano più dialetto, ma non ancora la trucida nuova lingua nazionale» (Consolo 1998: 94-95) annunciata da Pasolini. Il viaggiatore de L’olivo e l’olivastro, poi, giudica «vacui» i giovani che, «con l’orecchino al lobo, i lunghi capelli legati sulla nuca» (Consolo 1994: 112), affollano la piazza di Avola. Altri legami fra Pirandello e Consolo ne L’ulivo e la giara. Gli stucchi di Giacomo Serpotta, che lo scrittore agrigentino ebbe modo, molto probabilmente, di osservare nella chiesa di Santo Spirito, con il loro carattere «mortuario […] fantasmatico» che «ha colto il pittore Fabrizio Clerici nella sua Confessione palermitana» (Consolo 1999: 156), hanno influenzato pure Consolo, il quale, in Retablo, chiama Fabrizio Clerici il protagonista e descrive le sculture in stucco dell’oratorio di via Immacolatella di Procopio Serpotta, figlio di Giacomo. «La bianca, spettrale fantasmagoria serpottiana» (Consolo 1999: 156), inoltre, richiama la «servetta Fantasia» attraverso cui i vari personaggi delle opere letterarie si materializzano, così come Macchia per Pirandello e Carandente per Serpotta parlano del «cannocchiale rovesciato» (Consolo 1999: 157). Analogamente, la superiorità di Cefalù su Palermo, sostenuta da Consolo varie volte16, è colta anche da Pirandello. Consolo immagina che questi, in viaggio da Palermo a Sant’Agata, in preda alla profonda suggestione «che gli suscitavano i nomi dei paesi: Solunto, Himera, Cefalù, Halaesa, Calacte…», si accorge che, «dopo Cefalù, il mondo colorato, vociante e brulicante del Palermitano andava a poco a poco stemperandosi [per] a prendere gradualmente una misura più dimessa, ma forse più serena» (Consolo 1999: 157-158). Pirandello, a confermare l’importanza dei luoghi, ebbe sicuramente presente, secondo Consolo, «il ricordo di quel suo lontano viaggio nel Val Dèmone» (Consolo 1999: 161) nello scrivere La giara, «la prima fuga nella memoria e nel ricordo, fuga dalla sua vita e dai fantasmi “pirandelliani” che lo assediavano» (Consolo 1999: 160). La novella, perciò, giudicata di recente una «divertita denuncia dell’intrinseca capziosità sia delle vicende che delle soluzioni giuridiche, calata in pieghe di umoristica densità» (Zappulla Muscarà 2007: 143), acquista nuovo significato nell’interpretazione di Consolo. La giara è per lui, infatti, a richiamare la sua tipica figura chiave della chiocciola, della spirale, sia «l’involucro della nascita, l’utero» sia «la tomba», mentre «quell’olio che la giara avrebbe dovuto contenere viene sì dall’ulivo saraceno, ma viene anche dall’albero sacro ad Atena, dea della sapienza» (Consolo 1999: 161-162), a ricordare la commistione delle due culture, araba e greca, della Sicilia. Consolo può allora vedere nel pino di Pirandello, tranciato, un simbolo degli «scadimenti, delle perdite, reali e simboliche, nel nostro Paese» (Consolo 1999: 163), a confermare la «visione del mondo, della vita come caos, mutamento incessante di forme, […] approdo all’assenza, al nulla» (Consolo 1999: 165). Anche in ciò Consolo si trova in consonanza con Sciascia17, che commenta, alla fine di Fuoco dell’anima: «Questa è la classe dirigente – per meglio dire digerente – che preferisce fare il pino di plastica piuttosto che salvare quello vero. Ed è così per tante, tante altre cose…» (Consolo 1999: 164). Con tutto questo, Consolo mostra l’importanza della ricezione dei testi letterari, avvicinandosi al lector in fabula descritto da Eco (1979). 16 Mi sia consentito, per questo, un rimando a Gallo 2017: 287-296. 17 Gianni Turchetta sottolinea, a proposito del termine ‘impostura’ de Il sorriso dell’ignoto marinaio, i legami di Consolo con Sciascia (2015: 1304-1305). Ne Lo Spasimo di Palermo, inoltre, Gioacchino Martinez legge, ne La corda pazza, la vita di Antonio Veneziano (115) e il narratore ricorda il «rifugio in Solferino dove Sciascia patì la malattia, sua del corpo e insieme quella mortale del Paese» (93-94). Vincenzo Consolo lettore di Pirandello 181
Bibliografia
Baldi G., 2014, Microscopie, Napoli, Liguori. Consolo V., 1985, Lunaria, Torino, Einaudi. Consolo V., 1992, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori. Consolo V., 1992, Retablo, Milano, Mondadori. Consolo V., 1994, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori. Consolo V., 1998, Lo Spasimo di Palermo, Milano, Mondadori. Consolo V., 1999, Di qua dal faro, Milano, Mondadori. Consolo V., 2004, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 2012, La mia isola è Las Vegas, Milano, Mondadori. Consolo V., 2015, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Serge, Milano, Mondadori, «I Meridiani». De Villi A. I., 2013, «Pasquale Marzano, Quando il nome è “cosa seria”. L’onomastica nelle novelle di Luigi Pirandello», (Pisa, ETS, 2008, 206 p.), OBLIO III, 9-10, p. 277-279. Eco U., 1979, Lector in fabula, Milano, Bompiani. Frabetti A., 1995, «L’“infinita derivanza”. Intertestualità e parodia in Vincenzo Consolo», Bollettino ‘900, n. zero, maggio, n. 1, http://www.comune.bologna. it/iperbole/boll900/consolo.htm Francese J., 2015, Vincenzo Consolo, Firenze, University Press. Gallo C., 2017, La Yoknapatawpha di Vincenzo Consolo, in: Sgavicchia S., Tortora M., Geografie della modernità letteraria, Pisa, ETS, I, p. 287-296. Galvagno R., 2015, «“Bella, la verità”. Figure della verità in alcuni testi di Vincenzo Consolo,» in: Diverso è lo scrivere. Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, Avellino, Edizioni Sinestesie, p. 39-64. Leopardi G., 1978, I Canti. Operette morali, Roma, Casa Editrice Bietti. O’Connell D., 2008, «Consolo narratore e scrittore palincestuoso», Quaderns d’Italià, 13, p. 161-184. Pirandello L., 1953, I vecchi e i giovani, in: Tutti i romanzi, vol. II, Milano, Mondadori. Pirandello L., 1955, Novelle per un anno, Milano, Mondadori, vol. II. Turchetta G., 2015, «Note e notizie sui testi», in: Consolo V., L’opera completa, p. 1271-1455. Zappulla Muscarà S., 2007, «La Giara e La patente fra narrativa e teatro ovvero Pirandello nell’isola del sofisma», in: Lauretta E., Novella di Pirandello: dramma, film, musica, fumetto, Pesaro, Metauro, p. 143-167.700
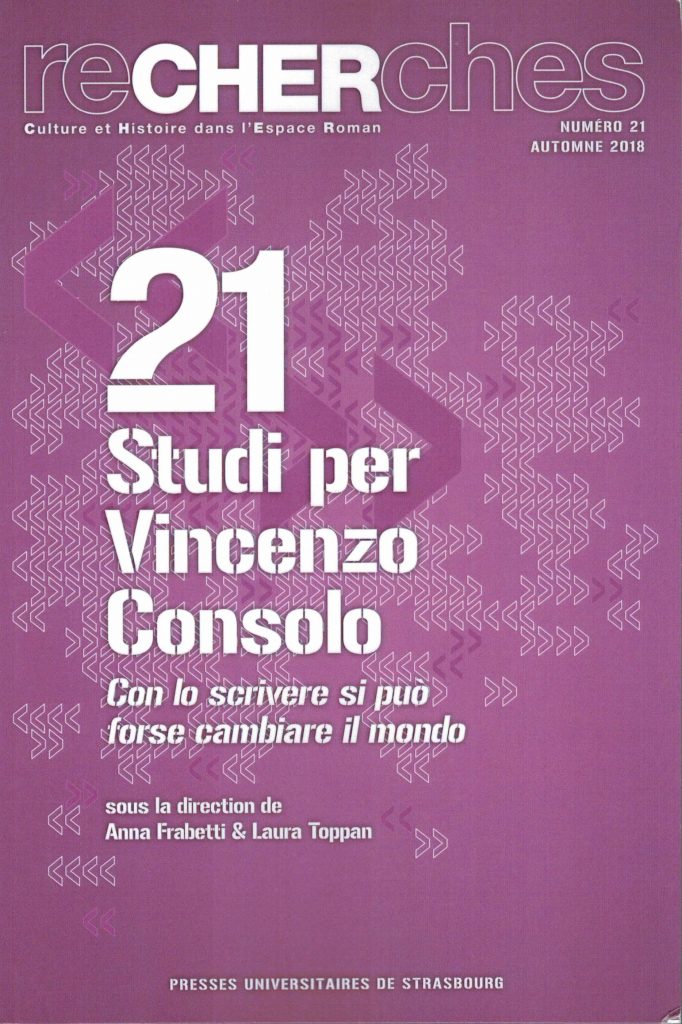
La mutazione antropologica tra sud e nord: i casi di Vincenzo Consolo e Gianni Celati
DANIEL RAFFINI
Il concetto di mutazione antropologica coniato da Pier Paolo Pasolini descrive il cambiamento della società italiana nel passaggio dal mondo contadino a quello industriale. Tra gli scrittori che si interessarono al fenomeno, cercando di trasferirne gli effetti nelle loro narrazioni e ragionando su di esso a livello teorico, si analizzano qui i casi di Vincenzo Consolo e Gianni Celati. Il primo descrive nei suoi racconti la fine del mondo contadino siciliano, il dramma della dissoluzione di un sapere millenario e la resistenza strenua ma inutile di alcuni personaggi reali che entrano nelle narrazioni. La mutazione antropologica sfocia in Sicilia nell’emigrazione di massa, che riflette il vuoto successivo alla fine del mondo contadino. Lo stesso senso di vuoto è percepibile anche dove quella società riesce a prendere piede, la Pianura Padana descritta da Gianni Celati nei suoi resoconti di viaggio e nei suoi racconti degli anni Ottanta. In questo caso lo svuotamento si riflette sulle persone e sul paesaggio e viene riportata dallo scrittore sulla pagina attraverso una scrittura scarna frutto di un’attenta osservazione. Il concetto di mutazione antropologica coniato da Pier Paolo Pasolini descrive il cambiamento della società italiana nel passaggio dal mondo contadino a quello industriale. Pasolini se ne occupa in una serie di articoli usciti tra il 1973 e il 1974 su varie testate, dando vita a un dibattito che vede l’intervento di molti scrittori e intellettuali italiani, tra cui Alberto Moravia, Edoardo Sanguineti, Italo Calvino, Maurizio Ferrara, Tullio De Mauro, Franco Fortini e Leonardo Sciascia. In particolare, Pasolini viene accusato di rinnegare lo sviluppo e di ripetere concetti già formulati. Lo scrittore riprende in effetti discorsi sulla società contemporanea già formulati da Marcuse, Horkheimer e Adorno, quando parlavano ad esempio di uomo a una dimensione e di tolleranza repressiva. Tuttavia, specifica Berardinelli nell’introduzione agli Scritti Corsari che «solo ora quei processi di cui aveva parlato la sociologia critica in Germania, in Francia e negli Stati Uniti, arrivano a compimento in Italia, con una violenza concentrata e improvvisa»1. Gli articoli di Pasolini ci restituiscono l’idea della società contemporanea come di sistema repressivo teso all’omologazione culturale, in cui una nuova classe media formata culturalmente su modelli esterni imposti dal potere viene a sostituire le vecchie categorie oppositive di fascismo e antifascismo. Scrive ancora Berardinelli che «per Pasolini i concetti sociologici e politici diventavano evidenze fisiche, miti e storie della fine del mondo»2. La mitizzazione dei processi sociologici rende possibile la trasfigurazione letteraria di questo mondo che va scomparendo in un gruppo di poesie italo-friulane tarde, pubblicate da Pasolini in quegli anni e poi entrate nella sezione Tetro entusiasmo della raccolta La Nuova Gioventù. Nell’articolo Acculturazione e acculturazione, uscito per la prima volta sul «Corriere della Sera» il 9 dicembre 1973 con il titolo Sfida ai dirigenti della televisione, Pasolini si scaglia contro la centralizzazione come livellazione delle differenze: Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana? Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni. […] Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta di un «uomo che consuma», ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo.3 La religione del consumo avrebbe preso il posto della religione vera e propria in qualità di oppio dei popoli di marxista memoria. Da qui parte Pasolini nel suo Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, dalla costatazione – in seguito alla vittoria del no nel referendum sull’abolizione del divorzio – che la società italiana è più evoluta in fatto di laicismo rispetto a quanto credessero il Vaticano e il PCI. Pasolini ne deduce un cambiamento del ceto medio, non più legato ai valori cristiani ma all’ideologia del consumo e ne trae la conclusione «che l’Italia contadina e paleoindustriale è crollata, si è disfatta, non c’è più, e al suo posto c’è un vuoto che aspetta probabilmente di essere colmato da una completa borghesizzazione»4. Pasolini registra insomma un cambiamento profondo nella società italiana a seguito del boom economico: Si tratta infatti del passaggio di una cultura, fatta di analfabetismo (il popolo) e di umanesimo cencioso (i ceti medi) da un’organizzazione culturale arcaica, all’organizzazione moderna della «cultura di massa». La cosa in realtà è enorme: è un fenomeno, insito, di «mutazione» antropologica.5 La mutazione antropologica implica da una parte il miglioramento delle effettive condizioni di vita delle persone, dall’altra determina però la fine delle culture popolari italiane in favore di un’unica cultura centralizzata fondata su un modello esterno di origine statunitense. D’altra parte Pasolini ha una visione fortemente ideologizzata e negativa della civiltà dei consumi, che definisce come il «più repressivo totalitarismo che si sia mai visto»6 e alla quale sente la necessita di opporre una battaglia politica prima ancora che culturale fondata sui principi di una rivoluzione proletaria e contadina. Il concetto di mutazione antropologica coniato da Pasolini sarà ripreso da scrittori del decennio successivo. Tra di essi un punto di vista privilegiato è quello del siciliano Vincenzo Consolo. Privilegiato perché è quello di uno scrittore attento ai contrasti insiti e ai cambiamenti storici della sua terra, la Sicilia. In Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino Pasolini parlava di un «illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto fino a solo pochi anni fa»7, per il quale gli stati preunitari, l’Italia unita, l’Italia fascista e l’Italia democratica hanno rappresentato senza soluzione di continuità la nazione estranea, l’altro e l’oppressore. Consolo, dal canto suo, tornerà a parlare di quel mondo contadino in termini mitici, come «di tempi andati, di tempi d’oro, tempi che sono durati fino all’altro ieri»8, e descriverà le rivolte dei siciliani di fronte al potere La raccolta postuma La mia isola è Las Vegas raccoglie testi brevi pubblicati nel corso degli anni da Consolo su vari giornali e fondamentali per capire l’evoluzione del pensiero dello scrittore così come la genesi 3 borbonico, all’unificazione, al Fascismo e all’Italia dopoguerra, per arrivare alla fine di quel mondo che pure aveva fatto in tempo a conoscere da bambino e che aveva descritto in alcuni racconti degli anni Cinquanta e Sessanta9. In due racconti tardi, pubblicati per la prima volta nel 2007 e nel 2008 e poi inclusi nella raccolta La mia isola è Las Vegas, Consolo cita direttamente il concetto pasoliniano di mutazione antropologica. In Alésia al tempo de Li Causi, parlando degli anni in cui studiava a Milano, l’autore scrive: Erano quelli gli anni della fine del mondo contadino e della rapida trasformazione dell’Italia in Paese neo-industriale, del miracolo economico e della mutazione antropologica; gli anni, quelli dell’espulsione dal Paese di milioni e milioni di lavoratori in cerca d’un futuro, d’un destino migliore. 10 Mentre nel racconto E Ciro vide Anna Magnani, riferendosi agli stessi anni, scrive: Era quello il momento della fine del mondo contadino, del fallimento della riforma agraria in Sicilia, della vittoria dei feudatari, eterni Gattopardi, e dei loro sovrastanti o gabelloti mafiosi. Era il momento quello che Pasolini poi chiamò della “mutazione antropologica” di questo nostro Paese.11 L’attenzione dello scrittore al tema della mutazione risale almeno agli anni Ottanta ed è legata all’osservazione del fenomeno dell’emigrazione di massa dei siciliani verso il nord Italia, dovuta all’irruzione delle nuove tecniche di produzione che mettono fine a tradizioni che in Sicilia, oltre ad essere millenarie, rivestivano un forte ruolo identitario, come quella della coltivazione degli aranci o della pesca del tonno12. In un racconto del 1985 dedicato al tema dell’emigrazione a Milano, Consolo parlerà del sud come di una terra «dove la storia si è conclusa»13. La mutazione antropologica rappresenta nella narrativa consoliana una cesura netta e su di essa lo scrittore fonda la funzione etica della propria scrittura. Se il mondo globalizzato digerisce nel suo ventre le culture particolari, se la cultura del centro progressivamente sostituisce le culture periferiche, il compito della letteratura è quello di narrare ciò che non c’è più. In questo senso fortemente significativi sono alcuni personaggi della sezione Persone della raccolta del 1989 Le Pietre di Pantalica, attraverso i quali Consolo prova a raccontare il momento di passaggio, l’attimo della fine, attraverso le figure di chi tentò di opporvisi. Antonino Uccello, poeta-etnologo amico di Consolo, cerca di salvare le vestigia di ciò che sta finendo, raccogliendo gli strumenti e le testimonianze del mondo contadino; oggetti che trova abbandonati, relitti della storia, il cui unico destino è quello di essere musealizzati. In un’intervista Consolo accosterà il proprio compito a quello dell’amico: di alcune delle sue opere. 4 Il poeta-etnologo de La casa di Icaro, credo che sia il personaggio più importante, la figura-simbolo di tutto il libro. È stato uno, Uccello, che, come un pietoso raccoglitore di detriti dopo la risacca, ha cercato di salvare, nel momento in cui essi sparivano, i resti, le testimonianze del mondo contadino. E non è questo in fondo il dovere e il destino di ogni scrittore della mia età e della mia estrazione, che si è trovato a cavallo della grande trasformazione, tra un mondo che spariva e un mondo che iniziava? Non è questo il compito e il destino sempre, in ogni epoca, di uno scrittore: raccogliere e custodire memorie, reliquie di un mondo che continuamente frana, sparisce?14 Ad un’altra Sicilia che va scomparendo, quella magica e barocca, sognante e mitologica, rimanda invece la figura del barone Lucio Piccolo, poeta fuori dalle mode e fuori dal tempo, simbolo di un’erudizione che ci ricorda quella di Mandralisca de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Piccolo fu amico e mentore di Consolo, che in queste pagine racconta il loro primo incontro, gli insegnamenti, le visite nella casa di Capo d’Orlando. Come Uccello, Piccolo è emblema di un mondo che non esiste più, tanto che nel momento della sua scomparsa il dolore che Consolo prova non è solo per la perdita dell’amico e maestro, ma anche «per un mondo, un passato, una cultura, una civiltà che con lui se ne andavano»15. Andando ancora indietro, Consolo risale ai tempi in cui quel mondo esisteva, con i suoi riti e le sue usanze, con la sua cultura, quella cultura popolare rivendicata come tale da Pasolini, contro tutti quegli intellettuali che la relegavano agli strati prerazionali. Consolo ci racconta le lotte di quel mondo, le rivolte e le battaglie per la sua sopravvivenza, in molti racconti de Le Pietre di Pantalica e in alcuni di quelli poi confluiti ne La mia isola è Las Vegas, così come nei romanzi, basti pensare alle rivolte di Alcara Li Fusi narrate ne Il sorriso dell’ignoto marinaio. Come afferma Flora Di Legami la scrittura di Consolo viaggia nel passato storico per isolarne travagli umani e sociali da depositare poi sulla pagina. E questa si dispone come archivio memoriale di un mondo, quello popolare (con i suoi tipi e le sue tradizioni), che non esiste più, e che non si conoscerebbe se non ci fosse un aedo delle microstorie o dell’antistoria pronto ad assumere su di sé il compito di narrare quanto è andato disperso.16 Anche per quanto riguarda il discorso sull’evoluzione linguaggio nell’epoca della mutazione antropologica Consolo sembra essere in linea con quanto Pasolini diceva in Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino: Dal punto di vista del linguaggio verbale, si ha la riduzione di tutta la lingua a lingua comunicativa, con un enorme impoverimento dell’espressività. I dialetti (gli idiomi materni!) sono allontanati nel tempo e nello spazio: i figli sono costretti a non parlarli più perché vivono a Torino, a Milano o in Germania. Là dove si parlano ancora, essi hanno totalmente perso ogni loro potenzialità inventiva.17 Il discorso di Consolo sulla lingua è più profondo di quello di Pasolini, non si limita solo a un recupero linguistico di tipo dialettale, ma allarga la propria ricerca e l’operazione di salvataggio anche al piano diacronico e ai diversi livelli d’uso della lingua, restituendo sulla pagina una grande dose di ricchezza e invenzione verbale, contro l’appiattimento del linguaggio letterario su quello dei media. 5 La mutazione antropologica sfocia dunque in Sicilia nell’emigrazione di massa, che riflette il vuoto successivo alla fine del mondo contadino e le difficoltà della nascita di una nuova società. Lo stesso senso di vuoto è percepibile anche dove quella società riesce a prendere piede, nella Pianura Padana descritta da Gianni Celati nei suoi resoconti di viaggio di Verso la foce e nei racconti degli anni Ottanta. In questo caso lo svuotamento si riflette sulle persone e sul paesaggio determinando una descrizione in cui la parola stessa diventa scarna ed essenziale e il paesaggio postindustriale ci mostra quanto la nuova società derivata dalla mutazione abbia in realtà un carattere effimero e transitorio. A differenza dello sguardo politicizzato di Pasolini e di quello partecipe di Consolo, Celati si pone dal punto di vista dell’osservatore anonimo, lasciando la centralità dell’evocazione all’immagine nuda. Una tecnica che gli viene dalla frequentazione, nei primi anni Ottanta, di quei fotografi raggruppati intorno alla figura Luigi Ghirri, i quali si proponevano di registrare attraverso il loro lavoro la mutazione del paesaggio italiano. Nell’introduzione a Verso la foce Celati definisce questi diari di viaggio come «racconti d’osservazione»18 e specifica meglio il tipo di osservazione necessaria e lo scopo che intende perseguire: Ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dai codici familiari che porta con sé, ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non si capisce, per poter arrivare ad una foce, dove dovrà sentirsi smarrita.19 L’osservazione di Celati non ha dunque un fine consolatorio, parte dallo straniamento e arriva allo spaesamento, ma solo così lo scrittore sente di poter rendere il senso ultimo di quel «deserto di solitudine»20 che si trova ad attraversare durante le sue peregrinazioni. Celati descrive il paesaggio padano svuotato della sua storicità in seguito a una mutazione di cui rimangono solo ruderi. Anche qui, come nella Sicilia descritta da Consolo, permangono relitti di una storia che non c’è più, che entrano in contrasto con le superfetazioni della modernità. L’esempio più evidente sono forse le corti, fattorie tipiche di queste zone, ora abbandonate: Ho sbirciato in un paio di quei cortili, c’erano strumenti agricoli abbandonati e paglia per terra. Gli abitanti delle corti sono andati tutti a vivere in quelle vilette geometrili sparse nelle campagne, e il bestiame è stato traslocato in grandi capannoni industriali.21 Di fronte alla piattezza e all’omologazione delle costruzioni moderne, le corti presentano una grande varietà di soluzioni architettoniche, che cambia da una provincia all’altra. I segni dell’antica bellezza non sono solo nelle corti, ma si possono ravvisare anche in alcuni centri storici, come in quello di Casalmaggiore Vedo strade girovaganti, portici e palazzi scrostati, finché non si arriva nelle stradine dietro il palazzo municipale, e da lì nella piazza centrale. […] Dalla piazza, ripassando per stradine un po’ in salita dietro il municipio, si arriva all’argine del Po. Accanto a una vecchia porta della città, la fila irregolare di palazzi sette-ottocenteschi, ognuno con facciata e forma e altezza 6 diverse, movimenti di linee senza mai forti squadrature, segue l’andamento sinuoso dell’argine e del fiume che si allarga in prospettiva.22 La differenza tra antico e moderno è dunque per Celati prima di tutto una questione di linee e di forme. A Codigoro lo scrittore osserva le case dalle facciate veneziane e le villette in stile liberty disposte lungo il canale, elementi che «formano davvero un luogo» e mostrano che qui «il tempo è diventato forma dello spazio, un aspetto è cresciuto a poco a poco sull’altro, come le rughe sulla nostra pelle»23. A ciò si oppone la fine del tempo, fine della storia e le forme geometrizzanti rappresentate dagli elementi della modernità, che minacciano i luoghi antichi: le industrie, che finiscono per costituire delle nuove città; i centri commerciali, che nel giro di pochi anni stravolgono il paesaggio; le strutture turistiche, presenti persino nelle zone più solitarie della foce del fiume; i cartelloni pubblicitari, che ostruiscono la visuale sostituendosi al paesaggio; infine, le nuove tipologie abitative dell’omologazione, le villette a schiera. La mutazione antropologica descritta da Celati non interessa solo il paesaggio, ma lo scrittore si sofferma anche sulle modalità di vita. L’alienazione dei luoghi rispecchia quelle delle persone. I nuovi non-luoghi creati dalla società di consumo, che di lì a qualche anno saranno teorizzati da Marc Augé, sono occupati da delle non-persone, svuotate anch’esse di storicità e private della diversità in favore dell’omologazione imposta24. In Acculturazione e acculturazione Pasolini si chiedeva se le persone sarebbero davvero riuscite a realizzare il modello imposto dalla cultura di massa e si rispondeva: No. O lo realizzano materialmente solo in parte, diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione o addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d’animo collettivi.25 In questo senso va anche l’osservazione compiuta da Gianni Celati sui luoghi dell’abitare che la mutazione antropologica impone agli abitanti della pianura, le villette a schiera che ricorrono come leitmotiv di queste pagine. Celati riprende le teorie dell’abitare espresse da Bachelard negli degli anni Cinquanta, adattandole al nuovo contesto depersonalizzato successivo alla mutazione antropologica. Le villette diventano allora simbolo stesso dell’alienazione postindustriale dei luoghi descritti, simbolo di un tentativo falso e illusorio di nascondersi della «vita piena di pena»26 e di non vedere «l’orizzonte pesantissimo pieno di camion e maiali»27: Quelle case non hanno volto, hanno solo aperture di sicurezza e superfici protettive dietro cui si va a nascondere. Si esce a vedere se in giro è tutto normale, poi si torna a nascondersi nelle tane.28 Se i luoghi precedentemente descritti da Celati mostrano una stratificazione del tempo e delle epoche, qui il tempo risulta sospeso, nelle villette le persone si autoesiliano involontariamente dal7 proprio tempo. Nel 1957 Gaston Bachelard ne La poetica dello spazio descriveva la casa come il luogo dove le persone si rifugiano a seguito dell’aumento di importanza della vita pubblica determinato dal progresso economico e tecnologico29. Se in Bachelard il senso di protezione evocato dalla casa ha ancora un valore positivo, Celati ci presenta trent’anni dopo i risultati di quel processo e ripropone in chiave negativa la visione della casa come rifugio. La mutazione antropologica cambia insomma i luoghi e le persone che li abitano. Raccontare la mutazione antropologica significa per gli scrittori raccontare la realtà in un momento in cui il realismo sembra essere una via non più percorribile. Ciò rende necessaria una riflessione e un lavoro da parte degli scrittori sulle forme e sui generi. Se Pasolini sceglie la via di una poesia per metà dialettale e per metà italiana per trasfigurare in forma artistica ciò che andava scrivendo nei suoi saggi, Consolo opta invece da una parte sulla rifondazione del romanzo storico su basi antiromanzesche e dall’altra sull’inserimento dell’elemento autobiografico all’interno delle strutture finzionali del racconto. Celati, infine, sceglie il diario di viaggio, un diario di viaggio denso di narratività e riflessioni, che fungono da punto di partenza per i racconti veri e propri di Narratori delle pianure e per le Quattro novelle sulle apparenze. Si nota insomma come la mutazione antropologica sia stata un motore, forse primo, che spinse gli scrittori a un ripensamento delle forme, quel ripensamento che culminerà nei nuovi realismi e nella fioritura della nonfiction a partire dagli anni Novanta, ma che affonda le basi sui grandi cambiamenti antropologici e sociologici che hanno interessato il mondo e l’Italia nella seconda metà del Novecento.
***
1 A. BERARDINELLI, Premessa, in P.P. PASOLINI, Scritti Corsari, Milano, Garzanti, 2000, p. X. 2 Ivi, VIII.
3 PASOLINI, Acculturazione e acculturazione, in ID., Scritti corsari…, 22-23. 4 PASOLINI, Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, in Scritti corsari…, 40. L’articolo era uscito per la prima
volta sul «Corriere della Sera» il 10 giugno 1974 col titolo Gli italiani non sono più quelli. 5 Ivi, 41. 6 PASOLINI, Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, in Scritti corsari, 53-54. L’articolo viene pubblicato l’8 luglio 1974 su «Paese sera» come lettera aperta in risposta a Italo Calvino.
7 Ivi, 53. 8 V. CONSOLO, Arancio, sogno e nostalgia, in ID., La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Milano, Mondadori, 2012, 133. Il racconto è pubblicato per la prima volta su «Sicilia Magazine» nel dicembre del 1988. Cfr. D. RAFFINI, La mia isola è Las Vegas: laboratorio e testamento letterario, in A.
Frabetti e L. Toppan (a cura di), Studi per Vincenzo Consolo. Come lo scrivere può forse cambiare il mondo,
«Recherches», n. 21, automne 2018, 129-142. 9 Si fa riferimento in particolare ai racconti Un sacco di magnolie, Befana di novembre, Grandine come neve e Triangolo e
luna, riproposti anch’essi nella raccolta La mia isola è Las Vegas. 10 CONSOLO, Alèsia al tempo di Li Causi, in ID., La mia isola…, 226. 11 ID., E Ciro vide Anna Magnani, in ID., La mia isola…, 229. 12 Alla coltivazione degli aranci Consolo dedica il già citato racconto Arancio, sogno e nostalgia; mentre sul tema
delle tonnare è il saggio La pesca del tonno pubblicato nella raccolta Di qua dal faro. 13 CONSOLO, Porta Venezia, in ID., La mia isola…, 113. 14 CONSOLO, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori, 2015, 1388. 15 ID., Piccolo grande Gattopardo, in ID., La mia isola…, 214. 16 F. DI LEGAMI, Vincenzo Consolo, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, 10. 17 PASOLINI, Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, in ID., Scritti corsari…, 54. 18 G. CELATI, Verso la foce, Milano, Feltrinelli, 2011, 9. 19 Ivi, 10. 20 Ivi, 9. 21 Ivi, 32. 22 Ivi, 38-39. 23 Ivi, 95. 24 Secondo la definizione di Augé: «Se un luogo può definirci some identitario, relazionale, storico, uno spazio
che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà un nonluogo» (M. AUGÉ, Nonluoghi.
Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1993, 73). 25 PASOLINI, Acculturazione…, 23. 26 CELATI, Verso la foce…, 35. 27 Ivi, 31. 28 Ivi, 94. 29 Cfr. G. BACHELARD, La poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975, 31-45
Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso
dell’ADI – Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018),
a cura di A. Campana e F. Giunta,
Roma, Adi editore, 2020

Il punto scritto: genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio
DARAGH O’CONNELL
In un’intervista fatta a Vincenzo Consolo parecchi anni fa, lo scrittore siciliano ha parlato della “fantasia creatrice” come di un elemento femminile con il quale si può uscire dal cerchio della ragione, un cerchio simboleggiato dalla metafora della “chiocciola” nel Sorriso dell’ignoto marinaio (O’Connell, 2004: 238-253). Questa fantasia creatrice nel romanzo, si muove nei panni del personaggio Catena Carnevale la fidanzata che sfregia il sorriso ironico e pungente del ritratto e, in seguito, ricama la tovaglia di seta intitolata «L’albero delle quattro arance «. La descrizione nel libro di questa tovaglia e fondamentale e assomiglia per certi versi proprio allo stile della scrittura consoliana, ed e in realtà una metafora per il testo stesso, se non l’intero progetto letterario di Consolo. Leggiamo: Sembrava, quella, una tovaglia stramba, cucita a fantasia e senza disciplina. Aveva sì, tutt’attorno una bordura di sfilato, ma il ricamo al centro era una mescolanza dei punti più disparati: il punto erba si mischiava col punto in croce, questo scivolava nel punto ombra e diradava fino al punto scritto. E i colori! Dalle tinte più tenui e sfumate, si passava d’improvviso ai verdi accesi e ai rossi più sfacciati. Sembrava, quella tovaglia, – penso la baronessa, – ricamata da una invasa dalla furia, che con intenzione ha trascurato regole numeri misure e armonia, fino a sembrare che la ragione le fosse andata a spasso. (Consolo, 2015: 167-168) Questa analogia tra la scrittura letteraria e il ricamo e lo sfregio di Catena, richiama proprio la poetica distintiva di Consolo: una poetica palinsestica che prevede l’accumulo e l’elisione di vari testi di provenienza diversa, siano essi di stampo giornalistico, creativo o saggistico, in uno spazio di singolare gestazione autoriale fra polifonia e palinsesto (O’Connell, 2008: 161-184). Queste pagine intendono analizzare, da diversi punti di vista, il primo capitolo del longseller di Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), delineando l’evoluzione del romanzo dalla sua forma primigenia fino alle più recenti rielaborazioni. Saranno messe a fuoco alcune varianti testuali (Messina, 2009: 143-202) e dichiarate le fonti, letterarie e non, sottese all’intero capitolo. Il primo capitolo e in effetti, a mio avviso, un grande palinsesto, e molte delle procedure adottatevi da Consolo richiamano una polifonia e una concezione alla Bachtin ell’enciclopedismo, la sua definizione di romanzo di Seconda linea. In più, il capitolo I sancisce in realtà molti aspetti della nuova poetica di Consolo, che in definitiva rappresenta lo spazio letterario in cui il passaggio da riso a sorriso e più evidente. Consolo conclude cosi la Nota dell’autore, vent’anni dopo aggiunta come postfazione dell’edizione Mondadori del 1997: […] che senso ha la riproposta di questo Sorriso? E la risposta che posso ora darmi e che un senso il romanzo possa ancora trovarlo nella sua metafora. Metafora che sempre, quando s’irradia da un libro di verità ideativa ed emozionale, allarga il suo spettro con l’allargarsi del tempo. (Consolo, 1997: 183)2 Sono passati vent’anni da queste enunciazioni, e oggi il testo sfaccettato di Consolo ha cominciato a ricevere il trattamento critico che merita. Abbiamo avuto oltre quarant’anni per metabolizzare e situare un romanzo della sua importanza, non solo nel contesto della narrativa italiana del ventesimo secolo, ma anche in quello dell’evoluzione poetica di Consolo. Si dovrebbe, pertanto, entrare nel cuore del dibattito su questo allargarsi del tempo, contribuire attivamente alla crescita di questo corpus critico-accademico con al centro la poetica di Consolo. Tuttavia, in questo approccio al capitolo I, ciò che più ci preme non e tanto il suo allargarsi nel tempo, quanto il suo restringervisi, cercando di individuare con esattezza i momenti cardine della composizione del testo. Sarebbe erroneo, in tanti sensi interconnessi, dire che Il sorriso e un testo nel fiore dei suoi quarant’anni. Quando leggiamo le mini-biografie sulle copertine dei libri di Consolo, siamo portati a credere che Il sorriso sia un prodotto testuale della metà degli anni ’70 e perfettamente inserito nel suo tempo. In realtà, va sottolineato che Il sorriso e un testo mutevole, «un lavoro perennemente mobile e non finibile», per dirla con Contini (1970: 5), la cui genesi può essere collocata intorno alla metà degli anni ’60 e le cui più recenti articolazioni possono essere datate al 1997. Questo saggio intende dimostrare che Il sorriso si può considerare come un atto letterario il cui incipit – non solo testuale, ma anche concettuale – e retrodatabile a cinquant’anni fa. Fuori dalla storia del testo in quanto tale, alcune delle tematiche e delle metafore de Il sorriso sono apparse in diverse guise, in altre narrazioni più tarde di Consolo. Sia Nottetempo, casa per casa sia L’olivo e l’olivastro si riferiscono esplicitamente al Ritratto d’uomo di Antonello (Consolo, 1992a: 138-139 [Consolo, 2015: 142-143]; Consolo, 1994: 124-125 [Consolo, 2015: 852- 853]). Per cui si può dire che Il sorriso, dal suo livello ipertestuale originario, 2 La Nota dell’autore, vent’anni dopo e successivamente riapparsa come saggio di chiusura in Consolo, 1999a, p. 276-282, con il titolo «Il sorriso», vent’anni dopo. 57 e diventato un ipotesto per le opere successive di Consolo3. Per di più, Il sorriso e il primo capitolo di una trilogia di romanzi che prendono le mosse da importanti momenti della storia siciliana e italiana: l’insorgere del fascismo nei primi anni ’20 e la sua correlazione in tempi più recenti con la nuova destra italiana, in Nottetempo, casa per casa (1992); e il fallimento del tentativo di creare una società giusta da parte della comunemente definita “generazione del dopoguerra”, simbolizzato dall’assassinio del giudice Paolo Borsellino, in Lo spasimo di Palermo (1998). Tralasciando queste considerazioni, la focalizzazione esclusiva su Il sorriso e, in particolare, sul capitolo iniziale del romanzo, si basa su alcune valide ragioni: anzitutto, il capitolo I risulta il più negletto di tutti, dato che la critica ha preferito studiare e interpretare i cosiddetti “capitoli caldi” della seconda meta del romanzo; poi, perché e il capitolo con la storia testuale più lunga, e dunque la sua gestazione dovrebbe apparire più evidente ad un’attenta analisi; infine, il capitolo inaugura una nuova poetica per Consolo dopo La ferita dell’aprile (1963): gli elementi di solito associati al romanzo – il significato del sorriso, la chiocciola, la compresenza di poesia e prosa, le forme metriche, gli stilemi, l’uso dell’elencazione, di forme dialettali e parodistiche, l’impegno dell’autore, e un’abbondante messe di intertesti, in breve, una polifonia – sono già tutti presenti nel loro insieme in questo capitolo. Certo i commenti dell’autore facilitano la lettura del primo capitolo del romanzo, e le riflessioni sono molto rilevanti, non solo per ciò che nascondono, ma anche per ciò che rivelano. Forse, quella più significativa riguardo al Sorriso appare nella Nota dell’autore chiamata in causa all’inizio, in cui, pur a distanza di venti anni, Consolo delinea i tre elementi fondamentali da cui la struttura del romanzo ha preso forma: I tre elementi allora, la rivolta contadina di Alcara, i cavatori di pomice di Lipari e il Ritratto d’Antonello reclamavano una disposizione su uno spazio di rispondenze e di senso, in cui il Ritratto stesso, nel suo presumibile percorso da una Messina, già di forte connessione storica, cancellata dai terremoti, a Lipari, isola-regno d’esistenza, di mito, a Cefalù, approdo nella storia e nella cultura, disegnava un triangolo e un movimento da un mare d’incertezze […] a una terra di consapevolezza e di dialettica. (Consolo, 1997: 177-178) Dei tre punti sopraelencati, solo il primo e notoriamente escluso, e di là da venire. Inoltre, questo movimento ad assetto triangolare, emanante dai brani d’apertura del capitolo, e illuminante riguardo alla poetica di Consolo e a come (e dove) egli si vede situato all’interno della tradizione letteraria siciliana: in una posizione intermedia tra quella occidentale e quella orientale, che e come dire, tra 3 Seguo le categorizzazioni e classificazioni genettiane della “transtestualità”, vale a dire la trascendenza testuale del testo, rilevate da Gérard Genette (1997: 7-8): «si tratta appunto di quella che chiamerò d’ora in poi ipertestualità. Designo con questo termine ogni relazione che unisca un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo anteriore A (che chiamerò, naturalmente, ipotesto) sul quale esso si innesta in una maniera che non è quella del commento». storia e mito. I movimenti spaziali da est a ovest nel primo capitolo del romanzo, e la decisione dell’autore di abbracciare le tradizioni storiche occidentali degli scrittori dell’isola, si scorgono nello stesso incipit4. Nel libro-intervista Fuga dall’Etna, riferendosi proprio alla prima parte del romanzo, Consolo afferma: Il libro e scritto nella prima parte in forma parodistica, mimetica, sarcastica se si vuole, quindi in negativo: faccio il verso a un erudito dell’Ottocento recluso nella sua mania antiquaria, che scrive i suoi saggi scientifici, che si occupa di malacologia, una materia quanto mai curiosa, eccentrica. (Consolo, 1993: 45) Se gli elementi parodistici, mimetici e sarcastici sono davvero presenti, e in abbondanza, nella prima parte del romanzo, Consolo pero non evidenzia tutti gli altri che danno “forma” a questo capitolo: un’angoscia delle influenze di altri scrittori, la ricerca di una nuova poetica, una concezione totalmente alterata di quello che è il genere del romanzo. L’analisi s’incentrerà proprio su questi elementi nascosti o impliciti, peraltro parzialmente rivelati dall’esame del graduale crescere del testo, gli inizi del quale si possono far risalire a un momento circostanziato della vita dell’autore, un evento che e l’emblema degli obiettivi dichiarati della sua poetica, vale a dire, la fusione dei due filoni, orientale e occidentale, della letteratura siciliana. E mia ferma convinzione, che l’incontro organizzato da Consolo tra i suoi due mentori, il poeta Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia, e il più chiaro esempio possibile del punto di partenza del futuro romanzo. Né Le pietre di Pantalica, Consolo racconta l’evento tenutosi il 7 marzo 1965, una data degna di nota, perché coincidente con la prima messa officiata in lingua italiana dopo il Concilio Vaticano Secondo: Sciascia arrivo da Caltanissetta al mio paese e assieme andammo da Piccolo. Al congedo, sulla porta, Piccolo solennemente disse allo scrittore, indicando con la mano su per le colline: «Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali». Avevo deciso di lasciare la Sicilia e di trasferirmi a Milano. «Non parta, non vada via» mi diceva Piccolo. «A Milano con tutti gli altri, rischia di annullarsi. La lontananza, l’isolamento danno più fascino suscitano interesse e curiosità.» Non potevo rispondergli che non ero ricco, che dovevo guadagnarmi la vita. Non potevo dirgli, soprattutto, che lì in Sicilia mi sembrava tutto finito, senza speranza, che a Milano, al Nord avevo la sensazione che tante cose si muovessero, che stesse per iniziare una nuova storia. (Consolo, 1988: 142-143 [Consolo, 2015: 599])5 Ad un primo sguardo, nel brano sono proprio pochi gli accenni riferibili alla futura opera Il sorriso, perché Consolo taglia corto con la storia dell’incontro raccontando di altre esperienze con Piccolo. Invece nella Fuga dall’Etna riprende il racconto con un’interessante coda: 4 Per le discussioni sulla mappatura della letteratura siciliana del luogo, cfr. il mio saggio: O’Connell, (2005: 29-48); e O’Rawe (2007: 79-94). 5 La più antica traccia si trova in due quaderni autografi (Ms 3, Ms 4), per cui cfr. Messina (2009: 58 e n. 53). Questo uno dei ricordi più belli, che riprendo da Le pietre di Pantalica: «[…] “Sciascia, la invito a scrivere di queste nostre terre, di questi paesi medievali.” “C’e qui Consolo,” rispose Sciascia. “Consolo e ancora giovinetto,” replico Piccolo sarcasticamente (avevo trentatré anni!). Ma io presi quella frase come impegno verso Sciascia e come una sfida verso il barone.» Sciascia era rimasto affascinato da quel poeta, da quel gran personaggio che era Piccolo. Erano, i due scrittori, quanto di più diverso, di più lontano si potesse immaginare, eppure nutrivano, l’uno per l’altro, stima e ammirazione. (Consolo, 1993: 23-24)6 Non è da ritenere una coincidenza il fatto che siano esattamente queste nostre terre, quei paesi medievali a costituire il contenuto o retroscena del primo capitolo del futuro romanzo. La sfida sottaciuta di Consolo a Piccolo diventa poi col tempo anche sfida a tutta la letteratura siciliana, e il romanzo che ne risulta e un romanzo i cui antenati sono certo Verga, De Roberto, Pirandello, Vittorini e Tomasi di Lampedusa, ma i cui “istigatori” potrebbero considerarsi Piccolo e Sciascia: sia detto per inciso, richiamati rispettivamente dal protagonista Enrico Pirajno Barone di Mandralisca (Piccolo) e del deuteragonista Giovanni Interdonato (Sciascia). Tredici anni di silenzio separano il primo romanzo di Consolo La ferita dell’aprile datato 1963 e Il sorriso. La concezione originale de Il sorriso, comunque, prende le mosse negli anni ’60 ed e connessa, almeno dal punto di vista ideologico, al periodo di “acuta storia”. Inoltre, e un romanzo siciliano in senso stretto, non solo perché tratta di storia siciliana, ma anche perché la sua nascita e il suo sviluppo sono databili al periodo 1963-1968, ovvero gli anni in cui Consolo visse in Sicilia prima di spostarsi a Milano definitivamente nel gennaio 1968. Ma Consolo, e chiaro, non smise di scrivere a meta anni ’60 per riprendere la penna in mano soltanto a metà degli anni ’70. Rimase attivo, sia sul piano creativo sia su quello giornalistico, durante gli anni che separano le date di pubblicazione dei due romanzi7. Tuttavia, ciò che si commenta e la preistoria effettiva del libro, ovvero come arrivo alla sua versione definitiva nel 1976. Quanto segue e la storia tracciata sulla fortuna di pubblicazione de Il sorriso dell’ignoto marinaio, dalle prime apparizioni fino ad oggi. Testo e testi: variazioni e varianti. Nel numero luglio-settembre di «Nuovi Argomenti» del 1969, diretto da Alberto Carocci, Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, appare per la prima 6 Le virgolette evidenzierebbero il passaggio citato da Le pietre di Pantalica fino a «una sfida verso il barone». In realtà, il passo da «C’e qui Consolo» a «una sfida verso il barone» non appaiono, come si è visto, in Le pietre di Pantalica. 7 Per la scrittura creativa, cfr. i racconti di quegli anni ora in La mia isola è Las Vegas (Consolo, 2012). Per quella giornalistica, anche se ne dà solo una visione parziale, Esercizi di cronaca (Consolo, 2013). Da non escludere sono anche gli articoli raccolti in Cosa loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010, (Consolo, 2017). Ed altri ancora, di vario argomento, risulta che ne siano conservati nell’Archivio Consolo. Volta un racconto dal titolo Il sorriso dell’ignoto marinaio. A tutti gli effetti e ciò che diventerà il primo capitolo del futuro romanzo omonimo (Consolo, 1969: 161-174). Il racconto non presenta alcun antefatto o appendici. E di poco successivo, del 1975, un libro dallo stesso titolo con un’acquaforte di Renato Guttuso del famoso Ritratto d’uomo (edizione limitata in 150 copie). Il volume contiene i primi due capitoli di quello che sarà il romanzo che conosciamo (Consolo, 1975a). Corrado Stajano, amico di Consolo, avvalendosi di una celebre metafora pirandelliana, ha scritto un pezzo per Il Giorno per segnalare questa pubblicazione: Adesso Manusé ha esaudito il gran sogno della vita, e diventato editore e c’è la possibilità, dicono gli uomini di penna, che questo libro che ha stampato, […] possa creare un nuovo caso letterario. Perché qui si sono incontrate due corde pazze siciliane, quella di Manusé e quella dello scrittore del libro, o meglio dei primi due capitoli del libro pubblicato in questo volume, che gli editori, quando il romanzo sarà finito, certo si contenderanno, perché Il sorriso dell’ignoto marinaio e un nuovo Gattopardo, ma più sottile, più intenso del romanzo di Tomasi di Lampedusa, uno Sciascia poetico, di venosa lava sanguigna e insieme razionalmente freddo nei suoi teoremi dell’intelligenza. (Stajano, 1975) La motivazione dell’articolo di Stajano sembra essere quella di voler forzare la mano di Consolo, spingendolo verso il completamento del romanzo. E anche notevole l’intento di fare pubblicità al romanzo futuro. Tuttavia, Stajano risulta anche molto ben informato del contenuto dei capitoli inediti e ciò suggerisce che al momento della pubblicazione della versione di Manusé la maggior parte del romanzo era già stata completata, o già comunque concettualmente concepita, e che Consolo ne stava discutendo apertamente con gli amici più fidati. Il romanzo completo, l’editio princeps, venne pubblicato l’anno successivo da Einaudi e fu accolto dagli elogi della critica (Consolo, 1976). Nel 1987 la Mondadori ne stampo un’edizione economica includendo una Introduzione firmata da Cesare Segre (Consolo, 1987). Nel 1991 Mursia pubblico una seconda edizione aggiornata dell’antologia di Leonardo Sciascia e Salvatore Guglielmino Narratori di Sicilia, che accoglie, con annotazioni, la prima sezione del capitolo I de Il sorriso (Consolo, 1991). Nel 1992 Einaudi ripubblico il romanzo (Consolo, 1992b) e nel 1995 ne apparve un’edizione scolastica, edita e annotata da Giovanni Tesio (Consolo, 1995).
Nel 1997 Mondadori ha pubblicato ancora una volta il romanzo insieme alla Nota dell’autore, vent’anni dopo (Consolo, 1997). Due successive riedizioni del romanzo sono state pubblicate sempre da Mondadori: la prima, nella collana Oscar scrittori del Novecento (Consolo, 2002); la seconda, in quella Oscar classici moderni (Consolo, 2004). Come si può intuire dalle date di pubblicazione, il periodo di gestazione de Il sorriso e stato decisamente lungo e in più va considerato che la versione originariamente pubblicata in «Nuovi Argomenti» differisce molto da quelle successive con una divisione in capitoli, anche perché parziale. Le varianti testuali tra le dieci versioni, edizioni e ristampe, databili dal 1969 al 1997, rivelano che Consolo ha rielaborato di continuo il suo testo. Che la maggior parte di esse siano quelle tra la versione di «Nuovi argomenti» e l’edizione del 1997, significa inoltre che Consolo ha ritoccato il testo dopo il 19768. Le varianti si diversificano per tipologia e importanza, partono dai più banali errori di battitura per arrivare alle sostituzioni e alle rielaborazioni di interi paragrafi. Questo di per sé suggerisce che il capitolo I e una sorta di workinprogress, un testo sempre compulsato dall’autore e completato da una serie di aggiunte accorpate nel corso degli anni. Lasciando da parte le fonti pubblicate, il cosiddetto emerso9, si può andare indietro fino al livello delle fonti precedenti alla pubblicazione e paratestuali che vanno a toccare il punto cruciale della genesi e gestazione del romanzo. Ho deciso di chiamarli pre-testi, nel senso che essi variano in tipologia, importanza e stato. Alcuni sono stati pubblicati e quindi dovrebbero rientrare nella categoria del paratesto, venendo così ad aumentare il nostro attuale bagaglio di nozioni sul romanzo. Pre-testi: genesi e gestazione Lo stato di incertezza che caratterizza i manoscritti autografi, i testi scritti a macchina, i saggi e gli altri “interventi autoriali”, con particolare attenzione alla gestazione del testo, sono noti. Anche il problema di datare il materiale presenta non poche difficolta. La tentazione, quando si ha a che fare con manoscritti e varianti testuali, e quella di sviluppare un approccio unilineare alla poetica dell’autore considerato; ascrivere a quell’autore certi presupposti fondamentali che tuttavia non sono facilmente verificabili. Nel caso di Consolo, al di là delle suddette edizioni del testo in forma di racconto e romanzo e dell’allettante realizzazione di varianti che intercorrono fra esse, esiste anche un ricco patrimonio di documenti non pubblicati. Nicolo Messina ha suggerito che sarebbe stato «illuminante, oltre che un’entusiasmante avventura, il poter penetrare grazie a un’edizione critica genetica all’interno della sua officina» (Messina, 1994: 40). Da allora, Messina si e imbarcato in questa avventura con una serie di articoli ispirati a un approccio filologico critico-genetico alle opere di Consolo, specialmente Il sorriso (Messina, 2005: 113-126). Oltre a ciò, Messina ha completato l’edizione critica del romanzo di cui si sentiva l’assoluta necessita e che è in sé stessa un vero capolavoro di critica-genetica10. Poiché Messina ha lavorato sui manoscritti e dattiloscritti, non mi ci soffermerò. 8 L’edizione del 1997 e il testo tenuto come base per lo studio di tutti gli altri, essendo la versione che ha ricevuto l’ultimo ne varietur dell’autore. Concordo in questo con Messina (2005: 121-124). 9 Ricorro alla denominazione di Messina (2005: 117-121). 10 Messina (2009). L’approccio critico-genetico di Messina e basato sui seguenti studi: Hay (1979), Degala (1988), Gresillon (1994), Tavani (1996) e Contat e Ferrer (1998). Ai fini del nostro discorso, pero, risulta assai significativo un dattiloscritto denominato Ds 2, o piuttosto le pagine che l’accompagnano (Ds 20), perché contengono una sorta di resoconto del futuro romanzo. In particolare, l’asserzione nella scheda Ds 20 che «sono due capitoli di un romanzo (capitoli o racconti autonomi, perché, nelle intenzioni dell’autore, intercambiabili e combinatori come carte da giuoco)», pone una serie di questioni che sono rilevanti per la genesi e la gestazione del testo. Ci sono numerose sovrapposizioni, intrecci tematici e corrispondenze lessicali tra i capitoli I e II del romanzo. Dal punto di vista strutturale, la narrazione di entrambi i testi e in parte focalizzata attraverso Mandralisca (capitolo I) e Interdonato (capitolo II) con corrispondenze tra i due. Il fatto che i capitoli I e II siano intercambiabili e combinatori, postula un’influenza di Italo Calvino sul metodo strutturale di Consolo, in particolare del saggio Appunti sulla narrativa come processo combinatorio (Calvino, 1995: 199-219). Nella spiegazione di Calvino dell’ars combinatoria tanti elementi avrebbero potuto colpire Consolo, non ultimi le citazioni da Strutture topologiche nella letteratura moderna di Hans Magnus Enzensberger11, Calvino tra l’altro afferma anche: La battaglia della letteratura e appunto uno sforzo per uscire fuori dai confini del linguaggio; e dall’orlo estremo del dicibile che essa si protende; e il richiamo di ciò che è fuori dal vocabolario che muove la letteratura. (1995: 211) E che Calvino nel saggio ritorni sul simbolo del labirinto dopo l’analisi fattane nel precedente La sfida al labirinto (1962), non avrà lasciato indifferente Consolo tutto preso dalla sua curiosa, personale concezione siciliana del labirinto in Il sorriso: cioè la chiocciola12. La questione della genesi del romanzo si può far risalire ancora più indietro, all’attività giornalistica di Consolo da metà degli anni Sessanta in poi. Al riguardo ci si può anche chiedere quale influenza abbia potuto esercitare il giornalismo sui suoi sforzi creativi. Per tanti aspetti il giornalismo consoliano e come un’istantanea dei multiformi interessi nutriti in quel tempo: letterari, artistici, politici e civili; e quando tutto ciò viene visto attraverso la lente de Il sorriso, ci si apre un’intrigante entrée nel mondo della sua attività creativa e poetica ancora in via di sviluppo. Consolo ha scritto per Tempo illustrato e, durante il suo primo periodo a Milano, ebbe una regolare rubrica intitolata Fuori casa nel giornale palermitano L’Ora13. Tuttavia, il suo rapporto con L’Ora 11 Avrà una diretta influenza su Consolo, si sa, il saggio di Hans Magnus Enzensberger (1966: 7-22). 12 Calvino (1995: 99-117) dove (116) si sostiene: «Quel che la letteratura può fare e definire l’atteggiamento migliore per trovare la via d’uscita, anche se questa via d’uscita non sarà altro che passaggio da un labirinto all’altro. E la sfida al labirinto che vogliamo salvare, e una letteratura della sfida al labirinto che vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al labirinto». Consolo mette in scena la sua sfida al labirinto attraverso il personaggio secondario di Catena Carnevale in Il sorriso. 13 La rubrica, pubblicata dal dicembre 1968 al maggio 1969, e definita un piccolo gioiello» da Nisticò (2001: 113); e si può rileggere in Consolo (2013: 179-223). precede il suo trasferimento a Milano ed e indissolubilmente legata con le sue attività in Sicilia14. Nel 1965 e negli anni immediatamente adiacenti, un gruppo di intellettuali e scrittori cominciarono a frequentare il giornale, tra questi Sciascia, il fotografo Enzo Sellerio, lo scrittore Michele Perriera e Consolo stesso. Vittorio Nisticò, direttore de L’Ora nel periodo 1955-1975, ricorda con affetto la presenza e il contributo di Consolo in quegli anni 15. Nel 1966, a seguito dell’omicidio per mano mafiosa del leader sindacale socialista Carmine Battaglia a Tusa (provincia di Messina), Consolo scrisse un breve racconto ispirato all’uccisione, Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, pubblicato ne L’Ora (16 aprile) un mese dopo l’evento 16. Anche se non può facilmente e strettamente rientrare nella categoria del giornalismo, il racconto, come sostiene Sciascia, e «una sorta di reportage giornalistico» (Consolo, 1967b: 429), ed e forse la prova più significativa della scrittura creativa di Consolo dopo La ferita dell’aprile, perché presenta in forma embrionale alcuni elementi linguistici, strutturali e tematici che saranno precipui de Il sorriso. Consolo, senza dubbio, ebbe come modello Le parole sono pietre di Carlo Levi, in particolare la terza sezione in cui si narra la sua visita a Francesca Serio, la madre del sindacalista socialista Salvatore Carnevale, assassinato anch’egli dalla mafia (Levi, [1955] 1979). Non e una coincidenza che Consolo abbia firmato in seguito l’introduzione per una nuova edizione del “libro-indagine”, (Levi, 1979; Consolo, 1999a, 251-257) in cui scrive tra l’altro: A Sciara, Levi ha trovato, sul filo sottile che inseguiva della nuova coscienza contadina, il punto più vero e più alto della realtà siciliana di quegli anni. E più vero e più alto si fa allora il tono del libro: le pagine su Francesca Serio di commozione rattenuta dal pudore, di parole scarne e risonanti. (Consolo, 1999a, 256) Lo stesso senso di ingiustizia e indignazione permea Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, anche se nella storia di Consolo la figura della madre e abbattuta dal dolore e il compito di parlare viene lasciato alla figlia, «una giovane bellissima». All’inizio la incontriamo impegnata in un’attività che fa seriamente presagire le preoccupazioni testuali e metaforiche del futuro romanzo: «dietro i vetri di una piccola finestra, ricamava» (Consolo, 1967b: 432; Consolo, 2012: 20). Come personaggio, la figlia anticipa la figura liminale, altamente metaforica, 14 La prima collaborazione risalirebbe esattamente al 4 febbraio 1964, una recensione di Menabò, 6. Cfr. Salvatore Grassia, in Consolo (2013: 229-230). 15 Nisticò (2001: 113): «Amavamo di lui il garbo, la modestia, il senso di amicizia, gli accenni di sorridente ironia, non meno di quanto ci affascinassero i ricami della sua scrittura, la sua totale mediterraneità, quei fuochi improvvisi della sua passione letteraria e civile.» Il memoriale di Nisticò e senz’altro un affascinante resoconto di un giornale di sinistra in prima linea nella lotta contro la mafia in uno dei più difficili periodi storici. 16 Il racconto fu poi ripreso da Narratori di Sicilia, cit. [ed. 19671], (Consolo, 1967b: 429- 434); ora, col titolo Un filo d’erba al margine del feudo (Consolo, 2012: 18-22; 239). Sul caso Battaglia, cfr. Ovazza (1967) e Santino (2000: 232-233). della venticinquenne Catena del Sorriso, che nell’Antefatto il padre si augura di vedere «serena dietro il banco a ricamare» (Consolo, 1997: 11)17. Anche il cognome di Catena e intrigante: si chiama, infatti, Carnevale, nome che rafforza il legame con il “giovane”, ventiduenne, Salvatore del racconto e con la famiglia di Le parole sono pietre. La presentazione della giovane ragazza da parte di Consolo suggerisce a Traina «sviluppi successivi della narrativa consoliana», come «l’insistenza sul dettaglio cromatico e sull’immagine “rubata” dal passante, che si fa quasi, emblematicamente, quadro o fotografia». (Traina, 2001: 16). Questa tecnica di sospensione della realtà tramite l’immagine fissa, una forma di ipotiposi, e un aspetto prevalente della narrativa più tarda di Consolo. Il racconto di Consolo contiene inoltre una serie di espedienti e scelte lessicali che saranno ulteriormente ampliati nel romanzo. Ecco esempi di emergenza di scrittura “consoliana”, quale poi impronterà il romanzo: «Il sole batteva […] sulle pietre di via Murorotto e sul portale d’arenaria ricamata del Palazzo»; «[…] col suo castello sull’acqua smagliante e triangoli di vele sui merli» (Consolo, 1867b: 429 2 431; Consolo, 2012: 18-19). E successivamente, nel capitolo I de Il sorriso, leggiamo: «Vorticare di giorni e soli e acque, venti a raffiche, a spirali, muro d’arenaria che si sfalda […]»; «Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollano i lor merli di cinque canne sugli scogli» (Consolo, 1997: 12; Consolo, 2015: 132). Inoltre, va sottolineato che la predilezione di Consolo per la catalogazione o inserzione, soprattutto di toponimi, e presente in maniera decisa nel racconto. Entrando nella citta di Tusa, il narratore si mette a conversare con un «vecchio con lo scialle», che indica le montagne circostanti: «Motta» […]. E poi «Pettineo, Castelluzzo, Mistretta, San Mauro…» […]. Stesi io il braccio nel vuoto oltre la ringhiera e indicai il mare. «Quelle macchie azzurre sono isole, Alicudi, Filicudi, Salina… Più in là c’è Napoli, il Continente, Roma…» «Roma» ripeté il vecchio. Volse le spalle al mare e continuo a indicare verso le montagne, ora con un breve cenno del capo: «Cozzo San Pietro, Cozzo Favara, Fulla, Foieri…». (Consolo, 1967b: 430; Consolo, 2012: 18) Il nome di Roma non dice niente al «vecchio», egli ripete meccanicamente ed elenca rapidamente i toponimi del suo mondo, toponimi non registrati sulle mappe ufficiali, come se la loro enunciazione andasse a evocare una realtà diversa. Questo senso di “urgenza toponimica” e la sua sospensione sono ripetuti nel capitolo I del romanzo, dove ancora una volta l’elenco dei toponimi della costa tirrenica della Sicilia e predominante: «Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo…» (Consolo, 1997: 12; Consolo 2015: 128). L’antico passato greco di Tusa e evocato in una breve parentesi del racconto e anticipa il Consolo de Il sorriso: La valle declinava dolce fino alla balza d’Alesa (le sue mura massicce, l’agora, i cocci d’anfora e i rocchi di colonna affioranti tra gli ulivi, la bianca Demetra dal velo incollato sul ventre abbondante). (Consolo, 1967b, 431; Consolo, 2012: 19) 17 Il ricamo di Catena e una chiara metafora tessile del testo. Per ulteriori approfondimenti di questo aspetto consoliano, cfr. il mio saggio: O’Connell, (2003, 85-105). Genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio 65 Il nome di Tusa deriva dall’arabo “Alesa al-tusah” (“Alesa la nuova”), quando l’antica città greca di Alesa perse il primato nella zona nella seconda meta del ix secolo, e il centro fu spostato verso il sito dell’odierna Tusa (Ingrilli, 2000: 56). Nel romanzo, Consolo sancisce una sorta di nostalgia antico-archeologica tramite l’esposizione di ulteriori elenchi toponimici: Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Calacte, Alesa… Citta nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. (Consolo, 1997: 13; Consolo, 2015: 128- 129) Oltre a manifestare le preoccupazioni più importanti del Mandralisca per l’archeologia e il suo rifiuto di affrontare la realtà contemporanea, nella fattispecie quel che si rivelerà essere un cavatore di pomice ammalato di silicosi, la frase si riferisce agli antichi toponimi greci della regione dei Nebrodi sulla costa tirrenica, alcuni dei quali erano già stati citati da Cicerone tra le città della Sicilia vittime di Verre: Tyndaritanam, nobilissimam civitatem, Cephaloeditanam, Haluntinam [Alunzio], Apolloniensem, Enguinam, Capitinam perditas esse hac iniquitate decumarum intellegetis. (Verrine, II.3, 103) Tuttavia nell’edizione del 1997 c’è una variante del testo: «Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Apollonia, Alesa…». Consolo ha chiaramente sostituito la diade Alunzio e Calacte con l’altra Alunzio e Apollonia con l’evidente intenzione di migliorare l’allitterazione della frase e ottenere un elenco alfabetico pressoché perfetto, e in tal modo ha rivelato che alcune rielaborazioni de facto hanno avuto luogo tra le due edizioni cronologicamente estreme dell’intero romanzo. Consolo suggerisce il motivo della sostituzione in un saggio celebrativo di Cefalù pubblicato nel 1999: «Nascere dov’erano soltanto echi d’antiche città scomparse, Alunzio Alesa Agatirno Apollonia, che con la loro iniziale in A facevano pensare agli inizi della civiltà» (Consolo, 1999b: 17). Le somiglianze sono evidenti e ci permettono di visualizzare i processi che hanno delineato la creazione di questo capitolo. Non e un caso, quindi, che questa invocazione alla lettera A, alla storia antica, alla storia seppellita sotto i toponimi odierni dovesse avvenire nella fase iniziale di un romanzo intimamente connesso tanto con ciò che la storia nasconde quanto con ciò che essa rivela. Apollonia, inoltre, si ritiene che fosse l’antico toponimo dell’odierna San Fratello, un paese che ha una funzione estremamente metaforica in gran parte delle opere di Consolo, non ultima Il sorriso18. Consolo sta, quindi, mettendo uno dei suoi marker, o 18 La citta e evocata, in vario grado, in La ferita dell’aprile (1963), Lunaria (1985) e nel racconto «I linguaggi del bosco», in Le pietre di Pantalica (1988). In particolare il sanfratellano, usato o semplicemente citato da Consolo a più riprese, sembra attirare l’attenzione dello scrittore per la natura e ricchezza di lingua “periferica”, voce di una cultura particolare in netto contrasto con la lingua omologata “centrale” cui ricorre la cultura dominante. Segnali, alludendo a qualcosa che acquisisce via via importanza con il procedere del racconto. L’evocazione di antichi toponimi era riapparsa invero in Le pietre di Pantalica, in quel Il barone magico che si avvale ancora una volta della toponomastica poetica e suggerisce con gli stessi toponimi (e qualcuno nuovo) non solamente una topografia autoriale personalizzata, ma anche la loro contiguità con l’atto di scrittura e gli inizi della parola: Qui era un tempo la città antica d’Agatirno, una delle città lungo questa costa che, coi loro nomi comincianti in A (Abacena, Alunzio, Apollonia, Amestrata, Alesa…) fanno pensare ai primordi, alle origini della civiltà. (Consolo, 1988: 147; Consolo, 2015: 603) Il passo tratto da Il sorriso condivide anche somiglianze con un’altra opera d’impostazione storica parallela, I vecchi e i giovani di Pirandello: Via Atenea, Rupe Atenea, Empedocle… – nomi: luci di nomi, che rendeva più triste la miseria e la bruttezza delle cose e dei luoghi. L’Akragas dei Greci, l’Agrigentum dei Romani, eran finiti nella Kerkent dei Musulmani, e il marchio degli Arabi era rimasto indelebile negli anni e nei costumi della gente. (Pirandello, 1973: 163) Il suo stato di intertesto e ulteriormente rafforzato appena più avanti, nello stesso quarto paragrafo, quando Consolo sostiene: «Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni» (Consolo, 1997: 13; Consolo, 2015: 129). Le affinità tra il pirandelliano nome: luci di nomi e il consoliano nomi […], suoni, sogni sono degne di nota. Forse sarà più significativo che Per un po’ d’erba ai limiti del feudo anticipi la tendenza di Consolo a usare documenti storici come discorsi compensativi all’interno delle proprie narrazioni, una pratica più pienamente realizzata ne Il sorriso dell’ignoto marinaio19. Sul portone del municipio era scolpito lo stemma della citta: un grosso cane muscoloso sopra una torre, le zampe posteriori contratte, sul punto d’avventarsi, i denti scoperti. (1860: «In più luoghi, come a Bronte, a Tusa e altrove, i Consigli municipali, costituiti dai Governatori distrettuali, erano composti di elementi della grossa borghesia o dell’aristocrazia di proprietari terrieri, avversi alle rivendicazioni contadine e ai fautori e capi del movimento per la divisione delle terre demaniali»). (Consolo, 1967b: 432; Consolo, 2012: 20) La parte del passo in corsivo e tratta da un documento contemporaneo allo sbarco di Garibaldi in Sicilia e sottolinea un fondamentale fattore storico del Risorgimento in Sicilia: l’opposizione delle classi dominanti in Sicilia al decreto del 2 giugno 1860 «col quale Garibaldi ordinava la divisione delle terre demaniali mediante sorteggio a tutti i capi di famiglia sprovvisti di terra, riservando una quota certa ai combattenti della guerra di liberazione ed ai loro eredi» (Romano, 1952: 139). 19 Segre esamina la funzione narrativa di tale pratica consoliana, anche se l’attenzione del saggio e incentrata esclusivamente sui documenti storici riprodotti in appendice e non su quelli incorporati nel testo stesso (Segre, 2005: 129-138). L’amara ironia che scaturisce dall’inclusione del documento sottolinea il fatto che in 106 anni poco era cambiato nella vita e nelle aspirazioni dei diseredati. E, forse, per questa ragione che Sciascia nella storia scorge il «gioco gattopardesco delle forze della conservazione» (Consolo, 1967b: 429). Da parte sua, di fronte alla staticità del corso degli eventi, Onofri sottolinea che l’immobilita storica, sancita dal documento legislativo, «trova finale suggello nella letteratura, testimonianza abbastanza precoce di quello che possiamo definire il circolo ermeneutico consoliano» (Onofri, 1995: 232). Tuttavia, a permeare queste pagine e soprattutto l’impegno di Consolo a favore della giustizia sociale. Nel racconto, dunque, si possono ritrovare le tracce evidenti del suo primo tentativo di scrivere qualcosa sui paesi medievali additati da Piccolo, pero attraverso il filtro dell’impegno di matrice sciasciana, cioè della sua stessa volontà di abbracciare i temi della giustizia sociale e politica. Sulla questione dell’inserimento di documenti storici nel narrato, il primo capitolo del Sorriso offre un accattivante esempio del metodo di Consolo. E riscontrabile nel diciannovesimo paragrafo e da nell’occhio proprio per quel che rivela delle procedure narrative impiegate dallo scrittore nei suoi testi multiformi. Il paragrafo, presentato per la sua maggior parte in corsivo, suggerisce una citazione o, almeno, una condizione narrante alternativa, una voce o un punto di vista diversi. Nel romanzo, l’unico altro luogo in cui una vasta porzione di testo e riportata in corsivo e nel Capitolo v, Il Vespero, in cui il passo incastonato non in tondo e mutuato direttamente da I promessi Sposi di Alessandro Manzoni: e la descrizione del momento della conversione dell’Innominato piegata da Consolo a tratteggiare il “tempo” e le sensazioni del personaggio Peppe Sirna (Consolo, 1997: 106; Consolo, 2015: 204-205; Manzoni, 2002: 409). Tranne il corsivo non c’è nel testo nessuna indicazione che si tratti di una citazione manzoniana. Nessuna indicazione, né note a piè di pagina né richiami all’autore, soccorre il lettore, il quale non può far altro che accettare la stranezza del passo ed andare avanti con la narrazione. Il brano e interrotto dall’improvviso cambiamento di registro impresso da Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, che esclama: «Uh, ah, cazzo, le bellezze!» (Consolo, 1997: 20; Consolo, 2015, 134), poiché la sua immaginazione prende il sopravvento sul resto del paragrafo. Ciò che precedeva in corsivo, pero, non è un parto dei rimuginii del protagonista del Sorriso, ma un qualcosa di abbastanza strano ed estraneo, e il frutto del pensare altrui, benché sia la mente del barone Mandralisca a rievocarlo. Si ha un indizio nella frase finale del paragrafo: Avrebbe fottuto il Biscari, l’Asmundo Zappala, l’Alessi canonico, magari il cardinale, il Pepoli, il Bellomo e forse il Landolina. Questo forse il Landolina e l’unica allusione, nel testo, ad una possibile fonte, anche se il lettore medio non ha modo né e in grado di saperlo. La parte in corsivo del brano, cioè i tre quinti del paragrafo, e, in effetti, una citazione diretta da una fonte che non sarebbe stata familiare per il Mandralisca, sebbene Consolo la abbia consultata come campione di stile di prosa degli intellettuali siciliani del tardo Settecento e del primo Ottocento. La fonte e proprio il Cavalier Saverio Landolina (1753-1814), figura dominante dell’archeologia siciliana all’inizio del xix secolo. La sua fama e la sua posizione di rilievo si dovevano alla scoperta della famosa Venere Anadiomene, fatta nel 1803 (Dizionario dei Siciliani illustri, 1939). Il testo in questione e da ricercare in una lettera datata 29 gennaio 1807 e indirizzata all’allora «Sopraintendente generale alle antichità», un certo Soratti Agnello, 1972: 218-219; Consolo, 1997: 19-20; Consolo, 2015: 134): Passando a visitare li monumenti del Tindaro ebbi il dispiacere di non ritrovare il più bel pezzo, che l’altra volta vi avevo ammirato. Erano due piedi con le gambe fino alle cosce di un giovane ignudo di elegantissimo greco lavoro, con un’ara dal lato sinistro ben ornata, di marmo alabastro bianco. Osservai ancora due grossi pezzi di marmo statuario, che insieme formavano il busto di un uomo di statura gigantesca; in uno dei detti pezzi si vede la corazza ornata di bassi rilievi, tra i quali si distinguano una bulla pendente sul petto con una testa molto crinita come si osserva in molte nostre medaglie. Dalla spalla destra era pendente sopra la mammella una fettuccia lavorata. Su la spalla sinistra era elegantemente rilevato il gruppo del pallio che doveva coprire le spalle. Sopra il ventre erano due ippogrifi. L’altro pezzo di marmo era il rimanente della corazza, cioè le fibule e le bulle pendenti sopra il sago che copriva le cosce le quali si vedono tagliate. Le bulle erano tutte figurate con varie teste di animali e qualcuna umana. L’esistenza di questi pezzi nel Tìndaro mi fa sospettare che potevano appartenere ad una statua dei Dioscuri, descritti sempre dai poeti in abito militare. Il brano di Landolina e citato pressoché alla lettera e le sole inter/estrapolazioni eseguite da Consolo vanno individuate nei tempi verbali e in quei segmenti del brano che si riferiscono al Landolina stesso. Questo tipo di intertestualità e abbastanza sconcertante per il lettore e, una volta rilevato, mostra il modo in cui si forgia lo stile di Consolo: testi dentro testi, siano essi citazioni poetiche di scrittori canonici o citazioni dirette da oscuri testi archeologici del xix secolo. La citazione letteraria diretta si può considerare ammissibile, se accettiamo che il punto di vista narrativo e qui quello del Mandralisca, com’e peraltro accertabile nel resto di questo capitolo iniziale, ma la citazione diretta da lettere di argomento archeologico e più problematica. Segre scrive che Consolo condivide con Gadda «la voracità linguistica, la capacita di organizzare un’orchestra di voci, il risultato espressionistico» e, assecondando le riflessioni di Bachtin, aggiunge che il plurilinguismo di Consolo e anche «nettamente plurivocità» (Segre, 1991: 83-85). Al riguardo i commenti bachtiniani sull’enciclopedismo nel genere del romanzo sono rilevanti, specialmente in quelli da lui definiti romanzi della seconda linea. Questo tipo di romanzo tende all’enciclopedicità dei generi, e si avvale anche dei generi inseriti. Il fine principale e introdurre nel romanzo la pluridiscorsività, la varietà delle lingue di un’epoca. Scrive Bachtin che i generi extraletterari sono introdotti non per “nobilitarli” e “letteraturizzarli” ma proprio perché sono extraletterari, perché era possibile introdurre nel romanzo una lingua extraletteraria (persino un dialetto). La molteplicità delle lingue dell’epoca deve essere rappresentata nel romanzo (Bachtin, 2001: 218). L’uso sapiente di Consolo di mescolare generi letterari ed extraletterari contrassegna Il sorriso come un complesso romanzo polifonico. Tuttavia, la funzione di memoria qui e profondamente testuale e quindi comparabile a un palinsesto. Un altro brano altamente significativo di Consolo in questi anni Sessanta appare ne L’Ora ed e un pezzo dedicato a Lucio Piccolo. L’articolo intitolato Il barone magico celebra in apparenza l’impresa poetica di Piccolo (Consolo, 1967a)20. Il testo di Consolo sarebbe un pretesto per la presentazione di tre poesie inedite di Piccolo e un frammento della sua prosa Balletto in tre tempi: L’esequie della luna21. Come nel caso di Per un po’ d’erba ai limiti del feudo, Il barone magico anticipa molto del futuro Sorriso, ma se l’attenzione nel racconto era imperniata sull’indignazione civile dell’autore, il pezzo su Piccolo vede un Consolo lontano dalle questioni politiche e, invece, fortemente immerso nelle potenzialità magiche della parola, radicate nella seduzione del testo poetico. Se il primo era sciasciano nei presupposti e risultati, il secondo e, in gran parte, piccoliano nella sua espressività. Queste tendenze conflittuali dovevano risolversi nell’intensa fusione della scrittura de Il sorriso, in cui Consolo stesso divenne, per Stajano, uno «Sciascia poetico» (Stajano, 1975). E – si potrebbe forse aggiungere – anche un “Piccolo impegnato”. Questi, poi, sono gli scritti di Consolo fino al momento del trasferimento a Milano nel 1968, scritti che rivelano chiaramente che egli aveva già in mente le coordinate del futuro romanzo. Non che il suo rapporto con il giornale palermitano si fosse concluso con la decisione di lasciare la Sicilia, anzi le collaborazioni di Consolo con L’Ora s’intensificarono e divennero più “tradizionalmente” giornalistiche. I temi affrontati per il quotidiano erano abbastanza diversificati e variavano dalla politica, alla cronaca, alla critica d’arte, alle interviste e recensioni, come anche ad alcuni saggi di produzione creativa. Nel 1975 Consolo torno in Sicilia a lavorare al romanzo e ricomincio a frequentare L’Ora. La testimonianza di Nisticò e interessante per l’attenzione prestata agli interessi poliedrici di Consolo e alle attività da lui svolte contemporaneamente alla scrittura de Il sorriso: Nei primi mesi del ’75 Consolo si trasferì per un po’ di tempo a Palermo. […] si butto con manifesta gioia in un intenso lavoro giornalistico. […] Insomma, un bel bagno mediterraneo di umile giornalismo, mentre tra un servizio e l’altro trovava il luogo e il silenzio dove ripararsi per dare gli ultimi ritocchi a Il sorriso dell’ignoto marinaio: il capolavoro che da li a qualche mese lo avrebbe consacrato tra gli eredi della grande letteratura che la Sicilia ha dato alla nazione. A dicembre ne pubblicammo in anteprima un capitolo: la festa in casa del barone Mandralisca. (Nisticò 2001: 113-114) 20 La maggior parte del materiale dell’articolo costituisce la prima sezione del suo successivo «Il barone magico» (Consolo, 1988: 133-135). 21 Le poesie erano Plumelia, L’andito e quella che sarà poi intitolata Non fu come credesti per lo scatto. Un altro esercizio giornalistico con attinenza diretta alla formazione del capitolo i e un articolo, datato al 1970, fremente d’indignazione civile per le deplorevoli condizioni di lavoro dei cavatori di pomice dell’isola di Lipari. Originariamente intitolato «Il paese dei vivi pietrificati», fu pubblicato su Tempo illustrato, ma sotto altro titolo e solo dopo aver subito pesanti interventi modificatori (Consolo, 1970)22. Ancora una volta, affiora il primo capitolo del romanzo che si occupa del destino dei cavatori di pomice di Lipari e della strana malattia da cui sono affetti: la silicosi, popolarmente conosciuta come Male di pietra. L’articolo di Consolo e degno di nota, in quanto mette in risalto un misto di strategie del discorso significative anche per la sua poetica narrativa (Consolo, 1997: 177). Le preoccupazioni di Consolo sono molteplici, ma ciò che dà forza all’articolo e nel fondo la messa a fuoco della percentuale insolitamente alta a Lipari di malati di silicosi e della loro breve aspettativa di vita. Come chiarisce l’ignoto marinaio del romanzo, a provocare la malattia e l’estrazione della pietra pomice senza rispettare le più elementari misure di sicurezza. Consolo definisce le cave «un kafkiano teatro di vita penale dove si aspetta da sempre il messaggio dell’imperatore»23. E una sorta di altra controversia liparitana, ma diversa da quella della Recitazione sciasciana, in quanto lo sfondo non e settecentesco e Consolo vi delinea una storia dei cavatori di pietra pomice sull’isola a partire dal 1838, quando il monopolio e dato in appalto ad un francese di nome Gabriel Barthe. Lo scrittore si addentra nella battaglia giudiziaria tra questi e il vescovo di Lipari Giovampietro Natoli per il controllo delle miniere: il vescovo ottenne la proprietà delle terre, rifacendosi a un decreto del re Roberto I d’Altavilla datato 108424! E non mancano accenni alla moglie del Guiscardo ovvero Adelasia di Monferrato, evocata nel primo capitolo del romanzo e sepolta a Patti. Questa serie di informazioni a prima vista insignificanti permette a Consolo di presentare l’effettivo proprietario delle cave di pietra pomice al momento della redazione dell’articolo: la mafia, legata al finanziere Michele Sindona, nato a Patti 25. Tuttavia, che le condizioni di lavoro dei cavatori non fossero cambiate 22 Sono grato a Caterina Consolo per avermi fornito una copia dell’originale Il paese dei vivi pietrificati, composto da 5 cartelle battute a macchina con annotazioni e correzioni di mano dell’autore, e aggiunte vergate da Caterina Consolo: il toponimo «Lipari» (indicante il tema), la data di redazione: «settembre», e il futuro del testo: «[pubblicato non integralmente]». La cartella finale e datata: «3 settembre 1970». 23 «Il paese dei vivi pietrificati», cit., c. 3. Omesso nella versione apparsa in Tempo illustrato. 24 Consolo cita dal documento storico riportandolo ne «Il paese dei vivi pietrificati», ma il passaggio non compare in «Cosi la pomice si mangia Lipari». 25 Il banchiere Sindona fu una figura di spicco che ebbe contatti stretti con la mafia, leader politici italiani e la Loggia Massonica di Licio Gelli: la P2 (ben nota per gli scandali in cui fu coinvolta). Cfr. Renda (1998: 400-404); Lupo (1996: 262-271). L’editore di Tempo Illustrato soppresse evidentemente ogni riferimento a Sindona e al fatto che il manager dell’impianto Italpomice, Gebhart Raisch, era presumibilmente un ex Maggiore delle SS. dal 1852, anno dell’azione del primo capitolo de Il sorriso, e ben descritto nel pezzo che segue: Alle spalle di Canneto e il monte Pelato, il monte grigio-bianco con pomice con tra le gole radi cespugli verdastri. […] Gli operai sono dentro le gallerie sparsi qua e là per il costone. Con solo le mutande addosso, sotto questo sole di agosto, sono neri, piccoli e neri contro il bianco abbagliante. Sembrano ragni o scarafaggi che si muovono sopra una parete di calce o di sale. Dall’altra parte della strada vi è il burrone che precipita fino al mare. Dalla costa sì partono e vanno fino al largo snelli pontili neri, geometrici, sui quali scorrono i nastri trasportatori che riempiono le stive delle navi attraccate all’altro capo26. Il passo ha notevoli affinità con un altro del capitolo I de Il sorriso in cui Mandralisca svia il minuzioso esame di Interdonato permettendo alla sua immaginazione di proteggerlo dalla vista di uno di questi ‘cavatori’ e rivelando cosi che Consolo sta visualizzando la scena attraverso il filtro del suo testo: Al di là di Canneto, verso il ponente, s’erge dal mare un monte bianco, abbagliante che chiama si Pelato. Quivi copiosa schiera d’uomini, brulichio nero di tarantole e scarafaggi, sotto un sole di foco che pare di Marocco, gratta la pietra porosa col piccone; curva sotto le ceste esce da buche, da grotte, gallerie; scivola sopra pontili esili di tavole che s’allungano nel mare fino ai velieri. Sotto queste immagini il Mandralisca cercava di nascondere, di rimandare indietro altre che in quel momento (frecce di volatili nel cielo di tempesta migranti verso l’Africa, verdi chiocciole segnanti sulla pietra strie d’argento, alte flessuose palme schiudenti le vulve delle spate con le bianche pasquali inflorescenze…)27 Il paese dei vivi pietrificati e poi un esempio di come i processi creativi di Consolo abbiano chiaramente influenzato la sua scrittura giornalistica, in un’inversione di tendenza rispetto agli scritti per L’Ora fin qui considerati. Questi articoli dimostrano che Consolo stava riconsiderando i temi Risorgimentali da tanti punti di vista e in differenti prospettive. Un ultimo punto da trattare, attinente alla gestazione del romanzo, e quello degli scritti consoliani relativi, ovvero ispirati, all’arte figurativa. Questa scrittura differisce considerevolmente da quella della produzione giornalistica ed e fatta principalmente di presentazioni per mostre di artisti contemporanei. Una in particolare, manifestando l’innata vocazione di Consolo a usare forme metriche nella prosa, esercito una diretta influenza sulla gestazione del capitolo i. Il testo, intitolato Marina a Tindari, fu scritto per la mostra personale di Michele Spadaro tenutasi a Como presso la Galleria Giovio il 15-30 aprile 1972. Un centinaio di copie del testo della presentazione di Consolo venne pubblicato 26 «Il paese dei vivi pietrificati», cc. 2-3. La parte di testo in corsivo e stata omessa nell’articolo di Tempo illustrato. 27 Consolo (1969) e Consolo (1975a) presentano entrambi la variante precedente «sotto un sole di foco che pare di Morea». Consolo ha scritto un altro pezzo per Tempo illustrato (2 ottobre 1971) con il titolo «C’era Mussolini e il diavolo si fermo a Cefalù». L’articolo porta avanti un’indagine sulla residenza di Aleister Crowley a Cefalù nei primi anni venti del Novecento ed e il primo indizio del futuro Nottetempo, casa per casa (1992). nello stesso anno dal fratello dell’artista, Sergio Spadaro, insieme a un breve saggio (Consolo, 1972)28. In Marina a Tindari, dopo un’introduzione di prosa prelevata direttamente da Consolo (1969), seguono ventiquattro versi: Quindi
Adelasia, regina d’alabastro,
ferme le trine sullo sbuffo,
impassibile attese che il convento si sfacesse.
— Chi e, in nome di Dio? — di solitaria
badessa centenaria in clausura
domanda che si perde per le celle,
i vani enormi, gli anditi vacanti.
— Vi manda l’arcivescovo? —
E fuori era il vuoto.
Vorticare di giorni e soli e acque,
venti a raffi che, a spirali, muro
d’arenaria che si sfalda, duna
che si spiana, collina,
scivolio di pietra, consumo.
Il cardo emerge, si torce,
offre all’estremo il fiore tremulo,
diafano per l’occhio cavo
dell’asino bianco.
Luce che brucia, morde, divora
lati spigoli contorni,
stempera toni macchie, scolora.
Impasta cespi, sbianca le ramaglie,
oltre la piana mobile di scaglie
orizzonti vanifica, rimescola le masse.
(Consolo, 1972: 15-16)
Nel primo capitolo di Consolo (1975a) il paragrafo 14 e un chiaro esempio delle numerose aggiunte testuali di questa edizione. Il paragrafo e costituito proprio da questo testo in versi di Marina a Tindari, ricondotto, per così dire, all’originaria prosa del catalogo, e in questa forma interpolato tale e quale da Consolo in nell’edizione di 1975a29. Echi di T. S. Eliot, Salvatore Quasimodo e Piccolo sono evidenti sin da una lettura iniziale. Il dato significativo, pero, e che la poetica di Consolo comporti anche l’innesto di altri testi nel romanzo. Questo accorpamento non è solo una forma di autocitazione, ma un radicale spostamento di materiali testuali e potenzialità poetiche: cioè la nuova poetica 28 Consolo scrisse anche per la personale di un altro pittore: Luciano Gussoni, Villa Reale di Monza, 10-30 novembre 1971. Il titolo della presentazione era, nota interessante, Nottetempo, casa per casa. Secondo Messina (2005: 123), il testo scritto per la mostra avrebbe avuto una diretta ripercussione nella costruzione del capitolo vii de Il sorriso, dove sarebbe stato rifuso. Cfr. Messina (2009: 390-393); e inoltre p. 592-621 e 623-627, con le anastatiche del catalogo di Spadaro e di Marina a Tindari, seguite da quella del catalogo di Gussoni. 29 La disposizione in versi e opera del curatore del libretto, Sergio Spadaro, che ha inteso cosi visualizzare i metri intravisti nella prosa consoliana per il catalogo originario. Per un’analisi delle forme metriche nella prosa di Consolo, cfr. Finzi e Finzi (1978: 121-135). di Consolo comporta l’accumulo di diversi testi di varia provenienza, siano essi giornalistici, creativi o di ambito saggistico, in uno spazio a meta fra il polifonico e il palinsesto di singolare gestazione autoriale. Inoltre, in questo particolare esempio, lo spostamento di materiali testuali investe il rapporto di Consolo con l’arte figurativa e le potenzialità proteiformi di parola e immagine. Altrove lo scrittore ha dichiarato: [.,.] io non ho mai scritto una recensione di tipo logico critico dei pittori. I pittori mi interessavano quando mi davano lo spunto per scrivere delle pagine di tipo lirico narrativo, ed allora poi utilizzavo queste presentazioni per scrivere quelli che io chiamo gli ‘a parte’, la parte del coro quando s’interrompe la narrazione. Queste digressioni di tipo lirico espressivo che i latini chiamavano ‘cantica’. (Consolo, 2006: 235) Questo tipo di poetici a parte o di elementi lirico-narrativi a carattere digressivo, sono presenti con maggior frequenza nell’opera più tarda di Consolo e vi assolvono una funzione decisamente corale. L’esempio dedotto dal capitolo i de Il sorriso rappresenta la prima apparizione di questa procedura unica nell’opera di Consolo, una procedura che suggerisce anche il suo ruolo epifanico all’interno della prosa. Non si tratta di un’ekphrasis nel senso stretto del termine, ma la fonte prima svolge una funzione ecfrastica nel suo accentuare l’articolazione del campo visivo. Cosi, queste fonti testuali, giornalistiche, saggistiche e creative, insieme alle varianti testuali, offrono un aiuto inestimabile per la ricostruzione del capitolo i de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Esse evidenziano i momenti salienti della gestazione e forniscono spunti di approfondimento delle preoccupazioni dell’autore; sono parte integrante dei processi creativi del romanzo e ampliano la nostra conoscenza degli aspetti oscuri dell’intero testo; soprattutto, ci permettono di vedere Il sorriso come un prodotto testuale degli anni attorno al 1960, periodo intimamente collegato agli anni di Consolo in Sicilia. Una volta a Milano, lo scrittore inizio l’arduo cammino di tracciare la forma del suo romanzo, di riunirvi tutti i disparati elementi di questo testo mutevole.

Daragh O’Connel
Bibliografia
AA.VV., 1939, Dizionario dei Siciliani illustri, ristampa anastatica, Palermo, F. Ciuni Libraio Editore. Agnello G. (a cura di), 1972, «Le antichità di Tindari nel carteggio inedito di Saverio e Mario Landolina», Estratto dall’Archivio Storico Siciliano Serie iii – Vol. xx, Palermo, La Società Siciliana per la Storia Patria, p. 218-219. Bachtin M., 2001, Estetica e romanzo, trad. Clara Strada Janovič, Torino, Einaudi. Calvino I., 1995, Una pietra sopra, Milano, Mondadori. Consolo V., 1967a, «Il barone magico: Lucio Piccolo», L’Ora, 17 febbraio. Consolo V., 1967b, «Per un po’ d’erba ai limiti del feudo», in: Narratori di Sicilia, a cura di Leonardo Sciascia & Salvatore Guglielmino, Milano, Mursia, p. 429-434. Consolo V., 1969, «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Nuovi Argomenti, 15 (luglio settembre), p. 161-174. Consolo V., 1970, «Cosi la pomice si mangia Lipari», Tempo illustrato, 17 ottobre. Consolo V., 1971, «C’era Mussolini e il diavolo si fermo a Cefalù», Tempo illustrato, 2 ottobre. Consolo V., 1972, Marina a Tindari, a cura di Sergio Spadaro, Vercelli, Arti grafiche Cav. Piero De Marchi. Consolo V., 1975a, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Gaetano Manusé. Consolo V., 1975b, «Un suggestivo anticipo del nuovo romanzo di Vincenzo Consolo. Festa in casa del barone Mandralisca», L’Ora, 9 dicembre. Consolo V., 1976, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Torino, Einaudi. Consolo V., 1985, Lunaria, Torino, Einaudi. Consolo V., 1987, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 1988, Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori. Consolo V., 1991, «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Narratori di Sicilia, a cura di Leonardo Sciascia e Salvatore Guglielmino, Milano, Mursia, p. 387-395. Consolo V., 1992a, Nottetempo, casa per casa, Milano, Mondadori. Consolo V., 1992b, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Torino, Einaudi. Consolo V., 1993, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli. Consolo V., 1994, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori. Consolo V., 1995, Il sorriso dell’ignoto marinaio, a cura di Giovanni Tesio, Milano, Elemond Scuola. Consolo V., 1997, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 1999a, Di qua dal faro, Milano, Mondadori. Consolo V., 1999b, «La scoperta di Cefalù (come un racconto)», in: Vincenzo Consolo, Giuseppe Leone, Cefalù, Palermo, Bruno Leopardi. Consolo V., 2002, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 2004, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori. Consolo V., 2006, «Clausura de las jornadas», Lunaria vent’anni dopo, a cura di Irene Romera Pintor, Valencia, Generalitat Valenciana, p. 235-237. Consolo V., 2012, La mia isola è Las Vegas, Milano, Mondadori. Consolo V., 2013, Esercizi di cronaca, Palermo, Sellerio. Consolo V., 2015, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani». Consolo V., 2017, Cosa loro. Mafie fra cronaca e riflessione. 1970-2010, Milano, Bompiani. Contat M., Ferrer, D. (a cura di), 1998, Pourquoi la critique génétique ? Méthodes, théories, Paris, CNRS Éditions. Contini G., 1970, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi. Enzensberger H. M., 1966, «Letteratura come storiografia», Il menabò, 9, p. 7-22. Genesi e scrittura ne Il sorriso dell’ignoto marinaio 75 Finzi A., Finzi, M., 1978, «Strutture metriche della prosa di Consolo», Linguistica e letteratura, 3: 2, p. 121-135 Genette G., 1997, Palinsesti: la letteratura al secondo grado, Torino, Einaudi. Gresillon A, 1994, Éléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes, Paris, P.U.F. Hay L. (a cura di), 1979, Essais de critique génétique, Paris, Flammarion. Ingrilli F., 2000, Paesi e paesaggi dei Nebrodi, Brolo, Ermes dei Parchi. Levi C., [1955] 1979, Le parole sono pietre, Torino, Einaudi. Lupo S., 1996, Storia della mafia: dalle origini ai nostri giorni, Roma, Donzelli. Manzoni A., 2002, I promessi sposi (1840), a cura di Salvatore S. Nigro, Milano, Mondadori. Messina N., 1994, «Due contributi alla lettura di Vincenzo Consolo tra ecdotica e “Quellenforschung”», Cuadernos de Filología Italiana, 1, 39-46 Messina N., 2005, «Per una storia di “Il sorriso dell’ignoto marinaio” di Vincenzo Consolo», Quaderns d’Italia, 10, p. 113-126 Messina N., 2009, Per un’edizione critico-genetica di Vincenzo Consolo. «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Madrid, Universidad Complutense de Madrid, «E-Prints Complutense», <http://eprints.ucm.es/8090/> Nisticò V., 2001, Accadeva in Sicilia. Gli anni ruggenti dell’«Ora» di Palermo, Palermo, Sellerio. O’Connell D., 2003, «‘Trista conca’: Dantean Anagnorisis and Echo in “Il sorriso dell’ignoto marinaio”», Echi danteschi/ Dantean Echoes, a cura di Roberto Bertoni, Torino, Trauben, p. 85-105. O’Connell D., 2004, «Il dovere del racconto: Interview with Vincenzo Consolo», The Italianist, 24 (2), p. 238-253. O’Connell D., 2005, «Zu Luigi: Pirandello and the Sicilian Literary Tradition», Pirandello Studies, 25, p. 29-48. O’Connell D., 2008, «Consolo narratore e scrittore ‘palincestuoso’», Quaderns d’Italia, 13, p. 161-184. Onofri M., 1995, Tutti a cena da Don Mariano. Letteratura e mafia nella Sicilia della nuova Italia, Milano, Bompiani. O’rawe C., 2007, «Mapping Sicilian Literature: Place and Text in Bufalino and Consolo», Italian Studies, 62, p. 79-94. Ovazza M., 1967, Il caso Battaglia. Pascoli e mafia sui Nebrodi, Palermo, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre. Pirandello L., 1973, I vecchi e i giovani, in Tutti i romanzi, II, a cura di Giovanni Macchia e Mario Costanzo, Milano, Mondadori. Renda F., 1998, Storia della mafia, Palermo, Sigma Edizioni. Romano S. F., 1952, Momenti del Risorgimento in Sicilia, Firenze, D’Anna. Santino U., 2000, Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Roma, Editori Riuniti. 76 Daragh O’Connell Segala A. (a cura di), 1988, Littérature Latino-américaine et des Caraïbes du xxE siècle. Théorie et pratique de l’édition critique, Roma, Bulzoni. Segre C., 1991, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi. Segre C., 2005, Tempo di bilanci. La fine del Novecento, Torino, Einaudi. Stajano C., 1975, «Il sorriso dell’ignoto marinaio. Due siciliani pazzi per un libro ‘unico’», Il Giorno, 30/11/1975. Tavani G., 1996, «Filologia e genetica», Cuadernos de Filología Italiana, 3, p. 63-90. Traina G., 2001, Vincenzo Consolo, Fiesole, Cadmo.
Le Chesterfield
*
Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia
che tocca i punti dolenti del passato e del presente e che
viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta
della ragione.
Leonardo Sciascia
Veniva giù da via Redentore un uomo piccolo e bruno, di trentatré
anni, capelli lisci sopra l’alta fronte. Camminava pensoso,
gli occhi neri e acuti che esploravano la strada, con guizzi d’attenzione,
illuminazioni di brio, adombramenti, a seconda dello
spettacolo della vita di quelle prime ore del mattino.
E venivano giù per corso Umberto, salivano su da corso Vittorio
Emanuele, sbucavano da Santa Maria degli Angeli, da Santo
Spirito, dalle Grazie, da vie e viuzze, braccianti, muratori e
zolfatari, convergevano tutti nella piazza Garibaldi.
Allo slargo di corso Umberto, dov’è la chiesa del Collegio,
l’uomo non poté fare a meno di sostare davanti alla vetrina d’un
libraio. Vi spiccavano dei bei libretti di poesie e prose, disposti
uno accanto all’altro a fare macchia bianca, un quadrato luminoso
e calmo nel colorato e chiassoso panorama delle copertine
intorno. Erano libri di Pasolini, Marin, La Cava, Uccello… E
insieme, bianca anch’essa, una rivista letteraria che si stampava
a Roma, “Nuovi Argomenti”, sulla cui copertina era impresso
l’indice, con in basso il nome dell’uomo davanti alla vetrina, e
un titolo, Cronache scolastiche: il suo diario d’un anno di maestro
elementare. Si sarebbe aggiunto, a quelle cronache, il Diario elettorale,
che aveva finito di stendere qualche giorno avanti e che
aveva lì, in fogli dattiloscritti, dentro una borsa. Diario elettorale
delle elezioni del giugno appena scorso, da cui ancora una
volta la Democrazia Cristiana era uscita trionfante.
L’uomo voltò le spalle alla vetrina e accese una Chesterfield,
sigarette che fumava dall’arrivo delle truppe americane in Sicilia.
Come Montale le Giubek dal tempo della guerra d’Africa.
Fumava tanto, e quelle forti, grasse sigarette americane. Strati
di nicotina s’interponevano ormai tra lui e quel mondo intorno,
come argini di sabugina e malta, rinforzi di cemento a puntellare
muri che, per ognuno nato nell’Isola, sono sul punto sempre
di crollare, dissolversi nel marasma e nel furore. Massa di
nicotina a saldare libri, conci di libri chiari e solidi, bugnati, da
sopra i quali poter guardare senza più rischio, poter studiare,
poter capire quella bufera grande che è la realtà della Sicilia.
Diuturno rischio, di vita e di ragione. Come nel ventre della
terra, nel cuore della zolfara. Da cui non s’esce mai. O, se usciti,
si guarda questo mondo con stupore di fanciullo – la Luna,
“grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio”,
su nel cielo – o nudamente, senza più illusioni. Sì, sapeva
bene l’uomo che nei vapori dello zolfo, che ambedue avevan
respirato dalla nascita, era la somiglianza, ma nella sorte d’essersi
trovati dentro o fuori la zolfara era la differenza fra sé e lo
scrittore grande di Girgenti, nei cui sofismi, nei cui fantasmi o
personaggi ognora s’imbatteva.
Frate Agrippino, in parlatorio, si fermò a guardare un quadro,
un ex-voto raffigurante zolfatari, due picconieri e un caruso, quasi
sepolti dai massi pel franamento interno d’una galleria, un San
Michele in aria, in un alone d’oro, l’Anime ardenti in basso del
santo Purgatorio. La scena lo portò col pensiero al suo paese, a
Mineo, nome che forse proveniva da una miniera; a sua madre,
Ignazia, che nelle fiamme ancor si consumava; a sé, quasi sepolto
dalle pietre dei padri gesuiti ma che la spada d’oro della
vera fede ormai aveva portato in salvamento.
Si scosse, s’accorse della valigia che reggeva e si ricordò della
corriera. Corse, via dal convento, per la contrada Balàte, si perse
in un labirinto di vicoli e di strade, senza riuscire a trovare la
stazione. In preda ormai all’angoscia, corse per tutta via Testasecca,
via Palmeri, e sbucò in corso Umberto, andando quasi a
sbattere contro l’uomo che, scostatosi dalla vetrina del libraio,
aveva ripreso la sua strada.
«La corriera, la corriera per Mazzarino!…» gli gridò implorante
frate Agrippino.
«In piazza Marconi» rispose l’uomo. «C’è tempo, parte alle
sette e mezzo.»
«E dov’è, dov’è questa piazza Marconi?»
«Venga con me, anch’io prendo la corriera.»
Frate Agrippino, rassicurato dalle parole dell’uomo, gli si affiancò,
si attaccò a lui come a una guida, un protettore.
«Anche lei va a Mazzarino?» gli chiese.
«No, vado a Regalpetra, in provincia di Girgenti.»
«Peccato! Io sono forestiero, vengo da Roma, ma sono nativo
di Mineo» gli disse frate Agrippino.
«Il paese di Capuana» disse l’uomo.
«Eh, Capuana. Non era un buon cristiano…»
L’uomo sorrise, divertito.
«Perché?» chiese per spingerlo a parlare.
«Mah! Prima di tutto, ha scritto cose licenziose. Poi, viveva
more uxorio con la serva. Terzo, praticava lo spiritismo,
che è proibito dalla Chiesa, inquietava le Animuzze Sante del
Purgatorio.»
«Ma le animuzze sante non sono contente di farsi ogni tanto
un bel viaggio qui sulla terra?»
«Eh no! Ché poi il tempo che perdono lo devono scontare lo
stesso, e devono riprendere a bruciare, a bruciare…»
«Ma almeno gli serve come pausa, come refrigerio.»
«Lo chiama refrigerio tornare in quest’inferno, in questa geenna,
in questa valle di peccato, di dannazione? Morire bisogna,
morire subito, anche volontariamente, in grazia di Dio, e andarsene,
andarsene… Ma io non posso parlare, non posso parlare…»
fece frate Agrippino; e quindi, abbassando la voce:
«I Gesuiti, i Gesuiti mi perseguitano!» e fissò negli occhi
l’uomo, con i suoi occhi spiritati. L’uomo, che prima aveva
sorriso divertito, si fece serio, triste, scoprendo all’improvviso
di trovarsi faccia a faccia col male misterioso e endemico
di questa sua terra. E gli capitava spesso, a lui cultore della
razionalità, del pensiero chiaro e ordinato, amante dell’ironia
e del piacere dell’intelligenza, d’imbattersi in persone che lo
incuriosivano per la loro originalità, per la loro comica eccentricità,
che gli facevano pregustare spasso, gioco lieve e ameno,
e che scoprivano invece, come denudandosi all’improvviso,
la malata pelle della pazzia. E gli si rivoltava allora tutto
in amaro, in penoso.
Giunsero nella vasta piazza Garibaldi, dove due chiese, Santa
Maria la Nova e San Sebastiano, si fronteggiavano, gareggiavano
in monumentalità e fasto, e dove al centro, occhio verde e
drammatico, s’apriva una gran fontana dalla cui acqua stagnante
affioravano pietre limacciose e le statue in bronzo d’un cavallo
marino trattenuto da un tritone, di fantastici animali, i denti
digrignati, riversi sul dorso, la pancia in aria, simili a blatte,
batraci, basilischi giganti.
La piazza brulicava d’uomini, a coppie, a crocchi, fermi, in
movimento. Conversavano, vociavano, entravano e uscivano
dai caffè, dalle pasticcerie, dalle tabaccherie che s’aprivano sulla
piazza, s’ammassavano davanti al furgoncino del panellaro.
Sembrava domenica mattina dopo l’uscita della messa cantata.
Solo ch’erano tutti in vestito da lavoro, rattoppato, stinto,
e questo era il raduno del mattino, col pretesto del caffè, delle
sigarette, del pane e panelle, per rincontrarsi, rivedersi, riparlarsi,
prima d’andare in campagna, alle zolfare, ai cantieri. Fra
poco sarebbero partiti, la piazza si sarebbe fatta deserta. Fino
a quando non sarebbero arrivati i maestri, i professori, gli impiegati,
i geometri, i cancellieri, gli avvocati, i giudici. E sarebbe
ricominciato nella piazza il vocìo, il brulichìo, il movimento.
«Lo prende il caffè?» chiese l’uomo a frate Agrippino.
«Caffè?! Io ingoio tasso e fiele! Aah, aah…» fece, accostando
di colpo la sua faccia a quella dell’altro, aprendo tutta la bocca,
tirando fuori, sopra i peli neri della barba, una gran lingua
bianca e secca, crepata «Vede? Sono attossicato.»
L’uomo ebbe un involontario scatto della testa all’indietro, per
l’improvviso gesto di quell’altro e per scansare quel fiato pesante,
arso e amaro di reserpina, che tuttavia lo investì. Accese subito
un’altra Chesterfield e aspirò profondamente.
«Andiamo,» disse «l’accompagno alla corriera» e si chiuse
in un silenzio spesso, calò in una sconsolazione, in una malinconia
senza rimedio.
Vincenzo Consolo
1988 Le pietre di Pantalica

Foto di Tano Cuva Villa Piccolo
Nella foto Leonardo Sciascia Lucio Piccolo Vincenzo Consolo
archivio Casa letteraria di Vincenzo Consolo
castello Gallego Sant’Agata di Militello
Consolo scrittura antimafia
S’intitola Cosa loro, l’ha appena pubblicato Bompiani (pp. 318, euro 18.00), e raccoglie una scelta di 64 articoli ricavata, come scrive il curatore Nicolò Messina, dall’«ottantina» che Vincenzo Consolo scrisse sulla mafia, taluni ancora inediti, tra il 1969 e il 2010, e cioè due anni prima di morire. In appendice, utilissimi, Altre notizie sui testi e il Regesto, ovvero la bibliografia completa anche di tutti i pezzi esclusi. In un modo o nell’altro, ci sfilano davanti i protagonisti d’un capitolo insieme doloroso ed eroico della storia siciliana, che però è metafora della nazione tutta, da Luciano Leggio, noto come Liggio, a Pio La Torre. In mezzo: Pantaleone, Falcone e Borsellino; Riina e Brusca; i cugini Salvo e Lima; Cuffaro, Lombardo e Dell’Utri; Enzo Sellerio, Letizia Battaglia e tanti altri ancora. Fa piacere notare che -se si eccettua il dattiloscritto datato dal curatore, ma non con certezza assoluta, nel 1969- i primi due articoli pubblicati entrambi nel 1970, su Liggio e Il Padrino di Mario Puzo, sono apparsi proprio qui, sulle colonne di Avvenire. E’ chiaro che, come recita il sottotitolo (Mafie tra cronaca e riflessione), si tratta di prosa giornalistica e interventi civili, di quella che, in un dattiloscritto del 1985, Consolo stesso, tenendola per altro in gran conto, chiama «scrittura di presenza» (di testimonianza e denunzia), ovvero «una scrittura militante interamente liberata dallo stile», in virtù della quale l’intellettuale si sostituisce allo scrittore. Una scrittura -aggiunge poi Consolo- che «sembra ormai caduta in disuso», proprio nel momento in cui -e mi pare perfetta diagnosi storico-antropologica-, nei piani alti della letteratura, e paradossalmente, «la verticalità dello stile inclina pericolosamente verso l’orizzontalità», in cui tutto si uniforma e omologa, sino a coincidere con il linguaggio «dell’informazione».
Ho detto che siamo di fronte perlopiù ad articoli di cronaca: ma stiamo attenti. Perché il talento dello scrittore sfugge spesso al controllo vigile del militante. Forte, seppure repressa, resta la tentazione della metafora, e sempre sul punto d’innesco -per fortuna- la vocazione narrativa. Così, per fare un esempio, su Ignazio Salvo, “il ministro”, nell’aula del processo, dopo la morte del cugino Nino, in un articolo del 1986: «Ma non aveva più quella patina lustra di un tempo, era pallido e imbiancato come se una raffica di polvere l’avesse investito». Per non dire di quella disposizione all’invettiva che, non di rado, erompe nei suoi libri d’invenzione. E’ il 1982, su Salemi: «paese terribile, di predoni e d’assassini, nemici di Cristo e amici di Caifa, paese estremo, desolato, posto su nude, riarse colline di gesso». Consolo in effetti, senza però mai recedere dagli imperativi morali e politici, non perde occasione per aprire parentesi, per divagare in funzione narrativa, per lasciarsi andare al ritratto, in modo da servire, quando possibile -persino dalla trincea di un’aula di giustizia-, le ragioni della letteratura. Cito proprio dal primo articolo apparso su Avvenire, propiziato dalla scomparsa di Liggio da una clinica romana, «senza lasciare traccia di sé», dopo la clamorosa assoluzione per insufficienza di prove «dall’imputazione di associazione per delinquere e da una serie di omicidi (nove) e di un tentato omicidio per non aver commesso il fatto». Ecco: «Abbiamo raccontato il fatto con estrema sintesi, perché vogliamo parlare più particolarmente, per ragioni “letterarie”, d’un personaggio che nella storia di Liggio entra ogni tanto per poi sparire e di cui la stampa poco si è occupata».
La letteratura, insomma. E, se si vuole, il romanzo, seppure allo stato latente: quando è vero che, a entrare ora in scena, come arrivasse da un romanzo di Simenon, sarà un funzionario di polizia poco noto che risponde al nome di Angelo Mangano, «un gigante di due metri», il quale, cinque anni prima, d’origine siciliana ma trasferito da Genova a Corleone, in soli sei mesi riesce a catturare il capomafia. Lo intercetta, Consolo, in un libro di Dominique Fernandez, Les événements de Palerme e in pochissime pagine ne fa leggenda: quella d’un investigatore che procede implacabile, con conseguenzialità quasi matematica, mentre ottiene lo straordinario risultato di riconciliare con le istituzioni, diventandone come l’eroe, un paese riluttante e risentito, terrorizzato e omertoso. Ma intendiamoci: questi qui restano tentazioni e scantonamenti, mere parentesi. E’ evidente sin da subito, infatti, che Consolo guarda a Sciascia come maestro di razionalità, senza però seguirlo in quegli esiti formali di scrittura spuria, nutrita di saggismo, nobilmente elzeviristica, che avrebbero anticipato, in opere come -per citarne solo alcune- Atti relativi alla morte di Raymond Roussel (1971), La scomparsa di Majorana (1975), L’affaire Moro (1978), tanta narrativa non finzionale dei nostri anni. Nessuna intenzione, da parte di Consolo, di dismettere il cilicio della «scrittura di presenza», di concedere qualche chance alle ragioni dello stile, sacrificando la nuda e cronachistica referenza della verità. E tutto questo proprio per preservare le differenze, che non sono solo e banalmente di genere letterario, ma estetiche e ontologiche, quando è vero che, se entriamo nel dominio del romanzo, l’estetica e l’ontologia coincidono: come dimostra in modo eclatante e coerente tutta la vicenda del Consolo narratore, da La ferità dell’aprile (1963) a Lo spasimo di Palermo (1998), passando per quel capolavoro assoluto che è Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976).
Che cosa voglio dire con ciò? Che per Consolo -il quale ha alle spalle la parola-giustizia di Vittorini, le alchimie liriche di Piccolo, le oltranze ritmiche di D’Arrigo- la letteratura più vera resta sempre consegnata a un’oltranza prosodica e a una scommessa di stile. Se gli si chiedeva quale scrittore sentisse a sé più vicino, la sua risposta, infatti, correva al nome d’un poeta: Andrea Zanzotto.
Massimo Onofri

