Giuliana Adamo
L’attenzione critica che qui si vuol dare a un confronto tra Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello trae spunto, a ritroso, dall’evento unico ed ultimo che li ha visti insieme il 20 giugno del 2007, a Palazzo Steri, a Palermo, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Filologia Moderna conferita ad entrambi, in curiosa conclusione del viaggio parallelo dei due scrittori, iniziato proprio nel 1963, anno del loro rispettivo esordio letterario.1 Escono, infatti, nel 1963 La ferita dell’aprile di Consolo – storia di un adolescente che dopo un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e dolori, arriva alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza; misto sapientemente dosato di autobiografia e di storia, di quotidiano e di mito – e Libera nos a malo di Meneghello, testo autobiografico che ‘offre un ritratto della vita a Malo, di una incomparabile ricchezza e incisività. È l’Italia […] della prima metà del secolo, nei decenni successivi alla Prima guerra mondiale’ che suscita anche nei lettori che veneti non sono ‘la “scossa del riconoscimento” (lo shock of recognition, come si dice in inglese) – un senso di partecipazione, di familiarità, nonostante le grandi differenze di contesto culturale’.2 Importante richiamare – anche se rapidamente – le superficiali analogie tra le rispettive scelte biografiche che rendono conto, in parte, delle ragioni della posizione peculiare che i due scrittori hanno avuto nel panorama culturale coevo: essendo tra i pochi ad essersi espatriati o dispatriati, con tutte le differenze dei singoli casi (Consolo a Milano, Meneghello a Reading in Inghilterra), dal proprio Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 39 luogo natìo e ad avere vissuto in un costante confronto tra le diverse culture con cui sono venuti a contatto. Entrambi, e ciascuno a suo modo, ulissici nel nóstos continuo con la propria Itaca: la Sicilia per Consolo, Malo per Meneghello. Prima di proseguire è importante ricordare, in sintesi, che il contesto letterario in cui prendono l’avvio i due scrittori è quello a cavallo degli anni ’50 e ’60 del Novecento, momento in cui, in un’Italia che faceva ancora i conti con gli strascichi della già conclusa esperienza del Neorealismo postbellico, imperversavano dibattiti e polemiche riguardanti soprattutto le nuove forme di espressione letteraria da ricercarsi, in ambito linguistico, nei territori che si estendevano tra il ricorso alla lingua italiana e la necessità dell’uso letterario dei dialetti. Per intendere la lezione stilistica di Meneghello sono preziose le parole di Cesare Segre, secondo cui lo scrittore di Malo si muove in uno spazio indipendente di outsider, di dispatriato e apprendista in Inghilterra, da Meneghello chiamata il ‘paese degli angeli’. Lo scrittore di Malo, quindi, ‘ha ben poco a che fare’ – sostiene Segre – con i precedenti più rappresentativi quali Fenoglio, Testori, Pasolini, Mastronardi perché la loro scelta dialettale è connotata da un ‘marchio sociologico’ di eredità neorealistica estraneo alla scrittura di Meneghello. E ha anche poco a che spartire sia con la diversa matrice della dialettalità espressionistica di Gadda; sia con l’uso mimetico del dialetto di Fogazzaro; sia con la dialettalità contenutistica di Verga, e poi di Pavese, in cui il ricorso alla dimensione dialettale esula dalle caratteristiche lessicali e morfosintattiche del dialetto. A queste differenze, si aggiunga, infine, il tratto peculiare della scrittura di Meneghello in cui, benché la funzione del dialetto sia in lui fondativa, il discorso narrativo avviene ‘prevalentemente in lingua’.3 Per Consolo il discorso è differente in quanto lo scrittore siciliano – pur con tutta la sua peculiare originalità espressiva che vede fondere l’eredità barocca di Lucio Piccolo con la ratio illuminista di Sciascia – si inscrive pienamente nella tradizione del romanzo storico siciliano che si estende, notoriamente, dal Verga della novella ‘Libertà’, al De Roberto de I viceré, al Pirandello de I vecchi e i giovani e allo Sciascia de Il consiglio d’Egitto. Tutti i romanzi e le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Per quel che riguarda, invece, la sua ricerca linguistica, come da lui stesso ampiamente ribadito nei suoi scritti, essa rimanda alla linea della sperimentazione di Pasolini e di Gadda (in opposizione alla soluzione razionalista e illuminata della lingua di Calvino e Sciascia), risultando in una scrittura che, come coglie la poetessa e scrittrice Maria Attanasio, ‘non è mai rotonda fertilità espressiva, 40 Giuliana Adamo levigato specchio, ma frantumazione caleidoscopica, allusivo aggiramento, inesauribile nominazione; al di là della parola, resta, indicibile, il vivido pulsare della vita’.4 Fatta questa necessaria premessa, torno all’argomento su cui mi soffermo in questa sede. Per il confronto che mi appresto ad abbozzare e a proporre – nulla di esaustivo ovviamente, ma ugualmente passibile, spero, di critiche costruttive, approfondimenti, analisi di differente approccio – il punto di partenza mi è sembrato giusto che fosse dato dalle rispettive lectiones magistrales – in apparenza così diverse – indirizzate, dai due laureandi, al Senato accademico e al pubblico presenti nella sala palermitana. Quella di Consolo, il primo a parlare, dal titolo ‘Due poeti prigionieri in Algeri. Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano’; quella di Meneghello intitolata ‘L’apprendistato’. 5 Le due lectiones mi pare si prestino ad essere usate come specimen delle rispettive opere, permettendo di tracciare linee di contatto e/o distacco, di analogie e/o differenze tra i due autori. Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano La lectio di Consolo, fin dalla dedica alla memoria di Leonardo Sciascia, segnala l’instancabile e appassionata militanza, da sempre parallelamente giornalistica e letteraria, dell’autore siciliano e verte sui temi che costituiscono il cuore di tutta la sua scrittura: 1) Il rapporto tra passato e presente (da cui il suo sguardo storico indagatore trae la linfa vitale: il passato come metafora del presente). 2) L’attenzione particolare alla Storia siciliana inquadrata nel contesto più ampio della storia mediterranea, fatta di incontri e scontri di popoli e civiltà e dalle stratificazioni culturali e linguistiche che ne conseguono. A questo, inoltre, si lega l’immancabile tema dell’opera di Consolo: il viaggio. Tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio: viaggio rituale dall’esistenza alla Storia, che invita alla conoscenza di sé e del mondo. Viaggio alla ricerca della luce-ragione che illumini, pur se in modo intermittente, le tenebre che avvolgono la condizione umana. 3) La necessità ineludibile della poesia (con il ricorso nella sua narrativa ad una lingua poetica, non comunicativa ma espressiva). 4) La citazione e la menzione continue di testi poetici e narrativi, scritti e orali, nelle diverse lingue del mondo consoliano: italiano, siciliano, spagnolo, latino, sabir, nonché il costante intarsio realizzato dalle fedeli Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 41 riprese di cronache e documenti d’epoca ufficiali e non, altro polo costitutivo della poetica e dell’opera di Consolo. Quanto al contenuto della lectio, in parole brevi, che valgono quasi come un sottotitolo, parla della vita terribile nel tardo Rinascimento, vissuto tra le sponde del Mediterraneo, che fa da sfondo alla comune prigionia, nelle carceri di Algeri, di Miguel de Cervantes e del poeta siciliano Antonio Veneziano alludendo, per via di metafora, all’attuale situazione del mare nostrum, crocevia di diverse civiltà e doloroso luogo degli scontri tra di esse. Si pensi, soprattutto, al problema dei migranti, nei confronti del cui trattamento da parte dell’Europa occidentale e, in particolare dell’Italia, la sensibilità dell’intellettuale Consolo ha raggiunto punte estreme di indignazione civile e di profonda pietas. Consolo ricostruisce la oscura biografia di Antonio Veneziano ‘l’elegantissimo latinista, il più rinomato poeta siciliano del secolo XVI’6 vissuto tra 1543 e 1593. Per fare questo, applica il suo rigoroso metodo di indagine storica e storiografica – eredità manzoniana e fondamento dei suoi romanzi storici, o meglio anti-romanzi storici – risalendo alle fonti scritte ed ufficiali e, quando possibile, a fonti più in ombra (archivi, fondi di parrocchie, testimonianze di oscuri cronisti coevi, lettere dimenticate, atti notarili, scritte murali, graffiti, canzoni popolari, etc.).7 In questo caso, Consolo cita, tra gli altri, le testimonianze di Giuseppe Lodi (bibliotecario ottocentesco della palermitana Società di Storia Patria); del demo-psicologo ed etnologo Giuseppe Pitrè; del canonico Gaetano Millunzi; di Leonardo Sciascia che, nel 1967, a proposito del Veneziano ricorda che era: ‘Violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti, incostante negli affetti famigliari e negli amori, assolutamente sprovvisto di rispetto per le istituzioni e per gli uomini che le rappresentano’.8 Tuttavia, ed è questo che interessa a Consolo sia per il plurilinguismo sia per la militanza polemica dell’intellettuale: malgrado il carattere e la mala condotta, scrive, scrive il Veneziano, scrive poesie in siciliano, in latino, in spagnolo, prose e composizioni in versi per gli archi di trionfo in onore dei vari viceré che s’installano a Palermo. Ma scrive anche satire contro gli stessi viceré, contro il potere politico, satire affisse sui muri. (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 26) La vita del Veneziano si rivela curiosamente speculare a quella di Cervantes (ricca come risulta di accuse malevole, assilli economici, disordini familiari, varie incarcerazioni). Ed è ad una di queste incarcerazioni, presumibilmente, che si deve l’incontro, o il re-incontro (forse, congettura Consolo, si 42 Giuliana Adamo erano incrociati anni prima a Palermo, ma questo resta da dimostrarsi), e la conseguente ammirazione reciproca, quasi amicizia, tra l’autore del Quijote e quello della Celia. Il Veneziano venne preso prigioniero sulla galea Sant’Angelo, al seguito di Don Carlo d’Aragona, dai corsari, al largo di Capri, il 25 aprile 1578. Quindi venne condotto come schiavo ad Algeri nel cui bagno penale incontrò Cervantes, a sua volta schiavo in quella città da più di tre anni. Anche la biografia di Cervantes, soprattutto in relazione alla sua prigionia algerina e ai suoi ben quattro tentativi di evasione, è ricostruita storicamente da Consolo sulla scia di scritti, documenti, testimonianze di autori vari, incluse quelle dello stesso Cervantes. Ecco, dunque, che è importante rilevare (e la lectio ce ne dà prova) come Consolo lavori col materiale che ha cercato, documentato, elaborato. Da un lato, quindi, vediamo emergere, l’importanza che ha per lo scrittore la Storia e il metodo usato nella sua ricerca di ricostruzione e ricomposizione del passato; dall’altro – e in maniera costitutivamente intrecciata – il lavoro creativo dello scrittore che intaglia una storia ricca di dettagli documentati in modo meno ufficiale dentro alla grande Storia, che lui avvertiva sempre come immobile e immutevole nelle sue prevaricazioni, nei suoi inganni, nelle sue menzogne, nelle sue ingiustizie, nei suoi silenzi, nelle sue esclusioni. Ed ecco – analogamente a quanto avviene nei suoi lavori storici, memori della lezione manzoniana ma prodotti nella sua lingua ‘rigogliosamente espressivistica’,9 plurivocale,10 pluridiscorsiva e pluristilistica – che Consolo si spinge a ricreare che cosa possano avere detto, fatto, provato insieme, ad Algeri, i due scrittori secenteschi: I due in carcere, ascoltano la cantilena in sabir, la lingua franca del Mediterraneo, che i ragazzi mori cantavano sotto le finestre dei bagni: Non rescatar, non fugir Don Juan no venir morir… cantilena riportata da Cervantes in Vita ad Algeri e ne I bagni di Algeri. Tutte e due avranno avuto catene alle caviglie e saranno stati vestiti allo stesso modo, il modo come Cervantes descrive il Prigioniero che entra con Zoraide nella locanda ‘il quale mostrava dagli abiti d’essere un cristiano giunto recentemente da terra di mori, perché era vestito d’una casacca di panno turchino, a falde corte, con mezze maniche e senza collo; anche i calzoni erano di tela turchina, e il berretto dello Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 43 stesso colore.’In quel carcere, con chissà che emozioni e sensazioni, scrivono l’uno la Celia (preso d’amore non si sa bene per chi fra i due possibili oggetti del suo amore: quello incestuoso per la nipote Eufemia o quello impossibile per la viceregina Felice Orsini Colonna, moglie di Marc’Antonio Colonna, comandante della flotta veneziana nella battaglia di Lepanto, nel 1571, allora viceré di Sicilia); l’altro presumibilmente Vita ad Algeri, le Ottave per Antonio Veneziano e comincia la stesura della Galatea. (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, pp. 30-31)11 I due protagonisti della lectio lasceranno Algeri, finalmente riscattati: il Veneziano nel 1579 (morirà nel 1593 nel carcere di Castellamare per lo scoppio doloso della polveriera), mentre Cervantes nel 1580 (per poi finire nel carcere di Siviglia o in quello di Castro del Rio dove nel 1592 concepisce il Quijote). In seguito, ricorda significativamente Consolo, Cervantes ritornerà sulla passata dolorosa esperienza: ‘[d]ice ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Non c’è sulla terra, secondo il mio parere, gioia che eguagli quella di conseguire la libertà perduta”’ (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 33). A questo punto, da quel che emerge da una lectio così costituita possiamo cogliere un insieme di elementi che offrono una misura valida per farsi un’idea dei tratti essenziali che permeano tutta l’opera di Consolo: 1) L’ ineludibile necessità etica che lo spinse, da sempre, a studiare, indagare, scavare, scrivere – cercando di capire e di aiutare a fare capire – la complessità della vita, nel Cinquecento come nel 2000, che si svolgeva e svolge nell’area mediterranea, dove sono nate incontrandosi e/o scontrandosi le grandi civiltà della storia occidentale. 2) La necessità di mostrare che la Storia – se distaccata dalla storiografia ufficiale, sempre soggettiva e parziale, scritta dai vincitori e mai dai vinti – può emergere più contraddittoria, ma più completa, grazie al corale contributo delle voci di ‘più picciol affare’. In tal modo, la scrittura della storia diventa (con certa utopia) incrocio di punti di vista diversi: Storia, insomma, come una messa a fuoco plurima e dialettica della realtà. In Consolo il rapporto Storia-invenzione del romanzo storico classico è rovesciato: ‘ciò che lì era documento qui è racconto, universo opinabile, discorso retorico. Ciò che lì è veramente accaduto, qui è come realmente accaduto’, evidenzia finemente Nisticò a proposito, in particolare, de Il sorriso dell’ignoto marinaio. La critica operata da Consolo è volta alla Storia in quanto scrittura, nella sua ‘demistificazione permanente del mito 44 Giuliana Adamo dell’oggettività e della verità dei documenti e della tradizione storica’.12 Ed è su questo assunto che si è basata la sua intera attività di scrittore. 3) Il valore della scrittura qui esemplato dall’esperienza di due intellettuali che si trovano in mezzo a indicibili difficoltà oggettive e, di conseguenza, il ruolo salvifico della poesia che – nonostante tutto e tutti e nonostante i suoi stessi autori – è eternamente valida e, a differenza della Storia, super partes. 13 4) La metafora del presente che quell’antica, tormentata, feconda esperienza cinquecentesca è chiamata simbolicamente a rappresentare, in quanto per Consolo: ‘un testo è vivo quando è metafora, quando non parla solo di sé’.14 5) La fondante tensione metaforica resa attraverso uno stile che rende ragione del coro di voci e di lingue che scintillano in questo testo (come in tutti i suoi testi) intrecciandosi per ricordarci che quel che è successo succede ancora e che, e qui Consolo usa le parole, tragicamente attuali, che Fernand Braudel riferiva all’età di Filippo II: ‘In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli ‘universi concentrazionari’ (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 34). Rappresentativa della poetica di Consolo è questa lectio che ho voluto usare come microtesto per individuare le linee portanti del macrotesto consoliano: non autobiografica, se non per pulsioni spesso inconsce; storico-filologica; testimonianza del suo impegno di scrittore e di intellettuale contro soprusi e ingiustizie. Le attestazioni dell’inesausto agire civile di Consolo, oltre che in tutti i suoi libri e nei suoi saggi, anche sulle pagine dei quotidiani italiani storicamente più schierati a sinistra, come l’Unità e Il manifesto, che hanno accolto i suoi veementi articoli sui temi dell’immigrazione, dei migranti, delle angherie e degli abusi perpetrati ai loro danni, della micidiale miopia italica e dell’assenza di memoria di quel popolo di migranti che sono sempre stati gli italiani. Per Consolo etica e scrittura sono una cosa sola,15 la memoria individuale e la memoria storica consentono lo scavo nel passato per riflettere sul presente; la lingua del suo scrivere – con le lingue sottostanti che la nutrono storicamente e culturalmente – è una lingua storica e filologica e non la si capirebbe se la si alienasse dal fondamento del determinarsi storico e sociale dei linguaggi. La esibita letterarietà di Consolo, tanto sottolineata dai critici, per essere correttamente intesa va ricompresa in un progetto artistico che utilizza l’opacità e il peso della tradizione letteraria come strumenti di una più acuta e complessa lettura della realtà. Se, infatti, Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 45 pur nell’ambito di una insistita critica sociale mossa dalla prospettiva di una solidarietà coi ‘vinti’ e coi subalterni non possiamo sottrarci alla constatazione (è questa la critica mossa a Consolo) della preziosità erudita del suo linguaggio, delle sue notevoli densità e perspicuità letterarie, lo si deve soprattutto al suo tentativo di drammatizzare una contraddizione che da sociale diventa, performativamente, stilistica e retorica. Quello che in realtà è lo scontro tra isole di ricchezza e oceani di indigenza diventa, nelle strutture narrative di Consolo, lotta tra l’abbandono lirico di un linguaggio (spesso anche in veste parodica) che è esso stesso ‘cosa’ (strumento di gioco e di piacere) e il dover essere etico e razionale per garantire la narrazione. Prosa e poesia si fronteggiano, esibendo ciascuna le proprie ragioni. La sua narrativa usa a piene mani una lingua e dei moduli poetici non strettamente narrativi (ma lontanissimi dalla prosa d’arte da lui aborrita): il retablo, il cunto, l’opera teatrale, la metrica versificatoria, espedienti stilistico-retorici quali l’enumerazione e l’iperbato, il repentino mutamento dei registri, che con il loro andamento ipotattico frangono la paratassi del più generale impianto narrativo. Le apparenti dissimmetrie, che la lectio riflette, tra piano dell’espressione – iper-letteraria, barocca – e quello del contenuto – materialistico, progressivo – sono ricomprese ma non ricomposte o pacificate nella sua scrittura, a causa di una contradditorietà mai risolta: il conflitto (sociale e retorico) rimane la cifra estetica più propria nell’opera di Consolo.16 L’apprendistato E veniamo alla lectio di Meneghello ‘L’apprendistato’, quintessenzialmente meneghelliana: autobiografica, riflessiva, ironica, giocata sapientemente sui diversi registri retorici che, come sempre nella sua scrittura, sono capaci di suscitare, in chi legge uno spettro variegato di emozioni: dal riso alla commozione alla riflessione al disincanto. Dall’inizio emerge subito l’interesse primario di una vita, il motore di tutti i suoi libri: l’attenzione alle parole e alle cose che esse veicolano inquadrata, da subito, nel suo personale percorso di studente dialettofono italiano e di professore di italiano in Inghilterra. Le sue lingue di cultura (italiano, greco, latino, inglese) affiorano subito, nel primo lungo paragrafo della lectio laddove, in modo colto e ilare, racconta di quel che provoca in lui l’essere in procinto di diventare ‘filologo’ e cerca di definire che cosa sia la filologia. Risale all’origine greca del termine dovuto a Eratostene, nel III secolo a.C., ‘matematico, ma bravo anche come 46 Giuliana Adamo astronomo, geografo, filosofo, storico, e altro ancora’ (‘L’apprendistato’, p. 37), che ‘[d]oveva essere un personaggio straordinario, molto più di Tagliavini’ (ibid., p. 36) – maestro di Glottologia di Meneghello a Padova che aveva scommesso coi propri alunni di ricostruire, partendo da una mezza pagina, nello spazio di un’ora, la grammatica (morfologia e sintassi) di una lingua sconosciuta. Meneghello si sofferma sulla definizione antica di Eratostene che pare fosse chiamato dai colleghi ‘pèntathlos’ come a dire ‘pentatloneta’, per segnalare questa versatilità, e forse per denigrarla. […] In inglese uno che riesce bene in molte cose […] è un all-rounder: dove io non ci sento sottointeso ‘[bravo in tutto] e dunque non supremo in nulla’. Ma ad Alessandria pare proprio che il sottointeso ci sia stato. (‘L’apprendistato’, p. 36) Alle ipotesi sulla filologia come versatilità di conoscenze e applicazione delle stesse, seguono le considerazioni sul lavoro filologico svolto da Eratostene nella sua qualità di direttore, a suo tempo, della Biblioteca di Alessandria ‘editore, recensore e emendatore di testi letterari’ (‘L’apprendistato’, p. 37). Tuttavia permane l’ambiguità del termine con cui si definiva ‘filologo’. Termine ombrello, per Meneghello, che accoglie almeno tre significati: 1) espressione legata al gusto del discorrere; 2) amante del lógos, ovvero più estensivamente ‘dotto’, ‘studioso’; 3) più specificamente e circoscrittamente ‘studioso delle parole […] insomma un linguista’ (ibid.). Le diverse facce della filologia che affascinano Meneghello lo portano ad uno dei suoi tipici scarti logici in conclusione della prima parte del suo testo: Contro le mie tendenze, mi si affaccia l’idea che anche per la filologia ‘it takes all sorts to make a world’, ci vuole gente di ogni risma per fare un mondo, vale a dire il mondo così com’è. Ma nei riposti ventricoli del mio sentimento non ci ho mai creduto del tutto. (‘L’apprendistato’, p. 38) Passa, quindi, ad una riflessione, brillantemente argomentata, sul suo rapporto con la linguistica (‘non mi considero un linguista’, ibid.), soffermandosi sulla sua lingua nativa, non materna (la mamma, friulana, non aveva latte) ma della balia maladense. Il dialetto di Malo è percepito da Meneghello quale ‘lingua del genere umano, gli esseri umani parlavano così, e i loro modi entravano in me, davano forma alle strutture interne (preesistenti, penso) della mia competenza, creavamo circuiti indistruttibili’ (‘L’apprendistato’, p. 38) lingua parlata, pre-logica, del cui apprendimento non aveva coscienza. Accanto, parallelamente, si innesca il processo Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 47 di apprendimento di una sorta di lingua seconda: l’italiano, di origine più artificiosa e innaturale appreso a scuola e sui libri, prevalentemente attraverso la lettura. Una lingua, sia ben chiaro, tutt’altro che nitida e netta a proposito della quale Meneghello si sente in dovere di precisare: veramente c’erano due filoni, quasi due matasse di viscoso tiramolla, schiaffate una sull’altra e annodate in una specie di doppia elica, come si vedeva fare nelle sagre di paese: il filone ufficiale, di stampo aulico e di derivazione letteraria, e il filone reale dell’italiano regionale. Quest’ultimo aleggiava attorno a noi, imparavamo noi stessi a servircene – quando si cercava di parlare in chicchera – e a mano a mano a scriverlo: certamente non ci rendevamo conto che fosse ‘italiano regionale’, la nozione non si era ancora formata o diffusa, e la cosa non sarebbe parsa allora una variante legittima della lingua nazionale. (‘L’apprendistato’, p. 38) La complessità di queste esperienze per lungo tempo non ha dato luogo ad un sistema articolato di idee sulla lingua, questo è potuto avvenire molto più tardi, grazie all’influenza di amici e colleghi incontrati in Inghilterra, parecchi dei quali a Reading, e la menzione silenziosa a Giulio Lepschy in particolare è connotativa del modo in cui Meneghello – si pensi soprattutto ai volumi delle Carte – alluda spesso a persone della sua realtà biografica evitando di farne i nomi, cifra tipica della sua scrittura zibaldonica.17 L’incontro e il confronto con il nuovo mondo culturale inglese, portano Meneghello a riconsiderare la sua precedente visione del proprio rapporto con le lingue: la struttura delle lingue ha subito un rivolgimento radicale, le vecchie impostazioni abolite e cancellate. Questa del nuovo che sopravviene e soppianta l’antico, pare uno schema ricorrente nella mia vita mentale. (‘L’apprendistato’, p. 39) Il punto cruciale della lectio, che lo avvicina pur nella loro diversità a Consolo, è dedicato a sottolineare che il suo vivo interesse per le lingue non riguarda l’analisi teorica delle loro strutture, ma ‘ciò che le lingue che frequentavo recavano con sé, un’immagine intensificata delle cose del mondo’ (ibid.), e questo si verifica soprattutto nella poesia: i poeti lirici in particolare, antichi e moderni, nelle lingue in cui li leggevo, latini, italiani, francesi, e per frammenti anche tedeschi e spagnoli (non inglesi, in principio: quelli sono venuti in seguito, nella mia tarda gioventù, in Inghilterra, ed è stata un po’ una gran 48 Giuliana Adamo mareggiata poetica). In queste scritture percepivo gli effetti di una forza oscura che mi sprofondava nel cuore della realtà: e non pareva rilevante, e nemmeno pertinente, che si trattasse davvero di lingue diverse, era come se fosse una lingua sola. (‘L’apprendistato’, p. 39) La lingua ha risorse infinite per sondare la realtà e Meneghello usa, per fare questo, l’unica lingua che conosce davvero: l’Alto Vicentino, o meglio, la lingua di Malo. Alludendo a Libera nos a malo sottolinea: Si formava in me scrivendo, il quadro naturale di queste varianti, ero in grado di distinguere con spontanea precisione tra questi diversi usi, e intravederne a sprazzi le separate capacità di esplorare, trivellando in profondo il reale. (‘L’apprendistato’, p. 39)18 Nell’ultimo scorcio del testo evoca uno dei temi a lui più cari, quello del lungo apprendistato che lo ha reso in grado di portare ‘ciò che scrivo a pareggiare la potenza di quell’antica esperienza, nei vari settori della vita che mi è capitato di attraversare’ (ibid.). Di grande efficacia retorica, e commovente, è la chiusa della lectio in cui, con un procedimento analogo a quello esperito da Seamus Heaney in ‘Digging’ nella raccolta Death of a Naturalist del 1966, laddove evoca la mano contadina del padre che afferra la vanga per scavare e la propria che impugna la penna per fare altrettanto (vv. 1-5): Between my finger and my thumb The squat pen rests: snug as a gun. Under my window, a clean rasping sound When the spade sinks into gravely ground: My father, digging. I look down per, quindi concludere (vv. 29-31): Between my finger and my thumb The squat pen rests. I’ll dig with it. si istituice un parallelo tra l’apprendistato di Luigi Meneghello scrittore e quello di Cleto Meneghello, suo padre, tornitore: Aveva imparato a tornire da ragazzo a Marano […]. Sui vent’anni era andato a Verona a fare il suo Capolavoro. […] Il capolavoro che gli diedero da fare era una vite senza fine; preparò il pezzo, misurò, ci fece i segnetti che bisogna farci per tornire una vite senza fine, e a Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 49 questo punto il capo che lo stava a guardare aveva già capito che era bravo e disse: ‘Basta così’. (‘L’apprendistato’, p. 40) Segue l’explicit, profetico, dell’ultimo discorso pubblico di Meneghello: Vorrei poter fare anche io così, se ne avrò il tempo, scrivere qualcosa di veramente conclusivo, magari solo una paginetta, o un paio, ma da scrittore finalmente maturo. E che voi, come già a mio padre i suoi esaminatori, mi diceste: ‘Ok, basta così’. (ibid.) Quanto emerso da questa lectio permette di ravvisarvi, analogamente a quanto visto nel caso di Consolo, le trame costitutive dell’intera opera di Meneghello: 1) La prima lingua innata e l’incontro con le altre lingue apprese che ha determinato la sua attività di vita e di scrittura. 2) Il ricordo di Malo – oggetto del suo continuo nóstos – eternato nelle sue opere. 3) La sua vita di perenne apprendista. Tutti elementi che convivono simultaneamente nella sua ultima lectio e in tutti i suoi libri. Cosa, dunque, hanno in comune Consolo (nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, in Sicilia, provincia di Messina e morto a Milano nel Gennaio del 2012) e Meneghello lo scrittore di Malo (nato nel 1922 a Malo, in Veneto, provincia di Vicenza e morto nel 2007 nella vicina Thiene)? Alcune cose più ‘esteriori’ furono indicate dallo stesso Consolo nel ricordo dedicato allo scrittore maladense, suo contributo alla Biografia per immagini su Meneghello, curata da Pietro De Marchi e da chi scrive. Lo riporto qui di seguito: La laurea honoris causa in Filologia moderna, a noi due insieme, a Meneghello e a me, quel giorno di giugno del 2007, là nell’aula magna del Rettorato di Palazzo Steri, in quel trecentesco palazzo che tante ne aveva viste (fu abitato dall’illustre famiglia dei Chiaramonte che l’aveva fatto costruire, fu poi sede vicereale, sede del Santo Uffizio, del tribunale e del carcere della terribile Santa Inquisizione). La laurea, dunque, insieme, a Meneghello e a me. E a me sembrava quel giorno, in quella magnifica aula, davanti al senato accademico e al vasto pubblico, di usurpare il posto di Licisco Magagnato, il Franco di Bausète, che si laureò a Padova nello stesso giorno insieme a Meneghello ed ebbero, i due laureati, insieme un solo ‘papiro’ di laurea ‘a due teste’. Però, quel giorno, mi rassicurava il fatto che Meneghello ed io eravamo gemelli, voglio dire che eravamo nati scrittori nello stesso anno, nel 1963, lui col suo Libera nos a malo ed io con il mio La ferita dell’aprile; e tutti e due ancora con uguale assillo linguistico, 50 Giuliana Adamo l’intrusione, nell’italiano, del vicentino, o meglio della lingua di Malo, ed io del siciliano, vale a dire di tutte le antiche lingue che giacevano nel siciliano. E poi… E poi, eravamo due dispatriati, il Meneghello in Inghilterra, a Reading, ed io nella Milano dei Verri, di Beccaria, di Manzoni, di Verga, di Vittorini… Dispatriati, noi due insomma, in due diverse ‘patrie immaginarie’. Cosa univa ancora, Meneghello e me? A guardare le immagini di quella cerimonia, l’autoironia dipinta sui nostri due volti. Ah, caro Meneghello, che incontro è stato quello con te a Palermo! Primo e ultimo incontro, perché subito, tornato a Thiene, tu sei partito per quel viaggio dal quale non si ritorna più. Ed io ti rimpiango. Tutti ti rimpiangiamo, ma ci confortano però i tuoi libri, tutti i tuoi magnifici libri. Quelli, sì, resteranno sempre con noi.. (Luigi Meneghello. Biografia per immagini, pp. 172-173) L’ironia, tratto assoluto dell’intelligenza, unisce di certo i due scrittori, ed il distacco anche geografico con il conseguente, lungamente reiterato, rispettivo nóstos. Così come il loro essere sempre stati fuori dal coro, spesso a remare contro le patrie tendenze critiche e letterarie (ricordo, per esempio, l’insofferenza di Meneghello per Quasimodo e Ungaretti e pure per Moravia, nonché quella di Consolo nei confronti del – per lui – letterariamente troppo tradizionalista Tomasi da Lampedusa, per l’avanguardista Gruppo 63, e per la maggior parte della nuova narrativa italiana, tra cui spiccava l’avversione per il dialetto posticcio e folklorico di Camilleri). Entrambi fuori, per loro (e nostra) fortuna, dalla logica aberrante del mercato editoriale. Pur in modi diversi entrambi voci contro nel panorama letterario italiano del secondo Novecento. E questo vale, ovviamente e ancor di più, per il problema della ricerca e della definizione della propria lingua di espressione letteraria a cui entrambi hanno dedicato il meglio della loro sapienza e della loro perizia, del loro talento e della loro passione. Tratti questi che li accomunano anche nel loro amore totale per la poesia, per la sua funzione e per la sua libertà espressiva. A questo punto, forzandolo in qualche modo ai fini del mio discorso, vorrei citare Wittgenstein che, nel 1929, in una sua lezione a Cambridge sostiene: ‘So far as facts and propositions are concerned there is only relative value and relative good, relative right’ e ancora: I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 51 This running against the walls of our cage is perfectly absolutely hopeless.19 Meneghello e Consolo si scontrano con lo stesso problema: in che lingua esprimere il mondo ‘possibile’ del proprio narrare? Dal canto suo Meneghello, che si è sempre misurato con la sostanza non univoca dell’esperienza umana cercando di darle una forma espressiva che il più possibile si avvicinasse al vero – anzi che fosse ‘più vera del vero’ – ammette: ‘Con le parole è impossibile essere precisi: non dico difficile, impossibile’ (Le carte III, p. 95). Eppure occorre narrare per capire il mondo, ma come? Risponde: con ‘la lingua nativa che illumina l’andamento delle cose’ (Le carte III, p. 99). Consolo, a sua volta, e analogamente dal suo punto di vista storicofilologico, si confronta con una realtà sfaccettata, plurivoca, composita, contraddittoria – si ricordi la sua visione e il suo tentativo di una resa plurima e dialettica della Storia – e per esprimerla, ritenendo ormai insufficiente e superata la lingua razionale-geometrica-comunicativa di Sciascia e Calvino, crea una lingua espressiva, dove la poesia evoca quello che la lingua italiana ormai ‘massificata’ e fatta scadere dall’abuso dei massmedia non è più in grado di comunicare. Una pulsione analoga muove i due scrittori. I risultati? Sorprendenti in ambo i casi. Sulla lingua di Meneghello critici e linguisti hanno detto tante cose e tra tutte si stagliano le perfette analisi di Giulio Lepschy che in un saggio del 1983,20 a proposito di Libera nos a malo, individua le tre lingue del libro quali: ‘italiano prezioso, italiano popolare, dialetto’, segnalando che ‘il dialetto è usato più per il suo valore espressivo o per la sua crudezza, che per la sua normalità o spontaneità’.21 E alla domanda ‘in che lingua?’ è scritto il libro, Lepschy, in sedi diverse, risponde senza indugi:22 In italiano. Libera nos a malo è un libro ‘italiano’, scritto ‘in italiano’, che appartiene alla cultura italiana (e attraverso ad essa a quella europea e internazionale), e insieme la arricchisce di elementi nuovi e originali.23 Un italiano reso più leggero e antiretorico grazie a quanto imparato nell’apprendistato inglese. Consolo, a cui potrebbero attagliarsi le parole di Lepschy su Meneghello (e a garantirne l’appartenza alla cultura internazionale, basterebbe la lista delle traduzioni delle opere di Consolo in quasi tutte le lingue romanze e in inglese, tedesco, olandese) arriva a forgiarsi una lingua espressiva, barocca (nel senso migliore del termine), 52 Giuliana Adamo ricchissima di citazioni – echi – rimandi che vanno dalla sfera erudita a quella più bassa. Lingua in cui convergono le lingue mediterranee: greco, latino, arabo, spagnolo, le varie parlate siciliane, incluse le lingue delle isole linguistiche (tra cui spicca il dialetto gallo-italico di san Fratello, paesino sui Nebrodi), italiano colto. La ricchezza linguistica consente la realizzazione della scrittura palinsestica di Consolo (per il quale sotto la superficie della propria scrittura ci devono essere i segni più importanti della letteratura di chi ci ha formato. E direi che su questo punto l’analogia con il ricchissimo tessuto narrativo di Meneghello è palese) e la messa a fuoco dell’irriducibile complessità del reale (da qui il suo preferito procedimento stilistico dell’amplificatio: l’accumulatio, soprattutto nominale), nello strenuo tentativo di rendere quello che è stato. La ricerca dei nomi di questo ‘archeologo della lingua’ non è semplice ricordo memoriale, ma attestazione del travaglio e del dolore di quella parola attraverso il male della storia. Rievocazione del tempo e dello spazio della Sicilia perduta attraverso i nomi che non sono segni di un’origine metafisica, ma della materialità del mondo prima della lacerazione, delle ferite, del dolore. Analogamente, Meneghello si è dedicato alla ricerca del recupero ‘archeologico’ di una società e di una cultura conosciute nell’infanzia e nella giovinezza e poi irrimediabilmente perdute. Non si tratta, però, di una rivisitazione della memoria percorsa dalla nostalgia e dalla retorica, ma di una vera e propria ricostruzione di ambienti, frammenti di vita e di cultura che mira a ridisegnare quella realtà attraverso una specie di ricerca antropologica, segnata sempre dal filo dell’ironia. E Consolo, in che lingua scrive? Non usava il dialetto: le espressioni, le parole dialettali sono sempre citazioni. Il suo linguaggio è l’italiano, ma l’italiano di Sicilia. Consolo, insomma, ripercorre la storia di Sicilia, dal Risorgimento all’ascesa del fascismo alla violenza mafiosa contemporanea, servendosi di un italiano costruito su ‘un fasto barocco e un ritmo musicale, con un gusto del dialettismo, del latinismo e dell’ispanismo, che contrastano espressionisticamente con i contenuti spesso tragici e con l’analisi, non sottolineata ma palesata e severa delle ragioni storiche’.24 Dice Consolo: Io non ho cercato di scrivere in siciliano assolutamente, ma vista la superficializzazione della lingua italiana e proprio per un’esigenza di memoria ho cercato la mia lingua che attingeva ai giacimenti linguistici della mia terra che erano affluiti nel dialetto siciliano, che io traducevo in italiano secondo la mia metrica della memoria.25 Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 53 Si potrebbero indicare molte altre aree di tangenza, vicinanza, analogia tra questi due scrittori che, pur diversi e geograficamente lontani, hanno dedicato la loro esistenza a mostrarci l’uno (Meneghello), più ‘antropologicamente’, che nella propria lingua nativa, innata e fondante, ‘le parole sono le cose’; l’altro (Consolo), con più impegno civile e utopia storica, che verrà un tempo in cui con parole nuove e, finalmente vere, perché riscattate dalla parzialità e dalle menzogne a senso univoco della Storia, ‘i nomi saranno riempiti interamente dalle cose.’26 È evidente che per entrambi il binomio etica e scrittura è indissolubile e che per entrambi scrivere sia una funzione del capire per avvicinarsi il più possibile alla realtà, all’unico ‘vero’ e, a questo proposito, grande è il debito nei confronti di Leopardi – di cui entrambi amano il poeta, il prosatore e il filosofo – contratto dai due scrittori. 27 Mi pare che la vicinanza più importante tra Consolo e Meneghello risieda in quella moralità che le parole di Franco Fortini definiscono come una forte e costante ‘tensione a una coerenza di valori e di comportamento’,28 espressa coerentemente e rispettivamente nella loro narrativa originale, coraggiosa, fieramente facente parte per sé stessa contro ogni tipo di omologante dittatura o partigianeria ideologica, letteraria, e del mercato editoriale. Trinity College Dublin Note 1 Ero presente a quella indimenticabile giornata palermitana sia per Consolo (su cui avevo appena finito di curare un volume di saggi), sia per Meneghello sulla cui opera stavo lavorando. Cfr. La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, con prefazione di Giulio Ferroni (San Cesario di Lecce: Manni, 2006) e Volta la carta la ze finia. Luigi Meneghello. Biografia per immagini, a cura di Giuliana Adamo e Pietro De Marchi con curatela iconografica di Giovanni Giovannetti (Milano: Effigie, 2008). 2 Giulio Lepschy, ‘Introduzione’, in Luigi Meneghello, Opere scelte, progetto editoriale e introduzione di Giulio Lepschy, a cura di Francesca Caputo (Milano: Arnoldo Mondadori, 2006), pp.xlv-lxxxiv (p.xlvii). 3 Cfr. Cesare Segre, ‘Libera nos a malo. L’ora del dialetto’, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, Atti del Convegno Internazionale di Studi In un semplice ghiribizzo (Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003), a cura di Giuseppe Barbieri e Francesca Caputo (Vicenza: Terra Ferma, 2005), pp. 23-27 (pp. 23-24). 4 Maria Attanasio, ‘Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10 (2005), 19-30 (p. 24). Ricordo, inoltre, che Consolo, nel solco di una discussione europea, negli anni del suo esordio letterario, circa il destino e la funzione del romanzo storico, ha ripudiato nella sua opera gli intrecci intrattenitori del romanzo tradizionale, ragione per cui, come non si è stancato di rimarcare nei suoi scritti e nei suoi 54 Giuliana Adamo interventi pubblici, scelse di spostare la scrittura dal ‘romanzo’ alla ‘narrazione’, secondo l’accezione datane da Walter Benjamin. Quanto al ripudio della lingua razionale e illuminista, lingua di una speranza ormai perduta irrimediabilmente, esso è motivato dalla mutazione antropologica avvenuta a seguito del boom industriale italiano nel corso degli anni ’50 del Novecento, su cui il Pasolini del saggio ‘Nuove questioni linguistiche’ (1964) ha scritto pagine fondamentali. La scelta poetico-espressiva della lingua letteraria di Consolo era in polemica con il linguaggio comunicativo, omologante, impoverito, tele-stupefacente determinato dall’avvento inarrestabile dei mass media. 5 Vincenzo Consolo, ‘Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano’ in Lectio Magistralis, documento ciclostilato (Palermo: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2007), pp. 23-34 (questo è il mio testo di riferimento): ora in La passion por la lengua: Vincenzo Consolo. Homenajes por sus 75 años, a cura di Irene Romera Pintor (Generalitat Valenciana: Universitat de Valencia, 2008), pp. 29-38. Luigi Meneghello, ‘L’apprendistato’, in Lectio Magistralis, documento ciclostilato (Palermo: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2007), pp. 49-56; ora in Luigi Meneghello. Biografia per immagini, pp. 36-40 (è questa l’edizione a cui faccio riferimento). 6 Consolo alla p. 24 della sua lectio ricorda: ‘Nel 1894 la palermitana Società di Storia Patria pubblica il fascicolo dedicato ad Antonio Veneziano per il terzocentenario della sua morte’ e annota che il bibliotecario della Società era Giuseppe Lodi, a cui si devono le parole riportate nella citazione. 7 I romanzi di Vincenzo Consolo, di cui cito solo le prime edizioni: La ferita dell’aprile (Milano: Mondadori, 1963); Il sorriso dell’ignoto marinaio (Torino: Einaudi, 1976); Lunaria (Torino: Einaudi, 1985); Retablo (Palermo: Sellerio,1987); Nottetempo, casa per casa (Milano: Mondadori, 1992); Lo spasimo di Palermo (Milano: Mondadori, 1998). 8 Leonardo Sciascia, ‘Introduzione’ in Antonio Veneziano, Ottave (Torino: Einaudi, 1967), p. 7. 9 Enrico Testa, Lo stile semplice (Torino: Einaudi, 1997), p. 348. 10 Sulla plurivocità della lingua consoliana d’obbligo il riferimento al saggio di Cesare Segre, ‘La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio’, in Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento (Torino: Einaudi, 1991), pp. 71-86 (p. 83). 11 A proposito della descrizione riportata a testo, alludo di volata alla necessità visiva della scrittura di Consolo che – basti solo pensare a qualche suo titolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio (Antonello da Messina), Lo Spasimo di Palermo (Raffaello), Retablo etc. –, contrae un debito sostanziale e fondante con la pittura analogamente a Meneghello che notoriamente rimase folgorato, all’inizio del suo apprendistato inglese, dal metodo didattico del Warburg Institute su cui ha scritto pagine importanti e sui cui ha ampiamente basato il suo insegnamento e quello del dipartimento di Studi Italiani da lui fondato a Reading. Si veda, inoltre, quanto riportano Giuseppe Barbieri e Ernestina Pellegrini, rispettivamente, alle pp. 191 e pp. 197-202 di Luigi Meneghello. Biografia per immagini. 12 Renato Nisticò, ‘Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo’, Filologia antica e moderna, 4 (1993), 179-223 (p. 182). 13 Sulla salvezza della scrittura, da varie prospettive, si ricordino le parole di Meneghello: ‘la crisi di tutto il mio sistema di idee pre-inglesi, durata decenni, un lungo, interminabile periodo in cui ho dovuto tener duro, hold tight, come un naufrago su uno scoglio: usando ciò che potevo, aggrappandomi a ciò che avevo, per esempio, la prosa di Leopardi’: Luigi Meneghello, Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta, 3 voll. (Milano: Rizzoli, 2001), III, p. 185. E ancora: ‘“Scavi”. Estrarre “salvezza” dallo scrivere […]. È una specie di scavo continuo […]. Vado a scavare in tutto quello che mi è capitato: scavo, butto via e ricomincio, perché sono convinto che in qualche parte là sotto deve esserci quello che cerco, i nuclei del materiale effusivo e il luccichìo delle scorie vetrificate dove si Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 55 vede risplendere, che cosa di preciso? come dirlo?’ (ibid., p. 258). 14 Si confronti con quanto, analogamente, dichiara Meneghello, a proposito dell’autobiografia, nell’intervista concessa a Luca Bernasconi, in Luigi Meneghello. Biografia per immagini, p. 205: ‘Però tutto questo non è fondato sull’idea che ciò che è accaduto a me ha qualche importanza, anzi sono convinto che non ne ha praticamente nessuna per gli altri, se non per me. Ma dentro contiene qualche cosa che non appartiene solo a me e, scrivendo, qualche volta emerge. Quando emerge, allora va bene, ce l’abbiamo fatta; e l’autobiografia è diventata qualche cosa di più e di diverso.’ 15 A questo argomento nel 2002 è stato dedicato un convegno a Parigi, alla Sorbonne Nouvelle, i cui atti si possono leggere nel seguente volume: Vincenzo Consolo. Étique et Écriture a cura di Dominique Budor (Parigi: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007). 16 Su questi aspetti si veda Nisticò, ‘Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo’. 17 Cfr. I seguenti volumi: Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta. Volume I: Anni Sessanta (Milano: Rizzoli, 1999); Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta. Volume II: Anni Settanta (Milano, Rizzoli, 2000). Per il volume III delle Carte si rimanda alla nota 13. 18 Si confrontino Meneghello e Consolo: le operazioni fatte sono diverse ma analoghe. Entrambi scavano nella propria lingua. Meneghello in quella parlata e non scritta del paese natale, nell’ambito storicamente ristretto alla propria esperienza biografica infantile e giovanile a Malo, nei due decenni degli anni ’20- ’40 del Novecento. Consolo, dal canto suo, scava storicamente e socialmente in un contesto storico millenario, secolare per: a) restituire la ricchezza linguistica del passato altrimenti destinata all’oblio; b) per rapportarsi sempre, metaforicamente, al presente. Meneghello: lingua della propria memoria biografica; Consolo: lingua della memoria storica collettiva. Ma la spinta etica a cercare di raccogliere nella loro lingua di espressione quanto di essenziale, di universale sia possibile reperire e tale da travalicare le proprie esperienze individuali è quello che li accomuna nel loro essere due ‘classici’ fuori dal coro. 19 Cfr. Ludwig Wittgenstein, ‘Lecture on Ethics: 1929- 1930’, ora in Ludwig Wittgenstein’s Lecture on Ethics. Introduction, Interpretation and Complete Text, a cura di Valentina Di Lascio, David Levy, Edoardo Zamuner (Macerata: Quodlibet, 2007), p. 42. 20 Sulle lingue di Meneghello, si vedano i lavori di Giulio Lepschy: ‘“dove si parla una lingua che non si scrive”’, in Su/Per Meneghello, a cura di Giulio Lepschy (Milano: Edizioni di Comunità, 1983), pp. 49- 60; ‘Le parole di Mino. Note sul lessico di Libera nos a malo’, in Luigi Meneghello, Il tremaio. Note sull’interazione tra lingua e dialetto nelle scritture letterarie (Bergamo: Lubrina Editore, 1987), pp. 75- 93. 21 Lepschy, ‘“dove si parla una lingua che non si scrive”’, p. 49 e p. 50. 22 Cfr. Giulio Lepschy, ‘In che lingua?’, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, pp. 15-22; ‘Introduzione’, pp.xliii-lxxxiv. 23 Lepschy, ‘In che lingua?’, p. 22 24 Cesare Segre, La letteratura italiana del Novecento (Roma-Bari: Laterza, 2004), p. 92. 25 Vincenzo Consolo, ‘I muri d’Europa’, Estudos Italianos em Portugal, Nova Série, numero a cura di Giovanna Schepisi, 3 (2008), 229-236 (p. 233). 26 Il sorriso dell’ignoto marinaio (Milano: Oscar Mondadori, 2004), p. 114. 27 Cfr. quanto Meneghello dice a proposito di Leopardi nella nota 13. 28 Franco Fortini, Attraverso Pasolini (Torino: Einaudi, 1993), p. 67
The Italianist (2012)
Tag: Oscar Mondadori
Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo

Intrecci mediterranei.
La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo
di Massimo Lollini
Cosa in comune quest’isola di culto, questo giardino, i suoi astanti, cosa l’ affabile algerino, tu coi cristiani di Bosnia, Sarajevo, i mercenari d’ogni Africa, i trafficanti d’armamenti, i boia d’ogni scarica e veleno, i Mafiosi del potere? Nel bronzo, si, e la crepa, il varco in ogni sacro testo, ogni decalogo, codice latino o d’altra lingua, dentro te, ognuno in questo tempo feroce e allucinato. (Lo spasimo di Palermo 41-42) Il mare, l’infinito e la guerra Concludendo un’importante riflessione sull’eredita mediterranea nella cultura europealo storico Georges Duby osservava un ventennio fa che “da circa un secolo il Mediterraneo offre a chi lo scruta, agli avamposti della speranza, un volto di violenza” (Duby 282). In realta questo volto violento richiama alla memoria storica la “parte piu tenebrosa” dell’eredita del classicismo greco-romano presente fin nelle origini della civilta mediterranea. Nella ricostruzione dei momenti fondamentali di questa civilta lo stesso Fernand Braudel ha sottolineato il carattere decisivo dei “conflitti tra civilta” da quelli brevi (Maratona, Lepanto) a quelli lunghi, come le tre guerre puniche o le crociate. Secondo Braudel questi conflitti mettono bene in evidenza “quali urti sordi, violenti e reiterati si scambino quegli animali possenti che sono le civilta”; e come le civilta siano “intrise di guerra e di odio, una immensa zona d’ombra che le divora quasi per meta” (Braudel, “La Storia” 110-11). Tuttavia le civilta non sono solo questo odio fabbricato e nutrito per l’altro. Esse rappresentano anche l'”eredita dell’intelligenza” l’accumulo dei beni culturali, sacrificio. Questi due elementi, quello “distruttivo” e quello “costruttivo,” appaiono strettamente intrecciati e appare quanto mai arduo e problematico il tentativo di separarli quasi fossero realta distinte ed autonome, come talora sembra proporre lo storico Braudel. La ricerca sul ruolo del Mediterraneo nella formazione dell’immaginario letterario europeo deve cogliere questo aspetto, se non vuole assecondare la marea montante di parole che puntano a derealizzare l’esistente e a costruire un mondo puramente ideologico che finisce per cancellare ogni consapevolezza della realta in cui si vive. Il saggio prende avvio da una riflessione sul nesso che si stabilisce nella cultura greca da una parte trail mare e l’orientamento verso l’infinito, e dall’altra trail mare e la guerra. Le due nozioni, quella di una ricerca intellettuale infinita e quella della guerra come esito inevitabile dell’attraversamento del mare, trovano un modello esemplare nella figura dell’Ulisse omerico, che i greci hanno lasciato in eredita alle letterature europee dall’antichita fino ai nostri giorni. L’esperienza della guerra di Troia ha segnato Ulisse in maniera profonda, rendendolo capace di un senso di pietas per il dolore proprio e altrui inconcepibile nel contesto dell’Iliade che rimane il “poema della forza” come ha scritto Simone Weil. L’episodio di Odisseo nella reggia feacia che piange sentendo il canto di Demodoco (da lui stesso richiesto) dove si racconta l’inganno del cavallo di Troia, e senza dubbio rivelativo di un profondo mutamento dell’eroe nel passaggio dal primo al secondo poema omerico (Odissea, libro VIII). Ma e la catabasi raccontata nel canto XI che rende manifesto in maniera inequivocabile il cambiamento rispetto al codice dell’eroismo al centro dell’Iliade. L’episodio piu potente rimane l’incontro con l’anima di Achille che preferirebbe essere un servo di una padrone povero piuttosto che essere morto. Emerge qui con forza la novita piu profonda dell’Odissea, il riconoscimento del dolore della propria morte e la scoperta della privazione dell’identita che essa comporta. La discesa di Odisseo nell’Ade rimane centrale nell’economia del racconto omerico cosi come si articola nei due poemi. Odisseo desidera ardentemente incontrare non solo Tiresia per conoscere il proprio destino, ma anche le anime di molti defunti per interrogarle sulle modalith e il senso della morte. In essi Odisseo trova una sapienza che e estranea ai vivi, la consapevolezza profonda del dolore che pervade la vitae il limite invalicabile rappresentato dalla morte. Altri momenti significativi del viaggio di Odisseo nell’Ade sono l’incontro con l’anima del compagno Elpenore e quello con la madre piangente. L’anima di Elpenore e la prima che si fa incontro ad Odisseo e lo implora di seppellire e compiangere il suo corpo rimasto in casa di Circe senza sepoltura. La dimensione del compianto e del lamento funebre per la morte dell’altro e al centro anche dell’incontro con l’ombra della madre. Il figlio vivo si trova qui unito alia madre morta nel comune desiderio di dare espressione al proprio dolore e al proprio pianto. Il viaggio nell’Ade e il lamento funebre sono importanti per Odisseo e la cultura greca e mediterranea almeno nella stessa misura del viaggio in mare. (4) Il viaggio in mare rappresenta cio che si teme piu profondamente, l’esposizione al pericolo infinito e incondizionato, la paura di una morte negli abissi marini senza sepoltura umana. Il viaggio nell’Ade e la sepoltura rappresentano la riconciliazione con gli esseri umani e divini, il conforto rappresentato dal lamento funebre che aiuta a vivere e a dare un senso sia pure straziante alla morte. Ma anche se tu tornassi se le distanze si accorciassero e la guida fiammeggiasse nel tuo sembiante tragico o nel tuo terrore intimo, sempre per me tu saresti la storia della partenza per sempre tu saresti in una terra senza promessa in una terra senza ritorno. Anche se tu tornassi, Ulisse. (Adonis Poesie) Questi versi, letti insieme a quelli di un’altra poesia di Adonis, L’erranza, bastano da soli a far comprendere come la condizione dell’esilio e dell’erranza siano una condizione irreversibile nella cultura mediterranea moderna sia nel mondo cristiano che in quello arabo. I versi di Adonis sono veramente significativi, soprattutto se letti insieme alle sue dichiarazioni di poetica (5): L’erranza, l’erranza L’erranza ci salva e guida i nostri passi L’erranza e chiarezza E il resto e solamente maschera L’erranza ci lega a tutto quello che e altro Ai nostri sogni imprime il volo dei mari E l’erranza e attesa. (Adonis Poesie) Nel verso “L’erranza ci lega a tutto quello che e altro” e contenuto il senso profondo della condizione dell’Odisseo moderno cosi come si manifesta nella tradizione mediterranea araba e cristiana, con molti punti in contatto con analoghe concezioni ebraiche che pure non si riferiscono al mito di Ulisse ma a quello di Abramo. Si tratta di una condizione di continuo esilio che rifiuta ogni certezza in nome di un apprezzamento intrinseco di tutto cio che e altro. Pur comprendendola Dante condanna la ricerca intellettuale di Ulisse dal momento che non e illuminata dalla luce divina. Per questo il viaggio di Ulisse rimane un “folle volo” che mantiene comunque qualcosa in comune con qualunque aspirazione alla conoscenza autentica e creativa, come sapeva bene Dante e come sanno gli scrittori moderni e contemporanei che sono venuti dopo di lui. Vincenzo Consolo dedica un capitolo de L’olivo e l’olivastro (1994) alla riscrittura del viaggio di Odisseo che viene presentato come metafora dell’esperienza del viaggio dello scrittore siciliano attraverso la sua isola e, piu in generale, come figura dell’uomo moderno e dello sradicamento esistenziale e storico provocato dalla civilta tecnologica da lui creata. Dopo la risoluzione del conflitto Ulisse si trova di nuovo immerso nella vastita del mare. Il suo viaggio questa volta procede in verticale e si presenta come “una discesa negli abissi, nelle ignote dimore, dove, a grado a grado, tutto diventa orrifico, subdolo, distruttivo” (19). Il viaggio di Odisseo nasce dall’orrore della guerra e dal senso di colpa per le morti e le distruzioni, e il viaggio di un sopravissuto. (9) E un viaggio dal mare verso la terra, da Oriente ad Occidente, “dall’esistenza alla storia, dalla natura alla cultura” (124) un viaggio al termine del quale non c’e la patria agognata, ma la condizione perenne dell’esilio. L’Itaca che trova l’Ulisse moderno non esiste pit perche e sottoposta ad una continua distruzione, del tutto simile a quella che esperimenta durante la guerra. Per questo, scrive Consolo, Ulisse comprende che Itaca coincide con Troia ed e costretto a ripartire, condannato ad una condizione di erranza. Nessun viaggio penitenziale o liberatorio appare possibile allo scrittore siciliano. Itaca la citta del mito non esiste pit; le citth della memoria e della letteratura appaiono sempre piu lontane. Siamo Iontani dal modello rappresentato da Conversazione in Sicilia di Vittorini che pure ha ispirato gli ultimi due romanzi di Consolo. Il romanzo di Vittorini poteva ancora contare sulla “conversazione” come mezzo per una rigenerazione spirituale e morale. Il ritorno di Silvestro in Sicilia serve proprio a questo e si nutre di un potente linguaggio lirico e simbolico che aiuta il protagonista a ritornare ormai deciso e maturo nella Milano del lavoro, dell’industria e della lotta politica per la costruzione di una nuova Itaca. La critica della cultura per Consolo non si nutre piu di alcuna utopia, mentre la posizione privilegiata della coscienza che valuta e giudica l’ordine delle cose appare sempre piu pervasa da domande inquietanti. Il paesaggio che ci descrive Consolo ha perduto la dimensione lirica e simbolica assumendo una sostanza allegorica in cui non si intravede una via di riscatto. E un paesaggio di rovine quello a cui approda l’Odisseo moderno. Un paesaggio in cui l’immagine di Itaca appare sbiadita al punto da scomparire. L’unica alternativa per lui sembra essere quella, gia indicata da Dante, del naufragio definitivo come conseguenza del “folle volo” di Ulisse. Si tratta di un’immagine drammatica, che Primo Levi ha fatto sua a conclusione del capitolo “Il canto di Ulisse” che non a caso ha un ruolo centrale in Se questo e un uomo. Per Consolo, come per Primo Levi (e Italo Calvino), la posizione etica delia scrittura consiste sempre piu in questa volonta di testimonianza che pone questioni fondamentali sul destino della civilta europea, e si esprime in domande radicali che coinvolgono il gesto stesso della scrittura, intesa come strumento fondamentale della cultura, della tecnologia e del sapere occidentale. Occorre allora chiedersi se la nozione di “esilio” su cui Consolo stesso ha insistito, sia la piu adeguata e dar conto dello spessore della sua ricerca intellettuale. Ritorneremo su questa importante questione nell’ultima parte del saggio. Le domande dello scriba menzogna l’intelligibile, la forma, o verita ulteriore? (Nottetempo 164) E questa la situazione in cui si muove anche il protagonista de Lo spasimo di Palermo (1998), Gioacchino Martinez, scrittore in crisi che si trova sempre piu perplesso e sgomento di fronte al gesto della scrittura: Aveva tentato infinite volte la scrittura, lettere memorie resoconti, ma l’orrore nasceva puntuale per quell’ordine assurdo, quel raggelare la ferita, quella codificazione miserevole dell’assenza prima e poi assoluta, dell’improvviso vuoto, dello sgomento fisso. (53) Questi ragionamenti sulla scrittura, piuttosto che ridursi a puro gesto autoriflessivo e solipsistico, rappresentano la linfa profonda che collega la riflessione di Consolo nella trilogia romanzesca rappresentata dal Sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo. Come accade in Primo Levi, Italo Calvino e nei maggiori scrittori del Novecento, Consolo inserisce nell’orizzonte della scrittura letteraria la presenza di un soggetto filosofico che riflette sulla propria attivita, nel tentativo di comprenderne l’orizzonte e il senso. Accade cosi chela domanda sulla possibilita del racconto e della scrittura e la parallela aspirazione a dare una testimonianza vera dei processi storici possono trovare espressione non tanto nella dissoluzione della forma e della soggettivith, ma nel “vuoto della forma” e nella decisione in base alia quale il soggetto filosofico trova nella contingenza della propria vita il proprio modo di abitare la verith (Lollini). Non posso dire di ricordare esattamente come e quando il mio greco scaturi dal nulla. In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra: il mondo intorno a noi sembrava tornato al Caos primigenio, e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava in moil ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi. (I: 226; mia l’enfasi) In maniera significativa la stessa metafora ritorna alia fine, nell’ultima pagina del libro in cui si spiega perche il viaggio di ritorno non e stato ne poteva essere un viaggio liberatorio: … non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. E un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un’ angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade o si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone e l’angoscia si fa piu intensa e piu precisa. Tutto e ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o l’inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. (I: 395; mia l’enfasi) Alla fine del lungo e avventuroso cammino che, come buona parte della narrativa di viaggio ha come modello appunto l’Odissea di Omero, Levi deve constatare di non essere riuscito ad allontanarsi dal Campo e che anche nella sua Itaca la memoria del Lager ritorna ossessiva e implacabile: Testimonianza e alterita Non riconosci la terra da cui eri partito. Chi sia, domandano, il reduce avvolto nella nebbia, nascosto dietro la vizza maschera del viso, privo di doni, di bottino. (Lo spasimo di Palermo 101) Le vicende storiche piu recenti, dalla guerra nella ex-Jugoslavia agli attuali conflitti in Afghanistan e Iraq, non fanno che confermare le tendenze remote della storia Europea nell’era della globalizzazione. L’attraversamento del mare finisce per dar luogo anche oggi al conflitto armato e alla fondazione di un ordine mondiale fondato sulla forza e sul mancato riconoscimento dei valori positivi insiti nella diversith culturale. E significativo che l’operazione bellica che ha portato all’ulteriore distruzione dell’Afghanistan gia stremato dalla poverta e dalla guerra pluridecennale sia stata chiamata “Giustizia infinita.” In quell’ aggettivo e da riconoscere un orientamento antico della civilta occidentale nata sulle sponde del mare greco. Ancora una volta il mare non appare un luogo di incontro e di comunicazione, ma di conflitto e di conquista che oggi assumono dimensioni planetarie. L’era attuale e stata preparata dalle rivoluzioni scientifiche e spaziali del diciassettesimo secolo. Sul piano scientifico, come ha scritto Koire si e passati dal mondo cosmico e chiuso della scienza antica aristotelica e tomistico-medievale all’universo infinito della scienza moderna, introdotta dal canocchiale di Galileo. La metafora geometrica e spaziale serve a introdurre la grande rivoluzione della concezione della spazio di cui ha parlato Carl Schmitt che vede in questo secolo e nelle scoperte geografiche che lo hanno preparato l’affermarsi di una dimensione “oceanica” della storia universale, con un’enorme dilatazione dello spazio, fattosi infinito e “vuoto.” Schmitt parla del passaggio dal nomos della terra fondato sulla condizione continentale europea e caratterizzato dal carattere locale dei conflitti al nomos del mare, in cui predomina l’infinito, dell’incondizionato, il movimento e la volonta di potenza, la guerra totale e lo spirito della tecnica senza piu limiti. Il mare di cui parla Schmitt non e piu il Mediterraneo, ma l’Oceano che e il vero protagonista della rivoluzione spaziale moderna e serve per comprendere la dimensione mediterranea in un orizzonte piu vasto e attuale. Schmitt vedeva nella condizione insulare dell’Inghilterra (e a suo modo degli Staff Uniti) il simbolo di questa rivoluzione spaziale alle origini della modernita (Schmitt). Sono fenomeni ancora in corso che si manifestano nei conflitti sempre piu numerosi e incontrollati. Consolo-Odisseo moderno continua i suoi viaggi nel Mediterraneo per portare testimonianza di questi processi violenti in toni che a tratti si fanno apocalittici e profetici. In questa prospettiva si collocano gli scritti giornalistici usciti negli ultimi anni sul Corriere della sera o l’Espresso. Tra questi ultimi spiccano “Viaggio a Sarajevo” e “Viaggio in Israele/Palestina del PIE.” Nel primo testo Consolo racconta di un viaggio fatto con altri scrittori italiani per testimoniare la guerra sanguinosa della ex Jugoslavia. (12) Ritroviamo qui il paesaggio di rovine e distruzione che hanno colpito soprattutto Sarajevo, una citta un tempo civile e fiorente nella tolleranza religiosa ed etnica. La testimonianza di Consolo insiste sulle atrocita commesse da uomini ormai privi di ragione e ridotti a natura, tanto che l’immagine di Sarajevo devastata dalla violenza umana a suoi occhi assomiglia alle immagini di Assisi colpita da un terribile terremoto nei giorni in cui egli si trovava a Sarajevo. n questo ambito di scritti tra testimonianza e profezia occorre ricordare anche il “Memoriale di Basilio Archita” (Consolo, Le pietre di Pantalica 183-91), un breve racconto-saggio dove lo scrittore testimonia di un’altra tragedia che insanguina il Mediterraneo nei nostri giorni. Si tratta del racconto della morte violenta di un gruppo di africani che imbarcatisi clandestinamente su una nave greca sono poi gettati in mare e divorati dai pescecani. La tragedia dei clandestini che muoiono nel tentativo disperato di attraversare il mare per sfuggire ad un destino di fame e poverta non aveva ancora assunto le dimensioni attuali quando Consolo scrive questo testo. Le sue parole assumono qui un ruolo veramente profetico nel mostrare il livello di degenerazione raggiunto dalla civilta greca e mediterranea. I versi del poeta greco Kavafis recitati dal vicecomandante della nave greca non fanno che confermare la decadenza di una cultura priva di un senso di responsabilita o di una visione etica e civile della convivenza umana. Si tratta di una cultura ormai incapace di riconoscere se stessa. La voce narrante del racconto, e quella di Basilio Archita un giovane sfruttato a bordo della nave greca che pure esprime un elementare senso di solidarieta con le vittime. Tuttavia egli non e affatto consapevole dell’origine greca del suo nome e trova un senso di identita unicamente nell’abbigliamento offerto dal consumismo di massa. In questa situazione per tanti aspetti distruttiva risulta veramente preoccupante il venir meno di un vigile senso critico nella cultura contemporaneo come si vede nell’accettazione sempre piu passiva dei fenomeni distruttivi in corso, e nel consenso diffuso che hanno incontrato in occidente le parole d’ordine di guerra dopo gli eventi del terribile il settembre 2001. Minoranze sempre piu esigue si oppongono con la forza della ragione a questo stato di cose dove la violenza del terrorismo e quella degli stati belligeranti non sembra aver piu limiti. Questa situazione ci aiuta oggi a capire il senso profondo delle opere di scrittori come Levi e Consolo che hanno denunciato il carattere pervasivo della maledizione tecnologica e del contagio della violenza distruttiva che domina la storia dell’Occidente. Proprio in questa testimonianza consiste l’attualith e la forza del loro messaggio non tanto nell’adesione al pensiero dell’erranza e dell’esilio che pure e presente nei loro scritti. NOTE (1) Della Weil the considera la guerra come “il principale motore della vita sociale” (Quaderni 1: 189), si veda il fondamentale saggio “L’Iliade poema della forza” (Weil 10-41). Cfr. anche la raccolta di saggi Sulla guerra. Hannah Arendt indica l’esistenza di un rapporto strutturale tra polemos e polis. Sostiene the la violenza e la guerra di per se non sono politiche ma fondano tuttavia la politica. Si veda la raccolta di saggi Arendt tradotia in italiano con il titolo Politica e menzogna (Milano: SugarCo, 1985). Su tutta la questione si veda Esposito. (2) Su questo aspetto si veda Boitani che intende Ulisse come “figura” o umbra nel senso di Auerbach. (3) Su questo punio, si veda Gentiloni. Put criticando l’impostazione schematica di Levinas Gentiloni sottolinea le differenze tra Ulisse e Abramo e indica nel cerchio la metafora della cultura greca e nella freccia quella della cultura ebraica, la logica contro il suo superamento (121). (4) Ernesto de Martino ha mostrato l’esistenza di una modalita mediterranea del lamento funebre a partite da uno studio sul pianio rituale delle donne lucane. Cfr. De Martino. La prima edizione del saggio e del 1958. (5) Adonis sostiene the la modernita non e specifica di un paese o di un popolo. Il suo aspetto universale consiste nello sviluppo scientifico che non si puo evitare. Adonis sostiene una visione creativa della modernita e conclude: .” .. the questions ‘What is knowledge?’, ‘What is truth?’, ‘What is poetry?’ remain open, … knowledge is never complete and truth is a continuing search” (Adonis, An Introduction to Arab Poetics 101). Cacciari, Massimo. Geo-Filosofia dell’Europa. Milano: Adelphi, 1994. Consolo, Vincenzo. Le pietre di Pantalica. Milano: Mondadori, 1988. –. Nottetempo, casa per casa. Milano: Mondadori, 1992. –. L’olivo e l’olivastro. Torino: Einaudi, 1994. –. Lo spasimo di Palermo. Milano: Mondadori, 1998. –. Di qua dal faro. Milano: Mondadori, 1999. –. Il sorriso dell’ignoto marinaio. 1976. Torino: Einaudi, 2000. Consolo, Vincenzo, e Franco Cassano. Rappresentare il Mediterraneo. Lo sguardo Italiano. Messina: Mesogea, 2000. Consolo, Vincenzo, e Mario Nicolao. Il viaggio di Odisseo. Milano: Bompiani, 1999. De Crescenzo, Assunta. “Paesaggio e mito Mediterraneo Nell’opera di Luigi Pirandello.” Il mare ciclope. Per un’identita Mediterranea. III Concerto Spettacolo. Atti del Convegno di Napoli 24 Aprile 1999. Ed. Assuta De Crescenzo e Aristide La Rocca. Napoli: Liguori, 2003. De Martino, Ernesto. Morte e pianto rituale nel mondo antico. Torino: Einaudi, 1958. Duby, Georges. “L’eredita.'” Il Mediterraneo: lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni. Ed. Fernand Braudel. 1985. Milano: Bompiani, 2003. 267-82. Esposito, Roberto. L’origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil? Roma: Donzelli, 1996. Gentiloni, Filippo. “Il viaggio fra mito e religione: Abramo Contro Ulisse.” Il viaggio. Ed. Di Giovanni Gasparini. Roma: Edizioni Lavoro, 2000. 117-32. Koyre, Alexandre. Dal mondo chiuso all’universo infinito. Milano: Feltrinelli, 1988. Levi, Primo. Opere. Ed. Marco Belpoliti. 2 vols. Torino: Einaudi, 1997. Levinas, E. “La signification et le sens.” Revue de Metaphysique et de Morale 2 (1964): 125-56. Lollini, Massimo. Il vuoto della forma. Scrittura, testimonianza e verita. Genova: Marietti 1820, 2001. Mondolfo, Rodolfo. L’infinito nel pensiero dell’antichita classica. Firenze: La Nuova Italia, 1956. Montanari, Franco. “I1 viaggio come motivo mitico. Odisseo, il ritorno al passato e un pensiero a Edipo.” Da Ulisse a Ulisse: il viaggio come mito letterario. Atti Del Convegno Internazionale Imperia, 5-6 Ottobre 2000. Ed. Giorgetta Revelli. Pisa: Istituti editoriali e poligrafici intemazionali, 2001. 37-48. Propp Ja, Vladimir. Morfologia della fiaba–le radici storiche dei racconti di magia. Roma: Newton Compton, 2003. Schmitt, Carl. Terra e mare. Milano: Giuffre, 1986. Shay, Jonayhan. Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character. New York: Atheneum Macmillan, 1994. Spinazzola, Vittorio. Itaca, addio. Vittorini, Pavese, Meneghello, Satta: il romanzo del ritorno. Milano: Il Saggiatore, 2001. Weil, Simone. “L’iliade poema della forza.” La Grecia e le intuizioni precristiane. Roma: Borla, 1984. –. Quaderni. A cura di Giancarlo Gaeta. Vol. 1. Milano: Adelphi, 1982. –. Sulla guerra. Scritti 1933-1943. Milano: Pratiche, 1998. MASSIMO LOLLINI University of Oregon Bibliography for: “Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo” Massimo Lollini “Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno
Odisseo”.
Italica. FindArticles.com. 21 Feb, 2012.
L’ulivo e la giara
di Vincenzo Consolo
Nell’estate del 1882 Pirandello a compagnia del padre, compie un viaggio – il primo suo vero viaggio – da Palermo e Sant’Agata Militello, per una Sicilia, per una campagna, per un paesaggio tutt’affatto diversi da quelli che aveva dentro e che conosceva. Scopo di questo viaggio, da parte di Stefano Pirandello, è d’intraprendere, dopo il suo crollo economico a causa dello zolfo, il commercio degli agrumi. II signor Vincenzo Faraci di Sant’Agata, proprietario terriero e agente della compagnia di navigazione Florio-Rubattino, presso cui si reca, dovrebbe aiutarlo nella sua nuova impresa. La famiglia Pirandello, già dalla primavera dell’82, si era trasferita da Girgenti a Palermo, s’era allocata in una casa di via Porta di Castro, a ridosso delle mura del Palazzo Reale. Partono dunque, padre e figlio, per Sant’Agata, alle prime ore del mattino, su un treno che li porta fino a Termini Imerese. Da qui, per l’inesistenza ancora della strada ferrata fino a Messina, proseguiranno in diligenza.
Immaginiamo, in treno e in carrozza, la curiosità, l’attenzione, il rapimento del quindicenne Luigi di fronte a quel nuovo mondo che gli scorreva davanti agli occhi, agli echi che gli suscitavano i nomi dei paesi: Solunto, Himera, Cefalù, Halaesa, Calacte…
Al fitto e profondo verde degli agrumeti, e ai golfi, alle insenature, alle calette, al mare lungo la costa tirrenica; e alla cortina boscosa delle Madonie e dei Nebrodi che separavano questo rigoglio vegetale dalle sconfinate, aride lande dell’interno, della desolata nudità del latifondo e dei grigi e fumosi altipiani dello zolfo. E doveva accorgersi che man mano, dopo Termini, dopo Cefalù, il mondo colorato, vociante e brulicante del Palermitano andava a poco a poco stemperandosi – a spegnersi finanche nelle decorazioni dei carretti che, da chiassosi e spettacolari, si facevano monocromi, giallognoli o verdastri – a prendere gradualmente una misura più dimessa, ma forse più serena.
Sostano a Santo Stefano di Camastra. Un paese, questo, dopo la frana del 1682 che aveva distrutto il vecchio abitato in montagna, concepito e fatto ricostruire in basso-su un promontorio a mare, da Giuseppe Lanza duca di Camastra. L’impianto urbanistico disegnato dal duca ,un rombo inscritto in un quadrato – era ripreso aulicaunque dallo schema del Parco Versailles e della palermitana Villa Giulia. Un paese dunque non affastellato, casuale, di case sopra case, ma “pensato”, moderno, piano, ordinat: un paese “bello” secondo la qualificazione vittoriniana de Le cità del mondo. E’un paese anche di grande attività, di lavoro: la lavorazione dell’argila, di cui quasi tutti gli abitanti vivevano. A margini, lungo la statale, erano le purrere, le cave d’agilla, gli stazzuna, le fabbriche di laterizi, e le putii i robba r’acqua, le botteche delle ceramiche d’uso quotidiano (desumiamo queste notizie dalla monografia di Antonino Buttitta e Salvadore D’onofriono, La terra colorata) davanti alle qual erano gli spiazi dove la creta veniva ammucchiata e impastata ( dagli impastatura, a piedi nudi seguendo un preciso disegno, a ventaglio, a chiasciola, a spicchi d’arancio o a cerchi concentrici) e venivano esposti i manufatti ad asciugare o messi in mostra per la vendota dopo la cottura.
E davanti a queste botteghe, Luigino, fra i tanti oggetti, tante forme, quartari lémmi, bùmmuli, lumèri, fangotti, mafarati, avrà visto quella grande forma, alta, panciuta, ch’era la giarra.
La fabbricazione d’una giara era un lavoro delicatissimo, di grande precisione e di alta specializzazione dei “mastri”. Veniva eseguito in tempi successivi, al tornio. Sulla base precedentemente asciugata (u piezzu) venivano poi man mano innestate le fasce, su su fino alla parte più convessa della pancia e alla rastremazione delle spalle, del collo e della bocca. Veniva poi stagnata, invetriata con piombo ossidato, all’interno e fino al labbro, prima di essere infornata. In quella stagione, prossima alla raccolta delle olive e alla loro spremitura – le olive dei vasti oliveti della zona del Mistrettese, delle Caronie, di San Fratello – dovevano essercene già molte esposte davanti alle botteghe, di giare, nelle loro varie misure canoniche – da mezzo cantàru, venti litri, fino alle grandi capaci di quattrocento, cinquecento litri d’olio – un solenne corteo di badesse nell’ocra infuocata della luce del tramonto.
A Sant’Agata Luigi e il padre sono ospiti per alcuni giorni della famiglia Faraci, in contrada Muti, in una casina di campagna su una collinetta da dove si domina il piccolo paese col castello dei principi di Trabia al centro, le casupole dei pescatori lungo la spiaggia e quelle dei contadini verso l’alto. Luigi ritrovava qui il suo coetaneo e compagno di scuola, al “Vittorio Emanuele II” di Palermo, Carmelo, figlio di Vincenzo Faraci. Fra i due ragazzi si stabili una solida amicizia. E, ritornata la famiglia Pirandello a Girgenti nell’85, Luigi e Carmelo andranno a abitare insieme in un stanzetta d’affitto in via Mastro d’Acqua, E l’ultimo anno di liceo, Luigi allora ferocemente immerso nei suoi studi e nell’amore per la cugina Lina. Carmelo Faraci si dedicherà a questo suo compagno geniale e stravolto dalla passione d’amore fino ad accudirlo, a preoccuparsi di tute le necessità pratiche. Poi Carmelo, finito il liceo. avrà un triste futuro, si ammalerà di tisi e lascerà Palermo per andare a rifugiarsi in un bosco sopra Sant’Agata, a Mangalavite.
Luigi, da Porto Empedocle, dalla villa del Caos, nell’agosto dell’87, deluso dall’amore, dal lavoro tentato nelle zolfare del padre, in preda al pessimismo più nero, si ricorderà di questo suo mite e fedele amico e gli scriverà. Le cinque lettere che Pirandello invierà al Faraci sono state pubblicate dal professor Giovanni R. Bussino, di San Diego in California nel libro Alle fonti di Pirandello. Scrive in una di queste lettere:
“Tu sei malato di corpo (e io ti voglio intanto in via di guarigione) ed io sono malato di spirito e della mia malattia non si guarisce. Mi credono tutti pazzo, e prima – per maggiore tormento – i miei più cari; il mio vizio dei nervi si è bruscamente accentuato ed io non so trovar pace in nessun luogo: la mia vita mi si è fatta brutta bene… M’indusse a scriverti – non te lo nascondo – una dolcissima memoria del passato…”.
La memoria dolcissima d’una serena campagna: e di due forme, antichissime e significanti: l’ulivo e la giara.
La novella La giara è pubblicata il 20 ottobre 1909 sul “Corriere della Sera”.
Pirandello è chiuso, in questo periodo, in una doppia, tetra prigione: quella burocratica dell’insegnamento al Magistero, dov’era inquadrato nella categoria degli “incaricati” certamente contrassegnato da un mastronardiano “coefficiente”, e quella domestica, dove la gelosia paranoica della moglie gli tesseva intorno ogni giorno di più le sue terribili maglie. La novella La giara è la prima fuga nella memoria e nel ricordo, fuga dalla sua vita e dai fantasmi “pirandelliani” che lo assediavano.
‘A giarra, commedia in dialetto, è del 1916.
E’ tempo di guerra. Il figlio Stefano è prigioniero degli austriaci, la madre appena morta – quella madre che aveva incarnato il suo romantico patriottismo, che ora, nell’urto con la tragica realtà, si lacerava – gli ritornava a colloquio come personaggio, la moglie ormai dentro quella tenebra dove “nessuna voce può raggiungerla più” Si sa che al teatro regionale e dialettale Pirandello fu trascinato dall’amico Martoglio e dalla forza della “Compagnia comica di Angelo Musco, che in quegli anni mieteva successi per tutta la Penisola Successi, certo, di questi istintivi e irresistibili teatranti catanesi, dovuti anche al bisogno di distrazione e di riso da parte degli spettatori angosciati dalla guerra. Pirandello scriverà per quel teatro per ragioni materiali, economiche ma deve anche scrivere quel teatro per ragioni spirituali, in un bisogno crescente di luce e di respiro quanto più si sente precipitare nel pozzo della disperazione. Al momento più basso e più cupo della sua vita, corrisponderà il momento creativamente più luminoso e liberatorio che è Liolà.
Subito seguirà La giara, con la quale chiuderà questo ciclo. E a noi piace credere che nel concepire La giara gli sia tornato il ricordo di quel suo lontano viaggio nel Val Demone, della fertile campagna alle falde dei Nebrodi, delle giare intraviste a Santo Stefano. “Sissignore, della giara grande, per l’olio, arrivata ch’è poco da Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricano. Uh, bella: grossa così, alta a petto d’uomo, pare una badessa” dice ‘Mpari Pè, il garzone di don Lollò. L’uomo rimasto prigioniero dentro la giara è una delle trovate sceniche, visive e gestuali, più felici del teatro pirandelliano. Saracena è la giara – giarrat – e saraceno quel conciabrocche dentro, ladro (involontario) della roba altrui, su cui volentieri don Lollò, nella sua furia, butterebbe dell’olio bollente. Ma zi’ Dima è anche un folletto, un imprevedibile ginn, di quelli annidati dentro bottiglie o lampade – egli ha commercio col diavolo, e quella gobba e quella pece nera ne sono la prova – che con le sue argomentazioni da dentro la giara contrasta e distrugge di volta in volta le argomentazioni esterne, giuridiche, codificate, di don Lollò e del suo avvocato.
Ma La giara trapassa questa farsa saracena o questo mimo siceliota, sofroneo o senarcheo, trapassa ogni eclisse solare e storica, va più indietro verso un tempo remoto, verso significati più abissati, archetipici. La giara è allora l’involucro della nascita, l’utero, ed è insieme la tomba (i Siculi seppellivano i loro morti, in posizione fetale, dentro i giaroni). E zi’ Dima non perde, non muore, sapiente, dialettico e sarcastico, vince e rinasce nello splendore d’un plenilunio, nel tripudio dei contadini.
E quell’olio che la giara avrebbe dovuto contenere viene si dall’ulivo saraceno, ma viene anche dall’albero sacro ad Atena, dea della sapienza.
Se Liolà, della stagione della vendemmia, è mimo dionisiaco o fliacico (Phliax era un demone della natura, della fecondità), La giara è mimo apollineo e cavillico, della stagione dell’olio che dà sapore – sapere – e che dà luce. L’ulivo saraceno, un ulivo del Caos, immaginato, sognato, riapparirà in limine, nella notte che precede la morte, sul palcoscenico del palcoscenico, in un terzo atto mai scritto, a reggere un tendone – sudario contro cui si reciterà l’ultima favola. Apparirà quell’albero di forma tormentata, agonica, da cui l’anima anela a uscire, a consumarsi bruciando, come olio dentro una lampada: a ritornare, annullandosi, nella nudità, nella verità, nel flusso infinito.


Consolo, la Sicilia come missione.
Cesare Segre “Diario civile”
A cura di Paolo Di Stefano
Mentre il primo romanzo di Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile (1963) ebbe scarsa risonanza, fu invece una rivelazione Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976, ma scritto verso il 1969). Qualunque discorso sullo scrittore deve necessariamente partire da qui, perché quel libro, uscito a tanta distanza dal primo, rivela già luminosamente i problemi che Consolo continuerà a dibattere e approfondire e ridefinire, nella sua successiva attività.
Quello che subito venne avvertito (Paolo Milano) è che il libro è una specie di anti-Gattopardo: identico il quadro storico (la Sicilia al tempo della spedizione dei Mille), enorme, a prescindere dalla qualità delle due opere, il divario stilistico e la differenza nella prospettiva della narrazione. Perché se Tomasi di Lampedusa si attiene al rapporto tradizionale tra riferimenti storici, invenzione narrativa e scrittura, Consolo mostrò subito la sua diffidenza (che alla lontana risale al Manzoni) riguardo alla storia come razionalizzazione dei fatti. Ben esplicitando le sue riserve, ci offriva dunque, con il suo non-romanzo, materiali storici che sta a noi rimontare e, se possiamo, razionalizzare.
In pratica, Consolo alternava frammenti di testi storici e cronachistici alle parti d’invenzione, istituendo tra gli uni e le altre una dialettica, che poi si ripresenta, a un livello ideologicamente più alto, nel diverso e pur convergente impianto politico dell’azione dei due protagonisti, il barone Enrico di Mandralisca e il magistrato Giovanni Interdonato. Il primo rappresenta bene i borghesi e gli aristocratici illuminati, quelli insomma dei moti carbonari; il secondo è un democratico di sinistra, che alla fine assolverà i responsabili dell’insurrezione contadina di Alcàra Li Fusi. I discorsi dell’uno e dell’altro espongono nel modo più efficace le due posizioni tra le quali oscillavano, all’epoca, le menti più consapevoli: la sanguinosa rivolta di Alcàra e la successiva spietata repressione saranno il principale oggetto del dibattito.
Ma la storia non ha solo la colpa di offrirci spiegazioni ingannevoli; essa è responsabile di accogliere la prospettiva dei vincitori, sacrificando, ancora una volta, quelli che non hanno nemmeno il diritto alla parola: i vinti, gli sfruttati, i miserabili. È appunto la prospettiva dei vincitori che farà assimilare (impropriamente) i piemontesi ai detronizzati borbonici. Quest’impostazione storiografica, diffusa negli anni in cui Consolo scrive il suo libro, sulla scia dei saggi di Benedetto Radice e di Salvatore Francesco Romano, produce un’altra serie di conseguenze nell’impianto del romanzo. Per «inventare» la voce di coloro che non hanno avuto voce, Consolo crea un plurilinguismo vivacemente espressionistico, che mette a contatto nobili frammenti latini e forme del siciliano o persino del dialetto galloromanzo di San Fratello (a pochi chilometri da Sant’Agata di Militello, patria di Consolo), canti popolari e barocchismi spagnoli. Da «archeologo della lingua», quale si definiva, ci fa attraversare verticalmente i principali strati della storia del siciliano e della Sicilia, magari grazie ai frammenti di una canzone di Federico ii.
Il collante di questo plurilinguismo non è concettuale, ma prosodico. La scrittura di Consolo si caratterizza infatti per il suo sottofondo di armonie verbali. Si può persino sostenere, e qualcuno l’ha sostenuto, che quanto lui scrive è senz’altro una prosa metrica, con i suoi nessi e le sue pause. La musica unifica dunque materiali così eterogenei. Consolo continuerà la serie di «romanzi storici» con Nottetempo, casa per casa (1992), evocazione, anche autobiografica, degli anni in cui le squadracce fasciste portarono la violenza a Cefalù, e con Lo spasimo di Palermo (1998), presa di coscienza del disastro operato dalla mafia, e celebrazione del Judex che dovrà restaurare la giustizia; mentre L’olivo e l’olivastro (1994) racconta un viaggio di ritorno, o di scoperta, in Sicilia, alla ricerca di una natura e di una cultura devastate dalla modernità. E sulla Sicilia della storia e della contemporaneità sono numerosi i saggi, e le raccolte di saggi, di Consolo: per esempio Le pietre di Pantalica (1988) o Di qua dal faro (2001). A parte vanno considerati i divertissements di argomento settecentesco, come Lunaria (1985) e Retablo (1987), che sono anche omaggi da una parte a Leopardi e a Lucio Piccolo, dall’altra all’Illuminismo milanese.
Con Vincenzo Consolo perdiamo uno scrittore eccezionalmente inventivo, capace di immergersi nella storia ma più ancora di giudicare il suo tempo. Sempre attento e acuto, mai in cattedra.
22 gennaio 2012 – Corriere della sera
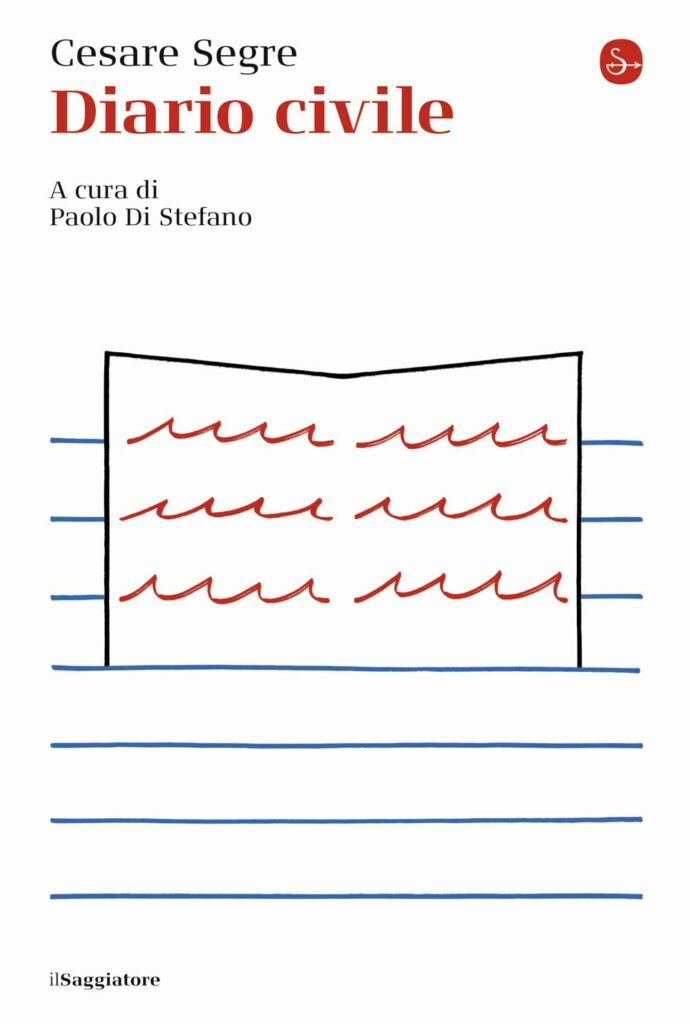
«Noi siàn le triste penne isbigotite».
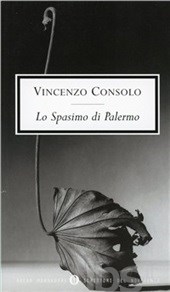
*
«Noi siàn le triste penne isbigotite».
Lo spasimo di Palermo di Vincenzo Consolo.
Con l’eccezione di pochissimi interpreti, in linea di massima la critica ricorre ad una approssimazione per definire Lo Spasimo di Palermo (1998) di Vincenzo Consolo: perlopiù schivando il termine ‘romanzo’ (e Consolo ormai dichiarava il genere invilito e impraticabile), chiama questo oggetto letterario per nome (lo Spasimo) oppure nelle varianti di ‘opera’, ‘libro’, ‘testo; e lo dice ‘vicino alla poesia’, o ‘vicino ai silenzi della poesia’, agli ‘approdi della lirica’, avvalendosi di simili locuzioni, tutte versatili e debitamente laconiche, e apertissime alle inferenze del lettore. Espressioni insomma vagamente oracolari, concise e scontornanti insieme: che additano ad uno scarto rispetto ai libri precedenti dell’autore, e forse accennano (ma assai in aenigmate) a uno scavalcamento dei dominî specifici di prosa e poesia e allo squilibrio netto della narrazione in direzione di quest’ultima; ma perifrasi che pure – e anche quando non siano diventate formule abusate (come accade), o maniera collaudata per sbrigarsi da un’impasse, non soltanto classificatoria – pure sembrano aggirarsi, tra allarmate e reticenti, intorno a un nucleo di non detto.
Perché certo è reale la dilagata ‘verticalità’ della scrittura consoliana, la sua innegabilmente cresciuta e fortissima contiguità alla lirica; ma dacché poi sempre poetica è stata la pagina dello scrittore siciliano – cadenzata, assonanzata, rimata; e gremita di echi letterari, colta, rara, di lingua incantata – a voler marcare le differenze rispetto al passato bisognerà mettere da parte la retorica e puntare piuttosto al rasciugamento della lingua e all’accentuarsi della contrazione testuale (della ritrazione autoriale); e dunque al modo ampiamente scorciato ed ellittico, allo ‘spasimo’, che è del periodo e del racconto.
Il mutamento, tuttavia, era annunciato. A guardare indietro, gli indizi stavano nell’acuirsi di un disagio peculiare in Consolo: se vogliamo in una sorta di insicurezza, una perenne quasi scontentezza delle strade già percorse, spesso anche ritentate, ma poi dismesse, accantonate; e in una crescente palpabile desolazione, nella fatica strana della penna. Le avvisaglie erano nei lunghi intervalli tra i libri tutto sommato pochi di questo autore che disperatamente e attardatamente ancora, nel pianeta ignorante e immorale, nel mercimonio globale, si ostinava a voltare le spalle al mercato e a voler fare Letteratura, a voler essere artista e scrittore ‘impegnato’, ‘civile’: un affabulatore, un incantatore, epperò al tempo stesso l’intellettuale utile ad arginare, curare, denunciare: magari a prevenire e a impedire il dolore del mondo, come insegnava una bellissima utopia di Vittorini. Le tracce si leggono nel succedersi dei testi: distanti uno dall’altro non solo cronologicamente, ma veramente poi ognuno a suo modo, nella lingua e nello stile: ogni volta a riprovare la forza della scrittura per piccoli aggiustamenti o inversioni di rotta o a furia di rimaneggiamenti; e con esiti più o meno felici, opachi o splendidi, ma forse, al fondo, con sempre meno entusiasmo. E stanno, le tracce, in una oscillazione tra due poli, nell’opzione combattuta – d’un tratto nettamente divaricata e poi stranamente mischiata, impazzita o violentemente turbata – tra ‘scrivere’ e ‘narrare’, tra certe punte aride, cronachistiche, e un progressivo spostarsi o arroccarsi nella zona della ‘espressione’. E vogliamo dire che il mutamento è andato al passo con l’approfondirsi di una riflessione (o di uno scoramento) che ha una radice antica, se è vero, come sembra a noi, che è dallo squieto interrogarsi del Sorriso dell’ignoto marinaio (1976), dall’assillo della ‘scrittura-impostura’ (ornamento, fiore bizantino, e comunque voce di secondo grado sempre: sempre finzione), se da quel tarlo discende il «rimorso» dello Spasimo. Un «rimorso» che Consolo ha affrontato per gradi, da Catarsi (1989) e Nottetempo casa per casa (1992); e poi ha scandito in due tempi, nell’Olivo e l’olivastro (1994) e qui, nel testo ultimo. Ci ha messo due libri per dircelo o per dirlo a se stesso, e lo ha fatto senza più volute e riccioli e sontuosità barocche, togliendosi la cifra così sua e spettacolare di fasto e di vertigine, elidendo la bellezza. E non perché lo Spasimo non sia bello, al contrario. Ma se nessuno dei testi di Consolo è facile, più degli altri è difficile questo: che porta il nome di un quadro della Passione, di una chiesa votata alla rovina, di un affanno che tortura, di «uno scatto di tendini e nervi» per «allucinato dolore»[1], e che come un dolore è difficile; come la dichiarazione di una colpa, come la confessione di un fallimento, è faticoso.
E davanti a questa scrittura quasi impossibile da realizzare e da sopportare – tutta a risalti e rilievi di pena, terremotata nella sintassi, smagrita nella lingua e nelle immagini, e tenace nella volontà di tormentare se stessa – chiudere la vicenda e frettolosamente siglarla con l’apparentamento spesso meccanicamente ripetuto con la lirica e i suoi «ardui approdi» o i suoi «silenzi», è quasi un non voler guardare, pare il tentativo di aggirare e di scansare il silenzio verso cui davvero Consolo si è mosso (e quanti ‘addii’ ci sono in questo libro?). La storia poi è sempre uguale. Sembra, come davanti al Tramonto della luna di Leopardi, di trovarsi di fronte a un eguale imbarazzo della critica, al non voler prendere atto – allora come adesso – di una messa in liquidazione.
Quando troppo sbrigativamente si afferma che la pagina di Consolo s’è fatta più vicina ai silenzi della poesia, l’impressione è che più sotto ci sia una questione semplicissima ma essenziale di cui si tace, quella di una scrittura che non vuole più incantare. Dov’è infatti la lingua che gremiva ed affollava Lunaria (1985), la «parola suavissima», la «notte di Palermo» («Nutta, nuce, melània / […] deh dura perdura, […] non porgere il tuo cuore / alla lama crudele dell’Aurora»; LUN, 13-14)? Che fine ha fatto la Luna?
Era «lucore», «faro nittinno», «fiore albicolante», la Luna: e cadeva, certo, nel sogno di un malinconico Viceré, come in un sogno famoso di Leopardi (Frammento XXXVII); e veramente pioveva giù dal cielo, lentamente in garze si sfaldava, spariva, moriva, lasciava in alto solo vacuo nero, vuoto. Ma poi dopo, in una Contrada senza nome, in un luogo che aveva conservato le parole antiche, la memoria, magicamente si ricomponeva, bianchissima risorgeva; e favolosamente rifaceva il sipario della quiete, l’inganno del cuore, la malìa, il «sogno che lenisce e che consola», la Poesia.
Per i poeti è un indicatore importante la Luna. Che pure nello Spasimo compare, però fugacemente, e per tre volte. La prima, in una rammemorazione, un idillio accennato e appena bruttato del tempo dell’infanzia. Lei piena ed aprilina splende, e la luce e la sua bellezza spande sopra il mare, il paese, i pesci che vengono a galla affatturati; e sopra un corpo massacrato, un morto ammazzato (SP, 15)[2]:
Era luna lucente in quell’aprile, gravida, incombente, notte di soste per anciove e sarde, di barche sui parati, di lampare spente, e conche d’ombra ai platani, alle palme. Urlavano donne in cerchio sulla piazza, alzavano le braccia. Era al centro il corpo steso e morto del Muto che pittava sulle prore sirene draghi occhi apotropaici. Il sangue cagliava e s’anneriva torno alla testa disgranata e pesta, al torso, al ventre.
È soltanto un momento, forse istintivamente canonico (ricorda un modo montaliano, o intimamente leopardiano : «E tu dal mar cui nostro sangue irriga, / Candida luna, sorgi […]»): una rapida incarnazione dell’indifferenza – e però c’è quasi una malignità sottesa in quel suo incombere di «gravida», che ce la mostra sovrastante, alta, e minacciosa di cascarci addosso, tutta peso.
Più inquietante è la seconda messa in scena lunare, con il protagonista dello Spasimo che si aggira tra i barboni di Milano, ma il luogo potrebbe essere una qualsiasi metropoli con la sua risacca di rifiuti e di degrado, col suo moderno paesaggio di rovine (SP, 70-71):
Stanno nel tempo loro, nell’immota notte […]. Proni, supini, acchiocciolati contro balaustre, muri, statue che in volute di drappi, spiegamento d’ali, slanci fingono l’estro […]. La luna imbianca groppe, balze, il gioco delle mante. Da dove giungono questi pellegrini, quale giorno li vide camminare, eludere dogane, quale raggio scoprì crepe, frane, il velo sopra l’occhio, la patina sul volto, i segni bassi della differenza? Sono gli stanziali dei margini, le sentinelle della voragine […], il segno dello squilibrio ingiusto, del cieco brulichio, dell’ottusa prepotenza. La terrosa schiera, il canto o il silenzio delle rotte senza approdo.
Non ha sempre questa tonalità cupa lo Spasimo, questo colore impastato e vischioso, agglutinato nell’allucinazione: il brano è il rimaneggiamento di un testo composto per un catalogo d’arte, nel 1995[3]; e la tecnica del riuso (che sia recupero, tessitura, accostamento, incollaggio o inserimento spinto delle pagine già scritte, delle proprie vecchie, sparse e disparate cose) è una prassi di Consolo, pericolosamente frequente. Però torniamo alla Luna: Lei che
in un altro tempo era «virgilia», guida e «malofora celeste»; che lieve e greve, malinconica atra o candente, faceva germogliare le parole, leniva la pena, accendeva e affollava il teatro delle meraviglie. E invece adesso sta in un rigo ed è nome senza aggettivi: «imbianca groppe» – non schiene; «balze» – si dice di un rilievo topografico, una roccia, una collina, un cumulo di terra; «il gioco delle mante» di una statuaria desolante. È una cosa, questa luna: un trasudamento o un faro freddo; e pare un sudario, una mano spessa di calcina sopra una umanità cascante imbozzolata in stracci, tra teriomorfa e minerale.
La terza luna (SP, 98-9) sarà di nuovo un simbolo, e la ritroveremo più avanti; ma solamente in parte è quella antica. Perché alla fine è Lei (l’incanto, il sogno, la scrittura) il rimorso di Consolo.
Per fare chiarezza sugli elementi di novità dello Spasimo, proviamo a mettere a confronto due momenti della scrittura dell’autore, gli estremi temporali di una ‘controstoria’ d’Italia costituita da testi autonomi e scandita per epoche di crisi – segnatamente il nodo dell’Unificazione nel Sorriso dell’ignoto marinaio, gli anni dell’avvento del fascismo in Nottetempo casa per casa, e con Lo Spasimo di Palermo quelli dal dopoguerra fino ai giorni nostri, ai giudici ammazzati con le bombe. Specificando che la presenza decrescente di aulicismi e arcaicismi dipende dalla collocazione cronologica delle vicende narrate (dall’età del Risorgimento all’epoca attuale), e sottolineando che i nostri prelievi saranno necessariamente indicativi e non esaustivi, guardiamo dunque al Sorriso, che non è il primo libro dell’autore siciliano ma il testo in cui si palesa la sua cifra stilistica gremita e riconoscibilissima; e quindi allo Spasimo, che della trilogia sta a conclusione. Ne vengon fuori due lingue qualitativamente differenti (una vorticosa, l’altra indurita e come rastremata) e l’esistenza di due diversi tipi o gradi di complessità:
Parlai nel preambolo di sopra d’una memoria mia sopra i fatti, d’una narrazione che più e più volte in tutti questi giorni mi studiai redigere, sottraendo l’ore al sonno, al riposo, e sempre m’è caduta la penna dalla mano, per l’incapacità scopertami a trovare l’avvio, il timbro e il tono, e le parole e la disposizione d’esse per poter trattare quegli avvenimenti, e l’imbarazzo e la vergogna poi che dentro mi crescean a concepire un ordine, una forma, i confini d’un tempo e d’uno spazio, a contenere quell’esplosione, quella fulminea tromba, quel vortice tremendo; e le radici, ancora, le ragioni, il murmure profondo, lontanissimo da cui discendea? (SIM, 125)
Sùbito un murmure di onde, continuo e cavallante, una voce di mare veniva dal profondo, eco di eco che moltiplicandosi nel cammino tortuoso e ascendente per la bocca si sperdea sulla terra e per l’aere della corte, come la voce creduta prigioniera nelle chiocciole, quelle vaghissime di forma e di colore della classe Univalvi Turbinati e specie Orecchiuto o Bùccina o Galeriforme, Flauto o Corno, Umbilicato o Scaragol, Nicchio, d’una di quelle in somma vulgo Brogna, Tritone perciato d’in sull’apice, che i pescatori suonano per allettare i pesci o richiamarsi nel vasto della notte mare, per cui antique alcuni eran detti Conchiliari o Conchiti, onde Plauto: Salvete fures maritimi Conchitae, atque Namiotae, famelica hominum natio, quid agitis? E Virgilio … Ma che dico? Di echi parlavamo. (SIM, 142- 43)
Il primo prelievo è un campione di mìmesi linguistica accusata con posposizione del possessivo, soppressione di preposizione, elisione di articoli e preposizioni, enclisi, imperfetto debole in –ea, troncamento, e terna anaforica battuta sul deittico (quel /quella); il secondo è un esempio di fascinazione, una piccola cavata elencatoria nel ‘barocco’ di Consolo: un periodo che si slarga e si gonfia, che lievita e si espande; e che parrebbe poter continuare a crescere su se stesso divagando ad libitum, o svolgendosi in volute, a spirale, per tortili virate. Che sia assedio o amore di vertigine (o entrambe le cose), si direbbe che la frase sogna: per incidentali, relative, similitudini e apposizioni.
Questo invece è Consolo adesso, questo è lo Spasimo (SP, 25):
Nella libera vita, elusione di regole e castighi, nel crollo d’abitudini e costumi, rimescolio di stati, cadute di ritegni, privo d’imposizioni e di paure, della voce, dello sguardo che ordina e minaccia, solo con Aurelia, Chino visse, nel marasma del paese, nella casa saccheggiata in ogni stanza, nel dammuso e nel catoio, il tempo suo più avventuroso.
Nel libro lo scrittore impiega pressoché esclusivamente il punto e la virgola[4]: una interpunzione che spesso, o come qui, obbliga alla rilettura, dacché per comprendere il testo occorre trovarne il ritmo e la cadenza. Che non sono affatto intuitivi, ma sono questi:
Nella libera vita, [elusione di regole e castighi,] nel crollo d’abitudini e costumi, [rimescolio di stati, cadute di ritegni,] privo d’imposizioni e di paure, [della voce, dello sguardo che ordina e minaccia,] solo con Aurelia, Chino visse[, nel marasma del paese, nella casa saccheggiata in ogni stanza, nel dammuso e nel catoio,] il tempo suo più avventuroso.
Solo rileggendo, insomma, riusciamo ad impostare la voce, ad abbassare la curva intonativa accordandola al senso dell’apposizione, del non altrimenti segnalato inciso, della parentetica. E si guardi alla costruzione peculiare del brano riportato sotto (SP, 24), al disorientante paritetico allinearsi dei membri di una sintassi tra accidentata e scomposta; e al rallentamento musicale prodotto da punteggiatura e ripetizioni – e qui veramente, con una impostazione grafica diversa, semplicemente andando a capo ad ogni virgola, diremmo che si tratta di una poesia:
Lo strazio fu di tutti, di tutti nel tempo il silenzio fermo, la dura pena, il rimorso scuro, come d’ognuno ch’è ragione, cosciente o meno, d’un fatale arresto, d’ognuno che qui resta, o di qua d’un muro, d’una grata, parete di fenolo, vacuo d’una mente, davanti alla scia in mare, all’arco in cielo che dispare, di cherosene.
È una sorta di procedimento (sklovskiano) della ‘forma oscura’: vale ad aumentare la durata della percezione di un oggetto (uno scritto, una musica, una tela), quindi ad accrescerne la permanenza e l’impressione nella memoria rendendone impegnativa la decrittazione, impervia la comprensione. E può essere che Consolo ci stia sfidando con la difficoltà del testo, che voglia costringerci a restare su ogni pagina e a rileggerla finché non la teniamo a mente (nella memoria, appunto): finché sappiamo recitarla sentendoci dentro le pause, gli scatti, la curva della sua voce (della sua pena). Ma pure è forte il sospetto che Consolo dal lettore abbia già preso le distanze, e stia parlando con se stesso. E che la linea faticosa e ‘spezzata’ della scrittura sia un esteso correlativo oggettivo, o come la traccia di un cardiogramma, la mimesi di uno spasimo che si torce nella penna e spezza la voce, e che in tutto il libro sgrana e frantuma la fabula e il discorso. Perché questo non è il passo disteso di un narratore, non c’è mai quell’agio; e lo annunciava, in esergo del testo, il Prometeo eschileo :
«Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore» – che significa: ogni cosa mi fa male, parlare o tacere; lo si voglia riferire alla persona dell’autore o al protagonista del libro, Gioacchino Martinez.
Torniamo però al nostro confronto. Si potrebbe pensare, e in un certo senso è così, che prevalentemente semantica sia la difficoltà del Sorriso, nel quale, sebbene la narrazione non si svolga piana come in un romanzo tradizionale, resta maggiore la disponibilità al racconto; e che sintattica sia invece quella dello Spasimo, in cui la forma narrativa si contrae accentuando la tendenza a slogare un periodo solitamente paratattico che avanza come a gomiti, veramente si allarga a spigoli, slontanando soggetto verbo e oggetto (normalmente invertendo in iperbato l’ordo naturalis) a mezzo di colate appositive. Ma si tratterebbe appunto di una verità parziale, poiché la complessità sintattica è anche un fatto, per quanto non il prevalente, del Sorriso (SIM, 143-144):
Prendemmo a camminare in giro declinando. Sul pavimento a ciottoli impetrato ricoverti da scivoloso musco e da licheni, tra le pareti e la volta del cunicolo levigate a malta, jisso, a tratti come spalmate di madreperla pesta, pasta di vetro, vernice d’India o lacca, lustre come porcellane della Cina, porpora in sulle labbra, sfumante in dentro verso il rosa e il latte, a tratti gonfie e scalcinate per penetrazioni d’acqua, che dalla volta gocciola a cannolicchi càlcichi, deturpate da muffe brune e verdi, fiori di salnitro e capelvenere a cascate dalle crepe: luogo di delizie origine, rifugio di frescura pel principe e la corte lungo i tre giorni infocati di scirocco, come le cascatelle della Zisa, i laghi e i ruscelli a Maredolce, i giardini intricati di bergamotti e palme, le spalle a stelle di jasmino, trombette di datura e ricci d’iracò, le cube e le cubale dei califfi musulmani, o come le fantasie contorte d’acque sonanti e di verzure, di pietre e di conchiglie dell’architetto Ligorio Pirro pel Cardinale D’Este.
Tutto questo, addio […].
Introdotta da un periodo breve, fiorisce gigantesca su un imprendibile complemento di luogo la frase nominale che fra chiasmi, allitterazioni e paronomasìe procede in corsa, balza in avanti a cascata gonfiandosi di immagini, aprendo ovunque rivoli, spandendo i suoi tentacoli, ingoiando le cose e generandone poi altre, e inarrestabilmente gremendosi, affollandosi. Ma è un procedere, una estroversione: tagliata in barocco, certo; e al fondo e in superficie è ansia: attorcigliata, srotolata o esplosa, è sempre la solita danza su baratri e sbalanchi, una frenesia di copertura, la maschera sul vuoto: infine una modalità del tragico: un movimento disperato e affannoso, si sa, e incantatorio anche: sforzato e lanciato all’infinito come se questo dire-toccare-accumulare fosse prendere e fermare le infinite cose, o salvarle e salvarsi; però resta un movimento verso fuori. Non è quello introvertito dello Spasimo: del periodo che si sfonda o si incava, che si avvolge e rifà all’indietro la sua spira; e non ingoia le cose, gli oggetti, il mondo, ma se stesso. Si ponga attenzione a questa ipotassi (SP, 52 – la messa in evidenza è nostra), alla parentetica che si dilata tra il soggetto (alla fine della frase) e il suo complemento (all’inizio della proposizione):
Ma anche per lui, per il padre, che pure della sciagura voleva parlare al figlio, dire finalmente, spiegare, e ora che partiva, ritornava laggiù, nella sua isola, ora che dal figlio di più s’allontanava, da quel fuggiasco costretto nell’esilio, la presenza di Daniela era opportuna
Il prelievo, poco illuminante a livello contenutistico, è esemplare dell’andamento macroscopico del racconto.
Lo Spasimo è la storia di un viaggio dalla Sicilia alla Sicilia, via Parigi e Milano. Consolo narra in terza persona, perlomeno prevalentemente; ma sembra che parli di sé. Gioacchino Martinez è uno scrittore invecchiato che non scrive più perché alla propria scrittura non crede. È un padre che si accusa di non aver saputo salvare il figlio dal disastro di una ideologia manipolata, degenerata poi nella violenza degli ‘anni di piombo’; e a Parigi, nell’ennesimo viaggio verso quel figlio con cui non sa parlare e che poco gli parla, da una fotografia sulla parete di un albergo, inizia a ricordare: l’infanzia sull’isola, lo sbarco degli americani nel ’43, il rifugio suo di bambino: il «marabutto», il posto per starsene lontano, col mondo tutto fuori, a immaginare; e il padre lì viene ammazzato dai tedeschi, e forse per colpa di Gioacchino. E ricorda, Martinez, l’amore per la sposa luminosa e fragile, Lucia; la casa di Palermo con lei e il figlio: l’oasi di una vita chiusa tra gli affetti e la scrittura, nel riparo di quelle mura, difesa dal bellissimo giardino; e poi le piante scerpate e avvelenate, la mafia che con le bombe si prende quella terra per lucrare sul cemento e i condominî; e quindi la fuga dalla Sicilia, il viaggio verso Milano pensata umana e civile ma in breve divenuta un altro luogo di terrore e spari, e poi, craxiana, fatta teatro di ogni mercimonio, della volgarità più oscena. E dopo, l’impazzire e il morire di Lucia, il figlio accusato di terrorismo che si rifugia in Francia, i tanti viaggi tra Parigi e Milano; e prosegue la storia fino al ritorno di Gioacchino a una Palermo incancrenita, dove lo scrittore muore, salta per aria nell’attentato a un giudice che assomiglia a Borsellino. Questa, per amplissime linee, la vicenda del libro.
Ma non sappiamo dire, con la straordinaria sicurezza che pure è di qualche interprete, che ‘equivocheremmo’ qualora sovrapponessimo le voci e le figure, se insomma scambiassimo l’afasia di Martinez per una possibile (o temibile) afasia di Consolo[5]. Perché in realtà ci pare che sia proprio di Consolo il rifiuto o l’impossibilità di scrivere del tragico protagonista dello Spasimo – una impossibilità che, per questa critica lontana dal dubbio, varrebbe a registrare «un dato antropologico e sociale» nella generalissima questione (almeno così capiamo noi) del senso della funzione intellettuale oggi.
Certo non intendiamo appiattire lo Spasimo alla dimensione esistenziale dell’autore: la separazione tra l’io che vive e l’io che scrive c’è sempre, innegabilmente; e la finzione, l’invenzione, è la condizione di qualunque narrazione, anche autobiografica. Ma pure se non sapessimo nulla di Consolo, anche se non riconoscessimo opaca in queste pagine un’esperienza sua reale, comunque, davanti all’opera che mette in scena uno scrittore che dichiara l’impasse, e con fatica e con durezza ogni volta torna sul proprio fallimento, che le proprie parole sente false e della propria scrittura recita il mea culpa – non potremmo non pensare che chiunque sia l’autore, in qualche modo stia parlando di sé, del suo rapporto con la Letteratura. E a maggior ragione nello Spasimo, che di tutti i testi di Consolo è veramente il più ‘sovrascritto’ dacché qui la «metrica della memoria» – lo sfondarsi della pagina e il precipitare suo in verticale per il sovrappiù di senso di cui la caricano le voci della Letteratura (e sono tante: Omero, Dante, Cervantes, Tasso, Manzoni, Leopardi, Verga, T.S. Eliot, Vittorini, Montale) – è anche e principalmente memoria fortissima di sé, dei propri libri, di una storia letteraria personale e vera che costantemente richiama se stessa e si mostra per lacerti, accenni, rinvii: da Un giorno come gli altri a Le pietre di Pantalica a Catarsi all’Olivo e l’olivastro.
Neppure sappiamo dire con certezza se lo Spasimo debba chiamarsi romanzo, antiromanzo, o narrazione poematica; e potremmo aiutarci specificando che è insieme tragedia, confessione, racconto del viaggio, o dell’esperienza, oppure un’espiazione, e un addio. Ma la questione dei nomi poi non muta la sostanza dell’oggetto: di questa che è (e rimane) una prosa, con le sue fortissime vibrazioni o fibrillazioni liriche; e che narra una storia, per quanto destrutturandola – con tristezza o con violenza, con qualche esibita trasandatezza, forse con una strana sprezzatura. Lasciamo quindi la definizione esatta dello Spasimo ai catalogatori esperti, ai teorici della letteratura; e in fondo anche ‘romanzo’ può andar bene poiché il genere, elasticissimo, è per natura aperto a tutti gli attraversamenti, a ibridazioni e contaminazioni[6]; e l’avversione al romanzo, ormai più volte espressa da Consolo, è una polemica nei confronti del suo attuale scadimento, una provocazione e una dichiarazione di non-omologazione al mercato cultural-editoriale che di tale ‘etichetta’ costantemente abusa, amalgamando strame e opere di Letteratura[7]. Ma indipendentemente dalle nostre incertezze classificatorie, e pure dal fatto che Consolo, dopo lo Spasimo, abbia realmente scritto oppure no (e a quasi due anni dalla sua scomparsa, ancora non vien fuori L’amor sacro, il «romanzo storico-metaforico» (sic) che egli stesso annunciò finito)[8] comunque non crediamo di sbagliare affermando che lo Spasimo di Palermo ha il modo di una parola ultima. E che è difficile per chi lo legge perché è difficile per chi, disperatamente, lo ha scritto.
La disperazione, insieme alla diminuzione di sé, è un tratto distintivo di Consolo: racconta una pena reale, crescente, e ossessivamente presente nell’ultima sua produzione – si guardi, prima che al massacro pervicacemente operato da Gioacchino Martinez nei confronti di se stesso e della propria scrittura, all’odio di sé che già nel 1989 si sbozzava nei toni gridati enfatici dell’Empedocle di Catarsi (lo scienziato-poeta impazzito per la falsità che sente dentro le parole – anche le proprie – e il cui «odio verso il mondo è pari all’odio per se stesso, pari al suo dolore, al suo rimorso»; Cat, 58), o allo svilimento a «infimo Casella», a
«eroe patetico» che è nell’Olivo e l’olivastro (OO, 107). Dentro c’è la coscienza della «cavea vuota», il senso di parlare «arditamente» – e a Consolo dové parere ‘teatralmente’ – al niente; forse il timore di perdersi nell’alessandrinismo, nella tentazione dell’ornato o nel vaniloquio della parola bella; e anche quello di scadere nella querimonia, nell’infinito lamento del vecchio che si sente escluso, estromesso. E con tutto il valore estetico morale e civile di cui sempre ha considerato depositaria e custode la Letteratura, Consolo deve aver fatto fatica a non smarrire il senso del proprio lavoro, la spinta del proprio scrivere, del suo ostinarsi ad additare dei valori al nostro tempo di ignoranze, di coscienze assordite ed avvilite, ottuse. Probabilmente nello Spasimo è il peso del disinganno che spezza e sgrana il racconto, che blocca il farsi del romanzo, della storia levigata e ‘tonda’; pure se indubbiamente esiste (e sarebbe fuorviante escluderlo), insieme al bisogno (ancora) di dire una parola ‘utile’ al mondo, il desiderio di misurarsi (ancora), di sperimentare la via diversa, il taglio che magari incida la corazza dell’indifferenza mentre attinge un risultato alto, una compiutezza di stile. Meno cesellata e preziosa è la lingua dello Spasimo (come già quella delle Pietre, dell’Olivo) rispetto alla voltura ricchissima, alla esuberanza vertiginosa e tortile cui ci aveva abituato la penna dell’autore siciliano; ma liricamente tesa, musicale per assonanze e rime interne, resta una partitura ritmica; e si presenta più facile all’approccio lessicale, porta i segni di una nuova asciuttezza, quasi la tendenza a una semplificazione che in qualche modo va a bilanciare il tratto singolare, internamente terremotato della struttura. Ma la questione è complessa, se la distanza dalla voce antica è aumentata progressivamente, disegnando e chiarendo un movimento, più che di distacco, di rigetto.
Mancano allo Spasimo le pezze d’appoggio del Sorriso, i documenti veri o contraffatti del romanzo di stirpe manzoniana misto di storia e d’invenzione; gli manca l’ironia, anche amara; e la quinta di teatro, la metafora di un tempo altro. Non ci sono i fatti del 1860 o gli anni Venti di Nottetempo per dire ‘in figura’ le cose di oggi, perché siamo nell’oggi, e la Storia non si esplicita per nomi e date, ma sta inscritta nella scena metropolitana o nell’iconografia stringata di una terra rovinata e guasta; e si aggruma ad ogni passo del racconto, lo incide di veloci apparizioni e di rumori (il traffico, gli spari, certi improvvisi boati) orientando e dirigendo la vicenda. E indubbiamente la narrazione mai facile di Consolo qui si fa più sussultoria dacché sfronda e scolla pesantemente la trama fino a darcela esplosa, confondendoci. Spesso, in un unico capitolo, passato prossimo e remoto (Milano e la Sicilia), il presente degli eventi (all’inizio Parigi, Palermo poi) e quello perenne di incubo e dolore stanno insieme: per paragrafi staccati, sì: epperò uno via l’altro e per continui salti, sempre in assenza di segnalazioni o di appigli che dicano chiari i tempi e i luoghi; e anche qui, per capire, siamo costretti a tornare indietro, a rifare la lettura. Pare sconnessa l’architettura, franata[9]. Che sia ormai insofferenza dell’invecchiato autore, sfida orgogliosa a un uditorio assente, fretta o voglia di finire, l’opera somiglia a un disegno impazzito: e costantemente pasticcia la sua struttura, la svisa, la fa sghemba: quasi a voler mostrare che la mano non sa (o non vuole) più reggere i fili di una compiuta fabula, che sta cedendo – ed è vero – alla stanchezza. Ma a guardar bene, il disegno di Consolo è tutt’altro che confuso: lo Spasimo è un congegno ben pensato, tagliato e montato per frammenti, tra analessi e prolessi, flashback e anticipazioni; e mentre gradualmente rivela la sua tramatura di ‘simboli’ (sono figure equivalenti il giudice, il padre, lo scrittore; e tutti i luoghi del rifugio – o della viltà – sono la scrittura) mentre che pare disperdersi o costruirsi quasi casualmente, si serra a cerchio intorno alla vicenda che si snoda nel presente: un’azione che si interrompe già alla seconda pagina del primo degli undici brevi capitoli del libro; che torna a svolgersi, si chiarisce e (provvisoriamente) si conclude tra il terzo e il quarto, che ancora si blocca in una rammemorazione e riprende poi a scorrere dal nono capitolo fino alla conclusione del testo. È insomma il racconto di un viaggio di ritorno che comincia in medias res, ritrova il suo principio per tornare poi al passo col presente, secondo uno schema antico, omerico. E veramente Consolo ha riscritto un’Odissea, dal tempo dell’Olivo e l’olivastro: però nei modi sgangherati e tragici e con le afonie di un cantore moderno.
Iperbati, anafore, assonanze e rime interne sono frequenti nello Spasimo; consueta è la cadenza degli endecasillabi e pure di senari, settenari, ottonari e novenari mascherati e fitti nel tessuto della prosa: ma è un dato acquisito che ritmi e procedimenti topici della poesia da sempre contraddistinguano la pagina di Consolo. Lirica è la pagina iniziale, quasi una protasi, amara e splendida; lirico e commovente l’addio alla donna morta; e veramente mirabile (un gioiello da antologia) l’addio a Milano (SP, 93-4) così lucido e fermo e dolente (e quanta vita, quanta fede letteraria, quante cose ci sono in questo addio fatto di luoghi di persone di scrittori di poeti) ma che poi cambia il tono suo pacato, si gela e si strozza in una maledizione, in uno sputo – ma potremmo continuare a lungo. E sporgenze, affacci e approssimazioni ai modi della lirica stanno nelle aggettivazioni, parche e però puntute, folgorate, tutte rapprese; e nelle inserzioni citazionali di versi, nelle incongruenze sintattiche violente, in certa fortissima icasticità di dettato; e nei cataloghi dei nomi che adesso non sbocciano fastosi ed opulenti e non si affoltano in vorticosa danza a coprire il vuoto, ilaro-tragici e infebbrati di vertigine, ma in quello cascano o colano gravi, disanimati e nudi. Resta colta e non omologata la lingua di Consolo, però si è incrudita: non gronda più umori densi o olii soavissimi, non si espande per volute, non ricama i suoi vecchi e splendidi arabeschi, ma vuole incidere e pesare, come una pietra: a tratti si fa rasposa per asciuttezza e sempre ha in gola una dissonanza aspra, una caduta, uno stridore, la disarmonia che spezza l’illusione la malìa il lenimento del canto (la tentazione dell’incanto). Per distillazione e smagrimento, per erosione si è rappresa in una bellissima economia verbale che coniuga torsioni incongruenze e lapidarietà sintattiche allo sfondamento in profondità e in espansione, all’appiombo verticale della parola poetica. Ma veramente quel che più rileva e fa la differenza, rispetto al passato, di questa lingua sfrondata, è l’ispessirsi delle sue zone di silenzio: tanti sono gli spazi bianchi che si aprono fra i capoversi o fra i paragrafi staccati; e le virgole, anche ravvicinatissime, che spezzano il fluire del racconto, isolano segmenti quasi versicolari: sono pause che si leggono come se ci fosse un salto d’aria in mezzo, come gli ‘a capo’ della poesia. E questo ispessimento deriva dal ricorrere di un procedimento che appunto porta in sé il silenzio perché implica un margine di non detto, di non spiegato: l’ellissi, che è il vuoto su cui rallentiamo, ci fermiamo; che siamo chiamati a interpretare, o di cui dobbiamo prendere atto.
Elide i nessi Consolo, spesso la consequenzialità narrativa; avanza per associazioni sue, per saltum, e sembra (voler) perdere il filo, o volerlo ingarbugliare a noi. Agisce ellitticamente quando ci confonde sovrapponendo le maschere, le personae in cui si scorpora e parla la voce narrante (io, tu, egli: nello Spasimo è lo stesso); o quando proditoriamente ci spiazza nel giro di una frase o di un capoverso con una posposizione che è un repentino cambio del soggetto (SP, 26):
Ricominciò a poco a poco a frequentare l’intrico dei vicoli dietro la sua casa, il quartiere tra la chiesa e la piazza di fondachi e di antri, casupole col mulo nella stalla, carretti ad aste all’aria, gabbie d’animali, buffette di scarpari, forge fumose, fermenti grassi, fioriture d’untumi, afrori da porte e lucernari, lippi e limaglie tra i ciottoli, ai bordi dello scolo. Sulla soglia, mischiavano le donne vasellina e zolfo per la rogna. Si negava a quel meandro in ogni tempo, come posto dentro una caverna, sotto perenne nuvola di cenere dell’Etna o sabbia del deserto, il sole che nelle cadenze, nel giro naturale temperava questa fascia del mondo, governava i giorni, le stagioni.
Ellittico è il discorso in cui tutte le parole funzionano come una stenografia e hanno dentro un’eco, allargano e sfondano la pagina col peso; ellissi è l’accostamento straniante dei frammenti, oppure l’omissione del verbo, o il comparire suo con impressionante ritardo (è la prassi con cui Consolo sistematicamente ci disorienta) come nel fraseggio apparentemente nominale in chiusura di questa pagina che riportiamo intera ad esemplificare in sequenza quanto appena detto (SP, 42-3):
Oblio di tempo e luogo in quella sosta di ristoro, estraniamento, ritaglio d’un mondo prossimo e lontano, e Abdelkrim mostrò il tramonto, il vuoto intorno, significò la chiusura del giardino, delle porte.
«A demain, monsieur, à demain» il sorriso sul viso nobile, caprigno.
Ancora spinto dal caso, nel cieco vagolare, nelle luci e nelle ombre della sera.
Portavano i passi verso il luogo dov’era la ragione del viaggio, del suo persistere nel mondo, verso quell’uomo esplicito e sfuggente, quel figlio che si negava a ogni confidenza, tentativo di racconto, chiarimento.
Furtivo avanti la libreria a spiare nella sala fumosa e affollata, lui con altri al tavolo, sorridente e ironico, accanto al profetico scrittore riccioluto.
“Piangevi per le nuvole, pei tuoni, ti stringevi a me forte, le nule le nule – lamentavi –, t’ostinavi a contare le stelle, a scovare le cicale, dicevi del veliero sopra il Monte, dei fuochi sopra l’onde, e lei che ridendo più in dentro ti spingeva nelle fole.”
Dentro frotte, masse, che non credea non credea che tante, notturne e inebetite, per viali passaggi impasses, angoli scuri, insegne lampeggianti, video e ordigni sessuali, negre maestose e vecchie consumate, club, guardiani ch’afferrano pel braccio, spacciatori, giovani piegati e barcollanti, uno stordimento, un fiume trascinava, in fondo, fino alla foce calma, alla penombra sotto un arco, ombre immobili e scorrenti.
Il periodo in apertura della citazione mostra due maniere allineate: quella nominale («Oblio di tempo → lontano») e quella predicativa («e Abdelkrim → delle porte»); elidono i verbi
«A demain → caprigno» (e ci lampeggia dentro Saba), «Ancora spinto → della sera», «Furtivo avanti→ riccioluto»; e sono modi scorciati e rappresi, intervallati dall’ordito più tradizionale di «Portavano → chiarimento» (con le anaforiche riprese melodrammatiche e l’euritmia retorica della terna sinonimica in chiusa) e dal frammento di sapore pascoliano
«Piangevi → fole».
In questo contesto, l’eliotiano-dantesco «Dentro frotte, masse → scorrenti», ci sembra immediatamente anch’esso privo di predicato; ma è un’impressione indotta dalla sintassi che procede centripeta tra slogature e agglutinazioni, per membri sbrancati. Il periodo infatti ha
«fiume» per soggetto, «trascinava» per verbo, «ombre» come oggetto e tre complementi di luogo: «dentro», «per» e «fino»; il primo («dentro») complicato dalla citazione che dovrebbe contenere e riportare il commento del protagonista Gioacchino, di cui il libro narra in terza persona; e che però innesta un ulteriore effetto di sbandamento per l’ambiguo sovrapporsi di soggetto narrato e voce narrante, e forse per l’improvviso baluginare o il chiarirsi della identità delle personae grammaticali, di egli-Martinez e di io-Autore-Consolo, dacché l’imperfetto debole credea indubbiamente vale per entrambe le persone, terza e prima; ma appunto la memoria dantesca ed eliotiana (e sono presenze capitali nello Spasimo) generano o rivelano la ‘confusione’; e istintivamente leggiamo come se a parlare fosse la prima («e dietro le venìa sì lunga tratta |di gente, ch’i’ non averei creduto |che morte tanta n’avesse disfatta»; If, III, 54-57; «A crowd flowed over London bridge, so many, /I had not thought death had undone so many»; WL, 61-63; la sottolineatura è nostra).
Ad ogni modo, reputare omesso il predicato è un errore che Consolo ci spinge a compiere. O meglio, lo commettiamo perché lo Spasimo ha una orchestrazione sinfonica, una sua musica: l’autore prende un tema, cambia strada, lo lascia, e poi a distanza, magari dopo molti altri toni e altri motivi, ci ritorna, lo riprende, lo continua. A rigore infatti, nel caso appena esaminato, Consolo sta continuando un ‘tema’ precedente, e ad essere più precisi avremmo dovuto parlare della elisione di un avverbio o di un periodo (o di una serie di periodi) che stanno due pagine prima di quella citata: «Via fino al Quais des Célestins […]. Via da quella zattera di pietra […], dentro borghi, strade, piazzette di dimenticanza, bistrots e librerie, volumi aperti su pagine istoriate, inchiostri multicolori, scrittura ondosa e sibillina. Quindi davanti al muro bianco, alla cupola smagliante, al minareto della moschea» (SP, 40); ma potremmo anche fare come se fosse sottinteso il «girovagò» dell’inizio del capitolo (è lontanissimo, a pagina 33); oppure, veramente, ‘andava’: perché il continuo e affannoso movimento, il desolato e interminabile peregrinare è un motivo che ritorna (ma ce ne sono altri: la colpa, il rimorso, il rifugio, l’addio), una nota dolorosa che lo Spasimo (questo libro che racconta un viaggio) perde e poi riprende. E ‘andava’ sarà il predicato saltato più avanti, in un diverso tempo e luogo della vicenda, a Milano anziché a Parigi; ma il modo ellittico – la ripresa del tema che compare a distanza, come fosse un refrain, in pagine differenti – è analogo a quello indicato in precedenza:
«Andava nell’ora antelucana per la città ignota, per vie, larghi senza nome, per scale, passaggi pedonali, nel neutro lampare dei semafori. Gli egri ippocastani attorno al monumento marcivano le bacche […]» (SP, 69).
E dopo altri coagulati motivi, altri rappresi pensieri (la fiumana del progresso, il Gran Ballo Excelsior, Verga che torna in Sicilia, gli scontri degli anni ’70 a Milano) ‘andare’ torna in anafora (SP, 70) in un altro capoverso:
«Andava in quel crepuscolo, fra lo sbarramento di portoni, di serrande, nel giallo dei fanali, nel vuoto, nell’arresto mattutino. Guardie infilavano i biglietti[…]»;
E più giù, dopo la descrizione della città desolata, la comparsa in scena di Manzoni[10], l’apocalissi dei barboni (questa pagina, che in parte abbiamo citato, staccata dal racconto, separata e chiusa tra due spazi bianchi) lontano insomma, ma ancora eliso, sottinteso, c’è il predicato, ‘andava’:
«Dentro il fitto intrico della cerchia e la curva larga in cui nei muri, negli accessi, erano ancora i segni del Naviglio» (SP, 71).
E muovendoci anche noi per salti, arriviamo all’avvio del testo, che è prologo o protasi o una specie di ‘a se stesso’, o un ‘a parte’: leggiamo l’incipit della scrittura «poematica» dolorosa e franta, l’inizio del viaggio (SP, 9):
Allora tu, i doni fatui degli ospiti beffardi, l’inganno del viatico, l’assillo della meta (nella gabbia dell’acqua, nella voliera del vento hai chiuso i tuoi rimorsi), ed io, voce fioca nell’aria clamorosa, relatore manco del lungo tuo viaggio, andiamo.
Ma più indietro – ché questo libro è un perenne ritornare di Consolo su di sé, sul suo mestiere, i suoi libri, la sua funzione di scrittore – c’è l’andare, il fermarsi, lo scendere, l’entrare, il correre del reduce «patetico» e «smarrito», del viaggiatore disperato di una Sicilia perduta: c’è l’odissea spezzata e fallimentare dell’Olivo; e Consolo doveva tornare su qualcosa che lì, con quel cammino, aveva incominciato a dire.
La parola «rimorso» sta all’inizio e alla fine dell’Olivo e l’olivastro; poi compare (ed è un indicatore di rotta) nell’avvio dello Spasimo; e in realtà sono numerose e tutte rilevanti le occorrenze del termine in queste due variazioni tragiche sul tema della colpa e sul viaggio di matrice omerica, sull’impossibile ritorno a un’Itaca scomparsa.
Si chiama così L’Olivo e l’olivastro perché fra quegli arbusti, nell’intrico fitto e armonico di selvatico e coltivato, ripara Ulisse quando scampa al suo lungo naufragare e tocca un mondo solido, o comunque più solido del mare: Scherìa incantata, la terra dei Feaci. Al personaggio del mito Consolo dedica un intero capitolo (il secondo del libro) rendendo esplicito il parallelismo tra due viaggi che si svolgono nel testo, entrambi di ritorno, epperò segnati da esiti differenti. Perché se Odisseo alla fine del suo travaglioso peregrinare raggiunge Itaca, il protagonista dell’Olivo approda invece a un’isola mutata, devastata: una Sicilia sconciata cementificata incancrenita dannata, ormai dominio dei Proci, del selvatico soltanto, della barbarie. E certamente narra di sé, Consolo: a descrivere il disastro è un personaggio senza nome di cui parla in terza persona ma che in tutto gli somiglia. Prescindendo tuttavia in questa sede dal moltiplicarsi dei ‘giochi a nascondere’ (e qui gli specchi dell’autore sono tanti), ci interessa il carattere espiatorio del cammino dei due erranti: l’antico eroe greco e il moderno protagonista dell’Olivo accomunati dal «rimorso» (otto sono le occorrenze del lemma, solo a contarle da pagina 9 a pagina 28 del testo) e dunque dall’aver commesso una colpa. E però quale?
Ulisse è l’ideatore degli inganni, l’inventore dell’idolo di legno che nasconde nel ventre la morte feroce, le braccia armate che distruggono Troia; e lui che ha coltivato métis e techné per un fine letale (questa è la lettura di Consolo) è il più colpevole degli Achei ma pure l’unico a salvarsi. Non è il guerriero più forte, o il più degno, il più valoroso; e lo sa. Perciò è il più carico di rimorsi: quelli che dovrà affrontare (per una sorta di contrappasso) materializzati in mostri (Ciclopi, Lestrìgoni, Sirene, la «rovina immortale» di Scilla e di Cariddi); e prima ancora, quelli che deve propriamente confessare nella reggia di Antinoo: perché nello
«strazio» del racconto è l’ammenda per cui l’eroe è assolto (OO, 45); e questa specifica ‘catarsi’ è necessaria (dire, narrare, confessare la colpa) acché il ritorno in patria possa compiersi. Ulisse dunque piange e narra: «narra fluente la sua odissea […] diventa […] l’aedo e il poema […] il narrante e il narrato, l’artefice e il giudice, diventa l’inventore d’ogni fola, menzogna, l’espositore impudico e coatto d’ogni suo errore, delitto, rimorso» (OO, 19); e ne vien fuori una strana mistione di vero e falso, confusamente l’impressione che dentro il racconto si insinui e stia acquattata una simulazione, una menzogna di fatto imprescindibile; ma la questione (metaletteraria) della possibile «impostura» della scrittura (che è un assillo tipicamente consoliano) pare solamente accennata qui, nell’Olivo, e si svilupperà poi, dolorosamente, nello Spasimo.
Quanto all’autore che nell’Olivo dice di sé in terza persona – che in apertura del testo dichiara l’impossibilità a narrare («Ora non può più narrare») e tuttavia, in furia o in pianto, pure dietro una maschera, racconta – anch’egli porta una colpa: «con un bagaglio di rimorsi e pene » (OO, 9) lasciò l’Isola bellissima e terribile (lei che tra calcinacci e tufi, corsa dai randagi e abitata dai corvi, è già terra votata all’abbandono, pare fatta di polvere); e se ne andò via, lontano (lontano anche da quella ingombrante imbattibile Natura: rigogliosa o riarsa o minacciosa di lave e terremoti e sempre troppo imparentata con qualche Assoluto: sempre comunicante con l’inutilità del fare, con un impietramento, con l’oblio); via verso la Storia, il cambiamento, una vita di impegno, di lavoro; epperò adesso, dopo tanti anni, lo schiaccia un peso più gravoso e sono «rimorsi», ancora: ma «un infinito tempo» di quelli e di «orrori, fughe, follie, vergogne» (OO, 16). Sembra insomma accusarsi, Consolo: lui che dalla Sicilia partì per andare a vivere, per scrivere a Milano. Si accusa di essere fuggito – ma non crediamo che intenda semplicemente dall’Isola; piuttosto, ci sembra, di non aver fatto quanto andava fatto, o comunque non abbastanza per evitare la frana di una civiltà, di una cultura (ma poi che cosa può in concreto sulla vita, sulla Storia, per la manutenzione del mondo, la penna di uno scrittore, la parola della Letteratura?). E nello smarrimento e nella indignazione, per tagli, in un lunghissimo e angoloso plahn tra cronaca e poesia, veramente nell’Olivo Consolo corre l’Isola intera in un frenetico andare senza soste, con l’urgenza di dirla tutta e dirne lo scempio, quasi che nominare il male lo potesse veramente fermare, o come fosse a salvamento: di lei (Isola e cultura e Storia e mondo) e di sé, di un impegno civile, del lavoro di chi scrive. Però, dall’ira che a volte con fatica monta, e forse ripete le sue parole quasi uguali (pare infatti di stare come fermi, per quanto sempre ci si muova, in questo inferno), da un affanno che è nel dire e maledire, dal lamento continuato, dalla sintassi narrativa che si spezza e ti inciampa (e ti stanca anche, con qualche pesante monotonia) senti che si è incrinata, che è diventata disperata quella superstizione volontaria (o era la fede letteraria) antica.
Certo ha degli slarghi narrativi l’Olivo: a tratti prende la forma e il ritmo del racconto breve e incastona le vicende di nativi, reduci o pellegrini di Sicilia – e tutti come toccati dall’Isola, ammalati (ci sono Verga e Caravaggio, Maupassant, Zummo, von Platen, fra questi ulissidi incupiti o pazzi o moribondi); e pure Consolo continua una sua intenerita o storta e tragica Odissea. Ma il libro è principalmente la cronaca del viaggio dentro una ‘terra guasta’, tutt’altro che vittoriniana: offesa da ignoranza cemento liquami speculazioni e mafie, e chiamata – con l’attuale degrado e con la bellezza violentemente deturpata – a far da emblema di una devastazione in atto, del macroscopico processo che ovunque azzera e imbarbarisce le coscienze cancellando insieme Storia, memoria, umanità e cultura. Più avanti ci fermeremo sui luoghi di questo nervoso periplo siciliano che da Gibellina parte e lì ritorna così chiudendo il suo percorso irregolare e zigzagante: e tante sono le tappe, accomunate dallo stesso orrore, e generalmente articolate sullo schema del confronto, della visione sincronica di un abominevole presente e di un passato splendido e svanito. Però a Segesta, in cima al teatro, lontano dal rumore, dallo spettacolo della reliquia violata e offerta alle mandrie dei turisti distratti, lontano dalla scena in cui si compie simbolicamente una diuturna e commercialissima dissacrazione – a Segesta il viandante dell’Olivo si ferma e sogna; e come sempre accade a questo tristissimo innamorato dell’antico (o potremmo dire del lontano, del perduto) «prova sollievo nella fuga, nel rapimento» (OO, 127). Ma un’altra volta – la terza e ultima sta alla fine del libro – Consolo qui dentro dice ‘io’ (per quanto provi ancora a confonderci indossando un’altra maschera, di un altro ulisside).
Leopardiana al fondo, ma più cupa che in Retablo, è la contemplazione dell’architettura del tempio che si spalanca al cielo «come porta verso l’infinito o come pausa, sosta d’un momento, quale la vita dell’uomo nel processo del tempo inesorabile ed eterno» (OO, 128). E la voce che dice ‘io’ mentre che si smarrisce a guardare il tempio, la notte, le stelle, questa che adesso parla in prima persona (e forse sta ripetendo una cosa che era già dentro le Pietre di Pantalica), sta esprimendo un desiderio di fine, di morte (OO, 128):
[…] all’infinito spazio, mi pongo arreso, supino, e vado, mi perdo […] nella scrittura abbagliante delle stelle, dei soli remoti […]. Rimango immobile e contemplo, sprofondo estatico nei palpiti, nei fuochi, nei bagliori, nei frammenti incandescenti che si staccano, precipitano filando, si spengono, finiscono nel più profondo nero.
Lo stesso che torna nella pagina finale dell’Olivo, quando tra i ruderi, nel teatro allestito sul colle della scomparsa Gibellina antica, si recita un episodio della guerra romano-giudaica, un moderno adattamento della tragedia di Masada narrata da Giuseppe Flavio. Consolo è di nuovo dietro uno schermo, ma in qualche modo crediamo di riconoscerlo nel tono e nei gesti di questi assediati che scelgono di togliersi la vita (OO, 148-9):
Avanza dal fondo Eleazar, il comandante della fortezza, in mezzo ai soldati.
– Da gran tempo avevamo deciso, o miei valorosi, di non riconoscere come nostri padroni né i romani né alcun altro all’infuori del dio… In tale momento badiamo a non coprirci di vergogna…Siamo stati i primi a ribellarci a loro e gli ultimi a deporre le armi. Credo sia una grazia concessa dal dio questa di poter morire con onore e in libertà…Muoiano le nostre mogli senza conoscere il disonore e i nostri figli senza provare la schiavitù…
Narra una voce.
– Così, mentre carezzavano e stringevano al petto le mogli, sollevavano sulle braccia i figli baciandoli tra le lacrime per l’ultima volta, al tempo stesso, come servendosi di mani altrui, mandarono ad effetto il loro disegno.
Tirano poi a sorte chi di loro avrebbe ucciso i compagni.
E così l’ultimo, anche per l’orrore, il rimorso, rivolge il ferro contro se stesso.
I romani, con tute di pelle, con caschi, irrompono sopra motociclette, corrono rombando dentro le crepe del cretto, squarciano il buio coi fari.
Trovano corpi, fiamme, silenzio.
Lo «strazio» del racconto non è dunque servito al viaggiatore dell’Olivo per ritrovare la sua Itaca – mutata è l’isola: non si torna a un mondo che ha smesso di esistere. E l’ultimo soldato di Masada, che uccide i compagni per risparmiare loro il peggio che sicuramente verrà, può solo morire, si uccide. E può essere che il «rimorso» sia in questa resa, in questo abbassare le armi e rivolgerle contro se stesso, nel dovere alle fine ammettere che non c’è speranza o letteratura che tenga.
Guardiamo adesso le occorrenze del termine «rimorso» all’interno dello Spasimo di Palermo. Superato l’esergo eschileo, il testo si apre con una pagina in corsivo che è insieme fuori e dentro il racconto, e in certo modo è la sua chiave. Il nostro lemma è nel paragrafo iniziale (che abbiamo già citato), e tuttavia il proemio vogliamo leggerlo intero. Il tema è ancora quello del viaggio e della colpa, e il ‘tu’ dell’allocuzione non è il lettore (SP, 9-10):
Allora tu, i doni fatui degli ospiti beffardi, l’inganno del viatico, l’assillo della meta (nella gabbia dell’acqua, nella voliera del vento hai chiuso i tuoi rimorsi), ed io, voce fioca nell’aria clamorosa, relatore manco del tuo lungo viaggio, andiamo.
Solca la nave la distesa piana, la corrente scialba, tarda veleggia verso il porto fermo, le fantasime del tempo. La storia è sempre uguale.
S’è placata la tempesta, nella grotta, sulla giara sepolta s’aggruma la falda della spuma. Speri che il cerchio – stimme, macule, lèuci ferventi – quieto si richiuda. Ignora il presagio, il dubbio filologico se per te lontano o dal mare possa giungere. Il segreto che sta nelle radici, nel tronco di quell’albero non sai a chi svelarlo, è vuota la tua casa, il richiamo si perde per le stanze. Avanzi in corridoi di ombre, ti giri e scorgi le tue orme. Una polvere cadde sopra gli occhi, un sonno nell’assenza. Il fumo dello zolfo serva alla tua coscienza. Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza:
In the beginning is my end
Ma pure in questa cala urlano sirene, aggallano carcami, approdano navigli clandestini, l’alba apre il volo a uccelli di passaggio. A coppie vanno gendarmi e artificieri, a schiere anime disciolte, a volte si confondono voci volti vie porte d’ingresso e di sortita.
Ricerca nel solaio elenchi mappe, riparti dalle tracce sbiadite, angoscia è il deserto, la pista che la sabbia ha ricoperto. T’assista l’eremita l’esule il recluso, ti guidi la fiamma di lucerna, il suono della sera, t’assolva la tua pena, il tuo smarrimento.
Le marche letterarie forti, l’attacco, slogato in Consolo epperò riconoscibilissimo della Love song of J. Alfred Prufrock («Let us go then, you and I […]») e la memoria aggettivale dantesca (è Virgilio chi «per lungo silenzio parea fioco»; Inf., I, 63) operano già per accumulo, orientandoci contemporaneamente in due direzioni apparentemente divergenti ma contigue e sovrapponibili: un moderno girovagare metropolitano in assenza di senso, e un antico viaggio penitenziale; in entrambi i casi (considerata anche l’epigrafe ‘infernale’ di Prufrock: Inf., XXVII, 61-66) un viaggio nella desolazione, o comunque nel dolore; e a compierlo (almeno così sembra) due viaggiatori tristi ancora sfocati: un ‘tu’ con l’ansia tormentosa di arrivare – ha con sé i doni inconsistenti di ospiti che pare lo abbiano deriso e un viatico che non serve (è la provvista del pellegrino, o la benedizione che si dà ai morenti?): è un ‘tu’ che non ha niente e porta un peso, un carico di «rimorsi» che non gli è riuscito di chiudere da nessuna parte, dentro nessun bagaglio (gli fanno una bufera intorno, devono essergli esondati addosso, perché non ci sono gabbie o sbarre che tengano l’acqua, o che fermino il vento); e poi c’è un ‘io’ di voce «fioca», dice parole che non si sentono nell’aria strepitosa, piena di rumori: e non è nessun Virgilio (sbagliavamo): è un relatore insufficiente, uno che riporta, però a strappi e a brani – forse con poco talento («[…] mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono […].»; SP, 88) – il lungo andare dell’altro.
Qualcuno insomma stanco o forse vecchio (canonicamente «tarda veleggia» la sua imbarcazione) viaggia per qualche placato mare, metaforico o reale (nella «corrente scialba» sembra purgatoriale), naviga verso un «porto fermo», una quiete; e viene da pensare a quella definitiva, alla morte (indipendentemente dai ricordi letterari, che ci sono, cominciando da Petrarca e Foscolo) perché la metafora è semplice: il cerchio che il ‘tu’ spera si richiuda, che non ha ancora concluso il proprio giro e che contiene, come in un crogiuolo, quello che lo ha composto: piaghe e macchie, ma pure luci abbaglianti bianche e ribollenti, può essere la vita; e può essere che il viaggio sia della memoria, che il porto fuori da ogni scorrere, fuori dal mutamento, sia quello che è stato, il passato, i fantasmi – che a riguardarli rivelano una storia «sempre uguale», come fissata in una ripetizione. Pare finita l’erranza, e prende terra questa barca in un riparo, la grotta in cui affiora una «giara sepolta», lambita dalla schiuma – un relitto appropriato alla scena marina, o magari una memoria infantile, un pezzo di storia privata di questo reduce, che è inutile affannarsi a interpretare. Anche se rileva notare che il lemma «sepolta», nello Spasimo, torna due volte soltanto, e sempre associato ad una colpa («colpe sepolte e obliate», SP, 47; «colpa sepolta», SP, 98).
E diventa criptico il discorso rivolto al ‘tu’ dal suo cronista, si fa ellittico: «Ignora il presagio, il dubbio filologico se per te lontano o dal mare possa giungere». Manca infatti il soggetto della proposizione ipotetica: il «relatore manco» non dice cosa possa giungere «dal mare» (evidentemente, lui e questo ‘tu’ silenzioso condividono un codice, si capiscono benissimo), anche se per il lettore l’appiglio alla comprensione sta probabilmente nella figura precedente, nella metafora del cerchio che si chiude. Ma c’è un’indicazione, una traccia letteraria palese che aiuta a sciogliere la contrazione della scrittura mentre che ispessisce e complica la fisionomia del viaggiatore triste. Il «segreto che sta nelle radici» è quanto fonda e tiene la casa di Odisseo: il «letto ben fatto» (Od, XXIII, 189) che non si può spostare e che Ulisse scolpì solido nel tronco di un ulivo centenario («C’era un tronco ricche fronde, d’olivo, dentro il cortile, / florido, rigoglioso; era grosso come una colonna: / intorno a questo murai la stanza […]»; Od, XXIII, 190-192) – la radice è la casa: ciò che uno è, che ha costruito e che trasmette: la vita la storia gli affetti l’esperienza la cultura. Ed è la marca omerica a gettare luce all’indietro sul presagio, la profezia ambigua di Tiresia a Ulisse: la morte (perché era lei il soggetto saltato della proposizione) ti verrà εξ άλός (questo il «dubbio filologico»): «dal mare» oppure da fuori del mare, «lontano» da quello; anche se poi, per questo nostro navigante, solo dal mare la morte può arrivare dacché veramente per lui non c’è terra: l’Odissea è (come nell’Olivo) rovesciata, l’approdo è apparente, imperfetto è il ritorno e la casa è vuota: non c’è nessuno con cui parlare («il richiamo si perde tra le stanze»), nessuno a cui tramandare un «segreto» che non serve.
Forse sulla maceria, nel vuoto, in questa nicchia di niente, ora che non c’è più da andar per mare, affrontare la tempesta, ancora cercare; forse ora che non c’è neanche la rabbia inquieta della giovinezza, ora, nella vecchiezza, in questo porto abborracciato, si può provare a rifare la storia (nella memoria) a cercarne il senso o la crepa: ora che da dove si era partiti si è tornati, per finire. «In my beginning is my end», nel mio principio è la mia fine – e la citazione dai Four quartets di Eliot qui non significa nessuna trascendenza, non allude a nessuna rinascita: sta solo nella pars destruens, come un’epigrafe; ci sta rappresa un’incombenza: un’imminenza (la conclusione è prossima, è vicinissima) e una necessità (l’impossibilità di una conclusione diversa da quella che stava scritta nel principio, o anche il dovere di ripensare a partire da quel principio).
Però la cala del rifugio non ripara dalla pena e non isola dal mondo: a urlare qui non sono le sirene del mito, ma, più prosaicamente, quelle di ambulanze e polizie; e le carcasse che nell’acqua «aggallano» potranno anche essere metaforicamente i punti morti, gli errori, le colpe che mordono il ‘tu’ che si è messo a ricordare, ma assomigliano alle carogne reali del Mediterraneo odierno, le navi a quelle degli attuali contrabbandi e degli sbarchi clandestini. E la ronda di «gendarmi e artificieri», il presidio della zona minacciosa e minacciata dagli ordigni, camminata da «schiere» di «anime disciolte» (significa vaganti? sbrancate? che si disfano? liquefatte?) svelano il quadro presagito dall’inizio (schiere di anime dannate si ammucchiano in attesa di Caronte [Inf, III, 120]; a «schiera larga e piena» [Inf, V, 41] vanno «di qua, di là, di giù, di su», come le mena la bufera) e mostrano la terra desolata dell’approdo, la ‘città irreale’ che in questo libro farà spesso da sfondo (Parigi, Milano, Palermo è lo stesso: «A crowd flowed over London Bridge, so many […] »; «[…] ch’i’ non averei creduto / che morte tanta n’avesse disfatta […]»); e forse il rischio ora è l’allucinazione, la confusione – o il non voler vedere, l’astrazione.
Ma anche se l’inferno batte vicinissimo, pure se la casa è vuota, sparita, anche se non c’è più nessuno ad ascoltare, «riparti»: fruga nella polvere, scava nella sabbia la «pista» che il deserto ha ricoperto (mantieni la memoria) – così dice il cronista di «voce fioca» al reduce sperduto, al cercatore di mappe e di reliquie che dovrà essere assistito dagli angeli strani dell’isolamento e dell’esclusione («l’eremita, l’esule, il recluso») e avrà per guida solo una «fiamma di lucerna» e il «suono della sera»: questo ‘tu’ che nella solitudine, dentro il silenzio, forse nel breve cono di luce di una lampada, somiglia a uno scrittore nel suo studio (l’attitudine è quella, l’immagine è topica); e immediatamente abbiamo pensato a Montale, a lui che con la sardana fuori scatenata, chiuso dentro il guscio, la sfera luminosa del suo pensiero, componeva un diverso (ugualmente amaro, ma quanto più fiero) Piccolo testamento («Questo che a notte balugina / nella calotta del mio pensiero […]. Solo quest’iride posso/ lasciarti a testimonianza / d’una fede che fu combattuta […].»); e ci siamo ricordati di Fortini, che mentre fuori la stessa follia imperversa, la stessa tempesta, in una stanza, al proprio tavolo, traduce le parole di un poeta, si obbliga a farle parlare ancora, a non lasciarle morire:
«Scrivi mi dico, odia / chi con dolcezza guida al niente / […]. La poesia / non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi» (Traducendo Brecht). Non siamo lontani da Consolo: pure se tutto è perduto, scrivi; anche se è dolore, racconta: questo l’invito al viaggio che dà avvio al libro («Allora tu […] ed io […] andiamo»), l’esortazione rivolta al ‘tu’ che forse è semplicemente un doppio dell’ ‘io’, forse è uno scrittore, forse è il protagonista dello Spasimo, forse è Consolo che parla a se stesso. A un ‘tu’ dolente e smarrito che cerca assoluzione («[…] t’assolva la tua pena, il tuo smarrimento»). E deve raccontare una colpa, come Ulisse nell’Olivo – deve scrivere questa storia. Che inizia subito dopo, ma disorientandoci (SP, 11):
E poi il tempo apre immensi spazi, indifferenti, accresce le distanze, separa, costringe ai commiati – le braccia lungo i fianchi, l’ombra prolissa, procede nel silenzio, crede che un altro gli cammini accanto.
L’afflato lirico, il modo scorciato (e il viaggio, la solitudine, gli addii) sono ancora quelli del proemio e difatti sembra che il testo si stia sviluppando esattamente di lì: un’impressione che non dura, perché già al secondo rigo ci accorgiamo di non capire ‘chi’ stia parlando e ‘di chi’ stia parlando. Non c’è più insomma né l’‘io’ né il ‘tu’, bensì qualcuno (un autore) che dice di una terza persona: il soggetto sottinteso (egli) che cammina solo e silenzioso con «le braccia lungo i fianchi» (ha le mani vuote, abbandonate, non ha niente) e che scambia per un-altro-a-fianco-a-sé la sua stessa «ombra prolissa» (che si stampa grande o lunga su una strada o contro un muro di questo paesaggio che non si connota e pare quasi uno spazio metafisico; ma possiamo anche pensarla sovrabbondante quest’ombra, e quindi cascante, stanca). È Gioacchino Martinez il soggetto narrato in terza persona, e certo assomiglia agli attori del proemio: è vecchio, è solo, è uno scrittore smarrito; anche lui tornerà (per finire) alla sua terra (al suo principio), in Sicilia, e non ritroverà la sua isola; e anche lui, che porta un carico di «rimorsi», cerca «remissione» (SP, 12).
Un’altra occorrenza del termine «rimorso» abbiamo incontrato esaminando la sintassi dello Spasimo. Siamo intorno al ’43, dopo lo sbarco americano in Sicilia, quando Martinez ha circa dieci anni. Il padre (con cui il bambino ha un rapporto conflittuale) aiuta un disertore, lo porta in un rifugio; ma i tedeschi li scovano e li uccidono. A rivelare il nascondiglio probabilmente è lo spaventato Gioacchino (SP, 24):
Lo strazio fu di tutti, di tutti nel tempo il silenzio fermo, la dura pena, il rimorso scuro, come d’ognuno ch’è ragione, cosciente o meno, d’un fatale arresto, d’ognuno che qui resta, o di qua d’un muro, d’una grata, parete di fenolo, vacuo d’una mente, davanti alla scia in mare, all’arco in cielo che dispare, di cherosene.
La colpa di cui Martinez sente il peso è quella di aver determinato, «cosciente o meno», la morte del padre (di averla anche in certi momenti, per rabbia, desiderata); ma a noi interessa questa specie di ‘sintomatologia dell’arresto’: l’immobilità, la paralisi, l’«estraniamento» che stanno insieme al «rimorso» e nello Spasimo gli si accompagnano sempre; e dacché il libro tesse una rete sotterranea di simboli, forse non è senza importanza che il posto in cui viene ammazzato il padre di Chino (il posto che da questo momento rappresenta e significa il «rimorso») sia proprio quello in cui il bambino realizza il suo isolamento volontario, la sua fuga dal reale. Ma dobbiamo essere più chiari.
C’è un luogo che si ripete nello Spasimo, un luogo che ogni volta si rifà e torna magari con un nome diverso, ma in fondo è sempre lo stesso, quello in cui Gioacchino si nasconde e sogna. È il suo rifugio segreto, il «marabutto» (viene dagli arabi la parola antica: indicava la dimora dell’eremita, la sua tomba): uno stanzone vuoto – lo strame a terra, la volta a cupola, una parete con le figurine saracene: un ricovero di capre mezzo sepolto dal terriccio, celato dalle frasche. Qui corre e si ripara Chino, ombroso, senza madre; qui si intana in odio al padre o a tutto il mondo, deciso a stare sempre lontano, solo; e nella finta caverna, nella solitudine, dentro la mezza luce la pena si quieta, vengono le figure; e inizia ogni racconto, il cinema, l’incanto (SP, 20):
Corse al marabutto, al rifugio incognito, segreto, ov’era deciso a rimanere sempre, solo, fuori da tutti, il mondo, sempre fino alla morte, avrebbe visto il padre, sì, avuto scorno, rimorso infine, pentimento.
S’accucciò in un lato, contro il muro, riguardò ogni cosa, le figure sul fondo celestino, le tortore fra i rami, i veli trasparenti della donna, i seni tondi, la sciarpa svolazzante intorno al corpo, e il cielo cavo della cuba. Ora la lama non piombava netta traverso la fessura, ma s’effondeva in chiaria lieve, lambiva le pareti, i lippi secchi e freschi, i fiori di salnitro, i gechi squamosi e palpitanti.
Gli si fecero appresso ad una ad una, e insieme circonfuse, tutte le donne, la giovane maestra che leggeva a scuola il suo componimento, Urelia col suo caldo e l’ansia acuta d’aglio, la siracusana bella e pregna di confetto, Lucia dorata e crespa, e la madre bianca più del letto, smunta, straziata, che lenta se n’andava.
Tanti nomi per dire una tendenza alla separatezza che è peculiare di Martinez: questa «tana» (SP, 18), lo «stanzino» in cui si chiude da bambino (SP, 21), il «capanno» che si inventa da ragazzo tra le radici pendule di un ficus: la sfera di «separazione, occultamento, letture fantasie proponimenti, nel meriggio pieno, nel silenzio», la cortina che lo cela e lo protegge mentre spia e vede le cose fuori, da sé distanti (SP, 47); e poi l’oasi «degli innesti e delle chimere sorprendenti» (si badi: in tutta la produzione consoliana il ‘luogo degli innesti’ ha sempre valenza metaletteraria): il giardino della casa di Palermo con le infinite piante e i fiori esorbitanti chiamato a fare da barriera intorno alla «quiete fragile» di Gioacchino ormai adulto (SP, 75), al suo sogno di una «vita sequestrata» (SP, 78) difesa dalla violenza e dall’orrore del presente, conclusa tra gli affetti e la scrittura; e ancora, in certo modo, l’Isola stessa, la Sicilia in cui, anziano, sente il bisogno di tornare per «chiudersi, occultarsi, finire nell’oblio» l’avventura della vita (SP, 53). E una separatezza, seppure differente, è il «silenzio» del vecchio: il rifiuto di scrivere detto in questo lamento come a spigoli d’affanno, con una sorta di precipitosa stanchezza nel modo cumulativo, negli incisi che di primo acchito non si distinguono, nella punteggiatura ‘difficile’ dell’avvio (SP, 37):
S’era chiuso nel silenzio, nel dominio della notizia, invasione del resoconto, scomparsa di memoria, nell’assenza o sordità dell’uditorio, vana era ormai ogni storia, finzione e rimando del suo senso diceva e si diceva. Ma sapeva che suo era il panico, l’arresto, sua l’impotenza, l’afasia, il disastro era nella sua vita.
Vanità dunque è raccontare ancora, ostinatamente parlare quando nessuno ascolta; vanità continuare a fare il ‘letterato’ in mezzo a «chiasso» e «scadimento» (Sp, 37), la «voce fioca» contro l’urlo potente delle mode, dei giornali, delle televisioni, del mercato culturale coi suoi mille imbonitori – per la Letteratura non c’è posto; ma resta che a produrre l’afasia è l’«impotenza» propria, la scrittura insufficiente, che non è servita a niente.
E un’ultima variante. Sempre nella vecchiezza, un giorno, a Parigi, scampando a un’aggressione, Martinez di nuovo si nasconde: trova riparo «in una cantina fatiscente, davanti a un film osceno»; ed è solo una contingenza, da quel luogo uscirà immediatamente, però pronunciando un ‘atto di dolore’ o una sorta di anatema, inorridito, più che dalla scena squallida, da se stesso: «Viltà di sempre, fuga dal reale, menzogna e adattamento. Via dalla caverna del rifugio, fuori per la porta d’emergenza […]» (SP, 43). Forse insomma nella
«caverna del rifugio» si annida il ‘vizio’, la viltà, la colpa che sta al fondo.
«Rimorso» ed estraneazione appaiono di nuovo affiancati, e cominciano a chiarire un legame stretto, nel colloquio tra lo scrittore e Mauro, da tempo rifugiato in Francia; il figlio nei cui confronti Martinez sente di aver fallito come padre, e che lo giudica con una punta di sufficienza, forse di disprezzo. La prima battuta è di Gioacchino (SP, 53-54):
« […] Il tempo, la memoria esalta, abbellisce ogni pochezza, ogni squallore, la realtà più vera. Per la memoria, la poesia, l’umanità si è trasfigurata, è salita sull’Olimpo della bellezza e del valore.»
«Ne hanno combinate i letterati!» ironizzò Mauro.
C’era stata ancora intenzione nella frase? Sospettava o aveva conoscenza? Rapida si presentò, unita come sempre al suo rimorso, emblema fisso d’ogni astrazione, latitanza, la sagoma bianca del fantastico bibliotecario, del cieco poeta bonaerense ch’era andato quella volta ad ascoltare nell’affollato anfiteatro.
«Che c’è, s’è risentito lo scrittore?» fece il figlio.
«Sai bene che non sono più scrittore, se mai lo sono stato. Ma perché ti rivolgi sempre a me in modo impersonale? Mai per quel che sono, tuo padre.»
«Padre si trova solo nei romanzi, nelle tragedie […]. Ma che discorsi, che discorsi… siamo tornati indietro di un po’ d’anni, tu giovane, io adolescente…» e rise Mauro.
«È il mio vizio, lo sai, la mia paralisi.»
Viene punto nel vivo il «letterato»; e il suo trasalire ha a che fare con le pratiche della trasfigurazione artistica, della compensazione estetica, col tarlo di una ‘finzione’ che intimamente lo rode; ma probabilmente c’entra anche il «tornare indietro», lo stare sempre fermo sui suoi assilli; e c’entra che il figlio non lo chiami ‘padre’, gli neghi quel nome, la funzione di chi indica la strada, educa, guida, addita una direzione. Il «vizio», la «paralisi» che Martinez confessa è poi la scrittura, questo luogo suo di arresto (la sua compensazione, il suo rifugio); e sta direttamente in rapporto con un «rimorso» di cui Borges è l’«emblema»: la «sa goma bianca» (quasi una apparizione, uno spettro) in cui si incarnano del pari «astrazione» e «latitanza». Borges che incantava con gli scacchi, gli specchi, le immense biblioteche impossibili e sperdenti, i labirinti, i libri magici, i giochi della mente: con l’infinito proliferare della Letteratura da se stessa, l’autofecondazione inarrestabile (mostruosa) che partorisce favole, trame, sogni, enigmi irrisolvibili, in una condizione di totale autosufficienza – di allontanamento dal mondo, di separatezza. E non a caso Borges più avanti ritornerà associato a una «illusione rovinosa» (SP, 80): quella di Mauro perduto dietro l’esaltazione politica negli anni della contestazione studentesca, ma più in profondità la propria, quella di lui, Martinez: «inerte, murato» e ugualmente perduto nell’inseguimento di un miraggio, dietro a un «folle azzardo letterario» (SP, 126). E nel continuato ‘esame di coscienza dello scrittore’ che è lo Spasimo, durissimo e costante (ossessivo) è l’autoaccusarsi del protagonista. Si guardi a questo stranito e quasi-teatrale dialogo ancora tra il padre e il figlio. Le parentesi valgono a riportare il non detto, il non espresso nel colloquio; ma forse siamo di fronte a una specie di Secretum. Inizia Mauro (SP, 35):
« […] ti trovo bene, un po’ più magro…»
«La vecchiaia… […] anticipa poi l’ulteriore smagrimento, e assoluto.»
«Di chi queste allegrie?»
«Mie, solo mie.»
«Fai progressi. Ancora un poco e sei alla poesia.»
(Sempre uguale la tua ironia, costante il tuo rifiuto d’ogni incrinatura, cedimento) (Il tuo lamento, il tuo bisogno di aggrapparti)
(Ti sei nutrito d’astrazioni, dottrine generali, ed ostinato credi che ancora possano salvare)
(Le parole con cui ti mascheri e nascondi sono solo una pazzia recitata, un teatro dell’inganno)
Si può dedurre che Martinez rimproveri al figlio l’eccessiva durezza e una pervicace astrazione ideologica (ma il testo è volutamente ambiguo: «nutrito d’astrazioni», in fondo, è pure lo scrittore con la sua chimera, la sua ‘missione letteraria’); e che a sua volta Mauro ferocemente e silenziosamente irrida il padre, il costante suo «lamento», il tono da tragedia, il patetico ostinarsi a interpretare un ruolo intellettuale mancato o inconsistente, l’insufficienza ad agire sulla storia, i destini, il presente; che disprezzi le parole dietro le quali il vecchio ha mentito e si è nascosto (e dopotutto ancora e sempre è evaso, si è consolato, dal reale si è allontanato: fuori del mondo ha sognato come nella tana antica, nel marabutto). E certo potrebbe essere così: ma dimenticheremmo che molta parte del dialogo (tutto il sottinteso) si svolge in interiore homine, e che probabilmente è solo Martinez a riempire i vuoti della conversazione coi suoi implacati assilli, con l’orrore che ha di sé. Tanto più che nello Spasimo, ad ogni occasione, questo scrittore che non può e non vuole più scrivere, di sé fa strazio: non salva niente. Impietosamente liquida la propria opera: poco talentuosa, perduta «nel ri stagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono…» (SP, 88); e tutti i suoi libri (che poi, richiamati dal testo, sono veramente i libri di Consolo) definisce «storie perenti, lasche prosodie, tentativi inceneriti, miseri resti della sua illusione, del suo fallimento» (SP, 66).
Ha «ripugnanza» della propria scrittura Martinez (SP, 66): di un piacere estetico atteggiato a impegno intellettuale e che invece era latitanza, astrazione, mascherata viltà. E non ha salvato nessuno: la moglie dalla paura, il figlio dalla violenza, il presente dal disastro.
«Rimorsi» assalgono Gioacchino che ancora pensa al figlio, al «candido ribelle» col quale non ha mai saputo parlare e che non è stato in grado di sorreggere, di aiutare, di avvisare dei rischi di una ideologia che poi tutti i più puri ha tradito; pensa a Mauro che scampando il carcere è fuggito dal paese e «da ogni padre imbelle, ipocrita e impotente» (SP, 89) – si è allontanato da lui, Martinez (SP, 81):
S’affrettarono i giudici a dichiarare «il padre no, non c’entra». E invece sì. Come ogni padre, ogni complice allora di quel potere, di quello stato, ogni responsabile della ribellione, dei misfatti di quei giovani.
È un nodo importante dello Spasimo questa tragica e inabile figura paterna: è un’immagine speculare dello scrittore che ha fallito il suo compito, il suo dovere di guida. Poi fallirà anche l’altro che lo stesso dovere incarna, il giudice – all’inizio del libro, Judex, il personaggio di un film muto, è l’eroe del bambino Chino: un portatore di giustizia, un riparatore di torti; e nella conclusione dello Spasimo un magistrato in carne ed ossa che ne ricorda un altro da vicino, che come Borsellino muore in un attentato (e insieme a lui Gioacchino) e soccombe non per sua incapacità o viltà, ma perché lo uccide la mafia, perché è più forte il mondo.
Come scrittore, come padre e come giudice ‘insufficiente’, Martinez si accolla la responsabilità e porta il peso della rovina che non ha fermato – l’attuale degrado, l’involuzione culturale, la perdita di valori, la bestialità e la volgarità imperanti; e lo sbando di una generazione «incenerita», sì, «da un potere criminale», ma smarrita e perduta perché «figlia di padri illusi» anch’essi naufragati (SP, 39): quelli che dopo la guerra «avrebbero dovuto ricostruire […] formare una nuova società, una civile, giusta convivenza» (SP; 126).
Alla fine prende la penna, Gioacchino, e scrive al figlio (SP, 126-128):
Abbiamo fallito, prima di voi e come voi dopo, nel vostro temerario azzardo.
Ci rinnegate, e a ragione, tu anzi con la lucida ragione che ha sempre improntato la tua parola, la tua azione. Ragione che hai negli anni tenacemente acuminato, mentre in casa nostra tenacemente rovinava, nell’innocente tua madre, in me, inerte, murato nel mio impegno, nel folle azzardo letterario.
In quel modo volevo anch’io rinnegare i padri, e ho compiuto come te il parricidio. La parola è forte, ma questa è.
[…] rimaneva in me il bisogno della rivolta […] nella scrittura. Il bisogno di trasferire sulla carta […] il mio parricidio, di compierlo con logico progetto […] per mezzo d’una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente comunicativa, di padri o fratelli – confrères – più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili del disastro sociale.
Ho fatto come te, se permetti, la mia lotta, e ho pagato con la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna.
Compatisci, Mauro, questo lungo dire di me. È debolezza d’un vecchio, desiderio estremo di confessare finalmente, di chiarire.
La lettera poi si interromperà, forse la confessione non è intera; ma il «rimorso» di Martinez lo conosciamo ormai: la coscienza di non aver salvato niente, di non aver fatto abbastanza col proprio mestiere letterario (ed era già la colpa dell’Olivo) che si accompagna a un acre giudizio di sé, alla condanna feroce della propria scrittura tutta ridotta a menzogna, autoinganno, fuga dal reale, sonorità e cascame.
E siamo arrivati all’ultima occorrenza del «rimorso» e finalmente alla terza e ultima luna di Consolo, con Gioacchino che ritorna in Sicilia:
Tornava nell’isola, il porto da cui era partito, in cui si sarebbe conclusa la sua avventura, la sua vita. Disvio, mora, sottrazione, anestesia, tormento della sorte […]. Vita ferita […]. Spoglia sospesa alla fronda lenta, all’inganno, al miraggio letterario.
Ma ogni viaggio, sapeva, era tempesta, tremito, perdita, dolore, incanto e oblio, degrado, colpa sepolta, rimorso, assillo senza posa.
Era la notte placida, le stelle, l’immacolata luna, la primavera dei risvegli, l’alba della promessa, l’amore che invade, trasfigura […].
Era il miracolo dell’arte, la consolazione della ginestra, il fraterno affetto, la mano porta al naufrago, l’idea fresca, collettiva di volgere la storia, lenire l’esistenza.
È vero che lo Spasimo somiglia alla poesia: lo attesta anche la struttura grafica di questa pagina (SP, 98-9) in cui l’a capo è quello di una composizione in versi liberi, non di un romanzo o di un racconto. Bisogna intendere: «ogni viaggio […] era tempesta […] era la notte placida […] era il miracolo dell’arte […]»; e il «viaggio» del testo, dello scrittore e padre fallito Gioacchino Martinez e della sua vita «sospesa […] all’inganno, al miraggio letterario», è la scrittura: la fabbrica delle consolazioni, l’incanto artificiale, il sogno indotto della «immacolata luna». Lei che è astrazione e latitanza, rifugio, oblio colpevole e «rimorso, assillo senza posa», Lei questo spasimo.
Sull’inutilità e il danno della letteratura, sui consuntivi amarissimi, disperatamente in negativo, in tanti hanno già fatto storia: Verga fingeva di scrivere, chiuso nel silenzio offeso degli ultimi anni a Catania; e prima di lui Foscolo scomponeva e ricomponeva nevroticamente le Grazie senza poterle mai finire; Manzoni disprezzava e negava il suo romanzo – «tiritera» lo chiama, «cantafavola»[11], menzogna; l’elegantissimo Leopardi gettava al macero tutte le illusioni col Tristano, e nel Tramonto della luna faceva precipitare l’astro bianco, a morte metteva la sua Regina antica, la seppelliva: e con lei la propria voce, il desiderio, il canto, il cuore. C’entra naturalmente l’esperienza, la maturità (che «senz’altra forza atterra»), c’entra anche la vecchiezza in Consolo, la perdita fisiologica dell’entusiasmo. Ma la scrittura dello Spasimo, o diciamo meglio, la questione dello spasimo di questa scrittura faticosa e contratta, e difficile per dolore, non può andar disgiunta da un particolare malessere che si produce in chi si ostini, oggi, a fare Letteratura alta e civile – cose, oggi, entrambe azzardate e anacronistiche.
Può essere che in assenza di un uditorio reale, a furia di parlare per o con se stesso, il poeta moderno finisca col dimenticare o col prendere per favola l’urgenza stessa e il valore del suo dire; che addirittura finisca col credere di aver recitato (di aver mentito) per vanità e gusto di esibizione, per il piacere solitario della forma splendida e sonante. E può essere che il disincanto che sta in ogni vecchiezza, assieme alla indisponibilità totale e vera della contemporaneità, abbiano spinto Consolo ad una severità eccessiva, e come a travedere: ad accusarsi, intendiamo dire, di colpe che forse aveva anche rasentato, ma che non gli appartenevano. Perché non era finta la sua disperazione, e neppure erano finti l’impegno, l’arte, l’indignazione; eppure questo autore non ha avuto nessuna pietà per la sua opera, per il suo mestiere: «lasche prosodie», ha detto delle sue cose, lo ripetiamo, «rifugio», «vizio dell’assenza», «vanità», «colpa», «malattia».
Lasciamo stare quanto potesse essere necessario a Consolo un rasciugamento, o quanto la ‘autocorrezione’, lo scarnimento dello Spasimo lo abbiano preservato dal rischio di farsi eco di sé, della lamentazione estenuata o di una barocca e vorace esmesuranza. La parabola di questa scrittura, il suo ridursi a una nuova e scabra essenzialità rinunciando all’alone favoloso, alla meraviglia e anche all’orpello, è un approdo che comunque sorprende, pure se viene dalla stanchezza; ed è una evoluzione, uno scatto, un movimento anomalo e vitale all’interno dell’ambito generalmente conservativo della prosa. Un modo diverso, che già faceva le prove nelle Pietre e nell’Olivo, assai lontano dai lenimenti classici e barocchi, dai sogni della luna, dai fasti tutti d’oro e neri al fondo di Retablo, del Sorriso; ed è la forma più dura e acuminata di una tragedia da sempre percepita ma che adesso alza i toni; e nella sua bellissima nudità è la voce più dolente dell’autore, e la più sincera.
Però resta l’impressione che Consolo abbia attinto la sua nuova maniera come punendosi, tagliandosi la vena che era sua di vertigine e cascame, di febbrile incessante e violentissimo rigoglio; e che della lingua propria abbia finito col provare fastidio, quasi il rimorso di una cosa falsa; e per questo abbia preso a resecarla, fino al rischio di cancellarla. Come con l’intento di adeguarla al silenzio furioso che si è sentito intorno.
Claudia Minerva
[1] E. SICILIANO, Lo Spasimo di Palermo, «La Repubblica», 11 novembre 1998; poi in L’isola. Scritti sulla letteratura siciliana, Manni, Lecce 2003.
[2] Tutte le citazioni da Consolo recano tra parentesi la sigla e il numero arabo che individuano il luogo da cui la citazione è tratta. Queste le sigle (tra parentesi quadre indico la prima edizione; fuori della parentesi quadra è data l’edizione di riferimento):
SIM = Il sorriso dell’ignoto marinaio [1976], Mondadori, Milano 2002.
LUN = Lunaria [1985], Mondadori, Milano 2003.
PP = Le pietre di Pantalica [1988], Mondadori, Milano 1990.
OO = L’olivo e l’olivastro [1994], Mondadori, Milano 1999. SP = Lo Spasimo di Palermo [1998], Mondadori, Milano 2000.
Altre citazioni sono da OMERO, Odissea (trad. R Calzecchi Onesti), Einaudi, Torino 1963; DANTE ALIGHIERI,
Inferno; T.S. ELIOT, The Waste Land. Le sigle adoperate sono rispettivamente Od, Inf, WL.
[3] Sulle molte versioni del testo I barboni, scritto da Consolo per il catalogo dell’artista Ottavio Sgubin, cfr. D. O’CONNELL, Consolo narratore e scrittore palincestuoso, «Quaderns d’Italiá», 13, 2008, pp. 161-184. Riassumendo: Barboni, simbolo inquietante del nuovo medioevo, «Il Messaggero», 3 marzo 1996; poi, Barboni e Natura morte, in Sgubin, Opere 1988-1997, Marsilio, Venezia 1997; poi, in Ottavio Sgubin, edizioni Mario Jerone, ottobre 1999; poi, Barboni, segno dei nostri fallimenti, «L’Unità», 29 Ottobre 2003; infine I barboni di Ottavio Sgubin, in Ottavio Sgubin pittore, aprile 2003.
[4] Sono del tutto assenti nello Spasimo i due punti e il punto e virgola; raro è l’impiego del punto interrogativo, dell’esclamativo e dei puntini di sospensione fuori delle (poche) battute di dialogo; sporadico (ricorre una decina di volte) l’uso del trattino.
[5] Cfr. M. ONOFRI, Nel magma italiano: considerazioni su Consolo scrittore politico e sperimentale, in (a cura di) E. PAPA, Per Vincenzo Consolo, Manni, Lecce 2004, pp. 59-67. Diversamente, ci sembra, all’indomani della scomparsa di Consolo e sull’aver presentito, nello Spasimo, un «congedo» dell’autore, cfr. ancora M. ONOFRI, Vincenzo Consolo, scrittore antagonista in lotta con il potere, «La Nuova Sardegna», 24 gennaio 2012.
[6] Cfr. G. FERRONI, Il mondo salvato da uno scriba, in «Corriere della Sera», 30 novembre 1998. Di ‘romanzo’ parla Ferroni (di una «dizione essenziale» dello Spasimo) e insieme di pagine «volte verso una liricità lacerante», di una «prosa poetica» che addensa su di sé la fatica dell’esistenza, della storia, della cultura, dell’alterarsi del mondo»: una spinta a narrare continuamente controllata dal «rifiuto dell’illusione del narrare», contigua alla fluida disponibilità al racconto tipica di certa disinvoltura postmoderna. In questo libro che «sgomenta», tuttavia, il critico legge tuttavia un segno di speranza nella «ostinata narrazione poetica», nel dialogo con la grande Letteratura, nell’ostinarsi delle parole, nel loro insistere e resistere a cercare giustizia e verità, come mostrerebbe la preghiera muta con cui il libro si chiude: «O gran manu di Diu, ca tantu pisi, / cala, manu di Diu, fatti palisi!». Cfr anche L. CANALI, Che schiaffo, la furia civile di Consolo, «l’Unità», 7 ottobre 1998. Lo Spasimo è forse «il più bello» dei libri di Consolo, dice lo studioso; è «il più duro e compatto»; ed è «un violento schiaffo» a tanta odierna «letteratura di basso consumo». È testo «impervio», «orgoglioso», «difficile»; simile (dice Canali) a una alternanza di deverbia e cantica, come nella tragedia e nella commedia antiche; ed è pieno di una poesia amarissima, «consapevole della inesorabile sconfitta, non solo personale, ma collettiva, delle istituzioni, dello Stato, dei pochi giusti destinati a soccombere alla violenza criminale o alle tresche segrete dei potenti. E questa attitudine è un altro schiaffo dato a chiunque, nel ‘mondo delle lettere’ non creda più nell’impegno civile e anzi talvolta lo beffeggi. È dunque una singolarità, questo ‘romanzo’ di Consolo: ad un massimo di tensione stilistica, semantica, lessicale, culturale, che potrebbe sfociare in un parnassianesimo fatto di essoterismo estetizzante, corrisponde invece un massimo di denuncia sociale sia pure consapevole della probabile inutilità del proprio sacrificio. Mai, come in questo libro, la furia, questa sì dissacrante, di Consolo, e il romanticismo idealistico della sua ispirazione, si erano tanto avvicinati alla lezione dei ‘classici’».
[7] Riportiamo la bella intervista rilasciata da Consolo ad A. Properi nel 1992 (V. CONSOLO, Il suddetto e i parrucconi, «L’Indice», 5, 1992). Sul mondo della letteratura di oggi e i suoi meccanismi editoriali così si esprime lo scrittore siciliano: Diciamo letteratura, ma dobbiamo intendere narrativa, romanzo o racconto. Ché, la poesia, imperturbata e ignorata, procede sempre più nella sua sacra lontananza, nel suo infernale Eliso o nel suo celeste Olimpo. Procede, lei figlia della Memoria, verso l’oblio, in questo nostro presente immenso dell’estrema frontiera del profitto. Presente che ha mutato ogni valore in merce, ogni espressione in assoluta, squallida comunicazione. Il romanzo sta morendo o è già morto (no, non è il ritornello avanguardistico) e mai come oggi si sono prodotti tanti romanzi, mai se ne sono consumati così tanti. E ognuno d’essi è imbonito come capo d’opera, come sommo frutto della più autentica letteratura, ognuno è imposto come indispensabile all’esistenza o quanto meno alla permanenza nello stato sociale in cui ci si è posti. Produce così, l’industria, come avviene per ogni altra merce, il romanzo per le masse, tristi e misere imitazioni d’altri tipi di moderne narrazioni, giornalistiche o televisive, e il romanzo di lusso per l’élite, riproposte di vecchie, già sepolte squisitezze letterarie, neorondismi di professori pensionati o neomanierismi di anemici o brufolosi scolaretti. I quali, professori e scolari, frenetici cottimisti, solitari e alienati lavoratori a domicilio, sono obbligati a produrre sempre più affannosamente per essere sempre più presenti nell’affollata e vociferante borsa dei “titoli”, sempre disponibili nel modesto mercatino rionale o nelle grandi fiere internazionali; sono obbligati a calcare pateticamente ribalte, a cavalcare tigri, a urlare, farsi inverecondi finanche nelle finte, recitate ritrosie. Chi in questa sede è invitato a confessarsi dichiara allora che, dotato di una forte inclinazione a delinquere, ha cercato, fin da quando ha mosso i primi passi nel territorio letterario, di violare le leggi oppressive della comunicazione e del mercato. Ha scritto poco e in un modo in cui la comunicazione era ridotta al minimo necessario, spostando proditoriamente la sua scrittura verso l’espressione, la forma incongrua e irritante della poesia, praticando un linguaggio che fa a pugni, stride fortemente con il codice linguistico stabilito dal potere; s’è tenuto sempre igienicamente lontano dalle accademie, dalle consorterie, dalle massonerie, dai gruppi d’ogni sorta, d’avanguardia o retroguardia. Tutti questi delitti hanno fatto sì che i tutori dell’ordine lo punissero, che i gendarmi lo tenessero sotto controllo come elemento antisociale. Così a ogni rara uscita, a ogni nuovo libro del suddetto, i parrucconi, i piazzisti della merce, istericamente si scompongono, cominciano a urlare: “È siciliano, non scrive in italiano, è barocco, è oscuro, è pesante come una cassata, le sue narrazioni non sono filate, fruibili: ma chi crede di essere, ma come si permette?.
[8] Cfr. «Il Piccolo», 11 giugno 2011; «La Repubblica», 30 giugno 2011.
[9] Una stroncatura viene da C. TERNULLO, Vincenzo Consolo, Dalla ‘Ferita’ allo ‘Spasimo’, Prova d’Autore, Catania 1998: parla di «scadimento», il critico; di una «pertinace sentenziosità» dell’autore che insisterebbe a «farsi ‘cattiva coscienza’ dei tempi» senza però possedere l’equilibrio di Sciascia; e di una «chiara disunità» del libro, di un «accostamento forzato e insincero dei segmenti narrativi» (p.66-7), di un rasentare l’horror nella descrizione della vecchiaia (p. 69) – giudizio ingeneroso e quasi intemperante, come si vede; e del resto, ognuno ha il proprio (ricordiamo comunque a Ternullo che le «voci di dannunziana memoria» alle quali si riferisce a p. 42 del suo libretto, sono leopardiane).
[10] SP, 70: «Quel contrapposto di gale e di cenci, di vanità e miseria»; segnalata dalle virgolette basse, è citazione dal capitolo XXVIII dei Promessi sposi, con la carestia a Milano.
[11] È quanto Manzoni scrive a Monti (15 giugno 1827) e a Cioni (10 ottobre 1827); lo leggo in A. LEONE DE CASTRIS, L’impegno del Manzoni, Sansoni, Firenze 1965, p. 246.
Pietha de Woogd ,traduttrice di Retablo in lingua olandese. Intervista Vincenzo Consolo Il 3 marzo 2011.
Vincenzo Consolo come Verga
Nel 1893 Giovanni Verga lascia Milano, “stanco di anima e di corpo”, per ritornare nella sua Sicilia. A Milano aveva soggiornato per circa vent’anni, essendovi giunto nel novembre del 1872, ma se ne andrà alquanto deluso e risentito. In Sicilia Verga ritroverà i sedimenti profondi della sua memorialità e soprattutto la lingua delle origini; primordiale, robusta, incorrotta, da cui trarrà linfa vitale e sangue la sua fantasia e con cui darà forza, spessore, virulenza alle sue storie e alla sua poetica, come non gli era ancora accaduto. Questo generoso amalgama si rivelerà una felice epifania e lo trasformerà nel potente scrittore che conosciamo. Stilisticamente una vera e propria rivoluzione, pari a quella di altri giganti della letteratura europea del suo tempo. All’archetipo del ritorno degli scrittori siciliani moderni nella loro isola, Vincenzo Consolo dedica un breve capitolo “I ritorni” che chiude la sezione verghiana degli scritti compresi in Di qua dal faro. Ritorno nelle sue molteplici declinazioni, che non è solo tópos, mito, visionarietà, storia o civitas, ma soprattutto memoria e lingua; vale a dire, il corredo più acconcio e prezioso per uno scrittore. Ora è giunto il momento anche per lui, il momento del nóstos e del ricongiungimento, come lo fu per Verga più di un secolo fa; anche Consolo ripercorre a ritroso il suo cammino, di uomo prima che di scrittore, e da Milano dove era salito nel 1968 vivendovi e operandovi per oltre un quarantennio, inverte la rotta per riapprodare nella sua isola. “Torno nella mia terra. Voglio morire nella mia isola”‘ , confida in un’intervista al settimanale palermitano “a sud’ europa” (1) nel dicembre scorso. Ribadita all’età di 77 anni, Consolo è del 1933, questa volontà suona perentoria, asseverativa, ultimativa. Quando questo avverrà, si sarà compiuta la parabola naturale di un uomo e di uno scrittore che non ha mai scisso, per sua e nostra fortuna, il legame profondo, primigenio, ancestrale, con l’ónfalos, con la terra, con la mater, che è impasto di lingua, carne, affetti e visione. E su quell’isola, non dimentichiamolo, c’è sedimentato il respiro di Sciascia e di Lucio Piccolo, di Verga e di Lampedusa, di Antonello e di Pirandello con la fantasia del Caos, il profumo perduto del suo pino. E c’è il mare, cioè il mito dei miti.
Ritorna, Consolo, con lo stesso risentimento, con la stessa delusione di Verga. Delusione per le aspettative tradite di una città divenuta, secondo le sue stesse parole, “città centrale della menzogna” (2). E non possiamo fare a meno di andare con la mente alla Milano di Tangentopoli e al tradimento che ne è seguito: al leghismo bieco e reazionario, al berlusconismo disinvolto e immorale, alla deriva etica, al degrado civile, all’indegnità opportunista della cosiddetta società letteraria, sempre più stomachevole. Il ritorno di Consolo non è un ritorno alla fonte salvifica (come fu per Verga); egli non ne ha bisogno; non ha bisogno di purificare la sua lingua alle fonti primigenie perché di quella lingua Consolo è impastato. Della sua oralità e della sua sostanza. Non torna per arginare la crisi dell’artista, perché di quell’universo vitale, labirintico e fecondo non si è mai separato. E rimasto, pur vivendo fuori dalla sua isola, il più siciliano degli scrittori siciliani: come Sciascia, come Buttitta. E questa è stata la sua forza e la sua fortuna. Egli non ha dissipato, e, in linea con la grande lezione della tradizione, ha tenuto salde le radici per non “disperdersi”, come dice Giuseppe Bonura, “in un ambizioso quanto vacuo internazionalismo’, senza anima e senza storia. In sintesi: senza verità. Se, com’egli scrive, “la letteratura è essenzialmente scrittura, è espressione linguistica; è tempo, ritmo delle parole, eco poetica di suoni” (3), il plurilinguismo, la poeticità, il suono, e direi anche il colore stesso della parola, non possono prescindere dalle lingue madri. Nessuna lingua artificialmente ricostruita può eguagliarne la potenza espressionistica, la densità sapienziale, la ricchezza significante, l’umoralità, l’irriverenza iridescente, l’ironia sovversiva. E lingua madre significa una lingua talmente antica e così arcaicada aver sfidato il divenire; che ha saputo tener testa all’omologante egemonia, al livellamento sterile e banale del linguaggio, nato dalla società consumistica e della pervasività televisiva.
Quest’opera di resistenza ha operato il Consolo artista, il Consolo creativo, attento alla parola quant’altri mai, attratto come direbbe Bonura “dalla passione inappagata del senso primitivo della parola” (4), da quella “nostalgia dell’inizio, dell’origine, quando un vocabolo poteva illuminare una vita” (5). Questa nostalgia, questa “regressione strategica” (sono ancora concetti di Bonura), si ricollega a radici antichissime e dai risultati espressivi sorprendenti. Valga per tutti l’Aristofane delle Tesmoforiazuse e della sua guardia, che argomenta in un misto di siculo-calabrese divertentissimo, e che non ha perduto nulla, a distanza di tanti secoli, della sua vis comica e della sua efficacia. Non si dimentichi che questa regressione strategica ci ha dato un capolavoro come Il sorriso dell’ignoto marinaio, da un lato, e come contrappeso quella favola barocca e notturna che è Lunaria. Un discorso approfondito meriterebbe anche il Consolo intellettuale, il ricercatore erudito, il filologo, il cultore di storia e di tradizioni, il saggista. Il Consolo che invidia la scrittura geometrica, rigorosa, analitica di sodali come Sciascia, Pasolini o Moravia è in realtà altrettanto illuminista, analitico, ragionatore. Chi vuole la prova di quanto sto sostenendo, si vada a leggere le oltre 280 pagine che hanno dato vita ad un libro composito come Di qua dal faro. Tutti assieme ora, quei saggi, quelle conferenze, quegli articoli, quelle prefazioni, compongono il corpo unitario di un volume che io trovo, oltre che bellissimo, assolutamente necessario.
ANGELO GACCIONE
NOTE (1) “a sud’europa” anno 3° n. 45, Palermo 21 dicembre 2009, pag. 18. Intervista a cura di Concetto Prestifilippo. (2) Idem. (3) Vincenzo Consolo, Di qua dal faro, Mondadori, 1999, cit. pag. 137, nel saggio “Verga fotografo” (4) LE LUCI DEL BAUHAUS – Linee/Voci, a cura di Angelo Gaccione, Gutenberg, 2001, pag. 7, “I labirinti della poesia”. (5) Idem.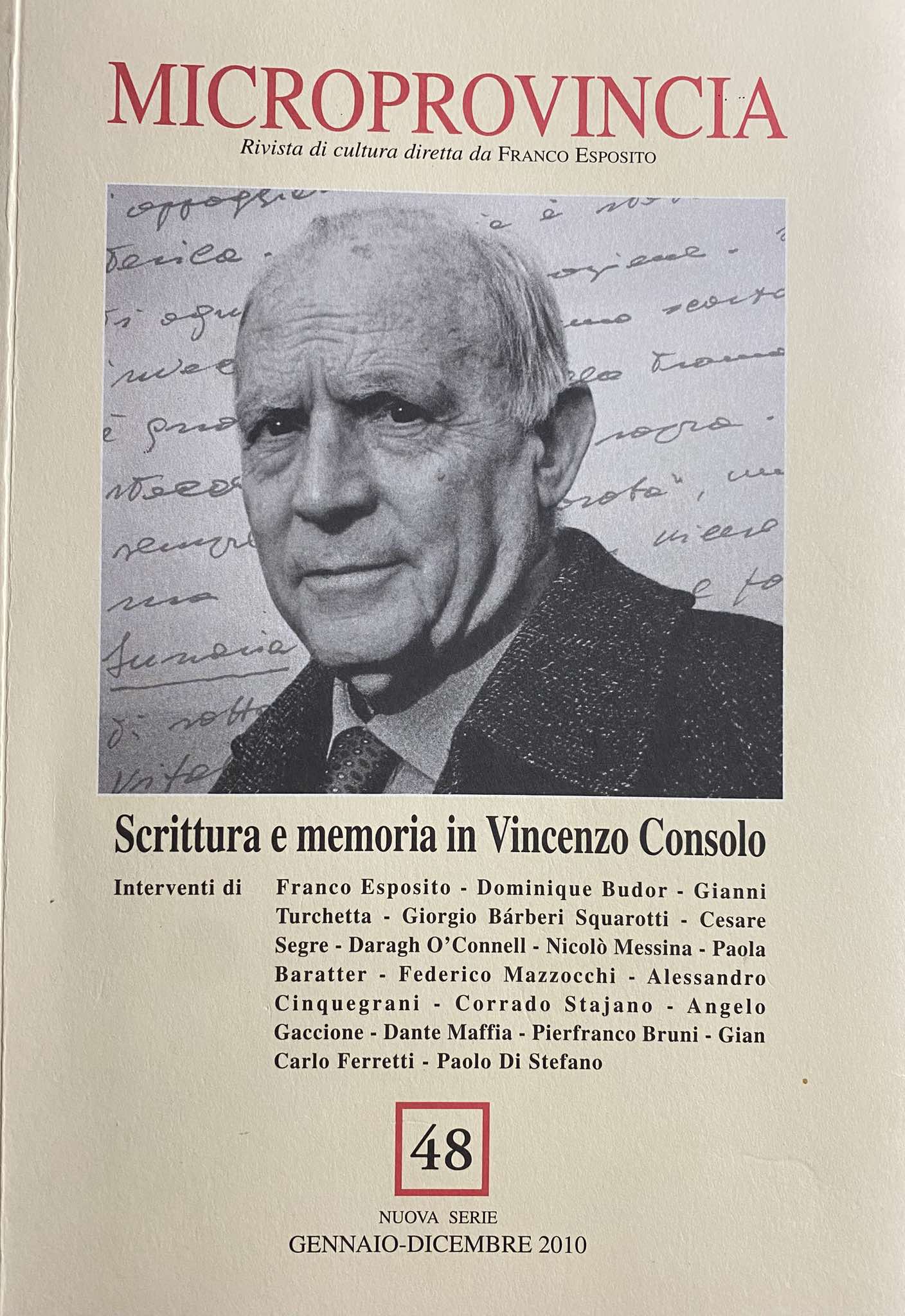
Satiri e dèmoni nel sabba siciliano di Consolo
Il romanzo di Vincenzo Consolo, Nottetempo, casa per casa, è tutto uno scatenarsi di follia.
Questa follia dilaga in una Sicilia antica, pastorale e agricola, splendida nei suoi monumenti medievali foderati di mosaici, imponente nei palazzi barocchi, pittoresca e tenebrosa nei vicoli brulicanti. E’ una follia dai molti volti, sempre a confronto con una natura vincitrice per la sua bellezza magica e indifferente, sue luci che non si curano di farsi strada negli animi.
Una natura dai cieli immensi, cui si contrappone la discesa in tenebrose caverne, ove i segni del tempo, si perdono tra le ombre. Pietro il protagonista, vive tra la licantropia del padre e la psicosi ossessiva della sorella. Personaggio positivo, condivide senza infatuazioni i programmi di rinnovamento politico e sociale che stanno velocemente, ma provvisoriamente, affermandosi: però anche li scopre le crepe dell’irrazionale e del fanatismo. Di contro al suo giudizioso rapporto con la pazzia, sta la funzione di condensatore di ogni sregolatezza mentale svolta da Aleister Crowley, l’inventore officiante di riti satanici in cui si mescolano alla promiscuità sessuale e alla droga tutte le invenzioni più stravaganti e kitsch di religioni e leggende esoteriche. Nella sua thélème di satiri e donne assatanate sono via via attratti il dannunziano barone Cicio e il pastore Janu.
Questo campionario di follia offertoci da Consolo sintetizza le manifestazioni dell’irrazionale che intorno al ’20, in Sicilia e altrove, invocando il fascismo in via di costituzione, vi trovarono poi un alveo. Era anche viva l’illusione di strapparsi a un’ indifferenza secolare, al sonno, alla noia: come una smania, un assillo verso qualcosa di agognato quanto sconosciuto. E la ricostruzione d’epoca è molto più sistematica di quanto non appaia a prima vista. Da un lato l’indolenza delle vecchie abitudini, il Circolo, i pettegolezzi di paese, i rapporti tra una nobiltà decaduta e pretenziosa e un popolo ancora primitivo. Dall’altro le nuove mode, le réclames con pizzichi di esotismo, l’esibizione di parole francesi e inglesi, le marche dei prodotti appena commercializzati, i compiacimenti dannunziani, la Florio. Fitti perciò gli inserti materici nella prosa d’arte di Consolo. Anche Aleister Crowley è un personaggio strico; suoi i versi inglesi riportati nei capitoli dedicatigli. Deve aver affascinato lo scrittore spingendolo a raccogliere notizie e dicerie su di lui: e certo subirono il suo fascino i molti che vennero a conoscenza o a contatto con questo santone attirati secondo i casi dall’aura misteriosofica o profetica di cui si circondava o dalla dissolutezza sua e dei suoi seguaci. Inglese o americano, Anticristo, mormone o quacchero, è facile credere che abbia sbalordito il chiuso ambiente in cui venne a sistemarsi.
Con questo mirabile romanzo si fa ancora più chiaro il programma svolto da Consolo nel ciclo della sua narrativa: rappresentare la Sicilia in varie fasi della sua storia, da quella greca riscoperta in frammenti enigmatici (Le pietre di Pantalica) alla dominazione spagnola (Lunaria) al settecento illuministico (Retablo)
al risorgimento e all’unità malamente realizzata (Il sorriso dell’ignoto marinaio). E per ottenere il necessario straniamento, analogo a quello operato dallo scrittore di Sant’Agata Di Militello, fungono da testimoni o pietre di paragone dei forestieri: il vicerè di Sicilia o il cavaliere e artista lombardo Fabrizio Clerici, ora il mistificatore inglese. Lo stile barocco, fitto di sicilianismi, fornisce il coinvolgente e inconfondibile colore locale, sovrastorico sinché non si apre a parole precisamente, significativamente connotate, lirico sinchè non discende con efficacia alla corposa quotidianità.
Ho appena parlato di narrativa, ma occorre chiarire. Consolo sempre aborrito il raccontare filato, la trama in senso tradizionale. Egli procede con una successione di scene sintomatiche, rivelandone i nessi con la riapparizione dei personaggi e segnalandone il tono con i ben scelti eserghi. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio, brani di opere storiche intercalati alle scene fornivano le notizie attestandone la verità. Sotto questo riguardo, Nottetempo, casa per casa è l’opera che si avvicina di più a un romanzo, dato il forte nesso fra le scene allineate nei dodici brevi capitoli e l’eterna presenza di pochi personaggi in fasi diverse della loro vicenda.
Anche Petro, alter ego dello scrittore, ha la sua vena di pazzia: vede i protagonisti dei romanzi che divora nei pochi momenti liberi, parla con loro interrompendo il silenzio delle sue letture. Questa pazzia positiva sembra essere la provvisoria catarsi proposta da Consolo. Una catarsi drammatica perché pare irraggiungibile (<<intinge la penna nell’inchiostro secco, nel catrame del vetro, nei pori della lava, nei grumi dell’ossidiana, cosparge il foglio di polvere, di cenere , un soffio, e si rivela il nulla, l’assenza d’ogni segno, rivela, l’impotenza, l’incapacità di dire, di raccontare la vita, il patimento>>); ma Petro alla fine si sa maturo per attingere le parole, il tono, la cadenza, per sciogliere il grumo dentro e dare ragione a tanto dolore.
Questa decisione di testimoniare, non solo i fatti ma i tumulti del sentimento, è formulata da Petro all’arrivo in Tunisia. Perché anche la topografia del romanzo si allarga progressivamente: da Cefalù e Palermo ai remoti paesi delle peregrinazioni di Crowley, da una Sicilia profonda, verghiana, a un’Europa atteggiata secondo un gusto dannunziano e liberty, Una topografia in cui irrompono deformandosi, le nuove idee, e l’impazienza rivoluzionaria si attua in velleitarie azioni terroristiche, mentre i fascisti fanno le loro scorrerie. Infine, Petro riesce a attuare lo strappo: lascia in nave la sua Sicilia dov’è in pericolo, emigrante più che esule, scettico verso i programmi di lotta enunciati dall’anarchico Schicchi che lo accompagna. La scelta della scrittura è, insieme, una lucida rinuncia a una vittoria.
Cesare Segre
Microprovincia gennaio – dicembre 2010
Io lo ricordo così
di Vincenzo Consolo
I libri di Danilo Dolci se li è apparecchiati tutti sul tavolino del salotto, un ambiente luminosissimo. Allineati in bell’ordi-ne, con i post-it gialli infilati nelle pagine che a lui parlano di più. Edizioni Einaudi, edizioni Sellerio, edizioni Mesogea, «una delle poche belle realtà messinesi». Di fronte, sulla parete, un ritratto di due ragazzi dall’autore impossibile, Pier Paolo Pasolini. Nella casa milanese di Vincenzo Consolo c’è letteratura ovunque.
«Ho riletto Banditi a Partinico e mi è venuta l’angoscia.
Angoscia a rileggere di quella mortalità infantile. Bambini senza cure per le infezioni, bambini senza latte. Ho riprovato la spinta a conoscere e a sapere che mi ha animato da ragazzo nella mia Sicilia, quando a quelle letture mi si aprivano mondi che non conoscevo. Io di Sant’Agata di Militello, zona non di feudi ma di piccola proprietà contadina, provavo una grande curiosità di sapere tutto della Sicilia occidentale. Andavo anche a Messina, certo, alla libreria D’Anna. Ma andavo con uno spirito particolare alla libreria Flaccovio di Palermo, che aveva anche le sue edizioni. Viaggiavo sempre in treno.
Un giorno andai a trovare Danilo Dolci, un mito per molti di noi, era il ’55 o il 56. Mi accolse nel suo studio e mi fece tantissime domande. Volle sapere dei miei studi, mi parlò di Nomadelfia, la comunità fondata nel dopoguerra da don Zeno Saltini in Toscana, vicino Grosseto, in cui lui aveva lavorato.
Io gli raccontai della mia vita in università a Milano. Dei miei anni in piazza Sant’ Ambrogio, dove accanto alla caserma della Celere c’era il Centro orientamento immigrati. Ci arrivavano da ogni regione del sud per essere smistati verso il centro Europa: la Svizzera, il Belgio, la Francia, mentre quelli che andavano in Germania venivano smistati a Verona. Gliela descrissi, Sant’ Ambrogio, come allora appariva a me. Una specie di piazza dei destini incrociati: meridionali i poliziotti della Celere, meridionali le braccia in cerca di un lavoro in fabbriche o miniere straniere. Gli parlai anche della signorina Colombo, la mia padrona di casa, tutta vestita di nero e che si esprimeva sempre in dialetto. Due sue nipoti erano scappate a Nomadelfia. E ovviamente questo lo incuriosì molto. Dietro di sé, alle sue spalle, teneva un quadro particolare: una lettera di minacce, l’immagine di una pistola da cui uscivano dei proiettili. Gliel’aveva mandata la mafia e lui l’aveva incorniciata. Feci anche amicizia con alcuni dei volontari che collaboravano con lui. Ricordo un urbanista, in particolare. Si chiamava Carlo Doglio. Bolognese ma lavorava all’Università di Palermo. Faceva l’assessore a Bagheria, era un militante del Psiup. Dormii da lui una notte e al mattino, quando feci per uscire di casa, mi tirò indietro per la camicia e mi ammoni a guardare bene a destra e a sinistra prima di mettere fuori la faccia. Bagheria era così: il luogo delle ville magnifiche dei nobili feudatari, villa Alliata e villa Palagonia, dove i mafiosi cercavano di farsi strada a colpi di grandi speculazioni e di violenza.
Ci vedemmo ancora, anche perché lui viaggiava molto per il mondo, faceva un’attività di conferenziere intensissima.
Venne una volta a Milano. Si era sposato con Vincenzina, che aveva già dei figli, lui ne ebbe altri ancora. Ricordo che avevano dei nomi singolarissimi: Libera, Sole, Amico… Ci trovammo e lui mi propose tutto un programma da realizzare per la Sicilia. Affascinante, senz’altro. Ma io mi limitai ad andare a fare qualche conferenza, poi mi arenai. In ogni caso Dolci riuscì a riunire intorno a sé bellissime persone. Era il suo progetto che attirava, insieme al suo carisma. Già ho detto di Doglio l’urbanista. Ma c’era anche Vincenzo Borruso, al quale rimasi molto legato. Un medico d’avanguardia, paler-mitano, autore del primo libro-inchiesta sull’aborto, L’aborto in Sicilia si chiamava. Storie di prezzemolo, storie di morti assurde. Da lui andò a fare il volontario anche Goffredo Fofi, che insegnava alle scuole elementari di Cortile Cascino a Palermo e poi lo raggiunse a Partinico. Ricordo che aveva partecipato allo sciopero all’incontrario, che era poi una delle invenzioni tipiche di Dolci: voleva dire fare una strada o una trazzera non autorizzate. Fofi venne espulso dalla Sicilia che aveva appena diciott’anni, con tanto di foglio di via obbliga torio. Seminavano bene, i collaboratori di Dolci. Ricordo u incontro proprio con Fofi a Palermo negli anni Ottanta. Credo che fossimo li per presentare qualche libro. Fatto sta che ritrovammo al Papireto, al famoso mercatino delle pulci C’era un negozietto di antiquariato, l’insegna portava sori un nome e Goffredo esclamò: «Ma questo era mio alunno>> Girammo un po’ alla sua ricerca, e alla fine arrivò un giovanotto che gli andò incontro abbracciandolo: «Goffredo!». Era davvero lui, il suo alunno.
Dolci si distingueva per la sua intelligenza. Acuta, lungimi-rante, nutrita della materialità delle cose che faceva. Ricordo la sua distinzione tra potere e dominio, per esempio, che era uno dei capisaldi della sua riflessione. Oppure quella, che sembra fatta a pennello per i nostri tempi, tra comunicazione e trasmissione. Temeva i meccanismi della trasmissione, di questo fiume di parole e concetti e immagini che si muove in una direzione sola e che è in grado di istupidire un popolo. Non è forse quello che sta succedendo oggi? Lui d’altronde segnalò i problemi di Berlusconi appena il fondatore della Fininvest entrò in politica. Credo che fosse un paio d’anni prima di morire. Scrisse che a carico di Berlusconi c’erano fatti «molto gravi», «cose risapute anche dalla magistratura». Lo si trova su Una rivoluzione non violenta, pubblicato da Terre di mezzo.
Se dobbiamo considerarlo un rivoluzionario? Be’, noi, e non solo noi, lo chiamavamo il Gandhi italiano. Venivano persone da tutta Europa a conoscerlo, dormivano al centro studi, si offrivano di lavorare con lui come volontari. Quando usci, Banditi a Partinico suscitò un’ impressione enorme. Danilo conosceva la violenza del potere, e di quello mafioso soprat-tutto. Restò sconvolto quando a Trappeto un ragazzo di diciassette anni venne trovato morto in campagna “pezzi pezzi”, che vuol dire fatto letteralmente a pezzetti. Gli avevano sparato e poi l’avevano messo sui binari del treno, che lo aveva maciullato. Terribile, quest’uso fraudolento e assassino dei binari mi ricorda la morte di Impastato. Fra l’altro mi piace immaginare che qualcosa del lavoro di Dolci sia arrivato anche a lui, al giovane Peppino, visto che da studente negli anni Sessanta frequentava il liceo di Partinico e proprio li iniziò a partecipare alle manifestazioni. si, diciamo che Danilo era un rivoluzionario costretto a misurarsi non solo con la mafia ma anche con un altro potere repressivo, che della mafia, soprattutto allora, non era certo nemico. Quello dello Stato.
La ricordo bene la famosa triade della Sicilia repressiva di allora. Si componeva così: in testa c’era Mario Scelba, il ministro degli Interni di Portella delle Ginestre; poi c’era il prefetto di Palermo Angelo Vicari, che era del mio paese, Sant’Agata di Militello; e poi c’era il cardinale Ruffini, uomo dell’Opus Dei e ammiratore di Francisco Franco, il dittatore spagnolo. Anche lui aveva avuto a che fare con Portella delle Ginestre, nel senso che era andato a trovare Gaspare Pisciotta in carcere dopo l’omicidio a tradimento di Giuliano, e gli aveva raccomandato di non parlare. Un “uomo del Signore” indimenticabile. Sosteneva che le sciagure della Sicilia erano tre: il parlar di mafia, il Gattopardo, tutte e due perché gettavano discredito sulla Sicilia. E infine, per la medesima ragione, Danilo Dolci. Capito con chi aveva a che fare, Danilo? Per questo subì ogni tipo di sanzione. Venne più volte condanna-10, e perse anche qualche causa in tribunale per i suoi libri, lo ricordo perché pubblicava con Einaudi, con cui collaboravo.
Una specie di persecuzione.
Che invece non avvenne con Michele Pantaleone, un altro dei protagonisti dell’antimafia di quel periodo di cui oggi non si parla più, e ingiustamente, visto che furono sue le prime denunce circostanziate dei rapporti tra mafia e politica. Lui per i suoi libri alla fine fu prosciolto dalle accuse; chissà, forse era meno inviso al potere perché non faceva anche l’agitatore sociale. Scriveva ma non organizzava gli scioperi all’incontrario o le lotte per la diga sul fiume Jato.
Quel che mi dispiace è che allora il Partito comunista abbia preso le distanze da Dolci. Che, pacifista com’era, lo considerasse quasi un disturbo per il verbo e la dottrina della rivoluzione. Assurdo, veramente assurdo. Perché Dolci era un segnale di luce, in quel panorama, una grande speranza. Il mondo della sinistra intellettuale e civile non di partito, naturalmente, ne aveva un’altra opinione. Ricordo un bellissimo ritratto che ne fece Giuliana Saladino, grande giornalista dell’Ora, in Terra di rapina. Ma anche Carlo Levi, che per la Sicilia di quegli anni girò molto, gli dedicò grande attenzione. E ricordo che, dopo il mio primo libro, mi capitò spesso di discutere con Sciascia dell’importanza della presenza di Danilo in quel contesto faticosissimo. Come dimenticare, d’altronde, quella straordinaria esperienza di Radio Sicilia Libera di Partinico, con cui cercò di sfondare tra i primi il monopolio dell’informazione radiotelevisiva, e per la quale pagò, di nuovo, prezzi personali? In fondo Danilo era una specie di missionario laico, come forse lo fu anche Pio La Torre. I suoi successori hanno nomi meno conosciuti, come quel fratel Biagio di via Archirafi a Palermo, laico pure lui, che accoglie i diseredati, o quel salesiano del Capo, don Baldassare. Oppure nomi assai più conosciuti e non laici: quelli di padre Pino Puglisi o di don Luigi Ciotti, per esempio.
Purtroppo il suo metodo di inchiesta sociale, il suo modo, diciamo così, di essere sociologo, non ha fatto molta scuola. Ricordo un prete valdese, Tullio Vinay si chiamava, che sull’esempio di Dolci era andato a Riesi, in provincia di Caltanissetta, e aveva messo su una scuola tecnica per i ragazzi, per poi mandare i migliori da Adriano Olivetti. E aveva pure fatto uscire le donne dalle case in cui stavano rinchiuse dando vita a una cooperativa di ricamatrici. Erano quegli stessi anni, i Cinquanta e i Sessanta. Vinay ne scrisse anche un libro, Giorni a Riesi, mi sembra. Poi, dopo un po’ di tempo, venne eletto in parlamento. Ma di altre esperienze analoghe non mi viene in mente. Ed è un peccato.
Quanto c’era di siciliano in Danilo Dolci? Non mi sembra la domanda giusta, o meglio, quella che ci aiuta a capirlo di più. Bisognerebbe chiedersi piuttosto quanto c’era di intelligenza e di umanità. E poi, sul piano della curiosità intellettuale, a me appassiona semmai un altro tema: quello dei figli dei ferrovieri. Mi affascina questa categoria di intellettuali nati da ferrovieri siciliani: Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo, lo stesso Dolci. Ci metto sopra d’istinto pure Pinelli, anche lui veniva dalla Sicilia. Probabilmente lì, in quella storia socia-le, i ferrovieri sono stati davvero l’aristocrazia della classe operaia, la componente popolare e del mondo del lavoro più consapevole.
Credo comunque che la storia di Danilo Dolci bisognerebbe metterla tutta in fila per poterla capire veramente. Figlio di ferroviere, intanto, abbiamo detto. Poi partecipa alla Resistenza, viene messo in carcere dai nazisti e scappa, va a Nomadelfia da don Zeno Saltini, quindi va a Partinico. E li le lotte sociali e quei bellissimi racconti di analfabeti e contadini scritti da un intellettuale coltissimo, che conosceva la letteratura russa, ma anche quella americana e quella tedesca, che scriveva poesie. E che aveva uno sguardo profondo e capace di andare lontano. No, tipi così non ne nascono spesso».
a cura di Nando dalla Chiesa
Milano 2010
Vincenzo Consolo e gli amici della lava nera
Vincenzo l’ho conosciuto nell’autunno 1968 a Zafferana Etnea, sotto il vulcano. Un paese a una ventina di chilometri da Catania, con una bella piazza, la parrocchiale, i caffè all’aperto, il mare lontano, come in uno scenario d’opera. Tutt’intorno vigne e castagni, in un paesaggio rotto soltanto da cimiteri di lava nera tra le ville fatiscenti degli ultimi baroni e i villini malcostruiti dei nuovi mastro don Gesualdo.
Vincenzo Consolo era piccino, biondo e di gentile aspetto. Qualche anno prima avevo letto “La ferita dell’aprile” incantato dalla sua felicità espressiva.
L’avevano pubblicato nel 1963 Niccolò Gallo e Vittorio Sereni che dirigevano “II Tornasole” di Mondadori, una collana di prestigio che, con “I gettoni” della Einaudi, diretti anni prima da Vittorini, avevano segnato il dopoguerra letterario.
Non era la solita opera prima, un romanzo, piuttosto, dove i caratteri del futuro scrittore erano già marcati, tra invenzioni del linguaggio, rifiuto della società incartapecorita, personaggi ribelli, rissa, idillio, beffa, amarezza e violenza, in un inarrivabile concerto comico.
Io ero un giovane giornalista precario. A Zafferana Etnea ero arrivato con l’incarico di scrivere per “Tempo illustrato” un articolo sul premio letterario “Zafferana-Brancati” che si proponeva come il rivoluzionario premio della contestazione. Il paese vantava lustri letterari. Gli scrittori siciliani erano venuti da sempre quassù – 574 metri sul mare – a villeggiare e a ripararsi dallo scirocco. Verga e Capuana davano il nome a una strada, De Roberto a una scuola, Brancati ricordava il paese in alcuni dei suoi libri, “Paolo il caldo”, il “Diario romano” e gli amministratori comunali, grati, gli avevano già dedicato una lapide nell’atrio del Municipio. Ora gli intitolavano anche il nuovo premio letterario. Erano riusciti a mettere in piedi una giuria di nomi illustri, Moravia, Paolini Dacia Maraini, Lucio Piccolo, Sciascia e Vincenzo Consolo, appunto. E poi un prete, critici, poeti e poetesse prevalentemente siciliani.
Conoscevo Moravia, Sciascia e Lucio Piccolo il barone poeta di Capo D’Orlando scoperto da Montale. Ero andato a intervistarlo anni prima, quando “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, suo cugino, aveva creato la moda dei principi di Sicilia e dei loro palazzi sontuosi. Intimidito, in mezzo a tutte quelle celebrità, con una frangetta sulla fronte, a Zafferana Etnea faceva pensare a un Beatle invecchiato. Indossava una giacca blu antiquata sotto cui spuntava una camicetta di seta blu a pois. Sembrava venuto dall’aldilà. C’era stata una gran bagarre al premio Zafferana-Brancati. Nella sala del Municipio gli animi dei giurati erano accesi, il 68 aveva incendiato il mondo, perfino i letterati si sentivano dietro le barricate. La discussione, pubblica, era punteggiata da un linguaggio allora corrente, un po’ grottesco in quelle bocche: contestazione, autocontestazione, potere culturale, potere decisionale, mozione, demistificazione, sistema, sistema, sistema, braccio di ferro con il potere, potere, potere, guerriglia, rivolta.
Poi i grandi temi dell’esistenza erano miserevolmente caduti come i castelli di sabbia costruiti dai bambini. E aveva vinto la famiglia allargata, il familismo amorale. Pasolini, con una studiata tecnica suadente, aveva proposto “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante. Subito seguito senza imbarazzi da Moravia che inizialmente aveva votato per un libro di Rossana Rossanda.
Sembrava una sceneggiata preparata con cura. “Il mondo salvato dai ragazzini” era un bel libro, ma la Morante era stata per decenni la moglie di Moravia. Ed era certo poco opportuno e anche non troppo decente una simile scelta per un premio che voleva essere rivoluzionario, diverso da tutti gli altri abituati a incoronare gli amici o gli autori delle case editrici dove i giurati pubblicavano i loro libri. Anche le mogli entravano ora nella rosa delle candidature -Sciascia era indignato. E con lui Consolo, due giurati, il prete.
Proponevano un altro bel libro, “Entromondo”, di Antonio Castelli, sugli emigranti siciliani, costruito sulle loro lettere alle famiglie. Il regolamento del premio prevedeva che per il vincitore occorressero i due terzi dei voti. ma la task-force Moravia-Pasolini, con affanno, o meglio con morbida violenza, sbaraglio i dissenzienti. Pasolini aveva tirato fuori la delega di Lucio Piccolo scappato nella sua villa tra gli aranceti e il cimitero dei cani. Poeti e letterati si erano aggregati, dolcemente impauriti, sotto il martellare delle parole del grande romanziere e del poeta maledetto. Ultima indispensabile conquista era stato il prete. Dalla teologia della liberazione ai desideri dei maggiorenti. La forza della cultura, la cultura della forza.
Al momento del verdetto, Vincenzo e io ci eravamo guardati e con un amaro ammicco ci erravamo intesi, “Eccoli qui i grandi inte llettuali della nazione, i fari del progresso sociale e civile” si dicevano le nostre occhiate. Da quel momento, credo diventammo amici.
A Milano ci vedevamo spesso. Abitavamo entrambi nel centro della città, lui lavorava alla Rai, io scrivevo sul “Giorno”, allora un grande quotidiano. Erano gli anni di piazza Fontana. La strage, subito dopo la bomba, aveva affratellato la comunità. Era stato troppo grave quel che era successo, i 17 morti pesavano anche sui cuori più duri. La paura si mescolava al coraggio, l’insicurezza alla volontà di resistere. Ogni giorno si rincorrevano voci minacciose, colpi di Stato, coi fantasmi di nuovi Bava Beccaris, mentre il processo della Banca nazionale dell’Agricoltura cominciava ad andare su e giù per l’Italia come una palla di neve che si gonfia, si squaglia per diventare alla fine acqua. Giustizia non fatta allora e oggi.
Vincenzo si sentiva ancora un immigrato. Era fuggito per salvarsi e si era salvato, ma chi poteva donargli ora le immagini, i colori, i sapori della terra natale amata e disamata? Quelle parole annotate da Goethe nel suo “Viaggio in Italia” il 13 aprile 1787 gli ronzavano nella testa: “Senza veder la Sicilia, non si può farsi un’idea dell’Italia. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto”. Era vero, non era vero quel pensiero del grande scrittore approdato a Palermo da soli 10 giorni?
Quella che veniva definita “la capitale morale” poteva ammorbi-dire la nostalgia per la terra dei gelsomini, delle rosse cupoline arabe, dell’incanto del mare color del vino? Milano allora era ricca di energie, popolata da intelligenze, da Raffaele Mattioli a Montale a Vittorio Sereni, a Mario Dal Pra, a Cesare Musati, a Franco Fortini a Giulio Natta a Franco Albini a Ernesto Rogers. La finanza, la letteratura la scienza, l’architettura. Che contraddizione tra il Sud abbandonato e irredimibile e quel Nord di speranza nonostante i traumi e le bombe: l’angoscia, il dolore dell’esilio, la fatica di vivere insieme e insieme la curiosità di conoscere il nuovo un nuovo mondo, il mondo operaio di Vittorini, di Volponi, tutto quanto non c’era in quell’isola immobile che aveva abbandonatogli facevano da contro canto. Era lontano il degrado di Milano a quel tempo.
Stava scrivendo, Vincenzo, dopo quel suo libro di giovinezza ricco di magia Vincenzo, dopo quel suo libro di giovinezza ricco di magia? Lui diceva di sì, ma non si spiegava, non si scopriva, impaurito. Per uno scrittore la seconda opera è uno scoglio difficile. inI genere i critici letterari sono più severi con il nuovo libro, le cui qualità non sono quasi mai paragonabili a quelle del primo.
Ci mise lo zampino il caso. Caterina, la moglie di Vincenzo, andò dal libraio Manusé a cercare un libro sul Settecento messinese da regalare al marito. Gaetano Manusé, siciliano di Valguarnera Caropepe, provincia di Enna, era arrivato a Milano nel dopoguerra e aveva impiantato una bancarella di ferro verde dietro l’abside della chiesa di San Fedele, a due passi dalla Scala. Intelligente, furbo, con un amore quasi ossessivo per i libri, aveva avuto già allora clienti illustri, Toscanini, Luigi Einaudi, Raffaele Mattioli, Eugenio Montale. Tra le sue mani erano passati libri preziosi, tra gli altri una vita di Alfieri postillata da Stendhal. Manusé uscì dalla sua garitta foderata di antiche mappe, trovò il libro per Caterina che conosceva e le chiese se suo marito aveva qualche scritto nel cassetto. “Si”, disse Caterina, “due capitoli di un romanzo che non vuole finire”.
Manusé mise in moto la sua immaginazione. Con finta ingenuità chiese a Consolo i due capitoli, chiese a Renato Guttuso un’acquaforte per illustrarli ed esaudì il sogno della vita, diventare editore. Nacque così “Il sorriso dell’ignoto marinaio” o meglio il suo prezioso frammento uscito dalla stamperia Valdonega di Verona, con l’incisione del pittore siciliano che raffigurava con tratti realistici il protagonista del romanzo.
“Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro , di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vivuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e a le vicende loro. E, avvertivasi in colui, la grande dignità di un signore.”
La letteratura più alta, il lacerto di un capolavoro in 150 esem-plari. Un romanzo storico di folgorante bellezza, protagonisti il barone Enrico Pirajno di Mandralisca – erudito, archeologo, mala-cologo, collezionista d’arte – e Giovanni Interdonato, avvocato, cospiratore democratico di sinistra, esule, magistrato, senatore del Regno d’Italia. Con loro braccianti, frati, mercanti, sbirri, banditi, pastori, negli ultimi anni del dominio borbonico, e anche dopo lo sbarco di Garibaldi, tra rivoluzioni liberali fallite, rivolte contadine, eccidi di massa, fucilazioni, tra Cefalù e Sant’Agata di Militello. I drammi della storia inclemente per gli uomini. Le loro cadute speranze.
Il 30 novembre 1975 scrissi un articolo sul “Giorno”: “Due siciliani pazzi per un libro unico” aveva per titolo.
Suscitò attenzione, creò curiosità. Le case editrici a quei tempi erano attente, non soltanto ai conti della spesa. Si fecero subito vivi con Consolo, Ernesto Ferrero della Einaudi e Mario Spagnol della Rizzoli. silente la Mondadori che, tra l’altro, aveva pubblicato “La ferita dell’aprile”. Dubbioso tra il gran nome che allora aveva la Einaudi e i sostanziosi assegni della Rizzoli, Consolo scelse la casa editrice di Torino, il catalogo della storia e della cultura nazionale dal 1933 a quegli anni.
Solo che adesso bisognava scrivere il resto del libro. Tutti lo tormentavano, anch’io.
Completò finalmente il terzo capitolo, “Morti sacrata”: un frate, ad Alcara Li Fusi scende dal suo eremo e incontra i contadini eccitati dallo sbarco di Garibaldi suscitatore di speranza perché promette terra e giustizia. Il frate profetizza una strage. E un capitolo intriso di dramma. 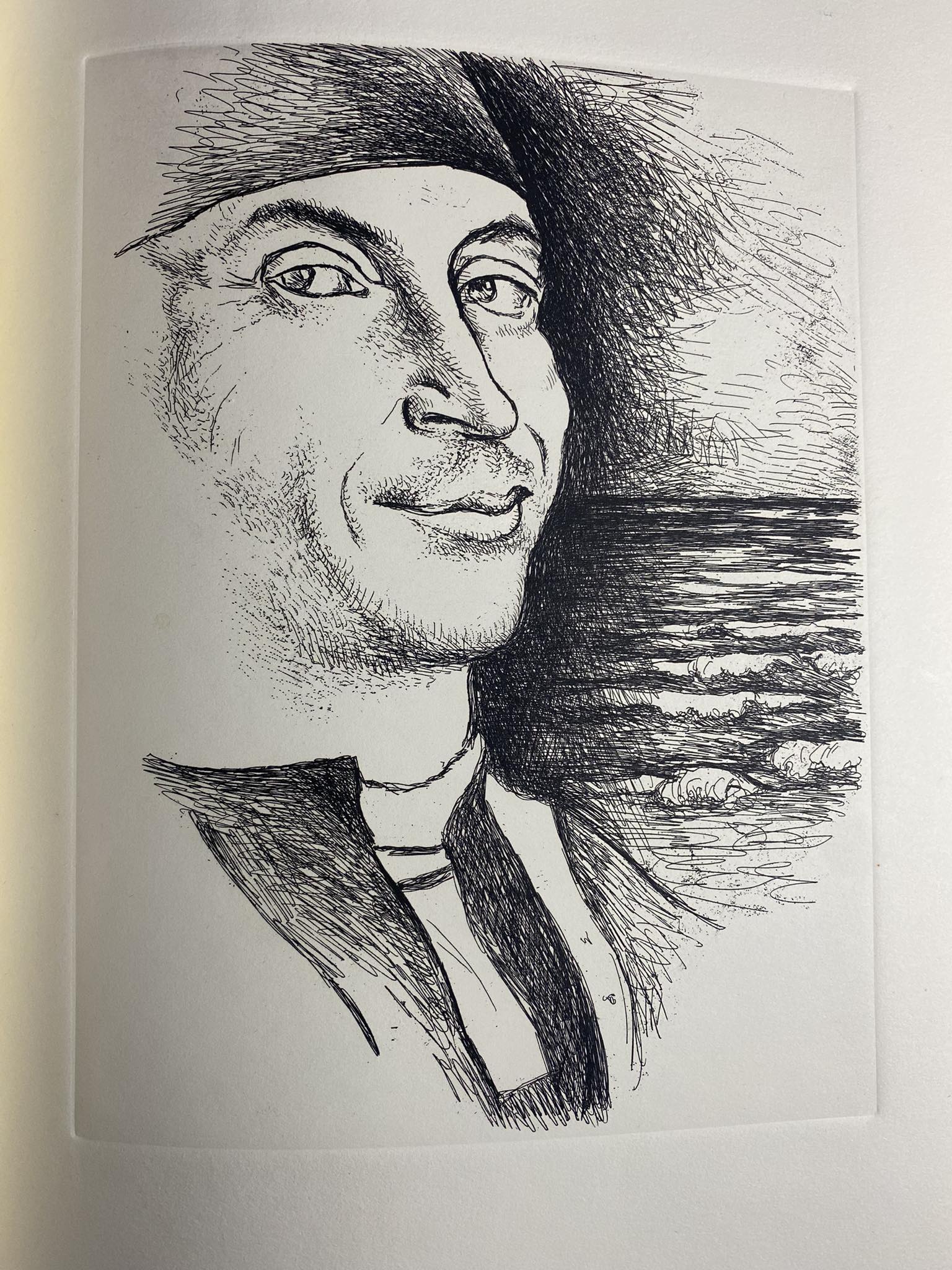
Vincenzo lo fa leggere a Caterina. Anche quelle pagine sono bellissime. Caterina si emoziona e insieme s’infuria. “E tu – gli dice – che sai scrivere in questo modo non hai la forza e il coraggio di finire il tuo libro?”
Le parole fanno presa. Vincenzo vince la paura di scrivere, lo scirocco dell’anima, il pudore. Tutto sa del suo “Sorriso” perchè in quegli anni non ha fatto che studiare e pensare al romanzo. Nella mente ha chiaro come va costruito e strutturato. Si mette all’opera e scrive con straordinaria rapidità gli altri capitoli. Il sorriso dell’ignoto marinaio esce da Einaudi pochi mesi dopo, il 10 giugno 1976. Un meraviglioso libro. Inquietato dai tormenti.
CHISTA E’ ” A STORIA VERA
SCRITTA CU LU CARBUNI
SUPRA ‘A PETRA
CORRADO STAJANO
Microprovincia – Rivista di cultura diretta da Franco Esposito
n. 48 Gennaio-Dicembre 2010
foto di Giovanna Borgese
