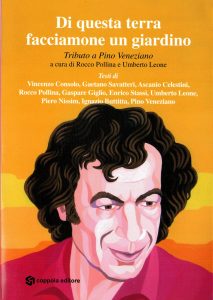Il romanzo di Vincenzo Consolo, Nottetempo, casa per casa, è tutto uno scatenarsi di follia.
Questa follia dilaga in una Sicilia antica, pastorale e agricola, splendida nei suoi monumenti medievali foderati di mosaici, imponente nei palazzi barocchi, pittoresca e tenebrosa nei vicoli brulicanti. E’ una follia dai molti volti, sempre a confronto con una natura vincitrice per la sua bellezza magica e indifferente, sue luci che non si curano di farsi strada negli animi.
Una natura dai cieli immensi, cui si contrappone la discesa in tenebrose caverne, ove i segni del tempo, si perdono tra le ombre. Pietro il protagonista, vive tra la licantropia del padre e la psicosi ossessiva della sorella. Personaggio positivo, condivide senza infatuazioni i programmi di rinnovamento politico e sociale che stanno velocemente, ma provvisoriamente, affermandosi: però anche li scopre le crepe dell’irrazionale e del fanatismo. Di contro al suo giudizioso rapporto con la pazzia, sta la funzione di condensatore di ogni sregolatezza mentale svolta da Aleister Crowley, l’inventore officiante di riti satanici in cui si mescolano alla promiscuità sessuale e alla droga tutte le invenzioni più stravaganti e kitsch di religioni e leggende esoteriche. Nella sua thélème di satiri e donne assatanate sono via via attratti il dannunziano barone Cicio e il pastore Janu.
Questo campionario di follia offertoci da Consolo sintetizza le manifestazioni dell’irrazionale che intorno al ’20, in Sicilia e altrove, invocando il fascismo in via di costituzione, vi trovarono poi un alveo. Era anche viva l’illusione di strapparsi a un’ indifferenza secolare, al sonno, alla noia: come una smania, un assillo verso qualcosa di agognato quanto sconosciuto. E la ricostruzione d’epoca è molto più sistematica di quanto non appaia a prima vista. Da un lato l’indolenza delle vecchie abitudini, il Circolo, i pettegolezzi di paese, i rapporti tra una nobiltà decaduta e pretenziosa e un popolo ancora primitivo. Dall’altro le nuove mode, le réclames con pizzichi di esotismo, l’esibizione di parole francesi e inglesi, le marche dei prodotti appena commercializzati, i compiacimenti dannunziani, la Florio. Fitti perciò gli inserti materici nella prosa d’arte di Consolo. Anche Aleister Crowley è un personaggio strico; suoi i versi inglesi riportati nei capitoli dedicatigli. Deve aver affascinato lo scrittore spingendolo a raccogliere notizie e dicerie su di lui: e certo subirono il suo fascino i molti che vennero a conoscenza o a contatto con questo santone attirati secondo i casi dall’aura misteriosofica o profetica di cui si circondava o dalla dissolutezza sua e dei suoi seguaci. Inglese o americano, Anticristo, mormone o quacchero, è facile credere che abbia sbalordito il chiuso ambiente in cui venne a sistemarsi.
Con questo mirabile romanzo si fa ancora più chiaro il programma svolto da Consolo nel ciclo della sua narrativa: rappresentare la Sicilia in varie fasi della sua storia, da quella greca riscoperta in frammenti enigmatici (Le pietre di Pantalica) alla dominazione spagnola (Lunaria) al settecento illuministico (Retablo)
al risorgimento e all’unità malamente realizzata (Il sorriso dell’ignoto marinaio). E per ottenere il necessario straniamento, analogo a quello operato dallo scrittore di Sant’Agata Di Militello, fungono da testimoni o pietre di paragone dei forestieri: il vicerè di Sicilia o il cavaliere e artista lombardo Fabrizio Clerici, ora il mistificatore inglese. Lo stile barocco, fitto di sicilianismi, fornisce il coinvolgente e inconfondibile colore locale, sovrastorico sinché non si apre a parole precisamente, significativamente connotate, lirico sinchè non discende con efficacia alla corposa quotidianità.
Ho appena parlato di narrativa, ma occorre chiarire. Consolo sempre aborrito il raccontare filato, la trama in senso tradizionale. Egli procede con una successione di scene sintomatiche, rivelandone i nessi con la riapparizione dei personaggi e segnalandone il tono con i ben scelti eserghi. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio, brani di opere storiche intercalati alle scene fornivano le notizie attestandone la verità. Sotto questo riguardo, Nottetempo, casa per casa è l’opera che si avvicina di più a un romanzo, dato il forte nesso fra le scene allineate nei dodici brevi capitoli e l’eterna presenza di pochi personaggi in fasi diverse della loro vicenda.
Anche Petro, alter ego dello scrittore, ha la sua vena di pazzia: vede i protagonisti dei romanzi che divora nei pochi momenti liberi, parla con loro interrompendo il silenzio delle sue letture. Questa pazzia positiva sembra essere la provvisoria catarsi proposta da Consolo. Una catarsi drammatica perché pare irraggiungibile (<<intinge la penna nell’inchiostro secco, nel catrame del vetro, nei pori della lava, nei grumi dell’ossidiana, cosparge il foglio di polvere, di cenere , un soffio, e si rivela il nulla, l’assenza d’ogni segno, rivela, l’impotenza, l’incapacità di dire, di raccontare la vita, il patimento>>); ma Petro alla fine si sa maturo per attingere le parole, il tono, la cadenza, per sciogliere il grumo dentro e dare ragione a tanto dolore.
Questa decisione di testimoniare, non solo i fatti ma i tumulti del sentimento, è formulata da Petro all’arrivo in Tunisia. Perché anche la topografia del romanzo si allarga progressivamente: da Cefalù e Palermo ai remoti paesi delle peregrinazioni di Crowley, da una Sicilia profonda, verghiana, a un’Europa atteggiata secondo un gusto dannunziano e liberty, Una topografia in cui irrompono deformandosi, le nuove idee, e l’impazienza rivoluzionaria si attua in velleitarie azioni terroristiche, mentre i fascisti fanno le loro scorrerie. Infine, Petro riesce a attuare lo strappo: lascia in nave la sua Sicilia dov’è in pericolo, emigrante più che esule, scettico verso i programmi di lotta enunciati dall’anarchico Schicchi che lo accompagna. La scelta della scrittura è, insieme, una lucida rinuncia a una vittoria.
Cesare Segre
Microprovincia gennaio – dicembre 2010
Tag: Vincenzo Consolo
Vincenzo Consolo e gli amici della lava nera
Vincenzo l’ho conosciuto nell’autunno 1968 a Zafferana Etnea, sotto il vulcano. Un paese a una ventina di chilometri da Catania, con una bella piazza, la parrocchiale, i caffè all’aperto, il mare lontano, come in uno scenario d’opera. Tutt’intorno vigne e castagni, in un paesaggio rotto soltanto da cimiteri di lava nera tra le ville fatiscenti degli ultimi baroni e i villini malcostruiti dei nuovi mastro don Gesualdo.
Vincenzo Consolo era piccino, biondo e di gentile aspetto. Qualche anno prima avevo letto “La ferita dell’aprile” incantato dalla sua felicità espressiva.
L’avevano pubblicato nel 1963 Niccolò Gallo e Vittorio Sereni che dirigevano “II Tornasole” di Mondadori, una collana di prestigio che, con “I gettoni” della Einaudi, diretti anni prima da Vittorini, avevano segnato il dopoguerra letterario.
Non era la solita opera prima, un romanzo, piuttosto, dove i caratteri del futuro scrittore erano già marcati, tra invenzioni del linguaggio, rifiuto della società incartapecorita, personaggi ribelli, rissa, idillio, beffa, amarezza e violenza, in un inarrivabile concerto comico.
Io ero un giovane giornalista precario. A Zafferana Etnea ero arrivato con l’incarico di scrivere per “Tempo illustrato” un articolo sul premio letterario “Zafferana-Brancati” che si proponeva come il rivoluzionario premio della contestazione. Il paese vantava lustri letterari. Gli scrittori siciliani erano venuti da sempre quassù – 574 metri sul mare – a villeggiare e a ripararsi dallo scirocco. Verga e Capuana davano il nome a una strada, De Roberto a una scuola, Brancati ricordava il paese in alcuni dei suoi libri, “Paolo il caldo”, il “Diario romano” e gli amministratori comunali, grati, gli avevano già dedicato una lapide nell’atrio del Municipio. Ora gli intitolavano anche il nuovo premio letterario. Erano riusciti a mettere in piedi una giuria di nomi illustri, Moravia, Paolini Dacia Maraini, Lucio Piccolo, Sciascia e Vincenzo Consolo, appunto. E poi un prete, critici, poeti e poetesse prevalentemente siciliani.
Conoscevo Moravia, Sciascia e Lucio Piccolo il barone poeta di Capo D’Orlando scoperto da Montale. Ero andato a intervistarlo anni prima, quando “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, suo cugino, aveva creato la moda dei principi di Sicilia e dei loro palazzi sontuosi. Intimidito, in mezzo a tutte quelle celebrità, con una frangetta sulla fronte, a Zafferana Etnea faceva pensare a un Beatle invecchiato. Indossava una giacca blu antiquata sotto cui spuntava una camicetta di seta blu a pois. Sembrava venuto dall’aldilà. C’era stata una gran bagarre al premio Zafferana-Brancati. Nella sala del Municipio gli animi dei giurati erano accesi, il 68 aveva incendiato il mondo, perfino i letterati si sentivano dietro le barricate. La discussione, pubblica, era punteggiata da un linguaggio allora corrente, un po’ grottesco in quelle bocche: contestazione, autocontestazione, potere culturale, potere decisionale, mozione, demistificazione, sistema, sistema, sistema, braccio di ferro con il potere, potere, potere, guerriglia, rivolta.
Poi i grandi temi dell’esistenza erano miserevolmente caduti come i castelli di sabbia costruiti dai bambini. E aveva vinto la famiglia allargata, il familismo amorale. Pasolini, con una studiata tecnica suadente, aveva proposto “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante. Subito seguito senza imbarazzi da Moravia che inizialmente aveva votato per un libro di Rossana Rossanda.
Sembrava una sceneggiata preparata con cura. “Il mondo salvato dai ragazzini” era un bel libro, ma la Morante era stata per decenni la moglie di Moravia. Ed era certo poco opportuno e anche non troppo decente una simile scelta per un premio che voleva essere rivoluzionario, diverso da tutti gli altri abituati a incoronare gli amici o gli autori delle case editrici dove i giurati pubblicavano i loro libri. Anche le mogli entravano ora nella rosa delle candidature -Sciascia era indignato. E con lui Consolo, due giurati, il prete.
Proponevano un altro bel libro, “Entromondo”, di Antonio Castelli, sugli emigranti siciliani, costruito sulle loro lettere alle famiglie. Il regolamento del premio prevedeva che per il vincitore occorressero i due terzi dei voti. ma la task-force Moravia-Pasolini, con affanno, o meglio con morbida violenza, sbaraglio i dissenzienti. Pasolini aveva tirato fuori la delega di Lucio Piccolo scappato nella sua villa tra gli aranceti e il cimitero dei cani. Poeti e letterati si erano aggregati, dolcemente impauriti, sotto il martellare delle parole del grande romanziere e del poeta maledetto. Ultima indispensabile conquista era stato il prete. Dalla teologia della liberazione ai desideri dei maggiorenti. La forza della cultura, la cultura della forza.
Al momento del verdetto, Vincenzo e io ci eravamo guardati e con un amaro ammicco ci erravamo intesi, “Eccoli qui i grandi inte llettuali della nazione, i fari del progresso sociale e civile” si dicevano le nostre occhiate. Da quel momento, credo diventammo amici.
A Milano ci vedevamo spesso. Abitavamo entrambi nel centro della città, lui lavorava alla Rai, io scrivevo sul “Giorno”, allora un grande quotidiano. Erano gli anni di piazza Fontana. La strage, subito dopo la bomba, aveva affratellato la comunità. Era stato troppo grave quel che era successo, i 17 morti pesavano anche sui cuori più duri. La paura si mescolava al coraggio, l’insicurezza alla volontà di resistere. Ogni giorno si rincorrevano voci minacciose, colpi di Stato, coi fantasmi di nuovi Bava Beccaris, mentre il processo della Banca nazionale dell’Agricoltura cominciava ad andare su e giù per l’Italia come una palla di neve che si gonfia, si squaglia per diventare alla fine acqua. Giustizia non fatta allora e oggi.
Vincenzo si sentiva ancora un immigrato. Era fuggito per salvarsi e si era salvato, ma chi poteva donargli ora le immagini, i colori, i sapori della terra natale amata e disamata? Quelle parole annotate da Goethe nel suo “Viaggio in Italia” il 13 aprile 1787 gli ronzavano nella testa: “Senza veder la Sicilia, non si può farsi un’idea dell’Italia. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto”. Era vero, non era vero quel pensiero del grande scrittore approdato a Palermo da soli 10 giorni?
Quella che veniva definita “la capitale morale” poteva ammorbi-dire la nostalgia per la terra dei gelsomini, delle rosse cupoline arabe, dell’incanto del mare color del vino? Milano allora era ricca di energie, popolata da intelligenze, da Raffaele Mattioli a Montale a Vittorio Sereni, a Mario Dal Pra, a Cesare Musati, a Franco Fortini a Giulio Natta a Franco Albini a Ernesto Rogers. La finanza, la letteratura la scienza, l’architettura. Che contraddizione tra il Sud abbandonato e irredimibile e quel Nord di speranza nonostante i traumi e le bombe: l’angoscia, il dolore dell’esilio, la fatica di vivere insieme e insieme la curiosità di conoscere il nuovo un nuovo mondo, il mondo operaio di Vittorini, di Volponi, tutto quanto non c’era in quell’isola immobile che aveva abbandonatogli facevano da contro canto. Era lontano il degrado di Milano a quel tempo.
Stava scrivendo, Vincenzo, dopo quel suo libro di giovinezza ricco di magia Vincenzo, dopo quel suo libro di giovinezza ricco di magia? Lui diceva di sì, ma non si spiegava, non si scopriva, impaurito. Per uno scrittore la seconda opera è uno scoglio difficile. inI genere i critici letterari sono più severi con il nuovo libro, le cui qualità non sono quasi mai paragonabili a quelle del primo.
Ci mise lo zampino il caso. Caterina, la moglie di Vincenzo, andò dal libraio Manusé a cercare un libro sul Settecento messinese da regalare al marito. Gaetano Manusé, siciliano di Valguarnera Caropepe, provincia di Enna, era arrivato a Milano nel dopoguerra e aveva impiantato una bancarella di ferro verde dietro l’abside della chiesa di San Fedele, a due passi dalla Scala. Intelligente, furbo, con un amore quasi ossessivo per i libri, aveva avuto già allora clienti illustri, Toscanini, Luigi Einaudi, Raffaele Mattioli, Eugenio Montale. Tra le sue mani erano passati libri preziosi, tra gli altri una vita di Alfieri postillata da Stendhal. Manusé uscì dalla sua garitta foderata di antiche mappe, trovò il libro per Caterina che conosceva e le chiese se suo marito aveva qualche scritto nel cassetto. “Si”, disse Caterina, “due capitoli di un romanzo che non vuole finire”.
Manusé mise in moto la sua immaginazione. Con finta ingenuità chiese a Consolo i due capitoli, chiese a Renato Guttuso un’acquaforte per illustrarli ed esaudì il sogno della vita, diventare editore. Nacque così “Il sorriso dell’ignoto marinaio” o meglio il suo prezioso frammento uscito dalla stamperia Valdonega di Verona, con l’incisione del pittore siciliano che raffigurava con tratti realistici il protagonista del romanzo.
“Il Mandralisca si trovò di fronte un uomo con uno strano sorriso sulle labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro , di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà. E gli occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia. Due pieghe gli solcavano il viso duro, agli angoli della bocca, come a chiudere e ancora accentuare quel sorriso. L’uomo era vestito da marinaio, con la milza di panno in testa, la casacca e i pantaloni a sacco, ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio: non aveva il sonnolento distacco, né la sorda stranianza dell’uomo vivente sopra il mare, ma la vivace attenzione di uno vivuto sempre sulla terra, in mezzo agli uomini e a le vicende loro. E, avvertivasi in colui, la grande dignità di un signore.”
La letteratura più alta, il lacerto di un capolavoro in 150 esem-plari. Un romanzo storico di folgorante bellezza, protagonisti il barone Enrico Pirajno di Mandralisca – erudito, archeologo, mala-cologo, collezionista d’arte – e Giovanni Interdonato, avvocato, cospiratore democratico di sinistra, esule, magistrato, senatore del Regno d’Italia. Con loro braccianti, frati, mercanti, sbirri, banditi, pastori, negli ultimi anni del dominio borbonico, e anche dopo lo sbarco di Garibaldi, tra rivoluzioni liberali fallite, rivolte contadine, eccidi di massa, fucilazioni, tra Cefalù e Sant’Agata di Militello. I drammi della storia inclemente per gli uomini. Le loro cadute speranze.
Il 30 novembre 1975 scrissi un articolo sul “Giorno”: “Due siciliani pazzi per un libro unico” aveva per titolo.
Suscitò attenzione, creò curiosità. Le case editrici a quei tempi erano attente, non soltanto ai conti della spesa. Si fecero subito vivi con Consolo, Ernesto Ferrero della Einaudi e Mario Spagnol della Rizzoli. silente la Mondadori che, tra l’altro, aveva pubblicato “La ferita dell’aprile”. Dubbioso tra il gran nome che allora aveva la Einaudi e i sostanziosi assegni della Rizzoli, Consolo scelse la casa editrice di Torino, il catalogo della storia e della cultura nazionale dal 1933 a quegli anni.
Solo che adesso bisognava scrivere il resto del libro. Tutti lo tormentavano, anch’io.
Completò finalmente il terzo capitolo, “Morti sacrata”: un frate, ad Alcara Li Fusi scende dal suo eremo e incontra i contadini eccitati dallo sbarco di Garibaldi suscitatore di speranza perché promette terra e giustizia. Il frate profetizza una strage. E un capitolo intriso di dramma. 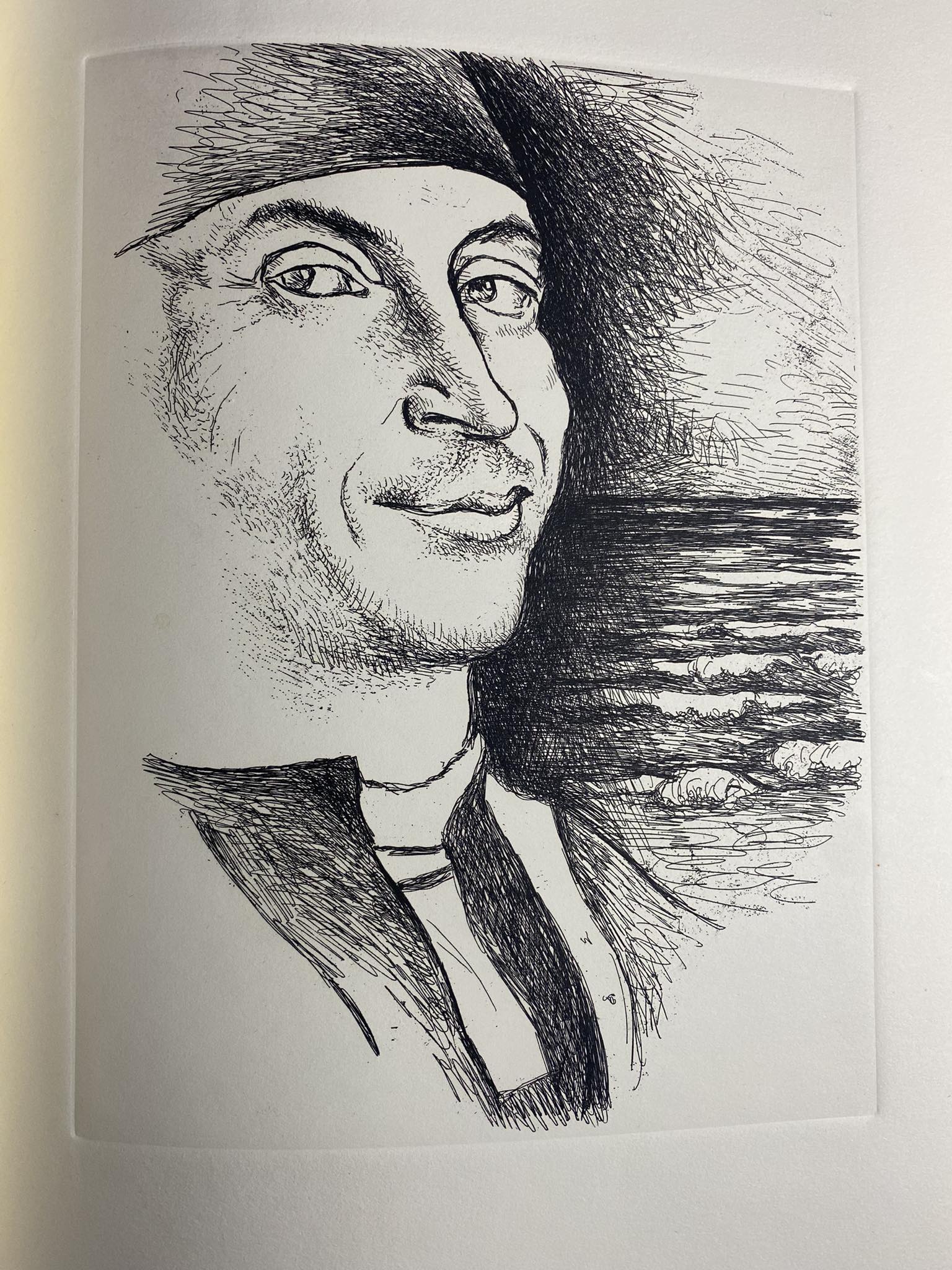
Vincenzo lo fa leggere a Caterina. Anche quelle pagine sono bellissime. Caterina si emoziona e insieme s’infuria. “E tu – gli dice – che sai scrivere in questo modo non hai la forza e il coraggio di finire il tuo libro?”
Le parole fanno presa. Vincenzo vince la paura di scrivere, lo scirocco dell’anima, il pudore. Tutto sa del suo “Sorriso” perchè in quegli anni non ha fatto che studiare e pensare al romanzo. Nella mente ha chiaro come va costruito e strutturato. Si mette all’opera e scrive con straordinaria rapidità gli altri capitoli. Il sorriso dell’ignoto marinaio esce da Einaudi pochi mesi dopo, il 10 giugno 1976. Un meraviglioso libro. Inquietato dai tormenti.
CHISTA E’ ” A STORIA VERA
SCRITTA CU LU CARBUNI
SUPRA ‘A PETRA
CORRADO STAJANO
Microprovincia – Rivista di cultura diretta da Franco Esposito
n. 48 Gennaio-Dicembre 2010
foto di Giovanna Borgese

Pino Veneziano e la canzone polpolare
E LA CANZONE POPOLARE
VINCENZO CONSOLO
Si sono perse le voci, e per sempre, dei poeti e dei cantori popolari di Sicilia, così come d’ogni altra regione o plaga di questo nostro paese, di questo nostro mondo d’oggi, assordato dai clamori imperiosi della violenza e della stupidità.
Voci, quelle, umane e melodiose che davano voce ai sentimenti e ai pensieri di un popolo, un popolo che gioiva soffriva dell’esistenza, soffriva della storia. Una catena sonora, quella popolare della Sicilia, che affondava l’origine sua nel più remoto tempo, nel tempo greco degli aedi e dei lirici. “La discendenza del canto popolare Siciliano dalla musica greca dell’epoca classica è una proposizione indiscutibile” scrive il musicologo Ottavio Tiby. Greco, si, il canto popolare siciliano, su cui però è passata la nenia lenta e profonda del deserto, del canto arabo vogliamo dire. Il “borghese” Alessio Di Giovanni, di Cianciana, per aver sentito una notte un carrettiere cantare il malioso canto che iniziava con il distico “Lu sunnu di la notti m’arrubbasti: / ti lu purtasti a dòrmiri cu tia”, si convertì al radicalismo dialettale, a scrivere tutte le sue opere, poesie romanzi, in siciliano. Canto arabo dunque, andaluso e gitano, che dall’Andalusia moresca passò in Sicilia e nel Napoletano, parole e suoni, quelli del canto popolare siciliano, che di generazione in generazione si tramandavano e si ricreavano, una musica popolare che fecondava e rinnovava la musica dotta. Abbiamo avuto per la prima volta cognizione di questo prezioso patrimonio culturale grazie all’opera del musicista e storico della musica Alberto Favara che, percorrendo paesi e villaggi dell’isola, trascrisse parole e note dei canti popolari, pubblicò, tra il 1898 e il 1923, il Corpus dei Canti delle terre e del mare di Sicilia, raccolta che completava, arricchiva anzi, le raccolte di soli versi dei folkloristi Vigo, Pitrè, Salomone Marino, Avolio, Amabile Guastella. Un lavoro in qualche modo simile a quello del Favara, ma già in epoca delle registrazioni meccaniche, ha fatto il poeta ed etnologo Antonino Uccello, il quale, nel momento della grande mutazione antropologica, vale a dire della fine della civiltà contadina, riuscì a registrare, dalle ultime voci superstiti, antichi canti popolari, e pubblicò, a cavallo degli anni sessanta, Canti del Val di Noto, Risorgimento e società nei canti popolari siciliani, Carcere e Mafia nei canti popolari siciliani.
Il Corpus del Favara trovava, quasi contemporaneamente, specularità nel Corpus di musiche popolari ungheresi di Bèla Bartòk e di Zoltan Kodàli. E intorno a quegli anni Federico Garcia Lorca pubblicava i “suoi” Canti gitani e andalusi. Il lavoro invece di Antonino Uccello si specchiava in quello svolto in Puglia da Ernesto De Martino, se non nell’Academiuta di lenga furlana, Poesia dialettale del novecento e Canzoniere italiano: antologia della poesia popolare di Pier Paolo Pasolini. Il quale, già nel 1972, così scriveva: “Non sussiste dubbio, comunque, che, salve le aree depresse, la tendenza del canto popolare nella nazione è a scomparire”. Aree depresse come la siciliana. E dunque le voci ultime e straordinarie di poeti e di cantori popolari: di Ignazio Buttitta, di Ciccio Busacca, di Rosa Balistreri, di Pino Veneziano. Autenticamente popolano, il Veneziano, picaro e gitano, dalla vita tormentata come quella di Rosa Balistreri. Ma, per ironia del caso, Pino portava lo stesso cognome del colto e grande poeta dialettale cinquecentesco Antonio Veneziano, l’autore de La Celia, dalla vita tormentata anch’egli, che ebbe la ventura di essere stato compagno di prigionia in Algeri di don Miguel de Cervantes.
Di povera famiglia, Pino, ancora fanciullo, è guardiano di capre nelle campagne di Sciacca, poi garzone di fornaio e quindi di bar, uno di quei lavoratori minorenni che a Palermo chiamavano “vaporta”, vai e porta. Agli inizi degli anni Sessanta, fa il cameriere in un ristorante di Selinunte. E a Marinella di Selinunte, in quella breve striscia di terra ai piedi della collina da cui s’alzano le colonne dei portentosi templi greci, si fa imprenditore, gestore di un ristorante insieme agli amici Jojò e Giacomino. E nel 1972, l’anno in cui Pasolini decretava la scomparsa del canto popolare in Italia, Veneziano impara a suonare la chitarra dal maestro zu’ Vicenzu Fasulu, detto Piricuddu. E nel suono della chitarra sgorgano i primi versi, la prima canzone: Lu Sicilianu, Il siciliano,”ca a tutti i banni chiamanu gitanu”, come nell’atroce Italia di oggi, piccolo borghese e neo-capitalistica, vengono chiamati spregiativamente marocchini tutti gli immigrati, maghrebini e no.
Non meliano e non arcadico, Pino Veneziano, ma nella linea buttittiana della consapevolezza storica dell’impegno civile. Da qui i suoi canti quali Lu patruni è suvecchiu, Nivuri su li bummi, La festa ddi li porci, Piazza di la Loggia, Allende, La Maffìa. Mentre Buttitta, e la stessa Balistreri, cantavano una Sicilia e un’Italia del Secondo dopoguerra, delle lotte contadine e dei sindacalisti uccisi dalla mafia, della seconda grande emigrazione nel centro Europa di masse di braccianti, Pino Veneziano cantava l’atroce Italia dei roventi anni Settanta, del regime democristiano, della corruzione e delle stragi perpetrate dai fascisti.
Ma c’era anche un Veneziano rapito cantore della bellezza della natura (Settembri), la natura forse ancora, là a Selinunte, delle lucciole pasoliniane. E un Veneziano cantore del rapinoso dei sentimenti umani, dell’amore: L’amuri, Ma dunni si tu?, Si tu nun veni, Non ti pozzu scurdà.
E forse un grande amore, travolgente, portò il povero Veneziano all’autodistruzione, alla rapida fine.
Ma rimangono, in questa plaga della più classica Sicilia, ancora vivi i tratti gitaneschi, le parole e la musica del Veneziano.
Di quel Veneziano che un giorno dell’84, là al Lido Azzurro, cantò per il vecchio e cieco poeta Jorge Luis Borges e lo commosse, il Borges che aveva cantato la milonga e il quartiere Palermo di Buenos Aires, la Palermo di Evaristo Carriego. Nella musica stanno, nelle corde / Della chitarra dal suono ostinato / Che trama nella milonga felice / La festa e l’innocenza del coraggio.
Di questa terra facciamone un giardino
Coppola Editore agosto 2009
Filosofiana ( relato de Las piedras de Pantalica ) Vincenzo Consolo
FILOSOFIANA (relato de Las piedras de Pantálica) VINCENZO CONSOLO 2ª edición, revisada y ampliada Edición, introducción, traducción y notas de Irene Romera Pintor Este libro ha sido editado con la ayuda financiera de la Fundación Caja Murcia, gracias a la gestión cultural del Director de la Sucursal de Caja Murcia de Puerto Lumbreras (años 2009 y 2010). Colaboran asimismo en la presente edición el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona y el Centro Giacomo Leopardi de Valencia De la presente edición, introducción, traducción y notas: © Irene Romera Pintor. Todos los derechos reservados. © Vincenzo Consolo. Todos los derechos reservados. En las contraportadas: © de la fotografía de Vincenzo Consolo: Jordi Pla. © de la fotografía de Irene Romera Pintor: Juan Carlos Comas. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático. Fundación Updea Publicaciones Barceló 1º, 28004 Madrid www.updea.org Segunda edición, 2011 Depósito legal: M-40467-2011 ISBN: 978-84-615-4082-2 Impreso en España A Vincenzo Consolo, por sus 75 años, en el vigésimo aniversario de las Piedras de Pantálica. (1ª edición 2008) A la ciudad de Lorca, tierra de mi padre, como homenaje a su gente y a su habla. (2ª edición 2011) ÍNDICE Pág Prólogo a la segunda edición ………………………………………………………………….. 9 INTRODUCCIÓN I. Estudio de “Filosofiana” ……………………………………………………………………… 13 I. a.Un relato de Vincenzo Consolo: “Filosofiana” ……………………………… 13 I. b.Los retos de la traducción de “Filosofiana” …………………………………… 19 II. Los regionalismos y su correspondencia ……………………………………………… 23 III. Referencias de citas bibliográficas ……………………………………………………… 27 IV. Recensiones sobre Le pietre di Pantalica …………………………………………….. 31 FILOSOFIANA I. Nota al Texto …………………………………………………………………………………….. 36 II. Nota a la Traducción …………………………………………………………………………. 37 III. “Filosofiana” ……………………………………………………………………………………. 39 IV. Relación comentada de regionalismos y otros matices del texto …………… 64 APARATO BIBLIOGRÁFICO I. Obra de Vincenzo Consolo ………………………………………………………………… 93 II. Traducciones de la obra de Vincenzo Consolo …………………………………….. 97 III. Premios y Reconocimiento a la obra de Vincenzo Consolo …………………. 103 IV. Trabajos de investigación …………………………………………………………………. 105 V. Encuentros monográficos sobre Vincenzo Consolo ………………………………. 117 VI. Estudios críticos ………………………………………………………………………………. 125 ÍNDICE DE NOMBRES …………………………………………………………………….. 133 9 PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN Para esta segunda edición de “Filosofiana” no sólo se ha llevado a cabo una labor de revisión y ampliación de la primera, sino que se ha modificado el planteamiento mismo de la propia traducción, con lo que tanto el texto de la traducción, como consiguientemente el glosario de términos y regionalismos que aparecen en la misma, han sufrido una reforma sustancial. En lo referente al glosario de regionalismos y de otros matices relevantes de la traducción, dado que el número de entradas se ha visto incrementado considerablemente en relación con la primera edición, he preferido ofrecerlo por orden alfabético en esta segunda edición con objeto de facilitar y simplificar su manejo. Con ello también se evita la incómoda presencia de asteriscos, que en la primera edición destacaban –dentro del corpus de la traducción– cada uno de los términos comentados, con lo que no sólo se rompía la fluidez de la lectura, sino que también la hacían más dificultosa. Del mismo modo, el aparato bibliográfico ha sufrido una profunda transformación. Para esta segunda edición mi propósito ha sido ofrecer una relación bibliográfica lo más nutrida y completa posible. En este contexto, no puedo dejar de agradecer efusivamente a Cesare Segre la atenta lectura crítica –en Valencia– que otorgó a la primera edición (abril 2008) y el tiempo que me ha dedicado para la elaboración de la presente edición en octubre de 2008 y febrero de 2011, en Milán. He tenido muy presentes sus observaciones tanto en materia bibliográfica como en cuestiones lingüísticas. Por último agradezco muy sinceramente a Vincenzo y Caterina Consolo que me abrieron las puertas de su casa y de su archivo. Le estoy particularmente agradecida a Caterina Consolo por mi estancia en octubre de 2008 y por las sesiones de trabajo en septiembre, octubre y noviembre de 2010, así como febrero y junio de 2011. La consulta con el autor ha sido imprescindible para perfilar matices traductológicos y para elaborar el “Aparato Bibliográfico”. Valencia, septiembre de 2011. INTRODUCCIÓN 13 I. ESTUDIO DE “FILOSOFIANA” I. a. Un relato de Vincenzo Consolo: “Filosofiana” “Filosofiana” es el séptimo de los quince relatos que componen el libro Le pietre di Pantalica (Las piedras de Pantálica), publicado en 1988. Consolo no era ya ciertamente un desconocido en los ambientes literarios italianos y europeos. El éxito de Il sorriso dell’ignoto marinaio, traducido inmediatamente a los principales idiomas, seguido unos años más tarde por Lunaria, en 1985, y por Retablo, en 1987, había creado un público expectante de lectores ávidos de saborear de nuevo una lengua de belleza, de recrearse con las resonancias, a la vez antiquísimas y nuevas, que despertaba en ellos el lenguaje consoliano, de recuperar una historia que creían sepultada y tomar conciencia de la necesidad de reaccionar contra el embrutecimiento material y moral que el mundo actual traía consigo, esa “distruzione e lo squallore: un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini” (Le pietre…, p. 166). No quedarían defraudados. Una vez más, Consolo vuelve a reavivar lo que Segre llamó acertadamente “su nostalgia del teatro”. Esta profunda sensibilidad de dramaturgo se manifiesta en su libro Le pietre di Pantalica al ofrecer de un lado la escenografía, de otro los personajes y por último la acción. Así, delimita cuidadosamente los contenidos de esta obra estructurándolos en tres grandes apartados intitulados: teatro, personas, acontecimientos. La primera parte (teatro) consta de siete relatos que presentan otros tantos escenarios de 14 los alrededores de Pantálica, antiquísima necrópolis desde los tiempos prehistóricos, situada en el corazón de la Magna Grecia. La naturaleza en este caso brinda al autor una escenografía de singular belleza en su austera grandiosidad. El séptimo y último relato de esta primera parte es precisamente “Filosofiana”. Nada es casual en Consolo. Tampoco el hecho de que esta pequeña joya de concisión cumpla a la perfección la regla de las tres unidades del teatro clásico: se desarrolla en un espacio de 24 horas, desde el alba de un día al alba del día siguiente, en un mismo lugar, los altos de Filosofiana, y con una misma acción, la búsqueda inicial de un tesoro, material para Vito Parlagreco y glorioso para don Gregorio Nànfara, acción única hasta el final del relato en que los dos protagonistas se quedan frente a frente sin haber conseguido el uno el oro, el otro la fama. Y en esa región de Filosofiana, o Sofiana, como se la conoce popularmente en Sicilia, surcada por cerros, montañas, valles y villas, cuyos nombres griegos dulces de repetir se convierten en versos1 , es donde Consolo va a situar a sus dos protagonistas. Pero también aquí, como en dos de sus obras anteriores, Il sorriso dell’ignoto marinaio y Retablo, estructura la coherencia interna de su libro por medio de una tupida red de ecos y reencuentros. Y es que Consolo mantiene a lo largo de su trayectoria literaria un personalísimo y constante sentido de la construcción narrativa. Procede por fragmentos, mezclando vivencias históricas y personales con personajes ficticios y documentos auténticos en sus obras. Así, cada una de ellas configura realmente las páginas de un único libro, recorrido por vibraciones y resonancias que se corresponden entre sí para gozo y disfrute de los iniciados, esos felici pochi que –al igual que los happy few de Stendhal– Consolo quiere como lectores. 1 Refundición de los versos de Salvatore Quasimodo, citados en Le pietre…, p. 123: “… Il cui nome greco / è un verso a ridirlo, dolce”. 15 Con una técnica narrativa casi de cámara cinematográfica2 Consolo presenta un largo primer plano de un hombre solitario, un campesino, con su mula y sus avíos de trabajo, que llega desde el valle al altiplano de Sofiana. Se desconoce todavía su nombre; sólo la voz en off del narrador omnisciente descubre los sueños de este labrador: uno cumplido, el haber logrado un retal de tierra aún lleno de piedras; el otro aún por cumplir, el sueño –que le hace reír de placer– de crear una casa suya llena de belleza, copia en pequeño de la mansión y de los jardines del rico terrateniente para el que había trabajado. Es de señalar la delicadeza de sentimientos de este labriego aún sin nombre. No es un sentimiento de envidia el que lo embarga, sino de admiración por la belleza. Sólo cuando el personaje se dispone a descansar, después de haber trabajado y rastrillado en su árido terreno, se descubre su nombre: Vito Parlagreco. Es entonces cuando el lector reencuentra a un viejo conocido. Vito ya había aparecido en el relato inmediatamente anterior a “Filosofiana”, “Ratumemi”, en el mismo libro Le pietre di Pantalica. Este relato se encuentra dividido en dos partes, separadas por la inclusión de documentos auténticos sobre los latifundios y hábitos de contratación de braceros. En “Ratumemi” Consolo había presentado con pequeñas pinceladas algunos rasgos del carácter de Parlagreco. Por tanto, al descubrir el nombre del labriego, bien entrada la lectura de “Filosofiana”, el lector sabe ya que este labrador es extremadamente delgado y que su aspecto famélico esconde una voracidad poco común. También sabe de la finura espiritual que subyace bajo su aspecto rudo. No es casual, en este sentido, su nombre y apellido, cargados intencionadamente de simbolismo. Vito era el nombre que elegían los primeros cristianos para expresar su esperanza en la vida eterna, al tiempo que Parlagreco 2 En 1992 Pasquale Scimeca llevó a la gran pantalla “Filosofiana” en su película Un sogno perso, film que se articula en torno a tres relatos, siendo el primero éste de Consolo. 16 atestigua la huella de la lengua hablada por sus antepasados, el griego. La cámara de Consolo se acerca enfocando de cerca y pone en primer plano a Vito almorzando. Influido por el silencio impresionante y su cansancio físico, Parlagreco va desgranando su hastío y desconcierto ante el misterio de la existencia humana. Sin embargo, Vito, haciendo honor a su nombre y alimentado desde niño por relatos de hallazgos fabulosos, abriga en su corazón un sueño de vida mejor: encontrar un tesoro de doblones de oro con el que su “vida de pesambres y de miedo” se torne en una de alegría y de sosiego. Y lo encuentra, o cree haberlo encontrado, al descubrir una antiquísima tumba llena de vasijas. En su ingenuidad, está convencido de que sólo necesita de una fórmula mágica para que su hallazgo se convierta en oro. Aquí entra en juego el segundo protagonista, que –éste sí– resulta desconocido para el lector: don Gregorio Nànfara. Su nombre y apellido también han sido cuidadosamente seleccionados por Consolo. Gregorio en griego significa el que está en vela, preparado para cualquier acción, al tiempo que Nànfara es un nombre siciliano que alude a una voz de timbre nasal. Consolo presenta aquí con gruesos trazos un arquetipo del típico charlatán, que se podía encontrar en cualquier pueblo hasta mediados del siglo pasado. En realidad un pobre hombre, aunque simpático, que sobrevive gracias a toda clase de expedientes, explotando la credulidad e ignorancia de las gentes del campo. A pesar de su pobreza y desaliño, es sin embargo respetado y admirado por la sencilla gente del pueblo debido a su supuesto conocimiento del griego y del latín, al prestigio de haber estudiado en la ciudad en un seminario y sobre todo a su ciencia esotérica, casi mágica, como demuestra su capacidad de detectar corrientes subterráneas en un país en donde el agua es un bien escaso. A él acude Vito Parlagreco para que emplee sus conocimientos en materializar el tesoro que prometía aquella tumba. El pícaro Don Gregorio, a cambio, consigue que el labriego le pague por adelantado mil liras por sus servicios. 17 Pero Consolo tiene reservada una última sorpresa. En paralelo al desconcierto que experimenta don Gregorio ante la tumba descubierta, aquí también el drama se torna farsa, burla escatológica. Esta burla cruel, a la que Vito Parlagreco y Gregorio Nànfara son sometidos, quiere ser metáfora –según me confirmó el autor– de la que sufrieron los campesinos sicilianos después de que el partido Blocco del Popolo, tras obtener la victoria en 1946, les hubiese asegurado el reparto de tierras. Tuvieron que presionar para ocuparlas hasta que finalmente, en 1950-1, les repartieron las peores (“questa terra ch’era ’na ciaramitàra, una distesa rossigna in groppa all’altopiano di cocci e di frantumi, pance culi manici di scifi, lemmi, di bombole e di giare”). Estos hechos se relatan en “Ratumemi”. De igual modo, en el relato de “Filosofiana”, Don Gregorio Nànfara fracasa en su encargo de materializar el oro a partir de los restos encontrados en la tumba y se las agencia para encontrar una justificación que lo exime de toda responsabilidad culpabilizando a Vito, que se había encontrado con un misterioso cabrero poco antes de descubrir la tumba. Parlagreco, abrumado por el sentimiento de culpa al no haber reconocido al duende tutelar guardián del tesoro en aquel pastor mudo que le regalara una liebre muerta, se traga junto con el vino el ojo de cristal que don Gregorio había dejado en un vaso. Nànfara lo va a retener en su casa, purgándolo con sal inglesa, hasta que el desgraciado lo restituya. Consolo trenza todo el relato de “Filosofiana” con dos hilos conductores: su ironía de raíz ática y su inmensa ternura. Ternura hacia el pobre Vito Parlagreco, ingenuo y bondadoso, y ternura también hacia el trafulla de don Gregorio, granuja de medio pelo, que acaba creyéndose sus propias argucias. Uno y otro son perdedores. Nànfara, por quedar desposeído de su ilusión de haber encontrado la auténtica tumba de Esquilo, descubrimiento con el que esperaba haber alcanzado la gloria. Y Parlagreco, por ser despojado de mil liras y “secuestrado” hasta que restituya el ojo de cristal de don Gregorio. 18 Así termina, con una carcajada, un relato envuelto en meditaciones poéticas y ensoñaciones de tiempos remotos, en donde no falta un toque de realismo mágico, que se materializa en la figura del cabrero. En el nombre de este muchacho –Tanatu– resuena la voz griega de “thanatos”3 (muerte), esa muerte que planea tan a menudo en los relatos de Consolo acompañando los sueños, la vida. Lo mismo que Segre habla de la “nostalgia del teatro” de Consolo, se podría hablar no ya de su nostalgia, sino de su vivencia de la vida como sueño, muerte y representación, tan anclada en su personalidad por la impronta, quizá inconsciente, del Barroco español en Sicilia4 . Aquel cabrero misterioso que aparece de improviso y desaparece tan veloz como inesperadamente, al igual que la muerte, ¿será en verdad un pastor de carne y hueso o el genio todopoderoso del cual dependía que el fango de las vasijas se convirtiese en oro? Y aquella voz surgida del fondo de las entrañas de la tierra, declamando un verso de Esquilo, ¿sería la de don Gregorio o la del propio poeta griego, que pedía ser 3 Como observó agudamente el profesor Fausto Díaz Padilla [cf. «“Filosofiana” o Cuando las piedras hablan», en La pasión por la lengua: Vincenzo Consolo (Homenaje por sus 75 años), ed. de I. Romera Pintor, Valencia, 2008, pp. 39-53 (véase en concreto la p. 40)], en el eco del diminutivo del nombre Gaetano, “Tanatu” –nombre del pastor–, resuena la palabra griega Thanatos que significa “muerte”, que es la sombra que planea en los altos de Filosofiana en este relato. Posteriormente, consultándolo con el propio autor, Consolo me confirmó que, en efecto, ésta había sido su idea para aureolar a este personaje del cabrero, algo misterioso, de un halo telúrico y arcano. 4 Cf. el prefacio a mi traducción de Lunaria, en la edición de 2003 (Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea) y Romera Pintor, I.: “Introduzione a Lunaria: Consolo versus Calderón”, en La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo. Giuliana Adamo (ed.), con una introducción de Giulio Ferroni, Manni («Studi, 99»), San Cesario di Lecce, 2006, pp. 161-176. Cf. asimismo Gianni Turchetta, introducción a Le pietre di Pantalica, “Oscar” Mondadori, Milán, 1990, pp. V-XIII. 19 honrado como hombre y no como dios? La respuesta queda abierta a cada lector. Pero lo que no deja lugar a dudas es la voz de Consolo que se hace paso a través de la de Parlagreco, una voz llena de belleza, que proclama los misterios arcanos y telúricos de una vieja tierra cargada de historia y, por ende, de memoria, para impregnar seres y paisajes de ese halo inconfundible, crisol de las civilizaciones que configuraron el Mare Nostrum y esencia de la esencia de Europa, que es la sicilianidad. I. b. Los retos de la traducción de “Filosofiana” Hasta la fecha sólo existen dos traducciones de Le pietre di Pantalica, obra de Vincenzo Consolo en la que se ubica el relato “Filosofiana”: en 1990 Maurice Darmon la tradujo al francés y en 1996 Anita Pichler lo hizo al alemán. Mi edición de “Filosofiana” de 2008 es, por consiguiente, la primera que ofrece la traducción del relato al español. Este hecho, con ser un privilegio, no deja de conllevar una enorme responsabilidad, tal y como se verá a continuación. A la hora de traducir “Filosofiana” he procurado respetar hasta el extremo la estructura lingüística, sintáctica y estilística del original. Conviene tener en cuenta que el uso del asíndeton, de la anáfora, de la yuxtaposición y de tantos otros recursos que recorren el texto de principio a fin tienen un alto valor estilístico y literario, y confieren al relato un sello de identidad propio del lenguaje de Vincenzo Consolo, que se caracteriza precisamente por su riqueza lingüística, por sus juegos de sonoridades y cadencias, por su léxico… por su belleza, en definitiva. Ha sido éste un tema que he consultado con el propio autor. La importancia de rendir en la traducción este sello de identidad consoliano me ha empujado a tratar el texto con el mayor respeto. No es fortuito el hecho de que, por ejemplo, haya conservado meticulosamente la misma puntuación. Ni son tampoco 20 fortuitas las construcciones sintácticas de la traducción, en las que he tratado de reproducir el mismo orden que en italiano. No cabe duda de que una traducción más libre y menos respetuosa con la lengua de origen habría optado en no pocas ocasiones por soluciones más asépticas y estandarizadas. Siguiendo en esta misma línea, y siempre con la idea de rendir la textura del original, he preferido siempre el vocablo más próximo por su sonoridad al del texto italiano, dentro del abanico de posibilidades que ofrecen las equivalencias al español. Este hecho responde una vez más a una voluntad consciente en el acto de traducir y no a una mera coincidencia lingüística. Así por ejemplo, no es fortuito el hecho de que haya optado por “candela” en lugar de “vela”, por “can” en lugar de “perro” o por “botijo” en vez de “cántaros” para traducir bombole. En definitiva, he elegido las voces más similares fonéticamente a las elegidas por Consolo, conservando las prioridades del regionalismo, así como el valor literario y culto de las mismas, pero privilegiando siempre la oralidad del discurso. No en vano la oralidad es un punto esencial en la escritura consoliana –quizá por aquella “nostalgia del teatro” a la que aludía Segre– y por consiguiente lo es también en su traducción. En definitiva, mi intención al traducir “Filosofiana” ha sido la de reproducir en la medida de lo posible el estilo, la sonoridad y la cadencia, así como las mismas construcciones lingüísticas y sintácticas del relato. Ahora bien, la decisión sin duda más arriesgada en mi trayectoria como traductora ha sido la de hacer corresponder los regionalismos sicilianos con los murcianos. La idea surgió al constatar las similitudes existentes entre las variantes lingüísticas de uno y otro. Este hecho no sorprende si se tiene en cuenta la proximidad geográfica del Levante español e Italia. La palabra que me llamó la atención en primer lugar –por su correspondencia casi exacta con su equivalente murciano– fue la de calipso, forma siciliana para “eucalipto”. La estructura del 21 término “eucalipto” se ha modificado en siciliano por medio de una metábole con aféresis, alteración que se recoge en el habla murciana casi literalmente (“calistro”). Todavía más significativo es el uso de algunos términos que desgraciadamente han caído en desuso tanto en España como en Italia, como “lampo” y “lastra”, pero que se siguen manteniendo vivos en los ambientes rurales de Sicilia y Murcia. Pero aún observé otras similitudes lingüísticas: el mismo rasgo que privilegia en ambas regiones el uso del pretérito simple sobre el compuesto, hecho que también se justifica por la proximidad geográfica del Levante español y Sicilia, así como por la identidad de sus raíces etimológicas, principalmente latinas con influencias árabes y también aragonesas en ambos casos. Sólo daré un ejemplo de la gratificante similitud e idéntica procedencia etimológica entre dos voces: “gebbia” y “aljibe”, que proceden del árabe clásico “gˇibb” y que comparten el mismo valor semántico. Estas equivalencias tan similares y llamativas me llevaron a estudiar la posibilidad de aplicar en todo el texto una correspondencia entre los regionalismos sicilianos y los murcianos. Aunque no fue la única razón porque, además de estas analogías lingüísticas, la narración transcurre en una región (Filosofiana) que me recordaba mucho a una tierra particularmente entrañable y querida para mí, la de Lorca, concretamente el “roalico” de Puerto Lumbreras, cuna de mi familia paterna, donde paso desde niña todos mis veranos y donde por consiguiente puedo vivir “in situ” sus gentes, sus sueños y empaparme de “viva voce” de su habla. Efectivamente, estas dos regiones, la siciliana y la murciana, se asemejan singularmente no sólo en su fisionomía física –altos planos que rodean pequeños valles– sino también en su historia. Ambas comparten civilizaciones sepultadas (fenicios, cartagineses, romanos, árabes…) y esconden en sus entrañas tumbas legendarias de personajes emblemáticos: la de Esquilo en Gela, la de los Escipiones en el Cabezo de la Jara. Ambas también mantuvieron vivas hasta mediados del siglo pasado la tradición de los “trovos”. 22 Fue así cómo finalmente –y tras una gratificante labor de investigación lingüística– me decidí a llevar a cabo la traducción de “Filosofiana” haciendo uso de los regionalismos murcianos. Con todo, en esta segunda edición he hecho un uso extensivo del habla murciana, aplicándola a todo el relato, aún cuando no se corresponda con un regionalismo siciliano en el texto original. Este nuevo planteamiento está más en consonancia con el espíritu y la dinámica global de la narración, así como con el ambiente rural que se describe y con el habla de los personajes. De este modo la presente edición recupera toda la plasticidad lingüística de las variantes regionales de esa lengua que en palabras de Vicente Medina “gana en dulzura y belleza conservando su tierno y delicado sabor local”, en estos momentos de depauperación cultural y lingüística donde los medios de comunicación están imponiendo una lengua estándar desprovista de color y sabor. Convenía, por tanto, recuperar estas voces ya olvidadas (“tanimientras”, “terretremo”, “escullir”, “lampo”, “lastra”, “pesambre”, etc.), imitando en eso a los franceses en la iniciativa seguida con entusiasmo por el gran público y lanzada por Bernard Pivot: “Sauvons un mot chaque jour”. En definitiva, a través del habla murciana, la presente traducción ofrece al lector español las mismas valencias cargadas de sorpresa y el mismo redescubrimiento de su propio idioma que Consolo brinda a su lector italiano. 23 II. LOS REGIONALISMOS Y SU CORRESPONDENCIA Conviene aclarar desde un principio que no existe una lengua murciana como tal. Existe desde luego una variedad de habla murciana o regionalismo murciano que se caracteriza precisamente por mantener rasgos morfo-sintácticos, fonéticos y léxicos del español antiguo, es decir del castellano, así como de otras lenguas con las que entraron en contacto, como el árabe (durante la dominación musulmana tras desmembrarse el reino visigodo), el aragonés (con la llegada de los religiosos aragoneses que predicaron en Murcia tras la Reconquista) y el catalán (la repoblación cristiana en Murcia era en su mayoría catalana). Pero la lengua de Murcia es hoy –y ha sido siempre– el español. En este sentido, resulta altamente significativo el hecho de que un buen número de vocablos que se recogen en los diccionarios de regionalismos murcianos o de hablas murcianas sean palabras españolas que con el tiempo han caído en desuso en casi toda España, pero que –muchas veces alteradas y modificadas– se conservan en Murcia, principalmente en las zonas rurales, así como en buena parte del Levante. Con ello ya queda señalado uno de los rasgos que mejor caracterizan este regionalismo: el de su conservadurismo lingüístico, su arcaísmo léxico, su sabor añejo. Es éste un rasgo que comparte el habla murciana con la siciliana y una de las razones que imprimen al texto de Consolo ese regusto de tiempos pretéritos evocado por el propio léxico, tan rico y sugerente, amalgama de voces actuales y vigentes, y a la vez de resonancias arcaicas, remotas, misteriosas. 24 Con todo, existe un gran número de alteraciones, principalmente fonéticas y morfológicas, propias del habla murciana. Lo que sin duda caracteriza la pronunciación de este regionalismo es la supresión de la “s” final (que viene a pronunciarse como una especie de “h” aspirada) y a menudo también de la “r” en final de palabra. En este contexto, conviene señalar que no he reflejado en la transcripción5 la aspiración de la “s” ni la pérdida de la “r” final con objeto de no perturbar la comprensión del relato, ya que una supresión gráfica sistemática de estas consonantes habría podido resultar desconcertante y provocar ambigüedades que pondrían en peligro la comprensión del texto. Sin embargo, no cabe duda de que ésta es la seña de identidad fonética del habla murciana. En cambio, sí que he reflejado en la traducción la supresión de la “d” intervocálica, tan extendida y tan típica del hablar murciano (“sío” por “sido”, “callaíco” por “calladico”, “comprendío” por “comprendido”, “parao” por “parado”, “múo” por “mudo”, etc.). También transcribo elisiones, como la de la “e” en la preposición “en” seguida de artículo (“n’el” por “en el”), la de “o” en “como”, o la de la “e” en la conjunción “que” y en la preposición “de” (“com’uno d’esos” por “como uno de esos”, “qu’era” por “que era”, etc.). Además de los vocablos que se consideran propiamente regionalismos, la inmensa mayoría del léxico que conforma el habla murciana está constituida por modificaciones o deformaciones de palabras vigentes en todo el territorio nacional. Son muchos los casos de aféresis, en que se suprime alguna letra o prefijo al inicio de la palabra («’tate» en lugar de “estate”), o bien aún en medio o al final de la palabra 5 Salvo en contadas ocasiones, como en «po’» y como en el poemilla, donde he suprimido gráficamente la “s” de “asponticos” y del verbo “es” para mejor transcribir el acento rural de la letrilla: (…) N’er Lanniri siet’aspontico’ / Sabucina e’ jarta d’oro (…). Por las mismas razones, sólo he transcrito la desaparición de la “r” final en contadas ocasiones, como “señó” por “señor”. 25 (“anque” por “aunque”, “custión” por “cuestión”, “señó” en lugar de “señor”). Son frecuentes asimismo la metátesis –en la que se altera el orden de los fonemas (“pedricar” por “predicar”, “naide” por “nadie”)– y otros metaplasmos en los que se alteran fonemas (“umbligo” por “ombligo”, “liopardos” por “leopardos”, “cimiterio” por “cementerio”, “nusotros” por “nosotros”, “semos” por “somos”, “dicir” por “decir, “mesmo” por “mismo”, ”uíste” por “oíste”), o en los que se contraen palabras (“ande” en lugar de “a dónde”). También son habituales las apócopes, que en ocasiones van acompañadas de mutaciones vocálicas («po’» en lugar de “pues”, «pa’» en lugar de “para”, «ca’» por “cada”, «to’» por “todo”, “quié” por “quiere”, “casá” por “casada”, “tiés” por “tienes”), así como todo tipo de añadidos fonéticos: prótesis al inicio de la palabra (“ajuntar”, “abajar”, “asentarse”), epéntesis en el interior (“muncho” por “mucho”, “lenjos” por “lejos”) y paragoges al final de la misma (“asín” por “así”, “sín” por “sí”). Muy típicos del habla murciana son igualmente dos sufijos que provienen del aragonés, “ico” (“puentecico”) y “uco” (“Vituco”), así como el sufijo “ujo-a” (“cosujas”). Finalmente, es muy frecuente también la mutación de la “l” por la “r” en los artículos seguidos de consonante (“er día” por “el día”, “ar cielo” por “al cielo”) y en no pocas palabras (“farta” por “falta”, “argo” por “algo”, “vorver” por “volver”, “curpa” por culpa”, etc.). Similares mutaciones se encuentran en el regionalismo siciliano: sufijo “uzzo” (“Vituzzo”), alteraciones de fonemas y letras (“cimiterio” en lugar de “cimitero”, “liopardo” en lugar de “leopardo”), contracciones y metaplasmos por supresión de fonemas (“vossi” en lugar de “vossignorìa”, «’gnorsì» en lugar de “signorsì”, “sto” en lugar de “questo”), etc. Por todo ello, el resultado de este uso del habla murciana en la traducción permite de un lado reflejar la compleja variedad lingüística del texto original y de otro enriquecer la versión española del relato a través de una variedad de matices, si no idénticos, cuando menos similares a los que el autor ha querido infundir a su obra. 27 III. REFERENCIAS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Diccionarios de regionalismos: Grosschmid, Pablo y Echegoyen, Christinna (1998): Diccionario de regionalismos, Barcelona, Editorial Juventud. Mortillaro, Vincenzo (1876): Nuovo Dizionario siciliano-italiano, Palermo [rist. anast. Palermo 1871, Vittorietti]. García Soriano, Justo (1980): Vocabulario del dialecto murciano, Murcia [facsímil de la 1ª edición de 1932]. Gómez Ortin, Francisco (1991): Vocabulario del Noroeste murciano, Murcia, Editora Regional. Ruiz Marín, Diego (2007): Vocabulario de las hablas murcianas. El español hablado de Murcia, Murcia, DM librero-editor. Vocabolario siciliano, vol. I (A-E) a cargo de G. Piccitto, CataniaPalermo 1977; vol. II (F-M) a cargo de G. Tropea, Catania-Palermo 1985; vol. III (N-Q), a cargo de Giovanni Tropea, Catania-Palermo 1990; vol. IV (R-Sgu-) a cargo de G. Tropea, Catania-Palermo 1997; vol V (Si-Z) a cargo de S. C. Trovato, Catania-Palermo 2002, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. 28 2. Diccionarios de consulta general: Barcia, Roque (1881-83): Primer diccionario general etimológico de la lengua española, Establecimiento tipográfico de Álvarez hermanos, Madrid. Battaglia, Salvatore, Grande Dizionario della lengua italiana, Turín, UTET, 1961 y ss. Corominas, Joan y Pascual, José Antonio, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980 y ss. DRAE = Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª edición (2001). De Mauro, Tullio (2005): Il dizionario della lingua italiana, Torino, Paravia. Lo Zingarelli (2002): Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli. MM = Moliner, María (2007): Diccionario del uso del español, Gredos. Sabatini-Coletti (2003): Il Sabatini-Coletti. Dizionario della lingua italiana, Milano, Rizzoli-Larousse. 3. Bibliografía general: Alvino, Gualberto (1998): Tra linguistica e letteratura. Scritti su D’Arrigo, Consolo, Bufalino. Introduzione di Rosalba Galvagno. Fondazione Antonio Pizzuto, Quaderni pizzutiani, Palermo. 29 García de Diego, Vicente (1964): Etimologías españolas, Aguilar. Ibarra Lario, Antonia (1996): Materiales para el conocimiento del habla de Lorca y su comarca, Universidad de Murcia, Murcia. Muñoz Garrigós, José (2008): Las hablas murcianas. Trabajos de dialectología. Edit.um, Murcia. Pitré, Giuseppe (2000): Grammatica siciliana. “Biblioteca delle tradizioni popolari”, Brancato Editore. Steiger, Arnold (1932): Contribución a la fonética del hispano árabe y de los arabismos en el ibero-románico y el siciliano, Madrid. 31 IV. RECENSIONES SOBRE LE PIETRE DI PANTALICA AÑO 1988 • Vico Faggi, “Dalla Sicilia con rimpianto”, Il Secolo XIX, 11-10-1988. • Sebastiano Addamo, “L’eterno ritorno di Consolo”, La Sicilia, 13-10-1988. • Francesco Mannoni, “Una Sicilia contadina magica e struggente”, Libertà, 15-10-1988. • Oreste Del Buono, “Sicilia con furore”, Panorama, 16-10-1988, pp. 134-7. • Guido Gerosa, “In magiche pietre scavate il paese dei sogni e della memoria di poeta”, Il Giorno, 16-10-1988. • Raffaeli Crovi, “Echi di Verga e Vittorini nella Sicilia necropoli di Consolo”, Italia oggi, 17-10-1988. • Giuseppe Amoroso, “La memoria che vagabonda dalla nobiltà alla barbarie”, La Gazzetta del Sud, 18-10-1988. • Renato Minore, “Care memorie”, Il Messaggero, 22-10-1988. • Giovanni Giudici, “Pietre di nostalgia”, L’Unità, 26-10-1988. • Maurizio Cucchi, “Consolo racconta una Sicilia ferita a morte”, La Stampa, 29-10-1988. • Natale Tedesco, “Viaggio tra felicità e orrore”, L’Ora, 29-10-1988. • Giovanni Giudici, “Consolazione in Sicilia”, L’Espresso, 30-10-1988. • Silvia Sereni, “Parole, immagini, colori di Sicilia”, Marie Claire, novembre, 1988. • Stefano Giovanardi, “Imbroglio siciliano”, La Repubblica, 02-11- 1988. • Giuseppe Bonura, “Com’è annebbiato il mito di Sicilia”, Avvenire, 05-11-1988. 32 • Natale Tedesco, “Scrivere è sogno e fuggire dalla vita”, Il Mattino, 08-11-1988. • Salvatore Nigro, “Un album siciliano sottratto alla rovina”, La Sicilia, 15-11-1988. • Giovanni Raboni, “Le pietre di Pantalica”, L’Europeo, nº 47, 18-11- 1988. • Ermanno Paccagnini, “Le pietre di Pantalica, frammenti di una civiltà”, Il Sole 24 Ore, 20-11-1988. • Mauro Bersani, “Le pietre perdute”, Corriere del Ticino, 03-12- 1988. • Claudio Marabini, “Un pasticciaccio alla siciliana”, Il resto del Carlino, 10-12-1988. • Eugène Mannoni, “L’ île mysterieuse”, L’Express, 21-12-1988. AÑO 1989 • R. Carbone, “L’ombra delle rovine”, L’Indice, nº 1, enero 1989, pp. 6-7. • Maria Sebregondi, “Le pietre di Pantalica”, Leggere, enero, 1989. • Gianni Turchetta, “Consolo: pietre e macerie. Il teatro del mondo e la nave degli orrori”, Linea d’ombra, nº 34, enero 1989, pp. 11-12. • Antonio Di Grado, “Amarezza e speranze”, La Sicilia, 6-01-1989. • Carmelo Depetro, “Parlando di Sicilia”, Ragusa sera, 28-01-1989. • Paolo Pogliani, “Le pietre di Pantalica”, Letture, febrero, 1989. • Andrea Zanzotto, “Consolo sospeso tra due Sicilie”, Corriere della Sera, 13-02-1989 (se publica también en Francia “Consolo entre deux Siciles”, Le Monde, 30-11-1990). 33 • Carlo Sgorlon, “Pietre che dicono cos’è la Sicilia”, Gazzettino di Venezia, 15-02-1989. • Romano Luperini, “Coniugando Verga e Gadda”, L’immaginazione, enero-marzo 1989. • Idolina Landolfi, “Sicilia patria perduta”, Il Giornale, 12-03-1989. • Luciano Satta, “Fra queste pietre il sussurro di un canto”, Il Giornale, 23-03-1989. AÑO 1990 • Nicola Di Gerolamo, “Il viaggio sentimentale di Vincenzo Consolo”, Arenaria, agosto-septiembre 1990. • Evelyne Pieiller, “Le roman d’un peuple, de son histoire, de ses langues”, La Quinzaine littéraire, 16-10-1990. AÑO 1991 • Jean Baptiste Marongiu, “Blessure sicilienne”, Liberation – Special livres, marzo 1991. • Louis Soler, “Les deux Siciles”, L’Ane, magazine freudien, nº 47, julio-agosto 1991. FILOSOFIANA 36 I. NOTA AL TEXTO 1. El relato de “Filosofiana” aparece recogido dentro del libro Le pietre di Pantalica, publicado por primera vez en octubre de 1988 por la editorial Mondadori de Milán, “Collezione Scrittori italiani e stranieri”. 2. La misma editorial sacará a la luz una nueva edición para la colección “Oscar Scrittori del Novecento”, en septiembre de 1990. En esta colección existen varias reediciones, desde la primera de 1990 hasta la última de 2007. Las diferentes reediciones, de esta colección van acompañadas siempre de una introducción de Gianni Turchetta. Todas ellas conservan el mismo formato. Son exactas entre sí, con la salvedad de las siguientes diferencias: • Cada reedición presenta una imagen diferente en las portadas de los libros. • En la edición más reciente de septiembre de 2007 se ha añadido el apartado “Bibliografía” (pp. XIV-XVIII). 3. Por lo que respecta a esta segunda edición de la traducción al español de “Filosofiana”, al igual que hiciera en la primera, me he basado en el texto original de la edición Princeps (Mondadori, 1988), que es la considerada definitiva por el autor (“Filosofiana”: pp. 75-97). 37 II. NOTA A LA TRADUCCIÓN 1. Las cuestiones lingüísticas y terminológicas relativas a las opciones de traducción para la presente edición en español de “Filosofiana” se analizan a continuación del relato de “Filosofiana”, en el capítulo IV (Relación comentada de regionalismos y otros matices del texto). La secuencia de los términos comentados en dicho apartado sigue un orden alfabético. En esta segunda edición, por tanto, los vocablos analizados dejan de estar señalados en el corpus de la traducción por medio de un asterisco junto a la palabra o grupo de palabras objeto de comentario, tal y como sucedía en la primera edición. 2. Por su parte, las notas que acompañan el corpus de la traducción están únicamente destinadas al comentario, aclaración o explicación de aquellas referencias literarias y culturales recogidas en el propio texto que puedan ser de utilidad para el lector. 39 FILOSOFIANA Al alba había llegado a Sofiana, a la fanega y media y algún que otro bancal que había mercao empeñando hasta la camisa, tras irse al traste las cooperativas y su esperanza de obtener la concesión d’un roalico de tierra en Ratumemi, Rigiulfo, Gibilemme o n’er mesmo infierno. Una tierra qu’era una cascajera, una llanura rojiza a lomos d’un cerro de tiestos y cascotes, culos panzudos de botellas, asas d’ánforas, lebrillas, botijos y jarrones. Como si en este campo hubiese habido hornos d’alfarería. Abandonados, cerrados y enterrados, dejando sobre el terreno como seña este cimiterio de cinabrio, lo mismo que la masa amarillenta d’escorias y cenizas al reor de las bocas de los pozos de Bubbonìa o de Pazienza eran las señas d’azufrales muertos (reino de cal, de sisca y de acíbara; refugio de sombras y vientos, cucalas, lagartijas, leros; lugar de desolación y de acoramiento). Y encomedias d’estos casquijos, crecían espárragos, cardos, alcaciles silvestres, calistros y robinias. Lió la mula a un tronco y se asentó sobre un murete de arenisca que asomaba to’ tieso, cuasi como seña de linde o cimientos de casa. El cielo aclaraba, las estrellas se apagaban, desaparecían, y la luna, una luna de tres cuartos, perdía su luz, palidecía, volviéndose papel de seda, vitela. Se veía, más allá del valle, más allá del Dessuèri y del Dittàino, más allá del Adrano, Jùdica y Centùripe, sobre un fondo de cielo violeta y luminiscente, la cumbre nevada y la humareda del volcán. 40 Miraba a su tierra, la suya, la escudriñaba. Sopesaba si debía empezar por roturar, plantar barbados y esquejes americanos, resistentes al mal tiempo, a la filoxera; y olivos, almendreros, pistacheros; y árboles de capricho como higueras, acerolos, jinjoleros, serbales, membrillos, granados; y plantas de olor y de belleza, rosas, claveros, jazmines, cidronelas, alrededor de la casita que habría hecho aquí, en lo más alto, la fachada cara al levante, quizá sobre estos mismos gruesos cimientos en los que se asentaba, la terraza, el parral y el pozo en la parte delantera. Se la figuraba en pequeño, pero copia de la gran masía de la Favara, donde había trabajado varios meses bajo las órdenes del amo llamado Saavedra6 , regia mansión, maravilla con cúpulas, terrazas, balconcitos, patios con columnas, suelos con azulejos de Valencia; aljibes, albercas, cenia, paseos con parras encomedio de campos de algodón y cañadú, jardín con plantas y flores de las más variadas, garullos y pavos en libertad por el jardín, y todos los pájaros del arca en las pajareras. Rió, rió de su sueño, se dio dos manotazos en los muslos y se levantó para tomar el legón y el pico. Tajo parejo comenzó por despedrar, librar el terreno de cualquier resto de barro roto. Rastrillaba y formaba aquí y allá en los bordes caballones rojizos, y a poco a poco aparecía, ahí donde no había hierbajos, chicoria o hinojo silvestre, una tierra negra y feraz, tierra de virginidad inmaculada, que jamás había conocido reja de arado, golpe 6 Nombre de la familia propietaria de las fincas y del palacio de la Favara desde el siglo XVI. Apellido de rancio abolengo español, perteneciente también a la nobleza del Reino de las Dos Sicilias. Por sus estrechas relaciones tanto con Murcia como con Sicilia, señalaré a uno de sus más ilustres representantes: el político y literato murciano Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648), que fue secretario del Cardenal Gaspar de Borja, primero embajador en Roma y después Virrey de Nápoles residiendo por algún tiempo tanto en Nápoles como en Sicilia. 41 de azadón, jamás había alimentado semilla de haba, cebada o trigo. Y cuando fue justo mediodía, con el sol perpendicular sobre el follaje del bosquecillo de Alzacuda, quiso enderezar el lomo7 pero se quedó derrengao. Se llevó las dos manos a los riñones e hizo fuerza, crujiendo y quejándose, hasta lograr ponerse derecho como un hombre. Imprecó su mala suerte, santos y diablejos, caminando hacia la mula, donde tenía liado el hato de la fiambrera con el empedrao, el vino, el pan y el queso frito que su mujer le había preparao. Se asentó de nuevo sobre el murete, cuadrado y pulido como un poyo delante del molino de Caldai o de la trituradora de la Providencia, extendió el paño de cocina, puso encima los avíos para comer. Y mientras comía miraba toda la faena hecha durante la mañana, la tierra negra libre de herbajo y de tiestos, parecía desnúa, después de inseculorum sécula a la luz der sol y d’estremecerse ante la ligera brisa otoñal. Lo que le turbaba era el silencio. Acompasado por el pisoteo de la mula, los cascabeles de las ovejas lejanas y algún que otro grito de un pájaro de paso. Y la montaña inmensa al fondo, una masa de negro y de blanco, con la humareda que salía de su cumbre expandiéndose por el azul de la bóveda. Cercanas se veían las casas de Caltagirone, de Adrano y de Piazza (contaban que en el Casal, en el vallecico del Nociara, habían descubierto bajo tierra una gran villa, el suelo de cuadradicos minúsculos que formaban frisos con guirnaldas de frutas y flores, escenas de caza con animales salvajes y fieros, leones tigres liopardos; pesca con redes de peces moteados, plata y oro, nenes que jugaban a coscoletas sobre cabras y palomas, luchas de gigantes heridos por flechas, un hombre con tres ojos. Pero la maravilla de la que se platicaba abonico era la 7 Según me hizo observar Segre, al emplear la palabra groppa (“lomo”) Consolo quiso subrayar la animalidad que conlleva el duro trabajo de la tierra (cf. la entrada “enderezar el lomo” en el capítulo siguiente). 42 sala de las zagalicas, tan apañás, en cueros, que bailaban y jugaban graciosas con la pelota, la sombrilla, er tamboril. De seguro la villa d’un rico caprichoso, muncho más rico qu’er rico Saavedra de la villa Pastorana en Favara). “Pero ¿qué semos nusotros, qué semos?” se preguntaba Vito Parlagreco8 , masticando su pan y queso de cabra con pimienta. “Hormiguicas que se matan a faenar n’esta vida breve como er día, un lampo. En fila dalante atrás sin parar n’esta era redonda que se llama mundo, llenos de granos, pajas, trigo, en pro de uno o dos más afortunaos. ¿Y qué? Er tiempo pasa, amontona fango, tierra sobre un gran escombro d’añicos de huesos. Y queda, como seña de la vida qu’ha transcurrío, argún que otro fuste de piedra acanalá, argo escrito en una lastra, arguna escena o figura como las desenterrás n’er valle de Piazza. Un cimiterio queda, de piedra y casquijos encomedio der cual crece, ca’ espuntar de primavera, l’alhelí, l’asfódelo”. Y miró los bancales de cascotes delante de él, las terracotas, algunas patinadas de musgo y otras pintadas de negro, rojo, unas lisas y otras grabadas con figuras mutiladas. “Qué caprichos, qué caprichos se daban los antiguos” se dijo Parlagreco. Y se dijo también que dejase ya de pensar en la vida que fue, que es, como lo hacía siempre en los altos de la faena, n’er silencio y en la soledad, de pensar com’un viejo, com’uno d’esos jubilaos asentaos dende la mañana dasta la tarde de cháchara a la puerta de la Liga. Pa’ irse a luego a luego de la tierra ar cielo, ar sol, a la luna, a las estrellas. Entonces, entonces era preso de vértigo, 8 Sólo aquí, después de tres largas páginas, se descubre el nombre del misterioso labrador. Consolo ya lo había presentado anteriormente en este mismo libro Le pietre di Pantalica. Había aparecido en concreto en las dos partes que componen el relato “Ratumeni”. Con unas cuantas pinceladas Consolo ofrece en “Ratumemi” un retrato tanto físico como psicológico del futuro protagonista de “Filosofiana”. Por lo tanto, su lector, puede ahora proyectar perfectamente su imagen mental y entender mejor sus reacciones (cf. la introducción). 43 le parecía escullir dentro d’un pozo sin fin. Y fue en ese punto, en esa quietud de desierto o eremitorio cuando, desde la lontananza de sus pensamientos, se sintió llamar, volver a llamar: «¡Ohu, ohu!» y le salió al encuentro, desde el fondo de su campo, seguido de ovejas y corderos, un cabrerico alegre, risueño, arremolinando en lo alto su cayado. Cuando estuvo delante, se plantó, poniéndose rojo rojo. Reía, reía, sin estarse quieto un momento, balanceándose de un lado a otro sobre sus piernas arqueadas, los pies envueltos en trapos. Era un zagal d’unos quince años, crecío de cabeza y tórax, con pelusa en la barbilla y sobre los labios, pero que s’había quedao corto d’estatura. Miraba fijamente con los ojos de par en par al labrador. «Eh» le dijo Parlagreco masticando «¿qu’haces? ¿Ande vas?» Mas el cabrero reía y no hablaba. Cortó entonces el labrador una tajada de pan con el cuchillo, colocó encima un trozo de queso y se lo ofreció al zagal. Éste, riendo, retrocedió, denegando con la cabeza. Probó con el vino, tendiéndole la botella. Y de nuevo el no de aquél. Pero ahí quedaba mirándolo fijamente, espiando su cara, sus gestos. Vito entonces fingió no darle importancia, no verlo, continuando distraído su comida, siguiendo con la mirada al rebaño disperso, un can9 blanco de pelo enmarañao que ladraba y corría tras las ovejas que s’alejaban a lo lenjos. Después Vito se encendió un pitillo, miró al muchacho que seguía ahí plantao 9 Góngora se negaba a utilizar el término “perro”, que consideraba un barbarismo –de hecho tiene un origen incierto–, y sólo consentía en emplear la palabra “can”, de procedencia latina. Con todo, el Roque Barcia recoge la etimología de Covarrubias, para quien el vocablo “perro” viene del griego Pyr, “que significa fuego, por ser estos animales de un temperamento seco y fogoso. Otros quieren se dijese á rodendo pede” (cf. Primer Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, Roque Barcia, Tomo cuatro, Francisco Seix, editor. Barcelona, 1879). 44 todavía sonriendo, echó las piernas sobre el murete, se dio la vuelta y se dispuso enseguida a reposar, el hato bajo la nuca a guisa de almohada. Tras el humo del pitillo, miraba el cielo terso e inmutable, mudo, vacío, como la tierra sobre la que se encontraba. Y pensó n’er zagal dentro der vacío, quién sabe desde hacía cuántos años en soledad, solo con sus ovejicas, encomedio de las hierbas, en los altos de Filosofiana, expuesto al agua y ar viento, bajo er sol, bajo la luna, bajando a Dessuèri, y más allá a través de los campos de Gela, vagando hasta Morgantina, hasta Licodia Eubea. Vida sola, sola, tanto que se le había olvidao, si arguna vez la tuvo, la palabra. Giró apenas la cabeza para mirar de reojo a ese pastor esquivo, y lo vio acucunaíco n’er suelo, er cayado entre las piernas, el rostro feliz por estar en compañía d’un cristiano. Pensó en sus tres zagalicos allá en Mazzarino, Michele, Maria, Bastiano, que iban a la escuela, jugaban en la calle, hablaban, gritaban, dormían por la noche bajo techo10. Y en estos pensares, aspeao como estaba por la cansera de la mañana, esculló a poco a poco en el sueño. Lo despertaron de golpe los alaridos, los ladridos del can. Se irguió, y vio al muchacho que saltaba, tomaba piedras del suelo y disparaba con su honda contra una bandada de airones que volaba en formación de ángulo, de flecha, como las dos alas desplegadas de un único pájaro grande. Se veía cada cuanto al airón timonel, en el ápice del ángulo, que con el pico y su largo cuello hendía el aire, ceder su puesto a otro que lo alcanzaba desde el extremo del ala. Y 10 Son los mismos sentimientos de ternura compasiva que expresa José María Gabriel y Galán (1870-1901) en su entrañable poesía “Mi vaquerillo”, que para un lector actual no deja de ser encantadoramente afectiva: “(…) / Pero el niño ¡qué solo vivía! / ¡Me daba una lástima / (…) / tan solo pasaba / las noches de junio / (…) / y las húmedas noches de octubre, / (…) / y las noches del turbio febrero, / (…) / con vientos y aguas!… / (…) / Yo tenía un hijito pequeño / (…) / que jamás te dejé si tu madre / sobre ti no tendía sus alas”. 45 así avanzaban, con sincronía y consonancia, emigraban, ahora que se aproximaba la ivernada, hacia lugares cálidos, Linosa, Lampedusa, Gerba, quizá después de un alto en el lago Dessuèri, en el estanque de los Pàlici o Vendìcari. Saltó del murete y corrió hacia el muchacho, lo agarró por los brazos y se los retorció detrás de la espalda, haciéndole caer la honda de las manos. Éste, tomado a traición, pataleaba y se revolvía. Lo arrastró hacia el muro, lo hizo girar sujetándolo con fuerza por las muñecas. «Basta» le gritó «¡basta!». El muchacho lo miró espantao. Después las lágrimas le llenaron los ojos. Vito aflojó su presión. «Ai-ro-n» dijo, señalando al cielo «ai-ro». «¡Pero tú hablas, hablas!» exclamó Vito. El muchacho se enjugó los ojos con el dorso de la mano. «¿Quién eres? ¿Cómo te llamas, eh?» le preguntó. El otro lo miró con ojos muy abiertos. «Uno, Vito» dijo Parlagreco apuntando el índice sobre el pecho. «¿Y tú?». «Ta-na-tu, Ta…» silabeó el muchacho, y se rió, descubriendo unos dientes agudos. «¿Tanu? ¿Tanu?» preguntó Parlagreco. El otro dijo que sí con la cabeza. «Los airones no se matan. ¿Comprendío?» remachó. El muchacho reía, y no decía ni si ni no. «Abora se van lenjos, qu’aquí llega el ivierno… ¿Tú, ande vas?». Pero Tanu no respondió, siguió riéndose. Luego de golpe giró, fue a recoger del suelo su honda, volvió y se la entregó a Parlagreco. «No, no» le dijo Parlagreco «tenla. ¿Qu’hago yo con ella?» Y fue a retomar su azadón. Tanu abrió el zurrón que llevaba en bandolera, puso dentro la honda y sacó un liebro muerto, con la cabeza corgando encostrá de sangre. Se lo llevó a Parlagreco. 46 «No, no, cómelo tú». Pero el muchacho insistía. «¡No!» dijo decidido Vito, y se echó a andar. Entonces Tanu dejó rápidamente el liebro sobre el muro, se llevó dos dedos a la boca, silbó para llamar al can y partió dando saltos y haciendo molinillos con su cayado. Vito lo persiguió, pero el otro corría veloz sobre sus piernas zambas, desapareció pronto, seguido del can y de las ovejas, en el follaje del bosquecillo de Alzacùda. Vito se quedó plantao mirando er punto por donde había desaparecío aquel zagal, la sendica encomedio de los troncos de calistro. Sintió despecho, luego algo parecido a pena, pena por ese zagal que quizá nunca más volvería a ver, lo que semeja a la muerte, como los airones que se ven migrar, esfumarse en la lejanía. Pena aún por él, que retornaba a estar solo, solo con su faena n’er campo de Filosofiana. Miró el liebro muerto sobre el murete, le dio la espalda y tornó decidido al punto donde había interrumpido su faena. De pronto, después de unos pocos golpes de pico, oyó resonar la tierra como si estuviese hueca, hubiese una cueva o una vasija enterrá. Excavó despacico despacico, amontonando tierra hacia los lados, y apareció a poco a poco una lastra alargá como la lápida d’una tumba. Fue preso de ansia, pensares; recuerdos acudían en tropel a su mente, de fábulas, encantamientos, tesoros escondidos por moros o por bandoleros. Le parecía estar soñando. Y este sueño que tenía por la noche con frecuencia, cuando s’echaba en la cama lleno de cansera, era er de cavar con las manos n’er polvo, n’er fango, y encontrar por fin una perola o cuarterola cormá de peluconas11. ¿Pero era sueño o 11 En el texto original marenghi (p. 82). Se trata de las monedas de oro acuñadas por Napoleón con motivo de la victoria de éste sobre los Austro-Húngaros en Marengo (1800). Por extensión cualquier moneda de oro macizo. Para rendir la misma equivalencia a un lector español elegimos la palabra “pelucona”, moneda 47 recuerdo lejano de cuentos, como er der Castillo d’Entella o er de la Gruta der Caballo en Sabucina, d’ese pastorcico que fue a la feria embrujá ande compra naranjas que se vuerven oro? Y recordaba siempre esta letra qu’abora s’había puesto a recitar: Una fuente n’er puentecico N’er Lanniri siet’aspontico Sabucina e’ jarta d’oro Testa de lumbre, Testa d’ oro… Sólo que sueño o fábula poca es la diferencia. ¿No es acaso sueño todo cuanto se cuenta, se inventa o se relata, por medio de la voz, de la escritura o de cualquier otro modo, de una vivencia de ayer, de hoy o de mañana, de una vivencia posible o fantástica? Es siempre sueño la empresa del narrar, un desligarse de la vida real y vivir en otra. Sueño o quizá aún locura, porque es propio de la locura la vida que se desliga y prosigue, como sombra, fantasma, ilusión, al lado de esta otra vida que nosotros llamamos real. ¿O de la muerte? Vito Parlagreco hizo palanca con la cuña del pico y alzó con esfuerzo la pesada lastra. Apareció una fosa, tallá dentro de la toba y bien cuadraíca. Una fosa repleta d’un terrero oscuro, blando como la de los hormigueros. Y del terrero afloraba un cráneo, el color amarillo de la frente, el negro de las órbitas, el marfil de la dentadura, y los huesos, sutiles como alas de pájaros, de las manos. Parecía el esqueleto de un hombre desplomado dentro del fango y que se esfuerza por salirse o de uno que, vuelto a despertar en su tumba después de milenios por la luz roja del sol poniente, hace ademán de incorporarse. de oro acuñada por los reyes Borbones españoles hasta Carlos IV inclusive. Esta moneda tenía en una de sus caras el perfil del rey vigente que ostentaba una peluca. De ahí su apelación popular. 48 Vito no tuvo sobresalto ni miedo, más bien notó la misma alegría como cuando en sueños descubría sus peluconas. Alegría sobre todo porque al reor al reor d’aquel antiguo muerto afloraban ánforas, orzas, platos, luminos, semienterraos también n’er terrero, como si flotasen sobre el agua cenagosa d’un aljibe. Estaba seguro abora d’encontrar en las vasijas de barro un tesoro escondío n’er tiempo de fábulas y d’encantos, y el único temor que sintió fue er de no saber la fórmula mágica, la frase, la palabra arcana que debía decir n’el instante de rozar el oro con los dedos. Temía que de un momento a otro todo pudiese desaparecer como nube errante, cenizas al viento, esfumarse como un sueño al despertar. Rezó entonces en su corazón a su madre a su padre, al niño que se le había muerto al nacer, a amigos y a conocidos. “Oh mis mortichuelos” rezó “difuntos qu’amé y que conocí, ayudarme, cambiarme al fin esta dura vida mía, esta vida de pesambres y de miedo”. «Amén, amén» concluyó en voz alta, la única palabra sacra que sabía y recordaba. A gatas se puso a rascar con los dedos la tierra que apresaba la loza, con un ansia y un deseo, una delicadeza12, iguales a los que sintió cuando había tocado por primera vez las carnes de su mujer. Liberó así la primera orza panzuda y más amplia, la apretó contra el pecho, echó una ojeada al interior: negror. Estaba negro como la noche ahí dentro. Esculló la mano y tocó una materia incrustá, rascó con las uñas y sacó fuera un grumo d’una substancia que parecía carbonilla grasienta. Estuvo seguro, seguro de qu’aquel carbón había sío hasta 12 Consolo ya había destacado esta delicadeza de espíritu de Parlagreco, que contrasta con el rasgo de rudeza casi animal en su duro bregar con la tierra, en el relato “Ratumemi”, que precede a “Filosofiana”. En él presenta a un Vito que, saciado tras haber comido, acepta todo lo que le ofrece su compañero para no herir sus sentimientos: “E Petro offriva la carne a Vito. Che, sazio, per secondare l’altro, faceva finta d’azzannare e subito la passava a Trubbìa o Brucculèri. Parimenti faceva col bomobolo del vino” (cf. Le pietre di Pantalica…, p. 53). 49 ese momento oro fino, monedas resplandecientes a la par der sol, y que por magia malvá, por no saber la fórmula secreta necesaria para consolidar para siempre el oro en su estado, encontraba abora este tanino en su mano, este puñao de mierda der diablo. Miró decepcionado la orza, el ánfora panzuda y barnizada. Nunca había visto nada más hermoso. La frotó con la mano, sopló para quitarle el polvo y aparecieron figuras de color rojo: un hombre desnudo por delante con una manteleta que le caía por detrás, la mano apoyada en una lanza; una mujer con vestido liviano, las alas desplegadas en la espalda, los brazos abiertos, como un ángel que revolotease por delante; otra mujer con yelmo en la cabeza y coraza habla con un zagalico que lleva en la mano un bastoncillo con dos aros; un gato moteado de cola ondulada brinca entre dos portadores de lanzas; en la cara opuesta, un hombre envuelto en un lienzo, una cinta al reor de la cabeza, ofrece a una joven, en túnica transparente hasta los pies, una bonica taza colmada quizá de ambrosía o de malvasía. Eran figuras que Vito no entendía, escenas de hechos oscuros y de misterios, enigmas que nunca en toda su vida resolvería. ¿Y si estuviese ahí, pintao n’aquella orza, er dicho mágico, la llave para romper el encanto13? Pensó entonces, pensó qu’el único que tenía er poder como tó er mundo sabía para romper o echar conjuros, predecir er tiempo, sentir corrientes d’agua soterrás, leer er pasao y la buena ventura era en Mazzarino don Gregorio Nànfara, hombre de ley y sabio, que de mozo había estao n’er seminario, frecuentaba iglesias, conventos y monasterios, sabeor d’historia, poesía, d’astros n’er cielo, de griego y de latín. Decidió pues no tocar na’ más no fuese a echar a perder el 13 Como en el resto de Europa, y sobre todo en ambientes rurales, el imaginario colectivo siciliano cultiva leyendas de tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Todo campesino sueña con encontrarlo bajo su azada, pero hay que conocer la fórmula secreta para que el tesoro se vuelva real y la materia que lo reviste desaparezca, dejando paso a monedas de oro macizo o piedras preciosas. 50 encanto, dejarlo to’ com’estaba y regresarse con don Gregorio. Pero se llevó consigo la orza ya cachifollá, como prueba tangible de qu’este tesoro escondío qu’él había encontrao no era un sueño, una visión. Volvió a colocar raudo y veloz sobre la tumba la pesada lastra, esparció tierra encima para enmascarar su descubrimiento. Al llegar a la mula, su mirada cayó sobre el liebro que Tanu había abandonado en el murete: una nube de moscas le comía los ojos y la herida, una cuadrilla de hormigas le entraba por la boca. «Baaah…» hizo Vito con una mueca sintiendo angustia. Pero a la par no pudo dejar de volver a pensar n’el extraño cabrero, er zagal desaparecío n’er bosque, creatura de mudez, de solitud. Espoleó la mula y bajó corriendo hacia Mazzarino como si cabalgase un gallardo alazán, llegó a las primeras casas de Cicoria cuando ya había descendido la tarde violeta. Fue flechado al Borgo, a la vieja casa de don Gregorio Nànfara. «Chisss, chisss…» le dijo don Gregorio con el dedo sobre los labios después del relato anhelante de Vito Parlagreco. «Por amor de Dios… ¿Platicaste con arguno?». «¡Quia! Osté es er primero con quien platico. Vine de Sofiana to’ p’alante hast’acá». «Bien hecho» dijo don Gregorio. «Si jamás, de arguien que no fuese yo, la nueva traspasase la impura aurícula, se disiparía to’ encantamiento, la esperanza se tornaría desesperanza». Vito lo escuchaba atónito, perdido en pos de aquel lenguaje alado. «Chisss… Quieto parao» le ordenó don Gregorio, y se levantó de la silla detrás de la mesa para encaminarse hacia la ventana. La cerró, y entonces se dirigió a la puerta, se agachó para mirar por la cerradura por si acaso alguien estaba a la escucha. Tranquilizado, encendió la lamparilla llena de cagarrutas de moscas que colgaba en medio del cuarto, volvió a sentarse. A su paso, la habitación parecía sacudida por un terretremo, crujían bajo sus zapatos las losetas sueltas. Era un hombrón corpulento, calvo y con el cráneo reluciente, un ojo 51 bien colocado en su sitio, azul y fogoso, y el otro, de cristal, inmerso dentro del agua del vaso sobre la mesita. «Nos» continuó Nànfara «nos qu’es sólo er que te habla, nos estamos más allá de toda impureza y de toda curpa. Nos que alcanzamos a escudriñar, gracias ar saber, a la sabiduría» y señaló con amplio gesto todos los libros viejos y enmohecidos a sus espaldas «er punto imperscrutable donde la Noche y er Día se conjugan, la estrella Austral con la Polar, er viento Griego con er Garbino14, er Bien con er Mal… Parlagreco, Parlagreco, son cosas difíciles d’entender, d’explicar…» suspiró, «Parlagreco… Tú que de la lengua griega, ay de mí, perdiste la sapiencia… Es la historia, la historia, er tiempo qu’arrolla y trastorna… ¡Parlagreco!» lo interpeló más fuerte. «¡¿Sí?!» respondió al instante Vito levantando la cabeza. «¿No será qu’en Sofiana t’adormilaste, no t’habrás pasao con er tinto de Favara?». «Eh, eh…» dijo Vito con una ligera sonrisa de compasión. «Esto me lo aguardaba, don Gregorio» se agachó, tomó del zurrón que había dejado en el suelo el cántaro pintado y se lo puso delante sobre la mesa. «¿Eh?» dijo «¿Conque sueño, engañifa d’achispao? ¿Eh?». Don Gregorio alargó los brazos y pegó su único ojo sobre aquella maravilla. «¡Qué belleza! ¡Qué belleza!» exclamó con arrobamiento. «Y aún hay dos más igualicas, que yo no he tocao, y platos, orcillas y luminos pequeños». Don Gregorio tuvo una sonrisa taimada, después una risita como el que saborea la dulzura del placer. Tomó la lupa de mango largo, de las que usan los señorones para leer el periódico delante del Círculo, y se puso atentamente a estudiar las figuras dibujadas sobre 14 El “viento Griego” es el viento del Noreste, es decir el de Levante. El “Garbino” es el viento del Suroeste, también llamado viento de África, es decir el de Poniente. 52 la orza. Murmuraba palabras incomprensibles, su ojo azul tras la lupa, agrandado como el que estaba en el agua del vaso. «Don Gregorio…» lo llamó Vito al cabo de un rato. «¿Ah?… Voy, voy…» respondió, sin levantar la cabeza de su estudio. Se puso después a recitar, como si declamase un papel teatral: «Es una crátera magnífica… Un deinos15 pa’ más precisión… Representa una escena funeraria. Este hombre que s’apoya en la lanza mira tristemente a su propia muerte, personificá por la jovencica alada qu’es una Harpía; siguen los parientes, con cintas y ofrendas pa’ la ceremonia; luego Atenea ordena a Hermes que guíe ar muerto abajo n’el Hades… ¡Qué belleza, qué belleza!» concluyó. Y se levantó, se puso a pasear por el cuarto atestado y maloliente que era toda su casa, hablando y gesticulando como un abogado en el tribunal. «¡Ésta es una prueba, otra prueba más, Parlagreco, de que Grecia no existe, no ha existío jamás!… Grecia es un invento de los ingleses y de los alemanes, d’estos protestantes… To’ tuvo lugar aquí, en tierra de Sicilia… ¡Qué Troya ni Micenas, Atenas, Las Termópilas ni Salamina!… ¡Aquí, fue aquí ande to’ ha ocurrío!» golpeaba con el pie las losetas y temblaba el suelo. «Debe acabar este cuento, esta impostura enorme que dura desde hace demasiaos siglos…». Se detuvo, agarró su ojo de cristal del vaso, y rápido se lo plantó dentro de la órbita. Se irguió, miró fijamente con sus dos ojos a Parlagreco. «¡Esquilo!» bramó con todo su vozarrón. «Esquilo está sepultao aquí, en nuestro territorio al reor de Gela…». Se sobresaltó, como si de repente algo lo hubiese golpeado16. 15 Esta cerámica griega también se conoce como dinos. Se trata de una crátera o vasija grande y panzuda que suele estar montada sobre un pie o peana. 16 Plutarco relata que Esquilo, disgustado al haber sido vencido por Sófocles en una competición dramática, abandonó Atenas y se trasladó a Sicilia, donde murió hacia el año 455 a. C. Según una creencia arraigada, Esquilo estaría enterrado en los alrededores de Gela. Don Gregorio de repente, se dio cuenta de que 53 «¡San Liberador!» exclamó. «¡¿Si fuese ésta la tumba, si fuese ésta?!…» Se acercó a Vito. «¡Parlagreco!». «¿Qué?» respondió Vito intimidado, mirándolo de abajo a arriba. «¿Notaste dentro lastras con inscripciones, máscaras trágicas, estatuas menúas de comediantes?». «No, no, mesmamente no…». «¡Ah, veremos, veremos!…». «Don Gregorio…» lo volvió a llamar Vito. «¿Ah?». «¿Pero este, es un tesoro o no lo es?». «¡Lo es, lo es, sín que lo es!». «¿Y a luego qué?». «¡A luego salimos esta noche, a las tres debemos estar en Sofiana! Yyy… ¡Callaíco! ¡Que no se t’escape una palabra, tan siquiera con tu sombra o con el alma de tu padre!». «¡Sín Señó!» juró Vito llevándose la mano al pecho. «Parlagreco…». «¿Qué?». «Mil liras. No t’ofendas…». «¿Enantes?». aquel muerto desconocido bien pudiese ser el dramaturgo griego. Destaquemos otra analogía entre la Comarca de Filosofiana y el campo lorquino. También en el Cabezo de la Jara, que es la colina más alta de Puerto Lumbreras, la tradición quiere que se encuentre la tumba de los Escipiones –Cneo Cornelio y Publio Cornelio Escipión, tío y padre respectivamente de Escipión el Africano, vencedor de Aníbal–. Estos generales romanos detuvieron el avance de los cartaginenses Asdrúbal y Magón por esos entornos, pero sucumbieron en la lucha siendo enterrados en la zona. En algunos mapas antiguos de España hasta bien entrado el siglo XX aparece señalizada la zona de la supuesta sepultura. 54 «Enantes, sín. Es la costumbre. Porque si a luego a luego, Dios nos libre, la desencantadura falla, por accidente o por influjo maligno, sin ser en verdad curpa mía, adiós, si t’he visto no m’acuerdo…». Vito, resignao, se quitó la boina de la cabeza y de dentro del dobladillo interior, enrollaícos, sacó dos billetes y se los entregó, tragando saliva, a don Gregorio. «Vito, Vito, Vituco, por la Virgen de Màzzaro, ¿qué pasa? Dímelo, habla, no me dejes penando…» le imploró su mujer, pegada a la puerta, todavía con el calor de la cama, descalza, el pecho jadeante bajo su camisa de tela, cuando Vito iba a salir. «Chisss, chisss…» le dijo Vito. «Na’, na’ malo, ’tate tranquilica. A luego a luego te platico. A naide, comprendío, a naide debes dicir que salí en mitá de la noche. ¡Ojo!» y Vito le hizo una caricia, desde la nuca hasta el pecho rosado, cerró la puerta a sus espaldas y se encontró en la calle. Don Gregorio esperaba ya delante de su casa, capazo en mano, sombrero en la cabeza y un mugriento guardapolvo gris de gabardina. Vito le ayudó con gran esfuerzo a montar sobre la mula, el hombrón se asentó a mujeretas, el culo sobre el basto y las dos piernas colgando de un lado. «¿Es mansa, es mansa esta bestia?» preguntó aprehensivo don Gregorio. «Como una recién casá, una miel. Osté no esté rígido, déjese acunar como en una cuna». Vito tomó la mula por el cabestro y se pusieron en marcha, camino abajo hacia la calle Minoldo, calle Galizia, dejando atrás las casas del pueblo, carretera arriba hacia Cannavera. Llegaron a Sofiana, al lugar de la tumba, hacia las tres, con una luna casi llena, un blanco lechoso que clareaba todo el campo, y unas pocas estrellas en los márgenes del cielo. 55 Don Gregorio se dejó caer de la mula, bufando se quitó el gabanillo que relucía de grasa, abrió el capazo y empezó a sacar fuera y a disponer sobre el murete de arenisca libros, cirios, una vara, una granada, pez griega y una estola de iglesia de un brillante color escarlata. Vito se puso a rastrillar la tierra que había esparcido sobre la lastra. La limpió a fondo, como un horno antes de colocar los panes, y volvió cerca de don Gregorio. «¿Está preparao, don Gregorio?». «Eh, carma. La priesa en estas cosas es enemiga de cuarquier éxito». Y entonces don Gregorio miró a Vito fijamente a la cara. «Desnúate» le ordenó. «¡¿Eh?!». « Desnúate. En cueros». «¿Osté está de guasa?». «Parlagreco, ¿es hora de guasa? Haz lo que te digo. ¿Es acaso capricho mío? ¡Está escrito aquí, n’estos libros arcanos, n’este der Cinquecento17, n’er Rutilio18, y n’este otro, er Gran Cuadrado Maltés19!». Y diciéndolo don Gregorio agitaba los dos libros ante las narices de Vito. Vito comprendió que no había na’ qu’hacer, agachó la cabeza y se fue tras un árbol. Se desnudó, no sin haber escudriñado el campo 17 El Cinquecento alude aquí a la época de publicación (siglo XVI) del libro de Rutilio Benincasa, Almanaque Perpetuo, del cual don Gregorio cita más adelante unos versos (ver nota siguiente). 18 Rutilio Benincasa (1555-1626?). Filósofo, matemático y astrónomo. Tuvo un gran prestigio y renombre entre los seguidores de las ciencias esotéricas y cabalísticas en toda Italia, pero sobre todo en Sicilia. Su libro Almanaque Perpetuo, publicado en 1593, abarca todos los ámbitos del saber, incluyendo conocimientos botánicos y agrícolas. 19 El Gran Cuadrado Maltés es también una obra de cabalística muy apreciada por los cultivadores del esoterismo y las artes mágicas. 56 por todo el horizonte. Volvió mortificado delante de don Gregorio, sólo con los calzoncillos puestos. Don Gregorio, tanimientras, había endosado la estola roja y encendido los dos cirios colocados rectos sobre el murete. Miró a Vito que se le acercaba con sus calzoncillos largos de tela blanca sobre la piel aún quizá más blanca, menos la cabeza que destacaba negra hasta el cuello. «Parlagreco, ¿Acaso estamos en la playa de Manfria o Falconara? ¿Qué?, ¿te vas a bañar? ¡Los calzoncillos, los calzoncillos!» bramó don Gregorio. Vito, resignado, sufrió esta última afrenta de presentarse desnúo com’un gusano ante otro hombre, anque éste tuviera un solo ojo, anque fuera n’er negror de la noche. Don Gregorio le tendió las dos candelas encendidas. «Ten» le dijo «sujétalas bien a l’artura der pecho». Pero Vito no se decidía a apartar las manos de sus partes nobles. «Aaah…» dijo don Gregorio impacientado. «Vusotros los perullos estáis siempre llenos de remilgos. Mira a los azufraores, van siempre desnúos, quizá incluso ante Su Majestad». Vito se convenció y tomó en mano las dos candelas. «Vamos» dijo don Gregorio «empecemos. Desd’este momento, cuidaíco, no debes decir ni mú, tan siquiera respirar. Haz sólo lo que t’ordeno». Don Gregorio abrió delante de las candelas el primer libro, que era el Almanaque perpetuo20 y, hundida la cabeza en las páginas, se puso a recitar estas sentencias: 20 El Almanaque Perpetuo (ver notas 17 y 18) incluye unas tablas aritméticas perpetuas que supuestamente proporcionan la manera segura de acertar los números ganadores de la ruleta, la lotería, etc. Todavía hoy en día siguen circulando por Internet para beneficio de los adictos a esos juegos. 57 «Orbis nemo sua contentus sorte videtur, Mille tenensque urbes plus cumulare cupit. Cuncta perire vides; sola est virtusque perennis Quae facit aeternos nobilitatque viros. Quid juvant miser heu argentum, et aurum cumulabis Si post tartaneis tu crucieris aquis. Quisquis per mare, vel per terram acquiserit, aurum, Stultus erit, coeli cum male inquit opes» 21. Don Gregorio, con su corpachón imponente, esa voz suya cavernosa, su cabezón calvo, le semejaba a Vito el arcipreste, el obispo de Piazza o de Caltagirone. Vito temblaba de frío o de emoción, y tenía a la vez la frente llena de sudor. «Procedamus, procedamus…» dijo don Gregorio. «Vayamos a la tumba». Volvió a poner raudo en el capazo todos los pertrechos que había traído, se puso a caminar tras Vito, que alumbraba con las dos candelas. Pero el brillo de la luna era más fuerte que el de las dos llamitas, tanto que las sombras de los dos hombres caían justo a sus pies y se movían con ellos. El grito de una lechuza se oyó en aquel momento llegar desde la cima de un árbol cercano. Don Gregorio murmuró alguna palabra que era sin duda un conjuro contra aquel pájaro nocturno de mal agüero. Vito se detuvo delante de la lápida. Entonces don Gregorio, con su manera de obispo tonante, volvió a leer en otro libro: palabras oscuras, nunca oídas antes, y, aún si se llegasen a oír, palabras por su propia naturaleza irrepetibles, por mí que escribo, por ti que lees, por nosotros pobres hombres cargados de culpas, nosotros que nos movemos ciegamente en este mundo, 21 Consolo me pidió que no tradujera estos versos en latín algo macarrónico, para mantener el aura esotérica en torno a D. Gregorio. 58 ignorantes de todo lo sacro, todo lo arcano. Y mientras salmodiaba, don Gregorio echaba sobre la lápida las hierbas que tomaba una a una del capazo, llamándolas por su nombre. «Pimpinela» decía «Petrosela, Buglosa, Chalote, Nabo, Apio, Pastinaca…». Y sin dejar de leer, empezó a trazar con la vara sobre la lastra círculos, triángulos, cuadrados. Después colocó con respeto el grumo ambarino de pez griega. «Dame una candela» dijo a Vito. Con la llama, prendió fuego a la resina, que se inflamó y se derritió dejando sobre el barro cocido una hermosa mancha como una meada. Don Gregorio mojó ahí el pulgar, se acercó a Vito y le hizo la señal de la cruz en la frente, los labios, la barbilla, el corazón, el umbligo… pronunciando a cada vez esta palabra: «Labis, labis, labis, labis, labis…» Vito lo dejó hacer, ahora ya impasible y frío como una estatua. Tomó por último don Gregorio del capazo la granada y se la llevó a Vito. «Parlagreco» le dijo «ésta es la parte más difícil: to’ depende de ti. Tienes que comer esta graná sin dejar caer ar suelo un solo grano». Vito dijo que sí con la cabeza y tragó aire haciendo correr a lo largo del cuello su nuez que era puntiaguda como el esternón de un pájaro. Abrió lo más grande que pudo la boca de su horno, embocó la granada, le hincó los dientazos, masticó y deglutió. Sólo una gota de jugo le resbaló por la barbilla, y fue raudo en recogerla con la lengua antes de que le cayese sobre el pecho22. «¡Bravo! ¡Bravo!» casi gritó don Gregorio que lo observaba atento con la candela en la mano. «¡Extraordinario!». 22 La capacidad de deglución de Vito Parlagreco ya la había señalado anteriormente Consolo en el relato “Ratumemi”, que precede al de “Filosofiana”. Cf. Le pietre di Pantalica…, p. 51: “Vito Parlagreco, ch’era magro, ma capace di mangiarsi per scommessa una madia di pasta con il sugo (…)”. 59 Vito esbozó una apagada sonrisa de satisfacción, sonrisa que se trocó rápidamente en una mueca de eructo. «¡Levantemos abora esta lápida!» ordenó solemne don Gregorio. Y esta vez Vito no necesitó la palanca del azadón, sino que levantó a pulso la pesada lastra con las manos. Lo primero que les saltó a la vista, aún más blanco por la luna que lo inundaba todo, fue el esqueleto que afloraba del antiguo muerto. Don Gregorio quedó deslumbrado, estupefacto. A poco a poco abajó a la tumba, y solemne, como hablando con el muerto, declamó: «¿Eres tú er trágico sumo que dio palabra ar dolor inexpresable der mundo? ¿Eres tú er divino23 Esquilo?». En el silencio que siguió a la pregunta, se oyó más fuerte la risa burlona del pájaro en lo alto del árbol. Y a luego una voz, como si viniese del cielo o de las profundidades de la tierra: “Légo kat’andra, mè theón, sèbein emé…” 24 Don Gregorio se convirtió en estatua de sal, miró a Vito que permanecía inmóvil en el bordillo con la candela en la mano. «Parlagreco» le dijo con voz trémula «¿tú hablaste en griego?». Vito, fiel a la consigna de no proferir palabra, sacudió la cabeza para decir que no. «¿Pero uíste, uíste un verso griego?». 23 El autor me confirmó que el verso de Esquilo que cita a continuación (cf. la traducción en la nota siguiente) es la contestación al calificativo de “divino” que Don Gregorio aplica al dramaturgo griego. De esta manera Esquilo quiere refutar cualquier connotación divina que sus admiradores le atribuyen para ser única y exclusivamente honrado en su condición humana. 24 “Quiero que como a un hombre, no como a un dios, me honres”. Esquilo, Agamemnón (Nota del Autor). 60 Vito sacudió de nuevo la cabeza. «Ah» dijo cabizbajo don Gregorio «ésta es una noche mesmamente rara, noche de misterios impenetrables… Vamos, Parlagreco, desenterremos esta vajilla». Vito, que esperaba con ansia esta orden, saltó al foso, se puso a cuatro patas y empezó a rascar la tierra con las uñas, como un can que busca trufas25. Liberó la primera vasija y se la llevó a don Gregorio. Nànfara, asentado en el suelo, la apretó entre sus muslos. Jadeaba. También la respiración de Vito, acucunado a su lado, era intensa. El busca tesoros esculló la mano, no sin haber dirigido primero al cielo, a la luna, su mirada tuerta suplicante murmujeando entre dientes sus letanías. Na’. También esa gran vasija resultó estar vacía, llena d’aire, con sólo una masa grumosa y carbonosa n’er fondo. Y con la segunda fue lo mesmo. Los dos hombres se quedaron como embobados. Don Gregorio, sin mirar a Parlagreco, fue después hasta la mula y volvió con una azadilla. Con ella, se puso a revolver el fondo de la tumba, a desenterrar tiestos, platos, lamparillas, que iba amontonando en el bordillo del foso a medida que los sacaba. Embistió a lo último contra los huesos del muerto que, apenas tocados, se deshicieron como si fuesen de azúcar. Sólo el cráneo resistió, con la dentadura de reluciente marfil intacta. Y bajo la cabeza de aquel muerto don Gregorio descubrió el mascarón de un hombre grotesco de pelo ensortijado en la frente, orejas como abanicos, ojos grandes y boca risueña que dejaba colgar la lengua fuera. “¿Pero qué quié decir esto, qué quié decir?” se preguntó don Gregorio. “¿Es una cochina guasa, nos la dan por culo? ¿En lugar 25 Consolo subraya de nuevo el paralelismo entre el labrador y los animales, ya sean bestias de carga (como en la expresión “enderezar el lomo”) o domésticos, como en este ejemplo (un perro de caza). 61 d’Esquilo estaría aquí Aristófanes? ¿La tragedia s’ha trastocao en farsa?” Y, jodío como estaba por el chasco de no haber encontrao una señal, una inscripción qu’indicase n’aquella tumba la presencia d’Esquilo, descubrimiento qu’habría confirmao sus tesis, l’habría dao fama en to’ er mundo, tomó la terracota injuriosa y la estampó estrellándola contra la pared de la tumba. El Parlagreco, cabizbajo, había ido a vestirse. La luna tramontaba, cuasi redonda, burlona como el mascarón, don Gregorio le lanzó una última mirada. “Luna, quasi Lucina, oh Reina gobernaora de las cosas naturales interiores…” repitió para sí. Y después, citando a Trismegisto26: “Detrimentum Lunae est detrimentum totius naturae…”. «Pero es creciente, creciente, ¡cochino demonio!» prorrumpió. Desde oriente ahora, del lado de Piazza y de la gran montaña que humeaba, se expandía un claror color rosa. «Don Gregorio, ¿vamos? Dentro d’una miaja tengo que vorver aquí a la faena…» le dijo Parlagreco. «Vamos, vamos» respondió don Gregorio, haciéndose ayudar para salir de la tumba. «Antes debemos recoger estas cosas… Estas vasijas me las llevo a casa, las quiero estudiar, quiero entender, entender por qué…». «¿Qu’hay qu’entender abora?…». «Po’ hay que, hay que…». Y el Parlagreco, para poner priesa, poner en marcha a ese fulero, recogió vasijas, platos, jícaras, luminos, los echó todos dentro del saco. 26 La identidad y datación de Hermes Trismegisto (cuyo nombre designa al dios mitológico tres veces grande) son inciertas y legendarias. Se le atribuye la autoría del Kybalion y del Corpus Hermeticum, un compendio de ideas filosóficas y religiosas de origen egipcio y griego. En todo caso, Hermes Trismegisto es considerado el primer alquimista, es decir el primero en buscar la piedra filosofal que trasmute la materia en oro. 62 Llegaron a la entrada del pueblo cuando los otros labradores salían, sobre sus mulas, asnos, yeguas. Saludaron, al cruzarse, al Parlagreco, y con respeto también a don Gregorio asentado sobre la mula, con el saco de vasijas apretado contra la barriga. Parecían así, los tres, una Huída a Egipto. Liada la mula a una argolla de la pared, Vito descargó las cosas de Nànfara y subió con él a su casa para ayudarlo. «Asiéntate» le dijo don Gregorio. «Hago café». «Tengo qu’irme. La paya está en peso…». «Dos minutos…». Don Gregorio, se quitó el ojo de cristal y echándolo en el vaso, se puso a trajinar con la cafetera napolitana. Bebieron el café, fumaron, escudriñándose mutuamente pa’ averiguar por dónde iba a salir ca’ cual. Vito temía que le fuese a pedir aún más perras. «¿Tiés hambre, Parlagreco? Yo desde ayer a mediodía no he catao bocao». «¡Ande que yo!». «Tengo magra…». Y al instante puso sobre la mesa pan, queso y una botella de vino de Favara. «Tú quizá pienses» empezó a decir don Gregorio masticando «qu’ha sío curpa mía… Yo estoy en paz, en conciencia, he hecho to’ según las leyes rituales… ¿Qué te crees? Pasé to’ er tiempo, desde que te fuiste, leyendo, consultando libros… Pero argo ha pasao, que ni yo, ni tú, ni tan siquiera los libros han previsto… Es esto lo que m’esfuerzo por entender… Dime: ¿tuviste sueños, señas, viste cosas raras enantes de dar con esta tumba?». «Boh… Sueños, naíca. Señas, cosujas sin importancia… Ayer pasó por Sofiana un cabrerico con las ovejas, un zagal múo… Luego, una bandá d’airones que migraba… Y er cabrerico, Tanu, me dejó como regalo un liebro qu’había matao con su honda». 63 «Ah, ¡cochino demonio!» tonó don Gregorio dando un puñetazo sobre la mesita. «¡¿Y no m’has dicho na’ enantes?!». «Osté no me preguntó na’…». «¿Y hacía farta?… Parlagreco, aquel no era un cabrerico de verdá, un zagal humano, era un visivilo disfrazao, un martinico… Y er liebro, er liebro, ¿qu’hiciste con él?». «Lo dejé allá, sobre er poyete… No me gusta na’. Tampoco a la paya, ni a los zagales les gusta la caza…». «¡Desgraciao! ¡Debías habértelo comío, haberlo comío, anque crúo!». Vito se sintió humillado por esta acusación que lo culpaba del fracaso. Tomó, para animarse, la botella de vino y llenó con furia el vaso. Se lo tragó de golpe. Pero, al beber, ingirió también algo sólido y liso. «Don Gregorio» preguntó, dejando el vaso sobre la mesita «¿qu’había n’er vino?». «¿Qu’había?» y don Gregorio miró en transparencia la botella, miró después el vaso vacío. «¡ Desgraciao!» bramó «¡Mi ojo! ¡T’has tragao mi ojo!». «¡Ah!» dijo Parlagreco escupiendo en el suelo con angustia. Enseguida, con la calor de la cara subiéndole a las cejas: «¡Pero cegato asqueroso!… ¿Pero es que se mete el ojo n’er vaso?». «¿Y ande lo meto, eh? ¿N’er culo me lo meto? Es una custión d’higiene, d’higiene… Claro, que vusotros perullos qué vais a entender…». «Yo me largo». Don Gregorio, de un brinco, alcanzó la puerta de la habitación. «¡Tú no te mueves d’aquí si enantes no me cagas el ojo!» le intimó «Es más, voy enseguía a mercar sal inglesa» y diciendo esto, salió, cerrando la puerta a sus espaldas acerrojándola con todas las llaves. 64 IV. RELACIÓN COMENTADA DE REGIONALISMOS Y OTROS MATICES DEL TEXTO El estudio de los regionalismos y de otros matices relevantes a la hora de traducir “Filosofiana”, tal y como se llevará a cabo en este apartado, se centra en el comentario de aquellos vocablos por los que he optado para la traducción al español. Según queda señalado en la Introducción, en esta segunda edición he hecho extensivo a todo el relato el habla murciana, aún cuando no se corresponda con un regionalismo siciliano en el texto italiano. Con todo, dentro del discurso narrativo he procurado limitarlo a aquellos pasajes en los que –detrás de la voz del narrador– se percibe el pensamiento o la cosmovisión del personaje, y no en los meramente descriptivos o en aquellos otros, mucho más poéticos en los que claramente habla Consolo. Naturalmente los regionalismos y las singularidades del habla murciana se encuentran presentes en los diálogos y, al igual que en la primera edición, en los casos en que aparece un sicilianismo en el texto original. Como ya he anticipado en el prólogo a la presente edición, la secuencia de los términos comentados en el glosario sigue en esta segunda edición un orden alfabético que permitirá localizarlos de manera rápida y efectiva, en lugar de seguir el orden de aparición en el texto traducido, tal y como sucedía en la primera edición. Tampoco quedan señalados los términos comentados en el corpus de la traducción mediante asteriscos, pues se hace innecesario gracias a la nueva ordenación alfabética. 65 Por último, las equivalencias al italiano de los términos comentados en el presente glosario corresponden únicamente a las de su primera aparición en el relato de “Filosofiana”. Conviene tener presente, sin embargo, que a menudo estos mismos términos vuelven a aparecer en otros contextos a lo largo de la narración. a luego a luego: poi (Le pietre…, p. 79) La locución adverbial “a luego a luego” ha caído en desuso en España hasta el punto de que el diccionario de uso de María Moliner (2007) la omite, a pesar de que el DRAE (2001) la sigue recogiendo. En la región murciana y más concretamente en el campo lorquino sigue siendo una expresión habitual y de uso corriente. Me ha parecido oportuno emplearla aquí, durante la intervención de Parlagreco, porque sin ser regionalismo (como tampoco lo es poi) rinde el valor arcaico propio del habla rural. En otro pasaje posterior del relato, esta misma locución permitirá reflejar en su propia estructura formal la repetición presente en el original: Dappoi, dappoi (Le pietre…, p. 89). a mujeretas: a modo femminino (Le pietre…, p. 89) Aún cuando este regionalismo murciano se utilice en singular con el sentido de “hombre afeminado”, la locución plural “a mujeretas” empleada para hacer alusión a la forma de montar (a caballo, mula, etc.) significa simplemente montar sentado en amazona, con las dos piernas de un lado. a poco a poco: a mano a mano (Le pietre…, p. 76) Expresión murciana con prótesis de la “a” inicial en lugar de “poco a poco”, que rinde la estructura de la locución a mano a mano. abora: ora (Le pietre…, p. 81) Regionalismo propio del habla murciana, que alterna con las variantes “aboa”, y “agora”, equivalentes todas de “ahora”. 66 acucunaíco: accovacciato (Le pietre…, p. 79) Regionalismo propio del habla murciana, de uso corriente. Significa “acurrucado”, “encogido”, “arrinconado”. achispao: imbriaco (Le pietre…, p. 86) Esta voz (“achisparse”) es un regionalismo popular con el sentido de “excederse con la bebida, emborracharse”, valor que se corresponde con el término siciliano imbriaco. al reor de las: torno alle (Le pietre…, p. 75) Deformación fonética propia del habla rural murciana que equivale a “alrededor de”. alcaciles silvestres: carciofi di ventura (Le pietre…, p. 75) El vocablo “alcacil” es una forma popular para designar la alcachofa, aunque no se circunscribe únicamente a la región murciana, ya que también se emplea en otras regiones. aljibes: gèbbie (Le pietre…, p. 76) A pesar de que no se trata de un regionalismo propiamente dicho puesto que este término se utiliza en toda España con distintos matices, en Murcia la valencia semántica de este vocablo se corresponde exactamente con la gèbbia siciliana. Ambos comparten la misma etimología. En Sicilia, el término “gèbbie” deriva del árabe clásico “gˇibb”, al tiempo que en Murcia la palabra “aljibe” proviene del árabe hispánico “algˇibb”. ¿Ande vas?: Dove vai? (Le pietre…, p. 79) Modificación fonética mediante contracción, propia del habla murciana. Equivale a “a dónde (vas)”. angustia: con smorfia di sconcerto (Le pietre…, p. 85) Regionalismo semántico del habla murciana, que limita el término a 67 una sola de las múltiples acepciones recogidas por el DRAE: (“náuseas” o “ganas de vomitar”), con idéntica valencia a la del vocablo siciliano scuncirtatu (estar con náuseas). De ahí que “tener o sentir angustia” en el sentido de “tener náuseas” se pueda considerar un regionalismo semántico del habla murciana. Bien es verdad que en italiano la palabra italiana sconcerto significa “estar confuso o desconcertado”, y que también en el resto de España la palabra “angustia” se utiliza extensivamente en su primera acepción de “congoja” o “ansiedad”. Con todo el uso de sconcerto en la narración de Consolo se corresponde con la acepción semántica del vocablo siciliano, por lo que la forma murciana utilizada en la traducción es la que mejor rinde esta valencia regional. Aparecerá de nuevo al final del relato: sputando a terra sconcertato (Le Pietre…, p. 97), traducido como “escupiendo en el suelo con angustia”. anque: sia pure (Le pietre…, p. 90) Modificación fonética por supresión de una vocal, propia del habla murciana (“anque” por “aunque”). apañás: bellissime (Le pietre…, p. 77) El término lumbrerense “apañada” (aquí con la supresión de la “d” intervocálica para rendir mejor la fonética regional) alude sobre todo al aspecto físico y viene a ser sinónimo de “guapo” o “de buen ver”. argo: qualcosa (Le pietre…, p. 96) Mutación de la “l” por “r” (“argo” por “algo”), propia del habla murciana. (se) asentó: sedé (Le pietre…, p. 75) La forma “asentarse” proviene de la modificación mediante prótesis de la “a” del término “sentarse”. Se trata de un uso propio del campo murciano. Aunque en realidad, el término existe como tal. De hecho viene recogido en el DRAE. Con todo, ya no se emplea con esta acepción 68 de “sentarse”, como no sea en el habla regional. Idéntica forma aparecerá más adelante en el texto original, asséttati (Le pietre…, p. 95), ajustándose perfectamente al vocablo “asentarse”. Esta voz, habiendo caído también en desuso en italiano, permanece en vigor como regionalismo. arguien: alcuno (Le pietre…, p. 85) Mutación de la “l” por “r” (“arguien” por “alguien”), propia del habla murciana. argún: qualche (Le pietre…, p. 78) Mutación de la “l” por “r” (“argún” por “algún”), propia del habla murciana. Lo mismo sucederá con la forma femenina: “arguna” por “alguna”. argo: qualche (Le pietre…, p. 78) Mutación de la “l” por “r” (“argo” por “algo”), propia del habla murciana. artura: altezza (Le pietre…, p. 90) Mutación de la “l” por “r” (“artura” por “altura”), propia del habla murciana. aspeao: stanco (Le pietre…, p. 80) Regionalismo propio del habla murciana, que significa “cansado”, “agotado”, con la pérdida intervocálica de la “d”. avíos: cose per mangiare (Le pietre…, p. 77) El término “avíos” se utiliza en el campo para aludir a la “provisión que se lleva al hato para alimentarse”. En otros contextos puede significar un conjunto de utensilios o herramientas, así como de otra clase de enseres. No me ha parecido oportuno en este caso optar en español por una traducción literal (“las cosas para comer”) porque rompe el carácter rural del discurso. 69 ayudarme, cambiarme: aiutatemi, cangiate (Le pietre…, p. 83) El uso del infinitivo en lugar del imperativo es propio del habla regional y se emplea de forma habitual en el campo murciano. bancal: tumulo di terra (Le pietre…, p. 75) Esta medida, la del tumulo, corresponde aproximadamente a la de un bancal en la zona murciana. boca de su horno: bocca del suo forno (Le pietre…, p. 92) En los ámbitos populares el “horno” se utiliza como expresión burlona para calificar las bocas grandes (“tienes la boca como un horno”). botijos: bombole (Le pietre…, p. 75) En Sicilia el término bombola indica más que una bombona, un recipiente de barro para mantener el agua fresca. Corresponde por tanto a nuestros botijos y cántaros. ca’ espuntar: a ogni rispuntar (Le pietre…, p. 78) Alteración fonética propia del habla rural murciana en la que el término “cada” se reduce por apócope. Equivale a “cada despuntar”. caballones: montarozzi (Le pietre…, p. 76) Regionalismo utilizado en todo el campo murciano y, en particular, en el de Lorca. Designa los montículos de tierra o de otros materiales que se acumulan entre surco y surco o también en los lindes de los terrenos y bancales. cabrerico: garzoncello (Le pietre…, p. 78) En español existe la palabra “garzón” pero con el significado de “joven mancebo”, ayudante de Guardia de Corps. Otra de sus acepciones es la de “joven sodomita”. Ninguna de ellas, por supuesto, se asemeja al sentido de garzone, a pesar de que se trata obviamente 70 del mismo vocablo. Por esta razón no he podido utilizar “garzón” en la traducción. Con todo, para rendir el matiz aportado por la forma siciliana garzoncello he recurrido una vez más al sufijo “ico”, propio del habla murciana. cachifollá: fallita (Le pietre…, p. 84) No se trata de un regionalismo propiamente dicho. De hecho, el término “cachifollar” aparece recogido en el DRAE. Ha caído en desuso pero sigue vigente en el habla de la región lorquina. Aquí “cachifollá” significa “estropeada”. calistros: calipso (Le pietre…, p. 75) Regionalismo de Lorca y Puerto Lumbreras. Tanto en Sicilia como en la región murciana, la deformación de la palabra culta “eucalipto” se produjo de la misma manera mediante aféresis del diptongo “eu” y alteración de consonantes. (la) calor de la cara subiéndole a las cejas: facendosi paonazzo (Le pietre…, p. 97) En el campo murciano la palabra murciana “calor” se utiliza mayoritariamente en femenino. Toda esta perífrasis no es un regionalismo propiamente dicho, pero sí una expresión con un grafismo típicamente popular para indicar el enrojecimiento de la cara producido por una cólera o indignación súbita muy violenta. El poeta y escritor de Cuevas de Almanzor, José María Martínez Álvarez de Sotomayor, recurre frecuentemente a ella. cansera: fatica (Le pietre…, p. 80) Preciosa palabra anticuada pero que volvió a tomar un nuevo vigor a raíz del poema “Cansera” –escrito en regionalismo murciano– del poeta murciano Vicente Medina (1866-1937), siendo actualmente la que se utiliza corrientemente en todo el campo de Murcia para 71 indicar a la vez el cansancio físico y el moral. Adopta en otras regiones españolas distintos significados (en Andalucía, por ejemplo, “tener una cansera” es el eufemismo para “estar tuberculoso”). cañadú: cannamèle (Le pietre…, p. 76) El término “caña de azúcar” es el empleado mayoritariamente en España con preferencia a los de “cañaduz” y “cañamiel” siendo sinónimos entre sí (DRAE y MM). Sin embargo, tanto en el campo murciano como en el de la zona de Levante, los labriegos utilizan la voz “cañadú” con apócope del fonema “z” final convirtiéndolo así en un regionalismo, que corresponde a cannamèle, si bien no alude exclusivamente a la caña de azúcar. En la zona de Águilas este término se utiliza para referirse a una clase de naranjas especialmente dulces. También existe el vocablo “palodú”, que designa cualquier planta de sustancias dulces, como el regaliz o el orozuz, y que en algunos ámbitos rurales se confunde con la caña de azúcar. Por su parte, el regionalismo “cañadú”, al ser menos usual, consigue evocar en un lector de otras regiones de España las mismas valencias que la palabra “cannamèle” en italiano. carma: calma (Le pietre…, p. 89) Mutación consonántica de la “l” por la “r” (“carma” por “calma”), propia del habla murciana. cascajera: ciaramitàra (Le pietre…, p. 75) Regionalismo ampliamente utilizado en todo el campo murciano que significa un terreno en donde se echa toda clase de desperdicios y, sobre todo, tiestos y trozos rotos de barro. casquijos: ciaramìte (Le pietre…, p. 75) El regionalismo murciano “casquijos” indica toda clase de guijarros y pedazos, principalmente piedras pequeñas y restos de vasijas de barro. 72 cenia: sènia (Le pietre…, p. 76) El término sènia ya no es propiamente un sicilianismo porque se ha incorporado al vocabulario italiano (cf. Mortillaro). Tampoco “cenia” es un regionalismo propiamente dicho, si bien se utiliza sobre todo en Valencia y en algunas zonas del Levante en lugar de “noria”. Tanto “cenia” como sènia son en todo caso menos usuales que “noria” y su correspondiente italiano noria, al tiempo que comparten idéntico sabor añejo. cimiterio: cimiterio (Le pietre…, p. 75) Se trata de la alteración fonética de la palabra “cementerio”, propia de los ambientes rurales de la región murciana. También la palabra cimiterio del original presenta una ligera modificación regional. corgando: pendula (Le pietre…, p. 81) Mutación de la “l” por “r” (“corgando” por “colgando”), propia del habla murciana. cormá: ricolma (Le pietre…, p. 82) Mutación de la “l” por “r” (“cormá” por “colmada”), propia del habla murciana. En este caso, también se ha contraído la terminación en “-ada”. creatura de mudez, de solitud: creatura mùtola, solinga (Le pietre…, p. 85) En español los adjetivos “mudo” y “solitario” no rinden el valor literario, lleno de resonancias arcaicas, que encierran las voces italianas mùtola y solinga. Por esta razón he preferido recurrir a los sustantivos “mudez” y “solitud”, anticuados y también literarios, para conservar el sabor añejo que ha querido transmitir Consolo, sin traicionar por ello el sentido del original. De igual modo y por idénticas razones, he optado por la forma “creatura”, que ha perdido cierta vigencia en el español de hoy en favor de “criatura”. 73 cuarterola: quartàra (Le pietre…, p. 82) Palabra en desuso pero que se corresponde exactamente con la voz siciliana quartàra. Se trata de la cuarta parte de un barril u otro recipiente. cucalas: ciàule (Le pietre…, p. 75) En Murcia, sobre todo en el campo de Lorca, se utiliza el término “cucala” para toda especie de pájaros negros, desde los cuervos hasta las cornejas. curpa: colpa (Le pietre…, p. 86) Alteración fonética mediante la mutación consonántica de la “l” por la “r”, propia del habla murciana. chicoria: cicorie (Le pietre…, p. 76) Término que alterna con el de “achicoria” en español. Al igual que cicorie, no se trata de un regionalismo. He optado por la forma “chicoria” por ser la que mejor se corresponde con la italiana y por tratarse además de la variante regional murciana. dalante atrás: avant’arriere (Le pietre…, p. 78) Regionalismo murciano. Equivalente exacto del avant’arriere siciliano, trasunto de los dos adverbios franceses avant y arrière: delante y detrás. dende la mañana dasta la tarde: da mane a sera (Le pietre…, p. 78) Deformación fonética propia del habla rural murciana que equivale a “desde la mañana hasta la tarde”. desencantadura: spegnatura (Le pietre…, p. 88) Se trata de un neologismo consoliano. Para mantener el mismo valor lingüístico y literario de spegnatura he reproducido su creación con otro neologismo. 74 empedrao: macco (Le pietre…, p. 77) Forma popular de la palabra “empedrado”, con pérdida de la “d” intervocálica. Es el típico guiso del campo murciano, hecho a base de habas y de arroz, semejante pues al macco siciliano. enantes: avanti (Le pietre…, p. 88) Forma propia del habla campesina de Murcia, en la que se combina la preposición “en” con la locución “antes de”, probablemente por la elisión de un gerundio (como por ejemplo “en llegando antes de”), y que se usa con el sentido de “antes de”. encomedias de: fra mezzo a (Le pietre…, p. 75) Esta preciosa locución preposicional lorquina, “encomedias de”, significa exactamente “en medio de”. También existe la forma masculina singular “encomedio de” con el mismo valor. Ambas locuciones rinden el sabor del original. enderezar el lomo: rizzare la sua groppa (Le pietre…, p. 76) Tanto el término italiano groppa, como el español “lomo” se utilizan principalmente para aludir a la espalda de los animales. Según me hizo observar pertinentemente Segre, Consolo lo emplea de manera consciente para subrayar la animalidad del duro trabajo en el campo del labrador, por lo que en la presente edición he querido rendir la misma valencia conservando la literalidad del original por medio del término “lomo”. De esta manera también se subraya el contraste con la expresión posterior “ponerse derecho como un hombre”. er día: il giorno (Le pietre…, p. 78) La forma “er” es una deformación fonética propia del campo murciano en la que se ha producido la mutación consonántica de la “l” por la “r”. Se trata de una constante fonética típica del habla rural de esta región y se encuentra presente no sólo en los artículos seguidos de consonante 75 (“er” por “el”, “ar” por “al”), sino también en muchas otras palabras (“argo” por “algo”, “farta” por “falta”, etc.). escullir: scivolare (Le pietre…, p. 78) Regionalismo semántico propio del habla murciana, que significa “resbalar”, “deslizar”, “caer” (aunque viene recogido en el DRAE). Este mismo verbo (“esculló”) se hará corresponder también con infilò (Le pietre…, p. 83), que aparecerá más adelante en el texto. faena: travaglio (Le pietre…, p. 77) El término “faena” no es propiamente un regionalismo, como tampoco lo es en puridad travaglio. Con todo, uno y otro aluden a un trabajo laborioso. Por su parte, la palabra “faena” es la que se usa en toda la zona del Levante para aludir de forma habitual y popular a toda clase de trabajo duro, pero sobre todo al agrícola. fanega y media: mezza salma (Le pietre…, p. 75) La palabra “fanega” es la medida de tierra que se utiliza en todo el Levante. Existen dos clases de fanega: la grande y la pequeña. En el campo murciano se utiliza más la grande, que equivale casi a una hectárea. Para ofrecer la equivalencia que más se aproxima a la medida de tierra del original he traducido mezza salma por “fanega y media”, ya que la salma tiene una medida superior a dos hectáreas. El término español “salma”, tomado del italiano, se sigue utilizando en la zona Mediterránea pero como medida de capacidad equivalente a una tonelada. farta: bisogno (Le pietre…, p. 96) Mutación consonántica en la que se intercambia la “l” por la “r” (“farta” por “falta”), propia del habla murciana. fieros: foresti (Le pietre…, p. 77) En algunas zonas de España el adjetivo “fiero” ha caído algo en desuso con el valor semántico de “feroz”, aunque en la zona lorquina se sigue 76 empleando de forma habitual con esta misma valencia. Se podría considerar por lo mismo un regionalismo. garullos y pavos: ciurri e pavoni (Le pietre…, p. 76) Puesto que no existe un regionalismo específico para nombrar al pavo, he elegido la palabra “garullo”, relativamente poco conocida, para mantener el mismo efecto de sorpresa lingüística en un lector español que Consolo consigue en italiano con la palabra ciurri. hato: trùscia (Le pietre…, p. 77) Término manchego muy utilizado en el campo lorquino. Se trata de una tela gruesa dentro de la cual se lía la comida que se lleva el trabajador para el día. hombrón: omone (Le pietre…, p. 86) He optado por “hombrón” en lugar de “hombretón”, que es sin embargo más usual, por su similitud fonética con el original omone. Pirandello fue el primero en Italia en utilizar literariamente este aumentativo, que a partir de él se divulgaría ampliamente. hormiguicas: formicole (Le pietre…, p. 78) Aunque formicole no sea un diminutivo, se trata de una forma propia del siciliano (en lugar de formiche). En este caso he optado por el diminutivo del término “hormiga”, empleando el sufijo regional de origen aragonés “-ico”, que es habitual en el habla murciana. Con ello, se rinde el mismo empleo del regionalismo que en el original. imperscrutable: imperscrutabile (Le pietre…, p. 86) He conservado el mismo tono culto, algo rebuscado, del término imperscrutabile, optando por el vocablo español “imperscrutable” (en lugar de “inescrutable”), que rinde el carácter literario del vocablo italiano. 77 inseculorum sécula: seculi e seculorum (Le pietre…, p. 77) España, como Italia, sigue manteniendo vivas en la lengua expresiones latinas, ya sean éstas clásicas o eclesiásticas. En los ámbitos rurales dichas expresiones padecen una lógica deformación fonética. ivernada: invernata (Le pietre…, p. 80) Arcaísmo que sigue vigente en el habla murciana. Al igual que sucede con el término “ivierno” (“invierno”), este tipo de regionalismos permanece más fiel a su etimología latina. jinjolero: zìzzole (Le pietre…, p. 76) El autor no eligió esta vez un regionalismo, sino que empleó el clásico término zìzzole (“azufaifos”). En la región murciana se utiliza la palabra “jinjolero” para designar dicho árbol frutal, siendo este vocablo más conocido que su sinónimo “azufaifo”. Aunque en la primera edición, por razones de similitud fonética con el original, había optado por “azufaifo”, para esta segunda edición he preferido emplear el término con mayor sabor regional. jugaban a coscoletas: giocavano in groppa (Le pietre…, p. 77) La expresión habitual murciana que se corresponde con la española estándar “a caballito” es “a coscoletas”. Aún cuando Consolo haya prescindido de un regionalismo siciliano, también en esta ocasión he preferido privilegiar la forma regional. lampo: lampo (Le pietre…, p. 78) Ambos términos, el italiano y el español, comparten idéntica etimología, del bajo latín “lampare” (brillar). La palabra española “lampo” ha caído en desuso en buena parte de España, aunque se sigue utilizando en la región murciana, donde se conserva también en algunas localidades la variante “llampo”. En Puerto Lumbreras el empleo de “lampo” sigue vigente y significa “relámpago”, así como “rapidez” y “fugacidad” en su acepción metafórica. 78 lebrillas: lemmi (Le pietre…, p. 75) En Murcia se emplea la forma femenina “lebrilla” para indicar un cuenco más pequeño que el “lebrillo”. lenjos: lontano (Le pietre…, p. 79) La incorporación de una “n” después de la vocal en muchas palabras es típica del habla murciana. Se trata de una alteración fonética de uso muy extendido en las zonas rurales (“lenjos” por “lejos”, “muncho” por “mucho”, etc.). lero: tarantole (Le pietre…, p. 75) El nombre que se da a la tarántula en Lorca y Puerto Lumbreras es “lero”, término que no se recoge en el DRAE por ser propiamente un regionalismo. liebro: lepre (Le pietre…, p. 81) La forma “liebro” viene recogida en el DRAE y se usa para hacer referencia al macho de la liebre. Con todo, en la zona murciana es el término que los cazadores utilizan habitualmente para referirse en general a las liebres. liopardos: liopardi (Le pietre…, p. 77) Idéntica alteración fonética en las dos zonas, la siciliana y la levantina, con el mismo cambio de vocal. luminos: lumere (Le pietre…, p. 83) Regionalismo murciano que significa “lamparilla de aceite”. martinico: monachino (Le pietre…, p. 96) Tanto el DRAE como el MM dan únicamente a este término la valencia de “duende” o “fantasma”, sin mayor especificación. En cambio, en la región murciana (principalmente en la ciudad de Murcia donde se 79 sigue utilizando corrientemente) se identifica al “martinico” con el duende juguetón que reside principalmente en las casas. Se puede por lo tanto considerar este término (enriquecido con esta acepción) como un regionalismo característico de la zona. El valor semántico de esta palabra se identifica plenamente con la del monachino siciliano. mercao: accattata (Le pietre…, p. 75) En italiano accattare significa “pedir, adquirir con esfuerzo”, al tiempo que en siciliano es simplemente “comprar” (cf. Mortillaro). Sin embargo, Consolo me aclaró que eligió este verbo para indicar que Parlagreco había comprado “con muchos sacrificios” su terreno. Para rendir este regionalismo al habla murciana, he elegido el término “mercar”, que también significa “comprar”. Este vocablo, que ha caído en desuso en buena parte del territorio nacional, viene recogido en el DRAE y se sigue utilizando en la región murciana. mesmamente: veramente (Le pietre…, p. 88) Regionalismo murciano, muy en uso todavía hoy en día en ámbitos rurales. Se trata de una modificación fonética mediante el cambio vocálico de “mismamente”. Significa “precisamente”, “cabalmente”. mis mortichuelos: morticelli miei (Le pietre…, p. 83) Regionalismo específico de la zona murciana en donde alterna también con la forma “mortisuelo”. Este término se emplea sobre todo para aludir a los niños que mueren al nacer. Por afinidad se extiende afectivamente a los muertos más íntimos. Por razones fonéticas he preferido la forma “mortichuelo” que conserva el fonema “ch”, presente en el regionalismo siciliano. moros o por bandoleros: saracini o da briganti (Le pietre…, p. 82) En puridad, el término saracini corresponde a “sarracenos”, al tiempo que briganti equivale a “bandidos”. Con todo, si bien en Sicilia el 80 término saracini se impuso en el habla popular después de que los tradicionales puppi siciliani y los canta storie divulgaran el Orlando furioso, en el sur de España el vocablo de uso equivalente es “moros”. De igual forma, la forma “bandoleros” corresponde a la designación más extendida para aludir a los “bandidos” no sólo en Andalucía, sino también en las regiones colindantes, como es el caso del campo lorquino. murmujeando: mormorando (Le pietre…, p. 94) Regionalismo semántico murciano que significa “murmurar”. naíca: niente (Le pietre…, p. 96) Se trata de la forma diminutiva de «na’» (contracción de “nada”), profusamente utilizada en la región murciana. nenes: infanti (Le pietre…, p. 77) En ninguno de los dos casos se trata de un regionalismo. Ambos términos poseen valencias semánticas similares. El término italiano ha caído en desuso en mayor o menor grado en su primera acepción (la que designa a un niño menor de siete años), siendo precisamente éste el valor que Consolo le otorga en su relato. En español, la palabra “nene” se emplea también para aludir a un niño de corta edad siendo su uso especialmente extendido en la región de Murcia. Osté: Vossia (Le pietre…, p. 85) Regionalismo rústico murciano, que consiste en la modificación fonética de “usted”. paya: moglie (Le pietre…, p. 96) Aún cuando el término “payo-a” se encuentre recogido en el DRAE con el significado de “aldeano”, sin embargo en el campo de Lorca y en general en los ambientes rústicos de la región murciana se emplea 81 como equivalente de “mujer”. En compañía del artículo (“la paya”) este vocablo alude a la esposa del que habla. perola: pignatta (Le pietre…, p. 82) El término “perola” no es un regionalismo propiamente dicho, pero se trata de la palabra que se utiliza comúnmente en la región murciana para designar un recipiente en forma de olla. Observemos que el siciliano pignatta ha dado “piñata” en español con otra connotación. De hecho, la “piñata” se reserva casi exclusivamente para las fiestas infantiles. perras: soldi (Le pietre…, p. 96) Las voces “cuartos” y “perras” (siempre en plural) son familiares o populares, como lo es soldi, y coexisten en toda España. No se trata por tanto de regionalismos, como tampoco soldi es un sicilianismo. Con todo, en algunas regiones se utiliza una de las dos con preferencia a la otra. Dado que en la zona murciana prevalece “perras” y con objeto de dar uniformidad a la traducción he optado por esta última. perullos: villani (Le pietre…, p. 90) En el texto original el término villani aparece alternando con la palabra contadini. Don Gregorio utiliza despectivamente la palabra antigua villani para indicar a Parlagreco que es un ignorante palurdo, incapaz de entender su alto razonamiento. Este matiz está perfectamente encerrado en el regionalismo murciano “perullo”, empleado despectivamente por el murciano de ciudad para burlarse del murciano de campo, de su falta de educación y de su lenguaje popular. No procedía hacer uso de la voz “villano”, porque una de sus valencias semánticas se deriva de la evolución de su significado, que con el tiempo ha llegado a significar “ruin, indigno, indecoroso” (DRAE). El vocablo italiano, en cambio, no presenta esta segunda acepción de descalificación moral que se encuentra en “villano”. 82 pesambres: stenti (Le pietre…, p. 83) En Murcia existe el regionalismo “pesambres”, contracción de “pesadumbre”, que cubre un amplio espectro semántico para expresar precisamente estos sentimientos de dolor, de pena y de penurias que forman el tejido de toda vida humana pero quizá más especialmente la de los labradores. Petrosela: Petrosella (Le pietre…, p. 92) El término petrosella alude al perejil. Procede del griego “petrosélinon” (apio que crece entre las hierbas), compuesto de “pétra” (piedra) y de “sélinon” (apio). La antigua ciudad griega de Sicilia, Selinonte, tomó su nombre de esta palabra. Por razones de estilo y para rendir el valor lingüístico y literario del original he mantenido el mismo vocablo. Po’ hay que: Eh, c´è (Le pietre…, p. 95) La forma «po’» presenta una mutación fonética mediante la reducción del diptongo y la característica pérdida de la “s” final. Significa “pues”. poyo: scaricatore (Le pietre…, p. 77) Aunque la palabra “poyo” no sea un regionalismo murciano propiamente dicho, ha caído en desuso en el resto de España. Con todo, se sigue utilizando habitualmente en la zona de Murcia y es por lo mismo el término que mejor se corresponde con el vocablo siciliano scaricatore. priesa: prescia (Le pietre…, p. 89) Aunque existen en español bellísimos términos que expresan esta misma idea (como “presura” o “premura”), he preferido el vocablo “priesa”, de resonancias arcaicas, en el que se produce una epéntesis de la vocal “e” (en lugar de “prisa”). Esta voz en desuso subsiste todavía en algunos ámbitos rurales y regionales, como en la zona de Puerto Lumbreras. Además, la elección de “priesa” rinde mejor que ninguna la cadencia fonética de la voz regional prescia. 83 protestantes: protestanti (Le pietre…, p. 87) El término “protestante” tenía en España las mismas connotaciones que en Italia. Se empleaba para designar a los ingleses y alemanes, haciendo un uso extensivo del término “protestante” por ser ésta la religión que profesaban mayoritariamente. A nivel popular este valor se siguió conservando hasta hace relativamente poco tiempo. queso de cabra con pimienta: pecorino con il pepe (Le pietre…, p. 78) Composición del queso tomazzo. queso frito: tomazzo (Le pietre…, p. 77) Comida típica de los labradores en toda la zona del Levante que consiste en queso de cabra frito con tomate y pimienta. Consolo más adelante indica en el relato que el queso de cabra que come Parlagreco lleva pimienta: pecorino con il pepe (Le pietre…, p. 78). Se puede deducir, por tanto, que se trata de un queso de cabra similar al que come Parlagreco dentro de las muchas variedades del queso de cabra típico del ámbito Mediterráneo. ¡Quia!: Mai (Le pietre…, p. 85) Interjección coloquial y popular muy utilizada en las zonas rurales de Puerto Lumbreras. Viene recogida en el DRAE, aunque ha caído en desuso en buena parte del territorio nacional. Deriva de “qué ha [de ser]” y viene a significar lo mismo que otra interjección de uso vigente en toda España: “¡Qué va!”. Con todo “quia” tiene un valor aún más enfático por pertenecer al habla rural. Quieto parao: Statti sodo (Le pietre…, p. 85) Locución adverbial empleada en la región murciana y que goza actualmente de gran popularidad en toda España gracias al influjo de un personaje televisivo. Se trata de una expresión con gran poder conminativo, que exhorta a permanecer inmóvil allá donde se esté. 84 roalico de tierra: fazzoletto (Le pietre…, p. 75) Regionalismo murciano, utilizado sobre todo en el campo lorquino, para indicar un trozo pequeño de tierra. El término se corresponde semánticamente con el fazzoletto utilizado por Consolo en el original. ¡San Liberador!: Santo Liberante! (Le pietre…, p. 87) Exclamación popular siciliana utilizada para invocar a un santo imaginario que “libera” y protege de todo mal al que lo invoca. Se trata por consiguiente de un santo “liberador” de males. se platicaba abonico: si contava sottovoce (Le pietre…, p. 77) El verbo “platicar” es un vocablo popular típico de todo el Sur de España, especialmente en las zonas rurales. No sólo tiene el valor semántico de transmitir información sino también de comentar aquello que se está diciendo, acepción que se corresponde con la del verbo contare. Por lo que respecta a sottovoce, existe el regionalismo “abonico”, que significa “en voz baja, despaciosamente, lentamente” y es el que se emplea en el campo lorquino. Literalmente significa “de manera bonita, con voz dulce y suave”. sendica: viòlo (Le pietre…, p. 81) El diminutivo en “-ico” se utiliza profusamente en la región murciana, donde “senda” se emplea en su acepción de camino estrecho en el campo o en la sierra. ¡Sín Señó!: ’Gnorsì! (Le pietre…, p. 88) Esta modificación fonética en la que se añade una “n” final a la partícula de afirmación “sí” es propia del habla rural murciana y se encuentra en otras palabras con la misma terminación en “i”, como “asín” por “así”. Por lo que respecta a “señó”, para rendir la aféresis regional del original (’gnorsì en lugar de signorsì) he optado por la típica fonética murciana 85 en la que se produce la pérdida de la “s” y la “r” en final de palabra. Equivale, pues, a “señor”. sisca: disa (Le pietre…, p. 75) En la región murciana se utiliza la palabra “sisca” (recogida en el DRAE) para aludir a una hierba que nace en las viñas y que sirve para hacer los mantos con que se cubren las barracas. En botánica, el término técnico italiano es ampelodesma, del griego ampelos (viña) y desmos (ligadura). Parece lógico deducir que el italiano disa sea la deformación popular de la palabra culta. Según el Roque Barcia, “ampelodesmo” en español significa “una especie de hierba semejante al esparto con que los sicilianos ataban las vides”. t’adormilaste: t’addormentasti (Le pietre…, p. 86) En la región murciana existe el regionalismo “endormiscarse” con el significado de quedarse involuntariamente dormido debido al cansancio u otro motivo, aunque de uso poco frecuente. Sin embargo, en este caso he preferido “adormilarse” porque rinde mejor la textura fonética del término italiano, que de hecho tampoco es un regionalismo. También transcribo la alteración regional del original en el pronombre “te”. Tajo parejo: Cominciò il suo lavoro (Le pietre…, p. 76) Aun cuando no aparezca ningún término en el texto original que se corresponda con esta locución, tan típicamente lorquina y al mismo tiempo tan propia del habla rural murciana, la idea que se desprende de este pasaje en italiano conviene plenamente con el uso de la expresión “tajo parejo”, empleada precisamente para hacer referencia al trabajo uniforme y metódico, en el que nada queda sin hacer. Esta locución, que tantas veces oí durante la recogida de la almendra en el campo lumbrerense, aporta también el matiz de una perseverancia sistemática en el incansable faenar y en el duro bregar con la tierra. 86 tanimientras: intanto (Le pietre…, p. 90) Precioso regionalismo, empleado con profusión por poetas y escritores murcianos desde Saavedra Fajardo hasta Martínez Álvarez de Sotomayor, que he querido rescatar aquí por su belleza. Significa “entretanto”. ’tate tranquilica: sta’ tranquilla (Le pietre…, p. 89) La forma «’tate» es la alteración por aféresis de “estate” en el campo murciano, que se corresponde perfectamente con sta’. terretremo: tremuoto (Le pietre…, p. 85) Arcaísmo utilizado en la huerta murciana que alterna con “terretiemblo” (por “terremoto”). tesoro escondío: trovatura (Le pietre…, p. 84) Al no existir en español una única palabra que rinda el sentido exacto del vocablo trovatura –regionalismo siciliano que se utiliza sólo cuando se encuentra un tesoro oculto (principalmente monedas de oro)– se hacía necesario traducirlo acompañado de un adjetivo que recogiera esta valencia añadida. tiestos: cocci (Le pietre…, p. 75) En Lorca, el “tiesto” –además de significar “maceta”– alude principalmente a trozos rotos de cualquier vasija de barro, aunque pueden ser de otro material. to’ p’alante hast’acá: diritto fino a qua (Le pietre…, p. 85) Regionalismo del campo de Lorca, en el que se suprimen varias sílabas. Se trata de la contracción de “todo para adelante hasta acá”, con el sentido de seguir un camino “todo recto hasta aquí”. 87 to’ tieso: diritto (Le pietre…, p. 75) Contracción propia del habla rural murciana en la que se suprime la última sílaba. “To’ tieso” equivale a “erguido”. umbligo: bellìco (Le pietre…, p. 92) En ninguno de los dos casos se trata de un regionalismo, sino de una alteración popular de los términos “ombligo” y ombelico. Una fuente n’er puentecico /N’er Lanniri siet’aspontico’/ Sabucina e’ jarta d’oro /Testa de lumbre, Testa d’oro…: A lu ponti ci n’è un fonti,/A li Lànniri setti mànniri,/ Sabucina d’oru è china,/Capudarsu, Capu d’oru… (Le pietre…, p. 82) He traducido la cancioncilla que rememora el personaje del relato mediante los siguientes regionalismos: añadiendo algún sufijo en “ico” que me ha permitido hacer la rima; suprimiendo la “s” final de “asponticos” y del verbo “es”, según se pronuncia en la región murciana, así como mediante la elisión de la “e” en la preposición “de” ante vocal. “Asponte” es un regionalismo aragonés que significa “aprisco”, “redil”, utilizado todavía hoy en algunas zonas rurales murcianas. También he empleado la forma contracta y alterada “n’er” por “en el”. Asimismo, he optado por la expresión murciana “jarta de”, deformación regional de la española “harta de”, con el sentido de “llena”, equivalente de la voz siciliana china. Finalmente, he elegido el término “testa” para capu (“cabeza”). Se trata de un vocablo que ha caído en desuso pero que se sigue utilizando en zonas rurales del Levante. Lo mismo sucede con la palabra “lumbre” por “fuego”, igualmente en desuso pero muy vigente en la región murciana a día de hoy. No me ha sido posible conservar las rimas internas que aparecen en el original en los tres primeros versos (ponti-fonti/Lànniri-mànniri/ Sabucina-china), aunque he conseguido darle ese aire rimado al conjunto. La traducción literal de la letrilla viene a ser: “En el puente hay una fuente/En Lànniri siete rediles/ Sabucina está llena de oro /Cabeza de fuego, Cabeza de oro…”. 88 «Uno, Vito»: «Jeu,Vitu» (Le pietre…, p. 80) Regionalismo del campo murciano y andaluz, donde en lugar del pronombre personal “yo” se usa el indefinido “uno”, uso que se corresponde con el regionalismo siciliano jeu. visivilo: scavuzzo (Le pietre…, p. 96) Alteración del fonema “e” por “i”, de la voz “vesivilo” (DRAE: “fantasma, visión” y MM: “fantasma, aparición”). Esta forma alterada se utiliza corrientemente en toda la región murciana, si bien abarca un mayor espectro semántico pues el término sirve para nombrar al duende que habita en un lugar y que de vez en cuando se aparece a los lugareños adoptando distintas formas. En Murcia coexisten las dos formas: “visivilo” y “vesivilo”. El vocablo elegido se corresponde bien con el término siciliano del texto original. (se) vuerven: (si) cangiano (Le pietre…, p. 82) Alteración fonética mediante la mutación consonántica de la “l” por la “r”, propia del habla murciana. zagal: caruso (Le pietre…, p. 78) Según el diccionario Battaglia, el término siciliano caruso alude a un joven empleado en labores agrícolas u otras. Tiene el sentido originario de “cabeza rapada o sin pelo”, porque era así como se debían asear los jóvenes que trabajaban en el campo o en las minas, de ahí que esta palabra se utilice en Sicilia para designar precisamente a estos jóvenes y por extensión a todo muchacho joven. Por su parte, el español posee una amplia gama de voces para cubrir el campo semántico de “muchacho”: zagal, mozo, chaval, rapaz, mancebo, etc. (con sus también variadísimos diminutivos correspondientes). Todas estas voces pueden ser intercambiadas a lo largo y ancho de España y no existe en ninguna zona un regionalismo específico, como es el caso de la palabra caruso en Sicilia. Bien es verdad que algunas regiones 89 españolas utilizan con preferencia un vocablo a otro. Así, por ejemplo, en Galicia se ha generalizado “rapaz”. He optado por “zagal” por ser el término (con su diminutivo “zagalico” y aumentativo “zagalón”) más extendido en la región murciana. También he recurrido a “zagal” en otros pasajes del relato: cuando lo utiliza Vito para referirse a sus hijos, haciendo un uso propio del habla murciana (como en “Tampoco a la paya, ni a los zagales les gusta la caza” que vendría a significar “Tampoco a mi mujer, ni a mis hijos les gusta la caza”), así como, en general, para aludir a muchachos-as muy jóvenes. APARATO BIBLIOGRÁFICO 93 I. OBRA DE VINCENZO CONSOLO27 I. 1. NARRATIVA (Romanzi) • La ferita dell’aprile, Mondadori, Milán, 1963. Reediciones: · “Nuovi Coralli, 181”, Einaudi, Turín, 1977. · “Oscar Oro, 23”, Mondadori, Milán, 1989. · “Oscar, Scrittori moderni”, Mondadori, Milán, 2008, 2010. • Il sorriso dell’ignoto marinaio, Einaudi, Turín, 1976. Reediciones: · “Oscar Oro, 9”, Mondadori, Milán, 1987. · Einaudi “Nuovi Coralli,” Turín, 1992. · Einaudi “Scuola”, Turín, 1995. · “Scrittori italiani”, Mondadori, Milán, 1997. · “Oscar scrittori del Novecento”, Mondadori, Milán, 2002. · “Oscar classici moderni, 123”, Mondadori, Milán, 2004. • Lunaria, Einaudi, Turín, 1985. Reediciones: · Mondadori, Milán, 1996. 27 Tan sólo reseño sus libros debido al gran número de artículos publicados en periódicos, revistas, prólogos o introducciones a libros. 94 · “Oscar” Mondadori, Milán, 2003. · “Oscar, Scrittori moderni”, Mondadori, Milán, 2010. • Retablo, 1987. La editorial Sellerio publica tres ediciones: · Primera edición: Sellerio, Palermo, colección “La memoria”, 1987. · Segunda edición: Sellerio, Palermo, colección “Il Castello”, 1990. · Tercera edición: Sellerio, Palermo, colección “La rosa dei venti”, 2009. Reediciones: · “Scrittori italiani”, Mondadori, Milán, 1992. · “Oscar scrittori del Novecento”, Mondadori, Milán, 2000. · “Oscar” Mondadori, Milán, 2009. • Retablo (versione teatrale di Ugo Ronfani), La Cantinella, Catania, 2001. • Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milán, 1988. Reediciones: · “Oscar” Mondadori, Milán, 1990. · “Oscar, Scrittori moderni”, Mondadori, Milán, 2010. • La Sicilia passeggiata, Eri, Turín, 1991. • Nottetempo, casa per casa, 1992. En 1992 aparecen tres ediciones: · Primera edición: Mondadori, Milán, 1992. · Segunda edición: Edizione CDE spa, Milán, 1992. · Tercera edición: Edizione CDE premi Strega, Milán, 1992. 95 Reediciones: · “Oscar scrittori del Novecento”, Mondadori, Milán, 1994. · Collezione “Premio Strega: i cento capolavori”, UTET, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, 2006/7. · “Oscar, Scrittori moderni”, Mondadori, Milán, 2010. • Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Donzelli, Roma, 1993. • L’olivo e l’olivastro, Mondadori, Milán, 1994. Reediciones: · “Oscar” Mondadori, Milán, 1999. · “Oscar, Scrittori moderni”, Mondadori, Milán, 2010. • Lo spasimo di Palermo, Mondadori, Milán, 1998. Reediciones: · Oscar Mondadori, Milán, 2000. · “Oscar, Scrittori moderni”, Mondadori, Milán, 2010. • Di qua dal faro, Mondadori, Milán, 1999. Reediciones: · “Oscar scrittori del Novecento”, Mondadori, Milán, 2001. • Amor sacro: en preparación. 96 I. 2. TEATRO (Opere Teatrali) • Catarsi: en Trittico, SanFilippo, Catania, 1989. en Oratorio, Manni, Lecce, 2002. • Pio La Torre, orgoglio di Sicilia (Atto Unico), Centro di Studi ed iniziative culturali, Palermo, 2009. • L’attesa, Bompiani, Milán, 2010. I. 3. NOVELAS (Racconti) • Neró Metallicó: Il Melangolo, Genova, 1994. Un racconto con 12 finali28, Gremese, Roma, 2009. • Il teatro del sole, racconti di Natale, Interlinea, Novara, 1999. • Isole dolci del Dio29, L’Obliquo, Brescia, 2002. • Siracusa come un incanto, Artestudio, Siracusa, 2003. • Il Corteo di Dioniso30, La Lepre, Roma, 2009. 28 Además de los doce finales diferentes realizados por diversas personas, incluye uno especial diferente del propio Consolo. 29 Incluye quince ilustraciones de Giorgio Bertelli. 30 Se trata de una reciente edición –con ilustraciones de Cecilia Capuana– que reedita Neró Metallicó y Il Teatro del Sole. 97 II. TRADUCCIONES DE LA OBRA DE VINCENZO CONSOLO 1. LA FERITA DELL’APRILE 1. 1. AL ALEMÁN: • Die Wunde im April (por Bettina Kienlechner y Ulrich Hartmann), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1990. 1. 2. AL ESPAÑOL: • La herida del abril (por Miguel Ángel Cuevas), en preparación para la editorial Barataria. 1. 3. AL FRANCÉS: • La Blessure d’Avril (por Maurice Darmon), Le Promeneur, París, 1990. 2. IL SORRISO DELL’IGNOTO MARINAIO 2. 1. AL ALEMÁN: • Das lächeln des unbekannten Matrosen (por Arianna Giachi), Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1984. 2ª y 3ª edición: Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990 y 1996. 98 2. 2. AL ÁRABE: • (por Naglaa waly), ed. Dar Shargiyat, El Cairo (Egipto), 2009. 2. 3. AL CATALÁN: • El somrís del mariner inconegut (por Alexis Eudald Solà), Ed. Proa, Barcelona, 2006. 2. 4. AL ESPAÑOL: • La sonrisa del ignoto marinero (por Esther Benítez), Alfaguara, Madrid, 1981. • La sonrisa del ignoto marinero (por Giovanni Barone y Mirta Vignatti), Laborde Editor, Rosario (Argentina), 2001. 2. 5. AL FRANCÉS: • Le Sourire du marin inconnu (por Mario Fusco y Michel Sager), prólogo de Leonardo Sciascia, Bernard Grasset, París, 1980 (2ª edición: para la colección “Les Cahiers rouges”, Bernard Grasset, París, 1980). 2. 6. AL INGLÉS: • The Smile of the Unknown Mariner (por Joseph Farrell), Carcanet, Manchester, 1994. 3. LUNARIA 3. 1. AL ESPAÑOL: • Lunaria (por Irene Romera Pintor), Centro de Lingüística Aplicada Atenea, Madrid, 2003. Premio Internacional a la Traducción de Obras literarias y científicas 2004, otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano. 99 3. 2. AL FRANCÉS: • Lunaria (por Brigitte Pérol y Christian Paoloni), Le Promeneur, París, 1988. 4. RETABLO 4. 1. AL ALEMÁN: • Retablo (por Maria E. Brunner), Folio Verlag, Wien / Bozen, 2005. 4. 2. AL ÁRABE: • En preparación (por Naglaa waly), ed. Dar Shargiyat, El Cairo (Egipto). 4. 3. AL CATALÁN: • Retaule (por Assumpta Camps), Edicions de la Magrana, Edicions 62, Barcelona, 1989. 4. 4. AL ESPAÑOL: • Retablo (por Juan Carlos Gentile Vitale), Muchnik, Barcelona, 1995. 4. 5. AL FRANCÉS: • Le Retable (por Soula Aghion y Brigitte Pérol), Le Promeneur, París, 1988. 4. 6. AL HOLANDÉS: • Retabel. Siciliaanse passies (por Pietha de Voogd), Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1992. 4. 7. AL PORTUGUÉS: • Retábulo (por José Colaço Barreiros), Difel, Lisboa, 1990. • Retábulo (por Roberta Barni), Berlendis & Vertecchia Editores, Sao Paulo (Brasil), 2002. 100 5. LE PIETRE DI PANTALICA 5. 1. AL ALEMÁN: • Die Steine von Pantalica (por Anita Pichler), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996. 5. 2. AL ESPAÑOL: • La presente edición y traducción de “Filosofiana”, relato de Las piedras de Pantálica (por Irene Romera Pintor), Fundación Updea, Madrid, 2008 (2ª edición de 2011, revisada y ampliada para la misma editorial). En preparación la traducción del libro completo. 5. 3. AL FRANCÉS: • Les Pierres de Pantalica (por Maurice Darmon), Le Promeneur, París, 1990. 5. 4. AL GALLEGO: • “Ratumeni” y “Comiso” (As pedras de Pantalica) relato de Las piedras de Pantálica (por Cándido Pazó y Dolores Vilavedra), en Seis narradores italianos, edición de Danilo Manera y Dolores Vilavedra, Edicións Positivas, Santiago de Compostela, 1993. 6. NOTTETEMPO, CASA PER CASA 6. 1. AL ALEMÁN: • Bei Nacht, von Haus zu Haus (por Maria E. Brunner), Folio Verlag, Viena-Bozen, 2003. 6. 2. AL ESPAÑOL: • De noche, casa por casa (por Ana Poljak), Muchnik Editores S.A., Barcelona, 1993. 101 • De noche, casa por casa (por Eloy-José Santos Domínguez), Primera edición en español para América Latina, Editorial Norma, Bogotá, 1996. 6. 3. AL FRANCÉS: • D’une maison l’autre, la nuit durant (por Louis Bonalumi), Gallimard, París, 1994. 6. 4. AL INGLÉS: • Night-Time, House by House (por Daragh O’ Connell), en preparación. 6. 5. AL PORTUGUÉS: • De Noite casa por casa (por José Colaço Barreiros), ed. Teorema, Lisboa, 1996. 7. L’OLIVO E L’OLIVASTRO 7. 1. AL ESPAÑOL: • El olivo y el acebuche (por Juan Carlos Gentile Vitale), Muchnik Editores S.A., Barcelona, 1997. 7. 2. AL FRANCÉS: • Ruine immortelle (por Jean-Paul Manganaro), Seuil, París, 1996. 8. LO SPASIMO DI PALERMO 8. 1. AL ALEMÁN: • Palermo. Der Schmerz (por Maria E. Brunner), Folio Verlag, Wien/Bozen, 2008. 102 8. 2. AL ESPAÑOL: • El pasmo de Palermo (por Pilar González Rodríguez), Debate, Madrid, 2001. 2ª Edición: para la colección “Las mejores novelas de la literatura universal contemporánea” (por Pilar González Rodríguez), prólogo de Constantino Bértolo, Biblioteca El Mundo, Madrid, 2003. 8. 3. AL FRANCÉS: • Le Palmier de Palerme (por Jean-Paul Manganaro), Seuil, París, 2000. 9. DI QUA DAL FARO 9. 1. AL ESPAÑOL: • De este lado del faro (por Miguel Ángel Cuevas), Parténope, 2008. 9. 2. AL FRANCÉS: • De ce côté du phare (por Jean-Paul Manganaro), Seuil, París, 2005. 10. Antología de ensayos y artículos sobre el tema del mundo mediterráneo, escritos todos ellos por Vincenzo Consolo y traducidos al inglés: • Reading and Writing the Mediterranean. Essays by Vincenzo Consolo, edición de Massimo Lollini & Norma Bouchard, Toronto, University of Toronto Press, 2006. 103 III. PREMIOS Y RECONOCIMIENTO A LA OBRA DE VINCENZO CONSOLO 1. Premio letterario CITTÀ DI SOVERATO, por La ferita dell’aprile, en 1964. 2. Premio PIRANDELLO, por Lunaria, en 1985. 3. Premio GRINZANE CAVOUR, por Retablo, en 1988. 4. Premio RACALMARE, por Retablo, en 1988. 5. Premio CITTÀ DI PENNE, por Le pietre di Pantalica, en 1989. 6. Premio STREGA, por Nottetempo, casa per casa, en 1992. 7. Premio INTERNAZIONALE UNIONE LATINA, por L’olivo e l’olivastro, en 1994. 8. Premio di Cultura CITTÀ DI MONREALE, por Lo spasimo di Palermo, en 1998. 9. Premio CASATO PRIME DONNE, por Lo spasimo di Palermo, en 1999. 10. Premio BRANCATI-ZAFFERANA, por Lo spasimo di Palermo, en 1999. 11. Premio NINO MARTOGLIO, por Di qua dal faro, en 1999. 12. Premio FERONIA, por Di qua dal faro, en 2000. 13. Premio PALMI, por el conjunto de su obra, en 2007. 14. Premio GIACOMO LEOPARDI, por el conjunto de su obra, en 2008. 104 Además, Vincenzo Consolo ha recibido el Título de Doctor Honoris Causa en dos ocasiones hasta la fecha: 1. por la Universidad “Tor Vergata” de Roma el 18 de febrero de 2003. Lectio Magistralis: “La Metrica della Memoria”. Laudatio de los Profesores Andrea Gareffi y Enrico Guaraldo. 2. por la Universidad de Palermo, el 20 de junio de 2007. Lectio Magistralis: “Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano”. Laudatio del Profesor Natale Tedesco. 105 IV. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN El presente capítulo bibliográfico recoge todos los trabajos de investigación relativos a la figura y la obra de Vincenzo Consolo. El material bibliográfico se ordena en torno a las tesinas (“Tesi di Laurea” y “Mémoire de Maîtrise”) y a las Tesis Doctorales. Los trabajos de investigación se ordenan por sus países de origen. La relación de países sigue un orden determinado por el volumen de trabajos de investigación. Con objeto de ordenar el material bibliográfico dentro de cada país he considerado oportuno presentarlos por universidades, en orden alfabético, y dentro de cada universidad por orden cronológico. De esta manera, atendiendo al volumen de trabajos de investigación, la relación de países seguirá el siguiente orden: Italia, Francia, Alemania, España, Bélgica, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos. IV. 1. ITALIA31: Tesi di Laurea Università degli studi di BARI 1999-2000: 31 Toda “Tesi di Laurea” (tesina) y Tesis Doctoral viene reseñada en Italia en el “Atlante Linguistico Italiano”. Para algunas de las tesinas aquí citadas, véase 106 • Dario Pignone: “La letteratura avvilita. Vincenzo Consolo” (dirección de Giuseppe Lasala). Università Alma Mater Studiorum di BOLONIA 2005-2006: • Maria Letizia Fiocchetti: “La Sicilia nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de Fabrizio Frasnedi; codirección de Matteo Ghirardelli). Università degli studi della CALABRIA 1994-1995: • Rosaria Larussa: “Pastiche linguistico e denuncia sociale nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de Nicola Merola). Università degli studi di CATANIA 1989-1990: • Carmela Gandolfo: “Per leggere Il sorriso dell’ignoto marinaio” (dirección de A. Di Grado). 1991-1992: • Giuseppa Mazzola: “Umori civili e scatto fantastico nella prosa di Vincenzo Consolo” (dirección de Nicolò Mineo). 1992-1993: • Agata Cardillo: “L’italiano regionale di Sicilia nella Ferita dell’aprile di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). en concreto: “Tesi di Laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania. Cattedra di Geografia linguistica”, a cargo de I. M. B. Valenti, en «Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano», III Serie, Turín, 2001, pp. 223-38. 107 • Federica Spampinato: “L’italiano regionale di Sicilia nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). 1994-1995: • Giovanni Pastaro: “Il dibattito critico su Vincenzo Consolo” (dirección de Guido Nicastro). • Maria Elena La Rosa: “L’italiano regionale e letterario in Retablo di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). 1995-1996: • Valeria Benanti: “L’italiano regionale di Sicilia in Lunaria di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). 1997-1998: • Giusi Burgaretta: “Teatro e teatralità nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de Sarah Zappulla Muscarà). Contiene varios Apéndices: “Appendice I: intervista a Vincenzo Consolo [Sant’Agata, 10-IX-98 (pp. 155-64)]; Appendice II: viene riportato il testo della rappresentazione di «Fuochi Freddi» (pp. 165-87), tratto da Lunaria e messo in scena nel 1991 a Monreale, nell’elaborazione drammaturgica di Ola Cavagna, dal regista Mauro Avogadro. Alla generosità del regista Mauro Avogadro si deve anche la disponibilità del testo di «Minima Lunaria» (pp. 188-246)”. • Gabriella Maria Concetta Giuliana: “L’italiano regionale nelle Pietre di Pantalica di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). • Laura Di Trapani: “La traduzione dell’italiano regionale nel testo spagnolo (E. Benítez, 1981) del Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). • Michele Mangione: “L’italiano regionale della Sicilia e altre lingue in L’olivo e l’olivastro e Nerò metallicò di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). 108 1999-2000: • Vanessa Di Salvo: “L’italiano regionale di Sicilia nello Spasimo di Palermo di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). • Arianna Tiralongo: “L’italiano regionale di Sicilia in Nottetempo, casa per casa di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). • Lorella Spinello: “Vincenzo Consolo. Una «figura in fuga», nello specchio dei suoi scritti” (dirección de A. Di Grado). Contiene en Apéndice: “Incontro con lo scrittore [Catania, 13-XII-98 (pp. 155- 82); Milano, 22-IV-99 (pp. 183-214)]”. 2000-2001: • Loreto Bongiovanni: “La traduzione dell’italiano regionale nel testo inglese (J. Farrell, 1994) del Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). 2001-2002: • Alessia Saraceno: “Vincenzo Consolo: un Odisseo tra i mari della scrittura” (dirección de Rosalba Galvagno). • Maria Giuseppina Catalano: “Figure del dolore. Follia e melanconia nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de Rosa Maria Monastra). Contiene en Apéndice: “Intervista a Vincenzo Consolo [Agrigento, 30-IX-2001 (pp. I-XXIV)]”. 2003-2004: • Stefania Cipolla: “La traduzione spagnola di Retablo di Vincenzo Consolo. Regionalità linguistica e problemi traduttivi” (dirección de Salvatore C. Trovato). • Cettina Cornelio: “La regionalità siciliana in Retablo di Vincenzo Consolo nella traduzione francese” (dirección de Salvatore C. Trovato). • Debora La Rosa: “Problemi di traduzione dell’italiano regionale nella versione francese (M. Fusco e M. Sager) del Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo” (dirección de Salvatore C. Trovato). 109 2004-2005: • Glenda Dollo: “La sfida al labirinto di Vincenzo Consolo” (dirección de Rosalba Galvagno). 2007-2008: • Andreina Litrico: “L’ekfrasis della Sicilia nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de Rosalba Galvagno). Università degli studi di MESSINA 1998-1999: • Eros Salonia: “Il teatro di Vincenzo Consolo: Catarsi. Il gioco dell’impossibile” (dirección de Giuseppe Rando). Università degli studi di MILANO (Bicocca) 2005-2006: • Lisa Rustico: “Il paesaggio siciliano in Vincenzo Consolo: Retablo” (dirección de Elena Dell’Agnese). Contiene en Apéndice: “Conversazione con Vincenzo Consolo [Milano, 11-V-2006 (pp. 159-68)]”. Università degli studi di PALERMO 2000-2001: • Daniela Giambanco: “La poetica di Vincenzo Consolo tra storia e mito” (dirección de Salvatore Lo Bue). Contiene una entrevista inédita a Vincenzo Consolo. 2003-2004: • Giovanna Tobia: “Memoria e ragione del paesaggio: V. Consolo e A. Castelli” (dirección de D. Perrone). Università degli studi di PAVIA 2004-2005: • Alessandra Morini: “Per Catarsi di Vincenzo Consolo: un esempio di tragico moderno. Ricostruzione filologica e critica. Con un’intervista 110 inedita a Vincenzo Consolo [Milano, 3-3-06 (pp. 182-9)]” (dirección de Clelia Martignoni; codirección de Anna Beltrametti y Federico Francucci). A parte de la entrevista en Apéndice, también reproduce tres conversaciones radiofónicas “tratte dalla trasmissione Damasco di «Radio tre», in cui Consolo si sofferma in particolare su tre grandi scrittori siciliani: Elio Vittorini, Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia, e sul rapporto con loro (pp. 189-210): 14-12-05: Elio Vittorini (p.190); 15-12-05: Lucio Piccolo (p. 197); 16-12-05: Leonardo Sciascia (p. 203)”. Università degli studi di PISA 1995-1996: • Chiara Savettieri: “Antonello da Messina: un percorso critico” (dirección de Antonino Caleca). Véase sobre todo el capítulo XIII: “Due scrittori siciliani ed Antonello “[cf. en particular: “13. 3. Vincenzo Consolo: il linguaggio come rivolta e come memoria” (pp. 455-77)]. 1996-1997: • Chiara Pellegrini: “La contaminazione linguistica in Vincenzo Consolo. Con un glossario dei primi tre volumi (1963, 1976, 1985)” (dirección de Livio Petrucci). ROMA 1990-1991: • Fabiola Paterniti Martello: “Vincenzo Consolo e l’esperienza della scrittura”, Università di Tor Vergata-Roma II (dirección de Emerico Giachery; codirección de Rino Caputo). 111 1994-1995: • Attilio Scuderi: “Le metafore malinconiche di Vincenzo Consolo”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dirección de Bianca Maria Frabotta). 1999-2000: • Paola Casciani: “Vincenzo Consolo: l’utopia e la città”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dirección de Stefano Giovanardi; codirección de Giovanna De Angelis). 2001-2002: • Linda Di Mauro: “Le arti visive nella narrativa di Sciascia e Consolo”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dirección de Antonella Sbrilli; codirección de Manuela Annibali). Università degli studi di SIENA 1993-1994: • Barbara Dragoni: “Vincenzo Consolo” (dirección de Alfio Vecchio). Contiene en Apéndice “Intervista a Vincenzo Consolo (pp. 525-39)”. 2005-2006: • Gabriele Vitello: «Il romanzo del ritorno» in Elio Vittorini e Vincenzo Consolo” (dirección de Daniela Brogi). Università degli studi di TORINO 1989-1990: • Massimo Catti: “Nuclei tematici nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de Marco Cerruti). 112 Università degli studi di TRIESTE 1991-1992: • Lorenza Cucchiani: “Anche la mia penna è intinta nello zolfo: la narrativa di Vincenzo Consolo tra razionalità e barocco” (dirección de Elvio Guagnini). Università degli studi di VENEZIA Ca’ Foscari 1998-1999: • Nicoletta Santangelo: “Vincenzo Consolo. Una voce tragica oltre la scena del teatro” (dirección de Ricciarda Ricorda). IV. 2. FRANCIA IV. 2. a. Mémoires de maîtrise Universidad d’AIX-MARSEILLE I 1989-1990: • Patricia Racine: “Immagini del Risorgimento nel romanzo siciliano” (dirección de Rubat du Merac). Contiene un Apéndice en dónde transcribe la conversación telefónica con Vincenzo Consolo (10-VI- 1990: pp. 150-57). Universidad de Stendhal GRENOBLE III 1992-1993: • Demetrio Trunfio: “Alle radici della scrittura: infanzia e lingua materna nell’opera di Vincenzo Consolo” (dirección de G. Bosetti). Universidad de NICE SOPHIA ANTIPOLIS 2001-2002: • Eleonora Gellini: “La Sicilia contadina attraverso lo sguardo di Vincenzo Consolo (Le pietre di Pantalica) e di Maria Occhipinti 113 (Una donna di Ragusa e Il Carrubo e altri racconti)” (dirección de Arnaldo Moroldo; codirección de Monica Mocca). PARÍS 1996-1997: • Elisabetta Brucoli: “Vincenzo Consolo e la Sicilia nella sua opera romanzesca”, Universidad de Paris-IV “La Sorbonne” (dirección de J. M. Gardair). 1999-2000: • Anne Parniere: “Sicile et sicilitude dans l’oeuvre narrative de Vincenzo Consolo”, Universidad de Paris-III “La Sorbonne” (dirección de Denis Ferraris). Se trata de una “Mémoire de maîtrise d’italien, Langues, Littératures et civilisations étrangères”. 2000-2001: • Anne Parniere: “L’écriture palimpseste: étude de l’oeuvre de Vincenzo Consolo à partir de l’analyse de Retable (1987), de D’une maison l’autre, la nuit durant (1992) et de Ruine immortelle (1994)”, Universidad de Paris-III “La Sorbonne” (dirección de Denis Ferraris). Se trata de una “Mémoire d’études approfondies. Culture et société en Italie du Moyen Âge au XXème siècle: langue, littérature, et civilisation”. Fecha: 18 de julio de 2001. Universidad de SAINT-DENIS 1989-1990: • Valérie Vita: “ Vincenzo Consolo, écrivain de la memoire” (dirección de Giuditta Isotti-Rosowsky). 114 IV. 2. b. Tesis Doctorales TESIS DOCTORAL de Maryvonne Briand Director de la Tesis: Mariella Colin. Universidad de Caen/ Basse -Normandie Título: “Poétique de l’espace et du temps dans l’oeuvre narrative de Vincenzo Consolo”. Fecha: 19 de junio de 2004. IV. 3. ALEMANIA ERLANGEN-NÜRNBERG 1989-1990: • Christine Dauner: “Vincenzo Consolo: Literatur als Geschichtsschreibung oder als Dokumentation” [Magisterarbeit in der Philosophischen Fakultät II (Sprach- und Literaturwissenschaften) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorgelegt von Christine Dauner aus Rosenheim; contiene en Apéndice: “Interview mit Vincenzo Consolo (pp. I-XXVII)”]. FRANKFURT AM MAIN 1988-1989: • Agnes Denschlag: “Die Sicilianità Vincenzo Consolo” (dirección de Gerhard Goebel-Schilling); [Abschlussarbeit zuz Erlangung des Magister Artium im Fachbereich Neuere Philologien (Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main)]. 115 IV. 4. ESPAÑA MADRID TESIS DOCTORAL de Miguel Gabriel Ochoa Santos. Director de la Tesis: Antonio Ubach Medina Universidad Complutense de Madrid. Título: “Historia, memoria y polifonía mítica en De noche, casa por casa de Vincenzo Consolo”. Fecha: 2005. TESIS DOCTORAL de Nicolò Messina. Director de la Tesis: Manuel Gil Esteve. Universidad Complutense de Madrid. Título: “Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio”. Fecha: 4 de julio de 2007. La presente Tesis Doctoral (ISBN: 978-84-669-3196-0) se puede consultar online en: http://eprints.ucm.es/8090/ IV. 5. BÉLGICA AMBERES 1993: • Annemieke Van Orshoven: “La verità del romanzo: Retablo (Vincenzo Consolo)” (dirección de Walter Geerts); [Eindverhandeling ingediend tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Letteren en Wijsbegeerte (Universitaire Instelling Antwerpen)]. 116 IV. 6. ESCOCIA STRATHCLYDE TESIS DOCTORAL de Daragh O’Connell. Director de la Tesis: Joseph Farrell. Universidad: University of Strathclyde (Escocia). Título: “The Trinacria Trilogy: Polyphony and Palimpsests in the Narrative of Vincenzo Consolo”. Fecha: 17 de septiembre de 2008. IV. 7. INGLATERRA LONDRES 1995: • Maria Cristina Cataldo: “Vincenzo Consolo: un viaggio nella letteratura e nella storia della Sicilia”, University College of London; [Se trata de una tesina del “Master in Arts” (60pp.)]. IV. 8. ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK TESIS DOCTORAL de Vincenzo Pascale. Director de la Tesis: Robert S. Dombroski y Eugenia Paulicelli. Universidad: Graduate Center de la City University de Nueva York. Título: “Lo sguardo e la storia: Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo”. Publicada con el mismo título en la editorial Vecchiarelli, Roma, 2006. 117 V. ENCUENTROS MONOGRÁFICOS SOBRE VINCENZO CONSOLO Además de las cada vez más frecuentes ponencias y comunicaciones que se presentan en los distintos congresos sobre la obra de Vincenzo Consolo, caben destacar los siguientes encuentros monográficos, dedicados por entero al autor, y que contaron con su presencia en los mismos: V. 1. Coloquio Internacional: “Vincenzo Consolo, éthique et écriture”, organizado por Dominique Budor y celebrado en París, los días 25 y 26 de octubre de 2002. Véanse las Actas de dichas Jornadas, recogidas en: DOMINIQUE BUDOR (ed.), Vincenzo Consolo, éthique et écriture, Presse Sorbonne Nouvelle, París, 2007. El libro contiene los siguientes artículos: • D. BUDOR, Pourquoi lire Consolo, «notre» classique32. • V. CONSOLO, La metrica della memoria33. 32 Véase también el aparato bibliográfico que adjunta. 33 Traducido en paralelo por Jean-Paul Manganaro: “Pour une métrique de la mémoire”. 118 L’être-dans-l’Histoire: • A. RECUPERO, Sicile 1943-2000: entre la pétrification de l’histoire et l’orageux changement de la société. • G. FERRONI, Une éthique de la parole. Le temps, la mémoire, le retour: • Mª P. DE PAULIS-DALEMBERT, Mémoire individuelle- mémoire de l’histoire: le palimpseste narratif. • D. FERRARIS, La syntaxe narrative de Consolo: pour une orientation du désastre. • C. IMBERTY, Vincenzo Consolo, ou le roman entre mémoire et mémoire historique. • J. P. MANGANARO, Tradition et Traduction: dans l’eau du Détroit. Les modulations du récit: • V. GIANNETTI, L’anghelos et le choeur: récit et narration chez Vincenzo Consolo. • W. GEERTS, Consolo ou les derniers replis de la fiction. • C. SEGRE, Temps et narration dans l’oeuvre de Vincenzo Consolo. Voix et mythes de la Sicile: • R. GALVAGNO, «Male catubbo». Les avatars d’une métamorphose dans le roman Nottetempo, casa per casa. • Mª F. RENARD, Paysage d’amour et de mémoire. • G. DAVICO BONINO, Consolo e il teatro. Enriquece dichas Actas el soporte informático (CD-rom) que se adjunta al final de las mismas. 119 V. 2. Jornadas de estudio: “Giornate di Studio in onore di Vincenzo Consolo”, organizadas por Enzo Papa y celebradas en Siracusa, los días 2 y 3 de mayo de 2003. Véanse las Actas de dichas Jornadas, recogidas en: ENZO PAPA (ed.), Per Vincenzo Consolo, Manni («Studi, 54»), San Cesario di Lecce, 2004. El libro contiene los siguientes artículos: • V. CONSOLO, Come una lastra memoriale. • P. CARILE, Testimonianza. • Mª R. CUTRUFELLI, Un severo, familiare maestro. • R. GALVAGNO, Destino di una metamorfosi nel romanzo Nottetempo, casa per casa di Vincenzo Consolo. • M. ONOFRI, Nel magma italiano: considerazioni su Consolo scrittore politico e sperimentale. • S. PAUTASSO, Il piacere di rileggere Il sorriso dell’ignoto marinaio, o dell’intelligenza narrativa. • C. RICCARDI, Inganni e follie della storia: lo stile liricotragico della narrativa di Consolo. • G. TRAINA, Rilettura di Retablo. Véase también: “L’appendice bibliografica” (pp. 135-41), al igual que la nota del editor (pp. 142-3). V. 3. Jornadas Internacionales: “Vincenzo Consolo: per i suoi 70 (+1) anni”, organizadas por Miguel Ángel Cuevas y celebradas en Sevilla, los días 15 y 16 de octubre de 2004. No hubo Actas. Algunas comunicaciones fueron publicadas en el número 10 de la Revista “Quaderns d’Italià”, titulado: Leggere Vincenzo Consolo / Llegir Vincenzo Consolo, Barcelona, 2005. 120 Destacan los dos textos de creación de Vincenzo Consolo: “La grande vacanza orientale-occidentale” y “Il miracolo”. Artículos específicos sobre Vincenzo Consolo: • Mª. ATTANASIO, Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo. • E. VILELLA, Nostos y laberinto. • P. CAPPONI, Della luce e della visibilità. Considerazioni in margine all’opera di Vincenzo Consolo. • M. A. CUEVAS, Ut pictura: el imaginario iconográfico en la obra de Vincenzo Consolo. • R. ARQUÉS, Teriomorfismo e malinconia. Una storia notturna della Sicilia: Nottetempo, casa per casa di Consolo. • G. ALBERTOCCHI, Dietro il Retablo: «Addio Teresa Blasco, addio Marchesina Beccaria». • N. MESSINA, Per una storia di Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo. V. 4. Jornadas Internacionales: “Lunaria vent’anni dopo”, organizadas por Irene Romera Pintor y celebradas en Valencia, los días 24 y 25 de octubre de 2005. Véanse las Actas de dichas Jornadas, recogidas en: IRENE ROMERA PINTOR (ed.): Lunaria vent’anni dopo, Generalitat Valenciana-Universitat de València, Valencia, 2006. El libro contiene los siguientes artículos: • V. CONSOLO, Ma la luna, la luna. • M. GIL ESTEVE, Aún Lunaria. • S. C. TROVATO, Il coraggio di una traduzione. A proposito della traduzione spagnola di Lunaria (di Irene Romera Pintor). 121 • A. PANTALEONI, Morte e pianto rituale in Lunaria di Vincenzo Consolo. • P. CARILE, Una testimonianza e una riflessione su Vincenzo Consolo: dalla Sicilia all’Europa. • M. A. CUEVAS, Lunaria antes de Lunaria. • G. ALBERTOCCHI, La luna e dintorni. • N. MESSINA, Lunaria dietro le quinte. • I. ROMERA PINTOR, Claves para una ensoñación lunaria. Contiene, además, los siguientes apéndices: • Mesa redonda, con la presencia y participación de Vincenzo Consolo, con ocasión de la presentación de la traducción al español de Lunaria (2003), con las intervenciones de Renzo Cremante, Joaquín Espinosa Carbonell, Manuel Gil Esteve, Isabel González, Irene Romera Pintor y Matilde Rovira. • Clausura de las Jornadas por Vincenzo Consolo. V. 5. Jornadas Internacionales: “Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de Il sorriso dell’ignoto marinaio”, organizadas por Irene Romera Pintor y celebradas en Valencia, los días 23 y 24 de octubre de 2006. Véanse las Actas de dichas Jornadas, recogidas en: IRENE ROMERA PINTOR (ed.): Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, Generalitat Valenciana-Universitat de València, Valencia, 2007. El libro contiene los siguientes artículos: Proemio: • V. GONZÁLEZ MARTÍN, Sicilianidad e hispanidad en la obra de Vincenzo Consolo. 122 Artículos monográficos sobre Il sorriso dell’ignoto marinaio: • V. CONSOLO, Antonello da Messina. • R. CREMANTE, La sperimentazione di Vincenzo Consolo fra storia e invenzione. • G. FERRONI, Forme della visione nel Sorriso dell’ignoto marinaio. • S. C. TROVATO, Regionalità e traduzione. Dalla Sonrisa spagnola a quella argentina. • G. ADAMO, Limina testuali nel Sorriso dell’ignoto marinaio. • Mª. BAYARRI ROSSELLÓ, El ignoto marinero sonríe ante el árbol de las cuatro naranjas. • J. ESPINOSA CARBONELL, Sasà, Palamara, frate Nunzio y otros secundarios activos (Consideraciones en torno a los personajes secundarios de Il sorriso dell’ignoto marinaio). • N. MESSINA, Il sorriso dell’ignoto marinaio. Vicissitudini di un progetto. Epílogo: • M. GIL ESTEVE, Dicen que Consolo. Contiene, además, los siguientes apéndices: • Presentación del libro: Lunaria vent’anni dopo (2006), con las intervenciones de Leonardo Carbone, Fausto Díaz Padilla, Manuel Gil Esteve, Isabel González, Vicente Navarro de Luján e Irene Romera Pintor. • Presentación del libro: La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo (2006), con las intervenciones de Giuliana Adamo, Giulio Ferroni e Irene Romera Pintor. • Clausura de las Jornadas por Vincenzo Consolo. 123 V. 6. Jornada Internacional: “Vincenzo Consolo between Sicily and Europe”, organizada por Martin McLaughlin y Daragh O’Connell, celebrada en Oxford el 15 de octubre de 2007 (“University of Oxford in association with and hosted by the Maison Française d’Oxford”). Pendiente de la publicación de las Actas. Señalo la relación de los participantes (por orden de intervención): • D. ZANCANI, Consolo Abroad: Criticism and Translations. • N. MESSINA, Un testo in controluce: Il sorriso dell’ignoto marinaio. Cronistoria di un’edizione. • R. GLYNN, Consolo: The Intellectual and the 1970s’. • C. O’RAWE, Consolo saggista e la Sicilia testuale. • D. O’CONNELL, Consolo narratore e scrittore «palincestuoso». • J. FARRELL, Traducendo Consolo: la questione dello stile. Keynote Lecture Vincenzo Consolo: I muri d’Europa. V. 7. Jornadas Internacionales: “La pasión por la lengua: Vincenzo Consolo (Homenaje por sus 75 años)”, organizadas por Irene Romera Pintor y celebradas en Valencia, los días 14 y 15 de abril de 2008. Véanse las Actas de dichas Jornadas, recogidas en: IRENE ROMERA PINTOR (ed.): La pasión por la lengua: Vincenzo Consolo (Homenaje por sus 75 años), Generalitat Valenciana-Universitat de València, Valencia, 2008. El libro contiene los siguientes artículos: • V. CONSOLO, Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano. 124 • F. DÍAZ PADILLA, “Filosofiana” o Cuando las piedras hablan. • G. FERRONI, L’evidenza del nome nella scrittura di Vincenzo Consolo. • J. FRACCHIOLLA, Storia e storie nell’opera di Vincenzo Consolo. • V. GONZÁLEZ MARTÍN, La Nuova Questione della Lingua en Vincenzo Consolo. • S. C. TROVATO, Vincenzo Consolo o della regionalità linguistica. Contiene, además, los siguientes apéndices: • Entrevista a Vincenzo Consolo, por Jean Fracchiolla. • “Un sogno perso”, por Pasquale Scimeca. • Presentación del libro: Vincenzo Consolo, éthique et écriture (2007), con las intervenciones de Dominique Budor, Vincenzo Consolo, Renzo Cremante, Irene Romera Pintor y Cesare Segre. • Presentación del libro: Filosofiana de Vincenzo Consolo (2008), con las intervenciones de Renzo Cremante, Giulio Ferroni, Manuel Gil Esteve, Irene Romera Pintor y Cesare Segre. • Clausura de las Jornadas por Vincenzo Consolo. Tuvieron lugar los siguientes encuentros: • Mesa redonda, moderada por J. Inés Rodríguez Gómez, en la que Joaquín Espinosa Carbonell presentó a Pasquale Scimeca. El Director de cine comentó y proyectó “Un sogno perso” (1992), película estructurada en torno a tres relatos literarios. El primero de ellos es “Filosofiana” de Vincenzo Consolo. • Intervención de Ludovica Tortora de Falco, que relató su experiencia como directora y productora de una película documental sobre Vincenzo Consolo: “In viaggio con Vincenzo Consolo” (2008), proyectando parte de la misma. 125 VI. ESTUDIOS CRÍTICOS VI. 1. Obra de consulta imprescindible es el número monográfico dedicado a Vincenzo Consolo de la revista palermitana «Nuove Effemeridi. Rassegna trimestrale di cultura», n. 29, VIII, (ed. Guida), dirigida por Antonino Buttitta, 1995/I. Número a cargo de Vincenzo Barbarotta y Gianfranco Marrone. En esta obra destacan los textos de Vincenzo Consolo: • “29 aprile 1994: cronaca di una giornata”, pp. 4-7. • “Que farai, fra Iacovone?”, pp. 179-181. También se recogen los siguientes artículos: • Ferroni, Giulio: “Bestie trionfanti”, pp. 153-7. • Ferroni, Giulio: “Il calore della protesta”, pp. 173-6. • Marrone, Gianfranco y Montes, Stefano: “Una statua in fuga”, pp. 40-6. • Mazzarella, Salvatore: “Dell’olivo e dell’olivastro, ossia d’un viaggiatore”, pp. 47-70. • Onofri, Massimo: “La luce della storia”, pp. 159-163. • Onofri, Massimo: “Uno stesso ceppo”, pp. 177-8. • Segre, Cesare: “Frammenti di luna”, pp. 30-9. • Segre, Cesare: “La costruzione a chiocciola”, pp. 96-100. • Segre, Cesare: “Una provvisoria catarsi”, pp. 150-1. • Trovato, Salvatore C.: “Forme e funzioni del linguaggio”, pp. 15-29. 126 Enumero por temas los autores de los estudios críticos (al margen de los artículos más extensos citados anteriormente): • La ferita…: Nino Palumbo, Mario Lunetta, Giovanni Raboni, Angelo Guglielmi, Nino Calabrò. • Il sorriso…: Paolo Milano, Enzo Siciliano, Vittorio Spinazzola, Giuliano Gramigna, Alfredo Giuliani, Gian Carlo Ferretti, Antonio Debenedetti, Lorenzo Mondo, Domenico Porzio, Marino Biondi, Jesús Fuentes Ródenas, Leopoldo Alzancot, Peter Hainswort, Hansjörg Graf. • Lunaria: Francesco Durante, Maurizio Cucchi, Giovanni Raboni, Gian Carlo Ferretti, Giuliano Gramigna, Giuseppe Saltini, Paolo Mauri, Antonio Prete, Hector Bianciotti. • Retablo: Fabrizia Ramondino, Severino Cesari, Geno Pampaloni, Lorenzo Mondo, Leonardo Sciascia, Lidia De Federicis, Goffredo Fofi, Luciano Satta, Gian Carlo Ferretti, Raffaelle Crovi, Remo Ceserani, Claude Ambroise. • Le pietre…: Oreste del Buono, Raffaele Crovi, Renato Minore, Maurizio Cucchi, Giovanni Giudici, Stefano Giovanardi, Giuseppe Bonura, Natale Tedesco, Salvatore Nigro, Antonio Di Grado, Gianni Turchetta, Romano Luperini, Andrea Zanzotto, Carlo Sgorlon, Louis Soler. • Nottetempo…: Lorenzo Mondo, Ermanno Paccagnini, Geno Pampaloni, Stefano Giovanardi, Silvio Perrella, Horacio Vázquez Rial, Mercedes Monmany, René de Ceccatty, Monique Bacelli. • Nerò…: Francesco Durante, Giuseppe Amoroso, Salvatore Claudio Sgroi, Renato Minore. • L’olivo…: Lorenzo Mondo, Giuliano Gramigna, Giuseppe Bonura, Stefano Giovanardi, Giuseppe Pederiali. Además de los estudios críticos y reseñas de prensa sobre su obra, dicho número monográfico recoge una entrevista al autor [realizada 127 por Roberto Andò (“Vincenzo Consolo: la follia, l’indignazione, la scrittura” (pp. 8-14)], así como una bibliografía detallada de la obra completa del autor (narrativa, ensayos, artículos, etc.) y de la crítica (pp. 182-5). Enriquecen el volumen los valiosos documentos fotográficos tanto de los paisajes emblemáticos de Sicilia, como de autores y críticos contemporáneos fotografiados junto con Vincenzo Consolo (Bufalino, Buttitta, Levi, Maraini, Montale, Pasolini, Piccolo, Rodari, Sciascia, Sellerio, Segre, Vázquez Montalbán…). VI. 2. La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo. Giuliana Adamo (ed.), con una introducción de Giulio Ferroni, Manni («Studi, 99»), San Cesario di Lecce, 2006. Véase la amplia ordenación bibliográfica, pp. 191-212. En esta obra destaca el texto de Vincenzo Consolo: • “La metrica della memoria”, pp. 177-189. También se recogen los siguientes estudios críticos que señalo por orden de aparición: • Ferroni, Giulio: “Prefazione”, pp. 7-10. • La Penna, Daniela: “Enunciazione, simulazione di parlato e norma scritta. Ricognizioni tematiche e linguistico-stilistiche su La ferita dell’aprile di Vincenzo Consolo”, pp. 13-49. • Cuevas, Miguel Ángel: “Le tre edizioni de La ferita dell’aprile: le varianti”, pp. 49-69. • Adamo, Giuliana: “Sull’inizio del Sorriso dell’ignoto marinaio”, pp. 71-120. • Messina, Nicolò: “Nello scriptorium di Vincenzo Consolo. Il caso di “Morte Sacrata” (Il sorriso dell’ignoto marinaio, III), pp. 121-160. 128 • Romera Pintor, Irene: “Introduzione a Lunaria: Consolo versus Calderón”, pp. 161-176. VI. 3. “Scrittura e memoria in Vincenzo Consolo”. Se trata del número monográfico dedicado a Vincenzo Consolo de la revista de «Microprovincia», n. 48, Nuova serie, Gennaio-Dicembre, 2010, Rosminiane Sodalitas, Stresa, dirigida por Franco Esposito. En esta obra destacan los textos de Vincenzo Consolo: • “Frammento”, p. 5. • “La metrica della memoria”, pp. 161-8. También se recogen los siguientes estudios críticos que señalo por orden de aparición: • Esposito, Franco: “E dopo il ’68, anche nella «provincia di frontiera» tutto fu nausea”, pp. 1-4. • Budor, Dominique: “Perché leggere Consolo, «nostro» classico”34, pp. 6-12. • Turchetta, Gianni: “«Per toccare la vita che ci scorre per davanti»: Retablo e l’arte come nostalgia”, pp. 13-9. • Bárberi Squarotti, Giorgio: “Il fonosimbolismo fascinoso di Consolo ne Il sorriso dell’ignoto marinaio”, pp. 20-38. • Segre, Cesare: “Satiri e dèmoni nel sabba siciliano di Consolo”, pp. 39-41. • O’ Connell, Daragh: “Il palinsesto della memoria: Consolo fra narrare e scrivere”, pp. 42-66. 34 Traducción del francés de Claudia Azzola. 129 • Messina, Nicolò: “Tra Mandralisca e Crowley. Su alcuni quaderni dell’Archivio Consolo”, pp. 67-7335 y 82-4. • Baratter, Paola: “Lunaria: il mondo salvato dalla Luna”, pp. 85-93. • Mazzocchi, Federico: “Vincenzo Consolo e l’incessante ricerca: tra enumerazione metaforica e metafora dell’enumerazione”, pp. 94- 116. • Cinquegrani, Alessandro: “La volontà di individuazione nella letteratura di Vincenzo Consolo”, pp. 117-126. • Stajano, Corrado: “Vincenzo Consolo e gli amici della lava nera”, pp. 127-132. • Gaccione, Angelo: “Vincenzo Consolo come Verga”, pp. 133-5. • Maffia, Dante: “Vincenzo Consolo, una lingua carica di segni”, pp. 136-9. • Bruni, Pierfranco: “Vincenzo Consolo, lungo le rotte di Odisseo”, pp. 140-5. • Ferretti, Gian Carlo: “Lunaria, una favola teatrale”, pp. 146-736. • Di Stefano, Paolo: “Due incontri con Vincenzo Consolo”, pp. 151-7. VI. 4. Por lo que respecta a libros que recogen una bibliografía crítica detallada sobre la obra de Vincenzo Consolo, me limito a destacar la siguiente monografía: • Traina, G., Vincenzo Consolo, Cadmo («Scritture in corso, 4»), Fiesole (Florencia), 1998. Para una amplia ordenación bibliográfica, cf. pp. 111-122. 35 En las pp. 74-81, viene publicado como “Appendice” una parte de los cuadernos del Archivo Consolo. 36 Original publicación de la entrevista de Gian Carlo Ferretti, en abril de 1985, pues vienen reproducidas por entero las respuestas manuscritas del propio Consolo (pp. 148-50). 130 VI. 5. ARTÍCULOS: • Segre, Cesare: Introducción a Il sorriso dell’ignoto marinaio, Mondadori, Milán, 1987, pp. V-XVIII. • Segre, Cesare: “La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Consolo, en Intrecci di voci, Einaudi, Turín, 1991, pp. 71-86. • Segre, Cesare: “Teatro e racconto su frammenti di luna”, en Intrecci di voci, Einaudi, Turín, 1991, pp. 87-102. • Segre, Cesare: “Inserti storiografici e storiografia sotto accusa nel capolavoro di Vincenzo Consolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio”, en Tempo di bilanci, Einaudi, Turín, 2005, pp. 129-138. • Trovato, Salvatore, C.: cuatro artículos sobre la lengua de Vincenzo Consolo. Dichos artículos –publicados años atrás– se recogen ahora, revisados y corregidos, por capítulos en el libro: Italiano regionale, letteratura, traduzione. Pirandello, D’Arrigo, Consolo, Occhiato, Euno Edizioni, Leonforte, 2010. Cap. I: Sulla regionalità letteraria in Italia: Pirandello, D’Arrigo, Consolo, pp. 11-27. Cap. IV: Tra dialetto, dialetti e italiano regionale in Consolo, pp. 89-122. Cap. V: L’elemento regionale in “Filosofiana”, un racconto delle Pietre di Pantalica di Vincenzo Consolo, pp. 123-177. Cap. IX: Sulla traduzione della regionalità: Il sorriso dell’ignoto marinaio e Retablo in spagnolo, pp. 301-337. VI. 6. EN PREPARACIÓN: • El libro monográfico sobre Il sorriso dell’ignoto marinaio de próxima aparición: Cochlías legere: “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, approcci critici. Edición de Nicolò Messina y Daragh O’Connell, Cesati, Florencia. ÍNDICE DE NOMBRES 133 ÍNDICE DE NOMBRES A Adamo, Giuliana, 18n, 122, 127 Addamo, Sebastiano, 31 Aghion, Soula, 99 Albertocchi, Giovanni, 120, 121 Alvino, Gualberto, 28 Alzancot, Leopoldo, 126 Ambroise, Claude, 126 Arqués, Rossend, 120 Attanasio, Maria, 120 Atenea (diosa mitológica), 52 Amoroso, Giuseppe, 31, 126 Andò, Roberto, 127 Annibali, Manuela, 111 Aristófanes (comediógrafo griego), 61 Avogadro, Mauro, 107 Azzola, Claudia, 128n B Bacelli, Monique, 126 Baratter, Paola, 129 Barbarotta, Vincenzo, 125 Bárberi Squarotti, Giorgio, 128 Barca, Aníbal (general cartaginés), 53n Barca, Asdrúbal (general cartaginés), 53n Barca, Magón (general cartaginés), 53n 134 Barcia, Roque, 28, 43n, 85 Barone, Giovanni, 98 Barni, Roberta, 99 Battaglia, Salvatore, 28, 88 Bayarri Rosselló, María, 122 Bellonci, Goffredo, 95 Bellonci, Maria, 95 Beltrametti, Anna, 110 Benanti, Valeria, 107 Benincasa, Rutilio (filósofo), 55n Benítez, Esther, 98, 107 Bersani, Mauro, 32 Bertelli, Giorgio, 96n Bértolo, Constantino, 102 Bianciotti, Hector, 126 Biondi, Marino, 126 Bongiovanni, Loreto, 108 Bonalumi, Louis, 101 Bonura, Giuseppe, 31, 126 Borja, Gaspar de (Cardenal), 40n Bosetti, G., 112 Bouchard, Norma, 102 Budor, Dominique, 117, 124, 128 Bufalino, Gesualdo, 28, 127 Burgaretta, Giusi, 107 Buttitta, Antonino, 125 Buttitta, Ignazio, 127 Briand, Maryvonne, 114 Brogi, Daniela, 111 Brucoli, Elisabetta, 113 Brunner, Maria E., 99-101 Bruni, Pierfranco, 129 135 C Calabrò, Nino, 126 Caleca, Antonino, 110 Camps, Assumpta, 99 Capuana, Cecilia, 96n Caputo, Rino, 110 Capponi, Paola, 120 Carbone, Leonardo, 122 Carbone, R., 32 Cardillo, Agata, 106 Carile, Paolo, 119, 121 Carlos IV (rey), 47n Casciani, Paola, 111 Castelli, Antonio, 109 Catalano, Maria Giuseppina, 108 Cataldo, Maria Cristina, 116 Catti, Massimo, 111 Cavagna, Ola, 107 Cerruti, Marco, 111 Cervantes Saavedra, Miguel de, 104, 123 Cesari, Severino, 126 Ceserani, Remo, 126 Cinquegrani, Alessandro, 129 Cipolla, Stefania, 108 Colaço Barreiros, José, 99, 101 Colin, Mariella, 114 Consolo1 , Vincenzo, 2, 3, 5, 7, 9, 13-20, 15n, 18n, 22, 23, 28, 31-33, 41n, 42n, 48n, 57n, 58n, 60n, 64, 67, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 93, 96n, 97, 102-125, 127-129, 129n, 130 1 Obra citada por orden cronológico. 136 La ferita dell’aprile (1963), 93, 97, 103, 106, 126, 127 Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), 13, 14, 93, 97, 106-108, 115, 116, 119-123, 126-128, 130 Lunaria (1985), 13, 18n, 93, 98, 99, 103, 107, 120-122, 126, 128, 129 Retablo (1987), 13, 14, 94, 99, 103, 107- 109, 115, 119, 120, 126, 128, 130 Le pietre di Pantalica (1988), 7, 13, 14n, 15, 18n, 19, 31, 32, 36, 42n, 48n, 58n, 65-88, 94, 100, 103, 107, 112, 126, 130 Catarsi (1989), 96, 109 La Sicilia passeggiata (1991), 94 Nottetempo, casa per casa (1992), 94, 100, 103, 108, 118-120, 126 Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia (1993), 95 Nerò metallicò (1994), 96, 96n, 107, 126 L’olivo e l’olivastro (1994), 95, 101, 103, 107, 126 Lo spasimo di Palermo (1998), 95, 101, 103, 108 Di qua dal faro (1999), 95, 102, 103 Il teatro del sole (1999), 96, 96n Isole Dolci del Dio (2002), 96 Siracusa come un incanto (2003), 96 Pio La Torre, orgoglio di Sicilia (2009), 96 Il Corteo di Dioniso (2009), 96 L’attesa (2010), 96 Cornelio, Cettina, 108 Corominas, Joan, 28 Covarrubias, Sebastián de, 43n Cremante, Renzo, 121, 122, 124 Crovi, Raffaele, 31, 126 Cucchi, Maurizio, 31, 126 137 Cucchiani, Lorenza, 112 Cuevas, Miguel Ángel, 97, 102, 119-121, 127 Cutrufelli, Maria Rosa, 119 D D’Arrigo, Stefano, 28, 130 Da Messina, Antonello, 110, 122 Darmon, Maurice, 19, 97, 100 Dauner, Christine, 114 Davico Bonino, Guido, 118 De Angelis, Giovanna, 111 Debenedetti, Antonio, 126 De Federicis, Lidia, 126 Dell’Agnese, Elena, 109 Del Buono, Oreste, 31, 126 De Mauro, Tullio, 28 De Paulis-Dalembert, Maria Pia, 118 De Voogd, Pietha, 99 Díaz Padilla, Fausto, 18n, 122, 124 Di Gerolamo, Nicola, 33 Di Grado, Antonio, 32, 106, 108, 126 Di Mauro, Linda, 111 Di Salvo, Vanessa, 108 Di Stefano, Paolo, 129 Di Trapani, Laura, 107 De Ceccatty, René, 126 Denschlag, Agnes, 114 Depetro, Carmelo, 32 Dollo, Glenda, 109 Dombroski, Robert S., 116 138 Dragoni, Barbara, 111 Du Merac, Rubat, 112 Durante, Francesco, 126 E Echegoyen, Christinna, 27 Escipión, Cneo Cornelio, 53n Escipión, Publio Cornelio, 53n Escipión, Publio Cornelio, Africano Maior, 53n Esquilo (dramaturgo griego), 17, 18, 21, 52, 52n, 59, 59n, 61 Espinosa Carbonell, Joaquín, 121, 122, 124 Esposito, Franco, 128 F Faggi, Vico, 31 Farrell, Joseph, 98, 108, 116, 123 Ferraris, Denis, 113, 118 Ferretti, Gian Carlo, 126, 129, 129n Ferroni, Giulio, 18n, 118, 122, 124, 125, 127 Fiocchetti, Maria Letizia, 106 Fofi, Goffredo, 126 Frabotta, Bianca Maria, 111 Francucci, Federico, 110 Frasnedi, Fabrizio, 106 Fracchiolla, Jean, 124 Fuentes Ródenas, Jesús, 126 Fusco, Mario, 98, 108 139 G Gabriel y Galán, José María, 44n Gaccione, Angelo, 129 Galvagno, Rosalba, 28, 108, 109, 118, 119 Gandolfo, Carmela, 106 García de Diego, Vicente, 29 García Soriano, Justo, 27 Gardair, J. M., 113 Gareffi, Andrea, 104 Geerts, Walter, 115, 118 Gellini, Eleonora, 112 Gentile Vitale, Juan Carlos, 99, 101 Gerosa, Guido, 31 Ghirardelli, Matteo, 106 Giachery, Emerico, 110 Giachi, Arianna, 97 Giambanco, Daniela, 109 Giannetti, Valeria, 118 Gil Esteve, Manuel, 115, 120-122, 124 Giuliana, Gabriela Maria Concetta, 107 Giuliani, Alfredo, 126 Giudici, Giovanni, 31, 126 Giovanardi, Stefano, 31, 111, 126 Glynn, Ruth, 123 Goebel-Schilling, Gerhard, 114 Gómez Ortin, Francisco, 27 Góngora y Argote, Luis de, 43n González Fernández, Isabel, 121, 122 González Martín, Vicente, 121, 124 González Rodríguez, Pilar, 102 Graf, Hansjörg, 126 140 Gramigna, Giuliano, 126 Grasset, Bernard, 98 Grosschmid, Pablo, 27 Guagnini, Elvio, 112 Guaraldo, Enrico, 104 Guglielmi, Angelo, 126 H Hainswort, Peter, 126 Hartmann, Ulrich, 97 Hermes (dios mitológico), 52, 61n I Ibarra Lario, Antonia, 29 Imberty, Claude, 118 Isotti-Rosowsky, Giuditta, 113 K Kienlechner, Bettina, 97 L Landolfi, Idolina, 33 La Penna, Daniela, 127 La Rosa, Debora, 108 141 La Rosa, Mª Elena, 107 Larussa, Rosaria, 106 Lasala, Giuseppe, 106 Leopardi, Giacomo, 2, 103 Levi, Primo, 127 Litrico, Andreina, 109 Lo Bue, Salvatore, 109 Lollini, Massimo, 102 Lunetta, Mario, 126 Luperini, Romano, 33, 126 M Maffia, Dante, 129 Manera, Danilo, 100 Manganaro, Jean Paul, 101, 102, 117n, 118 Mangione, Michele, 107 Mannoni, Eugène, 32 Mannoni, Francesco, 31 Marabini, Claudio, 32 Maraini, Dacia, 127 Marongiu, Jean Baptiste, 33 Marrone, Gianfranco, 125 Martignoni, Clelia, 110 Martínez Álvarez de Sotomayor, Jose María, 70, 86 Martoglio, Nino, 103 Mauri, Paolo, 126 Mazzarella, Salvatore, 125 Mazzola, Giuseppa, 106 Mazzocchi, Federico, 129 McLaughlin, Martin, 123 142 Medina, Vicente (poeta murciano), 22, 70 Merola, Nicola, 106 Messina, Nicolò, 115, 120-123, 127, 129, 130 Milano, Paolo, 126 Mineo, Nicolò, 106 Minore, Renato, 31, 126 Mocca, Monica, 113 Monastra, Rosa Maria, 108 Mondo, Lorenzo, 126 Monmany, Mercedes, 126 Montale, Eugenio, 127 Montes, Stefano, 125 Morini, Alessandra, 109 Moroldo, Arnaldo, 113 Mortillaro, Vincenzo, 27, 72, 79 Moliner, María, 28, 65, 71, 78, 88 Muñoz Garrigós, José, 29 N Nànfara, Don Gregorio (personaje de “Filosofiana”), 14, 16-18, 49-63, 52n, 55n, 57n, 59n, 81 Napoleón (emperador), 46n Navarro de Luján, Vicente, 122 Nicastro, Guido, 107 Nigro, Salvatore, 32, 126 O Ochoa Santos, Miguel Gabriel, 115 143 Occhiato, Giuseppe, 130 Occhipinti, Maria, 112 Onofri, Massimo, 119, 125 O’Connell, Daragh, 101, 116, 123, 128, 130 O’Rawe, Catherine, 123 P Paccagnini, Ermanno, 32, 126 Palumbo, Nino, 126 Pampaloni, Geno, 126 Pantaleoni, Angelo, 121 Paoloni, Christian, 99 Papa, Enzo, 119 Parlagreco, Vito2 (personaje de “Filosofiana”), 14-17, 19, 25, 42, 43, 45-63, 48n, 58n, 65, 79, 81, 83, 88, 89 Parlagreco, Bastiano (hijo de Vito), 44 Parlagreco, Maria (hija de Vito), 44 Parlagreco, Michele (hijo de Vito), 44 Parniere, Anne, 113 Pascale, Vincenzo, 116 Pascual, José Antonio, 28 Pasolini, Pier Paolo, 127 Pastaro, Giovanni, 107 Paterniti Martello, Fabiola, 110 Paulicelli, Eugenia, 116 Pautasso, Sergio, 119 Pazó, Cándido, 100 Pederiali, Giuseppe, 126 2 (Vitu, Vituco, Vituzzo) 144 Pellegrini, Chiara, 110 Perrella, Silvio, 126 Pérol, Brigitte, 99 Perrone, D., 109 Petrucci, Livio, 110 Piccolo, Lucio, 110, 127 Piccitto, Giorgio, 27 Pichler, Anita, 19, 100 Pignone, Dario, 106 Pieiller, Evelyne, 33 Pirandello, Luigi, 76, 103, 130 Pitré, Giuseppe, 29 Pivot, Bernard, 22 Pizzuto, Antonio, 28 Plutarco (historiador griego), 52n Pogliani, Paolo, 32 Poljak, Ana, 100 Porzio, Domenico, 126 Prete, Antonio, 126 Q Quasimodo, Salvatore, 14n R Raboni, Giovanni, 32, 126 Racine, Patricia, 112 Ramondino, Fabrizia, 126 Rando, Giuseppe, 109 Renard, Marie-France, 118 145 Rodari, Gianni, 127 Rodríguez Gómez, J. Inés, 124 Romera Pintor, Irene, 2, 3, 18n, 98, 100, 120-124, 128 Recupero, Antonino, 118 Riccardi, Carla, 119 Ricorda, Ricciarda, 112 Ronfani, Ugo, 94 Rovira, Matilde, 121 Ruiz Marín, Diego, 27 Rustico, Lisa, 109 S Saavedra (personaje de “Filosofiana”), 40, 42 Saavedra Fajardo, Diego de, 40n, 86 Sager, Michel, 98, 108 Salonia, Eros, 109 Saltini, Giuseppe, 126 Santangelo, Nicoletta, 112 Santos Domínguez, Eloy-José, 101 Saraceno, Alessia, 108 Satta, Luciano, 33, 126 Savettieri, Chiara, 110 Sbrilli, Antonella, 111 Sciascia, Leonardo, 98, 110, 111, 126, 127 Scimeca, Pasquale, 15n, 124 Scuderi, Attilio, 111 Sebregondi, Maria, 32 Segre, Cesare, 9, 13, 18, 20, 41n, 74, 118, 124, 125, 127, 128, 130 Seix, Francisco (editor), 43n Sellerio, Enzo, 127 Sereni, Silvia, 31 146 Sgorlon, Carlo, 33, 126 Sgroi, Salvatore Claudio, 126 Siciliano, Enzo, 126 Sófocles (trágico griego), 52n Solà, Alexis Eudald, 98 Soler, Louis, 33, 126 Spampinato, Federica, 107 Spinazzola, Vittorio, 126 Spinello, Lorella, 108 Stajano, Corrado, 129 Steiger, Arnold, 29 Stendhal, 14 T Tanu (personaje de “Filosofiana”), 45, 46, 50, 62 Tedesco, Natale, 31, 32, 104, 126 Trismegisto, Hermes (alquimista y filósofo), 61, 61n Tiralongo, Arianna, 108 Tobia, Giovanna, 109 Tortora de Falco, Ludovica, 124 Traina, Giuseppe, 119, 129 Tropea, Giovanni, 27 Trovato, Salvatore C., 27, 106-108, 120, 122, 124, 125, 130 Trunfio, Demetrio, 112 Turchetta, Gianni, 18n, 32, 36, 126, 128 U Ubach Medina, Antonio, 115 147 V Valenti, I. M. B., 106n Van Orshoven, Annemieke, 115 Vázquez Montalbán, Manuel, 127 Vázquez Rial, Horacio, 126 Vecchio, Alfio, 111 Veneziano, Antonio, 104, 123 Verga, Giovanni, 31, 33, 129 Vignatti, Mirta, 98 Vilavedra, Dolores, 100 Vilella, Eduard, 120 Vita, Valérie, 113 Vitello, Gabriele, 111 Vittorini, Elio, 31, 110, 111 W Waly, Naglaa, 98, 99 Z Zancani, Diego, 123 Zanzotto, Andrea, 32, 126 Zappulla Muscarà, Sarah, 107
Isole dolci del Dio.
*
Quasimodo le chiama “Le isole dolci del Dio” e le guarda dal Tindari nella bellissima lirica intitolata “Vento a Tindari”. Per noi siciliani dell’isola grande, queste isole che avevamo di fronte, soprattutto per noi che abitavamo sulla costa settentrionale, erano delle isole da una parte fantasmatiche perché apparivano e sparivano a seconda del tempo, le nebbie o le calure estive, a volte sembravano vicinissime e dalla zona dove io abitavo si vedeva finanche il faro di Vulcano. Però d’altra parte era un mondo “maledetto” per noi isolani perché quelle erano le isole dei coatti e poi anche dei confinati politici quindi quando la mia sorellina andò a Lipari e incontrò il suo fidanzato, io l’andai a prendere al molo di Milazzo poi l’accompagnai a casa in treno, perché le signorine da sole non viaggiavano, lei in treno mi raccontò questo suo incontro e mi disse tutta felice che poi questo ragazzo sarebbe venuto a casa per chiedere la mano di mia sorella come si usava allora. Io le dissi “vedrai papà cosa dirà…”. Infatti la sera a cena lei disse “sai papà ho incontrato un giovane, ci siamo parlati e mi ha detto che verrà a chiederti la mia mano.” Mio padre, che era molto rigoroso soprattutto con le figlie femmine, le diede uno schiaffo e disse “e io ti ho mandato a Lipari per cercare un fidanzato?”. Poi si sono sposati nel ’60. Allora ero studente a Barcellona e quando potevo andavo da mia sorella e scoprii questo Paradiso che sono le isole Eolie. Quando avevo tempo libero mi imbarcavo a Milazzo sulla “Luigi Rizzo” che allora era l’unica nave e man mano scoprii prima Lipari poi le altre isole, Salina, Alicudi e Filicudi, Stromboli. Una volta ebbi anche un naufragio su un aliscafo: tornavo da Stromboli, era estate e c’erano tantissimi turisti, a Panarea avevano caricato molte persone per cui questo aliscafo cominciò a imbarcare acqua e quasi affonda, spararono i razzi per chiedere aiuto, arrivarono i pescherecci, ci portarono su questi pescherecci e poi ci abbandonarono su una spiaggia di Panarea tutti bagnati. L’indomani finalmente ho potuto raggiungere Lipari. Un altro ricordo alle Eolie: nel ’62 ero lì e arrivò la colonia romana di Moravia, Pasolini con tutti i suoi ragazzetti e Dacia Maraini con la madre Topazia Alliata: io li vedevo, li osservavo, sapevo chi erano. Andavano a fare il bagno a Vulcano alle sabbie nere e io mi mettevo vicino ad ascoltare i loro discorsi. Un giorno sulla spiaggia dopo aver fatto il bagno mi sono seduto accanto a Moravia con nonchalance; Moravia era paralitico da una gamba e zoppicava e arriva una persona che gli racconta che un subacqueo aveva raggiunto una profondità di non so quanti metri ed egli sentenziò “io mi contento di scendere nella profondità dell’animo umano”. Nasceva proprio quell’estate il nuovo amore fra lui e Dacia Maraini. Al Centro Studi Eoliano ho avuto un incontro per l’anniversario del Constitutum, la costituzione democratica che si erano dati gli eoliani. C’era anche un altro personaggio straordinario che ho frequentato a Lipari, Leonida Buongiorno, che mi raccontava le sue vicende personali e non, di cui ero molto amico era una specie di biblioteca delle isole Eolie. Ho conosciuto anche il prof. Giuseppe Iacolino, un altro studioso delle isole Eolie. Pirandello dice che “noi siamo i primi 9 anni della nostra vita” nel senso che da quando nasciamo cominciamo a guardare quindi questi segni esterni ce li portiamo dentro per tutta la vita, sia i segni visuali che i segni orali – questo lo dice anche Dante nel “De vulgari eloquentia”: noi impariamo la prima lingua, la lingua volgare, dalle persone che ci stanno intorno nei primi anni della nostra vita. Nascere in una grande città come Palermo, Catania o ad Agrigento dove è nato Pirandello o nascere alle Eolie è assolutamente diverso perché i segni sono diversi, per cui un eoliano ha un carattere diverso dall’abitante dell’isola grande. Per la vita così dura e aspra l’eoliano era un tipo parsimonioso e laborioso, sull’isola non c’era il latifondo quindi non c’era la mafia e quindi il lavoro per gli eoliani era senza nessun tipo di compromissione e di cedimento ai poteri. C’è un libro di un confinato politico a Lipari che racconta degli altri confinati: quelli che potevano affittavano una casa a Lipari, gli altri invece erano relegati nel castello, una sorta di prigione, però c’era molta solidarietà da parte degli eoliani, c’era aiuto nei confronti di questi confinati. Quindi gli eoliani erano anche persone generose. Oggi non so se è ancora così. Vedere un mondo “altro” anche primigenio, che cos’è la vita nella sua elementarità e nelle sue leggi fondamentali. I turisti spesso vengono dal nord industriale, da luoghi più abbienti e devono capire cosa significa vivere in una piccola isola. L’esempio della rivolta che c’è stata a Lampedusa per quelli che chiamano centri di accoglienza ma che sono dei veri e propri lager: i lampedusiani vivono anche loro di turismo ma non sopportano che la loro isola diventi un lager a cielo aperto, molti questi poveri infelici hanno anche perso la vita.
Se questi turisti approdando a Lipari, nelle isole Eolie leggessero prima e conoscessero i 5000 anni di storia che ha avuto soprattutto Lipari, la stratificazione di civiltà che c’è stata andando a vedere il museo unico che c’è a Lipari capirebbero che luogo unico è, al di là del mare e del cielo. Sulle Eolie c’è anche il libretto “Isole dolci del Dio” uscito nel 2002 per le edizioni l’Obliquo, scritto per amore delle isole. Al momento sono impegnato a scrivere un’opera per Mondadori, alla conclusione della quale l’editore ristamperà tutta la mia produzione nella collana Meridiani. Dopo quest’ultima fatica, mi piacerebbe lasciare Milano e tornarmene finalmente nella mia amata Sicilia, ma non so se mia moglie Caterina è d’accordo…
Vincenzo Consolo
venerdì, 03 aprile 2009 – (da “Il notiziario delle Isole Eolie)
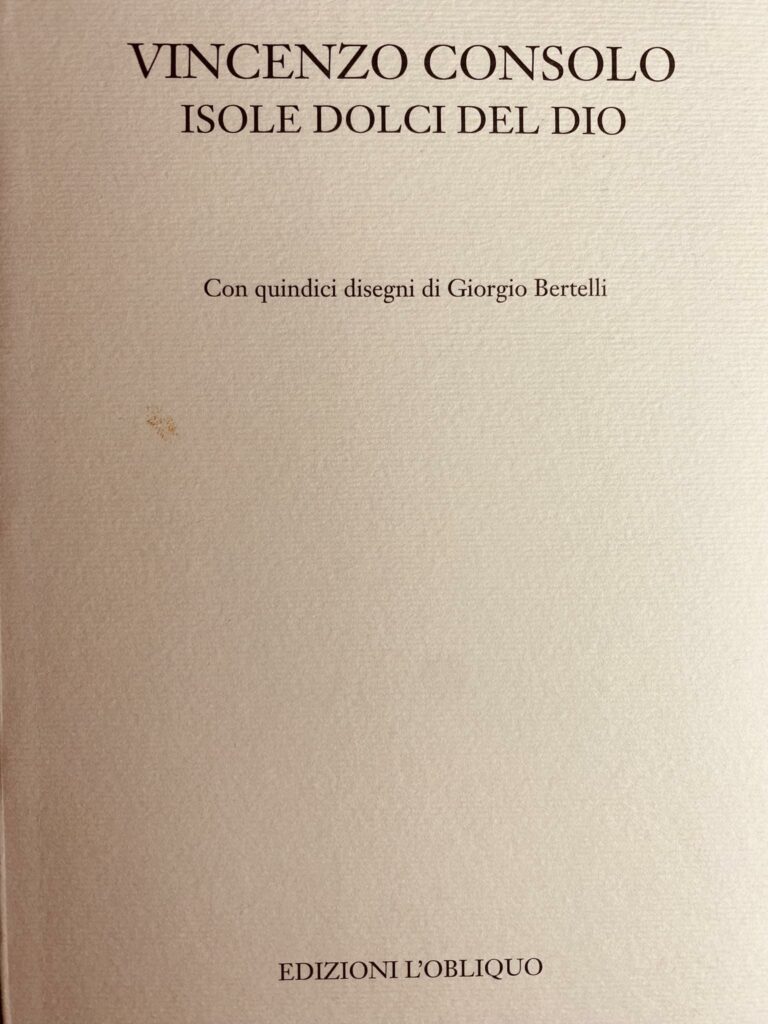




Il Mediterraneo tra illusione e realtà.
IL MEDITERRANEO TRA ILLUSIONE E REALTÁ, INTEGRAZIONE
E CONFLITTO NELLA STORIA E IN LETTERATURA
Letto al convegno “ La Salute Mentale nelle terre di mezzo” organizzato da Psichiatria Democratica 12-13.3.2009, Caltagirone
In una notte di giugno dell’ 827, una piccola flotta di Musulmani (Arabi, Mesopotamici, Egiziani, Siriani, Libici, Maghrebini, Spagnoli), al comando del dotto giurista settantenne Asad Ibn al-Furàt, partita dalla fortezza di Susa, nella odierna Tunisia, emirato degli Aghlabiti, attraversato il braccio di mare di poco più di cento chilometri, sbarcava in un piccolo porto della Sicilia: Mazara (nella storia ci sono a volte sorprendenti incroci, ritorni: Mazar è un toponimo di origine punica lasciato nell’isola dai Cartaginesi). Da Mazara quindi partiva la conquista di tutta la Sicilia, dall’occidente fino all’oriente, fino alla bizantina e inespugnabile Siracusa, dove si concludeva dopo ben settantacinque anni. Si formò in Sicilia un emirato dipendente dal califfato di Bagdad. In Sicilia, dopo le depredazioni e le spoliazioni dei Romani, dopo l’estremo abbandono dei Bizantini, l’accentramento del potere nelle mani della Chiesa, dei monasteri, i Musulmani trovano una terra povera , desertica, se pure ricca di risorse. Ma con i Musulmani comincia per la Sicilia una sorta di rinascimento. L’isola viene divisa amministrativamente in tre Valli, rette dal Valì: Val di Mazara, Val Dèmone e Val di Noto; rifiorisce l’agricoltura grazie a nuove tecniche agricole, a nuovi sistemi di irrigazione, di ricerca e di convogliamento delle acque, all’introduzione di nuove colture (l’ulivo e la vite, il limone e l’arancio, il sommacco e il cotone…); rifiorisce la pesca, specialmente quella del tonno, grazie alle ingegnose tecniche della tonnara; rifiorisce l’artigianato, il commercio, l’arte. Ma il miracolo più grande durante la dominazione musulmana è lo spirito di tolleranza, la convivenza tra popoli di cultura, di razza, di religione diverse. Questa tolleranza, questo sincretismo culturale erediteranno poi i Normanni, sotto i quali si realizza veramente la società ideale, quella società in cui ogni cultura, ogni etnia vive nel rispetto di quella degli altri. Di questa società arabo-normanna ci daranno testimonianza viaggiatori come Ibn Giubayr, Ibn Hawqal, il geografo Idrisi. E sul periodo musulmano non si può che rimandare alla Storia dei Musulmani di Sicilia, (1) scritta da un grande siciliano dell’ 800, Michele Amari. Storia scritta, dice Elio Vittorini, “con la seduzione del cuore” (2). E come non poteva non scrivere con quella “seduzione”, nato e cresciuto nella Palermo che ancora conservava nel suo tempo non poche vestigia, non poche tradizioni, non poca cultura araba ? Tante altre opere ha scritto poi Michele Amari sulla cultura musulmana. Per lui, nel suo esempio e per suo merito, si sono poi tradotti in Italia scrittori,
2
memorialisti, poeti arabi classici. Per lui e dopo di lui è venuta a formarsi in Italia la gloriosa scuola di arabisti o orientalisti che ha avuto eminenti figure come Levi Della Vida, Caetani, Nallino, Schiapparelli, Rizzitano, fino al grande
Francesco Gabrieli, traduttore de Le mille e una notte (3).
Vogliamo ripartire da quel porticciolo siciliano che si chiama Mazara, in cu
sbarcò la flotta musulmana di Asad Ibn al-Furàt, per dire di altri sbarchi, di siciliani nel Maghreb e di maghrebini, e non solo, in Sicilia.
°°°°°°
Finisce la terribile e annosa guerra corsara fra le due sponde del Mediterraneo, guerra di corsari musulmani e di corsari cristiani, finisce con la conquista di Algeri nel 1830 da parte dei Francesi. Ma si apre anche da quella data, nel Maghreb, la piaga del colonialismo. E comincia, in quella prima metà dell’ 800, l’emigrazione italiana nel Maghreb. É prima un’emigrazione intellettuale e borghese, di fuorusciti politici, di professionisti, di imprenditori. Liberali, giacobini e carbonari, si rifugiano in Algeria e in Tunisia. Scrive Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli : “Erano quelli regni barbari i soli in questa età civile che dessero cortese rifugio ai fuoriusciti”(4). Dopo i falliti moti di Genova del 1834, in Tunisia approda una prima volta, nel 1836, Giuseppe Garibaldi, sotto il falso nome di Giuseppe Pane. Nel 1849 ancora si fa esule a Tunisi.
A Tunisi si era stabilita da tempo una nutrita colonia italiana di imprenditori, commercianti, banchieri ebrei provenienti dalla Toscana, da Livorno soprattutto, primo loro rifugio dopo la cacciata del 1492 dalla Spagna. Conviveva, la nostra comunità, insieme alla ricca borghesia europea, un misto di venti nazioni, ch s’era stanziata a Tunisi. Accanto alla borghesia, v’era poi tutto un proletariato italiano di lavoratori stagionali, pescatori di Palermo, di Trapani, di Lampedusa che soggiornavano per buona parte dell’anno sulle coste maghrebine.
Ma la grossa ondata migratoria di bracciantato italiano in Tunisia avvenne sul finire dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, con la crisi economica che colpì le nostre regioni meridionali. Si stabilirono questi emigranti sfuggiti alla miseria nei porti della Goletta, di Biserta, di Sousse, di Monastir, di Mahdia, nelle campagne di Kelibia e di Capo Bon, nelle regioni minerarie di Sfax e di Gafsa. Nel 1911 le statistiche davano una presenza italiana di 90.000 unità. Anche sotto il protettorato francese, ratificato con il Trattato del Bardo del 1881, l’emigrazione di lavoratori italiani in Tunisia continuò sempre più massiccia. Ci furono vari episodi di naufragi, di perdite di vite umane nell’attraversamento del Canale di Sicilia su mezzi di fortuna. Gli emigrati già
3
inseriti, al di là o al di sopra di ogni nazionalismo, erano organizzati in sindacati, società operaie, società di mutuo soccorso, patronati degli emigranti. Nel 1914 giunge a Tunisi il socialista Andrea Costa, in quel momento vicepresidente della Camera. Visita le regioni dove vivevano le comunità
italiane. Così dice ai rappresentanti dei lavoratori: “Ho percorso la Tunisia da un capo all’altro; sono stato fra i minatori del Sud e fra gli sterratori delle strade
nascenti, e ne ho ricavato il convincimento che i nostri governanti si disonorano nella propria viltà, abbandonandovi pecorinamente alla vostra sorte” .
La fine degli anni Sessanta del 1900 segna la data fatidica dell’inversione di rotta della corrente migratoria nel Canale di Sicilia, dell’inizio di una storia parallela, speculare a quella nostra. A partire dal 1968 sono tunisini, algerini, marocchini che approdano sulle nostre coste. Approdano soprattutto in Sicilia, a Trapani, si stanziano a Mazara del Vallo, il porto dove erano approdati i loro antenati musulmani per la conquista della Sicilia. A Mazara, una comunità di 5.000 tunisini riempie i vuoti, nella pesca, nell’edilizia, nell’agricoltura, che l’emigrazione italiana, soprattutto meridionale, aveva lasciato. Questa prima emigrazione maghrebina nel nostro Paese coincide con lo scoppio di quella che fu chiamata la quarta guerra punica, la “guerra” del pesce, il contrasto vale a dire fra gli armatori siciliani, che con i loro pescherecci sconfinavano nelle acque territoriali nord-africane, contrasto con le autorità tunisine e libiche. In questi conflitti, quelli che ne pagavano le conseguenze erano gli immigrati arabi imbarcati sui pescherecci siciliani. Sull’emigrazione maghrebina in Sicilia dal 1968 in poi, il sociologo di Mazara Antonino Cusumano ha pubblicato un libro dal titolo Il ritorno infelice.(5)
È passato quasi mezzo secolo dall’inizio di questo fenomeno migratorio in Italia. Da allora e fino ad oggi le cronache ci dicono delle tragedie quotidiane che si consumano nel Canale di Sicilia. Ci dicono di una immane risacca che lascia su scogli e spiagge corpi senza vita. Ci dicono di tanti naufragi. E ci vengono allora in mente i versi di Morte per acqua di T.S. Eliot :
Phlebas il Fenicio, da quindici giorni morto,
dimenticò il grido dei gabbiani, e il profondo gonfiarsi del mare
e il profitto e la perdita.
Una corrente sottomarina
spolpò le sue ossa in sussurri. (6)
Le cronache ci dicono di disperati che cercano di raggiungere l’isola di Lampedusa. Disperati che partono soprattutto dalla Libia, ma anche dalla Tunisia e dal Marocco. Accordi ricattatori sono stati stipulati dal governo italiano con il dittatore Gheddafi, ma i mercanti di vite umane continuano sempre a spedire per Lampedusa barche cariche di uomini, donne, bambini, provenienti dal maghreb e dall’Africa subsahariana. I famosi CPT, Centri di
4
Permanenza Temporanea, a Lampedusa e in altri luoghi non sono che veri e propri lager. Il governo italiano intanto non fa altro che promulgare leggi xenofobe, razzistiche, di vero spirito fascistico. Di fronte a episodi di contenzione di questi disperati in gabbie infuocate, di ribellioni, fughe, scontri
con le forze dell’ordine, scioperi della fame, gesti di autolesionismo e di tentati suicidi, di gravi episodi di razzismo e di norme italiane altrettanto razzistiche si
rimane esterefatti. Ci ritornano allora le parole di Braudel riferite a un’epoca passata: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi contrazionari”.(7)
Volendo infine entrare nel tema di questo convegno La salute mentale nelle terre di mezzo, vogliamo qui annotare che sono soprattutto le donne a soffrire le violenze, i disagi della vita, del costume, della storia e citiamo qui degli autori classici che in letteratura hanno rappresentato questo dramma. L’Ofelia dell’Amleto di William Shakespeare innanzi tutto; la suor Maria di Storia di una capinera di Giovanni Verga; la Demente di Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello; Le libere donne di Magliano di Mario Tobino; la donna reclusa in una stanza in Voci di Marrakech di Elias Canetti.
(Vincenzo Consolo)
Note:
- Storia dei Musulmani di Sicilia di Michele Amari – CT Romeo Prampolini 1933
- I Musulmani in Sicilia di Michele Amari a cura di Elio Vittorini -pag. 6
Bompiani 1942
3) Le mille e una notte – Einaudi 1948
4) Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825 – pag. 890 Rizzoli 1967
5) Il ritorno infelice di Antonino Cusumano – Sellerio 1976
6) Poesie di T.S. Eliot -pag. 79 – Ugo Guanda 195
7) Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II di Fernand
Braudel -– vol.I pag. 921-922 – Einaudi 1976
Breve bibliografia sull’emigrazione:
Pantanella di Mohsen Melliti – Edizioni del Lavoro 1992
5
Le non persone di Alessandro del Lago – Feltrinelli 1999
Clandestino nel Mediterraneo di Fawzi Mellah Editore Asterios Trieste 2001
Mi chiamo Alì…(Identità e integrazione: inchiesta sull’emigrazione in Italia) di
Massimiliano Melilli – Editori Riuniti 2003
Migranti (verso una terra chiamata Italia ) di Claudio Camarca – Rizzoli 2003
I fantasmi di Portopalo di Giovanni Maria Bellu – Mondadori 2004
Bilal (Il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi)di Fabrizio Gatti
Rizzoli 2007
A Sud di Lampedusa ( Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti) di Stefano
Liberti – Minimum Fax 2008
Scontro di civiltà per un ascensore in piazza Vittorio di Amara Lakhous –
Editore e/o 2006
Milano, 10.3.2009




Foto di alcuni relatori del convegno
Vincenzo Consolo con l’amico Emilio Lupo – Segretario nazionale di Psichiatria Democratica
Le musiche della mia vita, intervista a Vincenzo Consolo, Raitre Milano, 22 febbraio 2009
I riflessi letterari dell’Unità d’Italia nella narrativa siciliana
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura Universitat de Girona
I riflessi letterari dell’Unità d’Italia nella narrativa siciliana Director professor Giovanni Albertocchi Treball final de recerca de Annunziata Falco febbraio 2009
1 Introduzione Questo lavoro di ricerca si propone di offrire un inventario ragionato, di romanzi e novelle di autori siciliani, da Verga alla Agnello Hornby, diversi tra loro per età, cultura e condizione sociale, per rendere evidente la persistenza della riflessione sull’idea del Risorgimento “tradito”, in romanzi ambientati negli anni che vanno dal 1860 al 1894, dallo sbarco dei Mille di Garibaldi in Sicilia alla repressione violenta dei Fasci. Gli autori prescelti, hanno in comune una esperienza di allontanamento dalla Sicilia, per brevi o lunghi periodi a Roma o a Milano, che coincide spesso con il periodo più creativo sul piano letterario, alla ricerca forse di una integrazione,che non ci fu,con gli ambienti culturali italiani, del “continente”. Comune è in loro l’ attenzione ad un ricostruzione degli avvenimenti attraverso i documenti ma anche attraverso la memoria personale e quella familiare dei fatti, comune è la scelta della narrazione storica, rivitalizzata, dopo l’esperienza risorgimentale, che permette di inserire materiali storici assieme a vicende e personaggi inventati, per ricreare un ambiente, una società, una mentalità, una realtà, come quella del Sud così poco conosciuta, con riferimenti precisi, documentati. Negli scrittori prescelti, appare evidente un’ansia di tornare su avvenimenti, sufficientemente vicini per poter capire e per poter far capire, per raccontare e forse per “educare”un pubblico borghese, un pubblico, che però non sempre accolse favorevolmente delle opere che, spesso, non erano in sintonia con il proprio tempo, troppo polemiche, negative, che registravano l’immobilismo di una società, il fallimento della borghesia, anche nel campo dei sentimenti privati, all’interno della famiglia. La necessità di fare i conti con il nostro recente passato, di capire come sia stata possibile un’Unità politica ed istituzionale che non ha avuto ragione delle differenze(anzi le ha acuite)tra Nord e Sud, è sempre più presente tra gli scrittori contemporanei, siciliani e non solo, e le opere dei grandi autori continuano a “fare scuola”, ad essere un modello di riferimento. L’idea,che è sottesa a questo lavoro, è proprio di presentare materiali che possano essere utilizzati in un successivo lavoro di approfondimento, su temi che emergono dai romanzi prescelti. Oltre le essenziali note biografiche e critiche sugli autori si è ritenuto importante presentare delle note storiche di confronto
Estratto.
Vincenzo Consolo.
Vincenzo Consolo,che ama considerarsi “figlio di Verga, l’inventore linguistico per eccellenza “ inizia a scrivere Il sorriso dell’ignoto marinaio nel 1969, ma lo pubblica solo nel 1976. Il libro viene subito salutato come “ il rovescio progressista del Gattopardo” da contrapporre all’immobilismo di Tomasi di Lampedusa . L’immagine dell’Italia è subito rivoluzionaria, la fidanzata di Interdonato, Catena, ha ricamato su una tovaglia un’Italia con dei vulcani al fondo, che inizialmente sembravano delle arance «Sì,è l’Italia»confermò l’Interdonato. E le quattro arance diventarono i vulcani del Regno delle Due Sicilie,il Vesuvio l’Etna Stromboli e Vulcano. Ed è da qui,vuol significar Catena,da queste bocche di fuoco da secoli compresso,e soprattutto dalla Sicilia che ne contiene tre in poco spazio,che sprizzerà la fiamma della rivoluzione che incendierà tutta l’Italia Si tratta di un vero romanzo politico, pienamente all’interno della linea della narrativa storica siciliana, il cui intento è quello di raccontare l’Italia degli anni Settanta attraverso un romanzo ambientato nel 1860, ai tempi dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il romanzo è ricco di materiali testuali eterogenei, come testi documentari, citazioni ironiche, che spezzano l’organicità del romanzo storico e con essa la pretesa dell’autore di governarne e spiegarne l’intreccio, insieme alla pretesa di governare la realtà e la storia. Il romanzo nasce mentre Consolo lavora a Milano e, come Verga, prova uno spaesamento iniziale per la nuova realtà urbana e industriale, la lontana Sicilia gli appare una pietra di paragone, un microcosmo nel quelle far riflettere temi e problemi di ordine universale. Il romanzo storico, e in specie il tema risorgimentale,passo obbligato di tutti gli scrittori siciliani,era l’unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente,le sue istanze e le sue problematiche culturali(l’intellettuale di fronte alla storia,il valore della scrittura storiografica e letteraria,la “voce” di chi non ha il potere della scrittura,per accennarne solo alcune) . Il sorriso dell’ignoto marinaio, che Consolo considera un omaggio a Morte dell’inquisitore di Sciascia, nasce da tre fattori di base: il fascino esercitato dal quadro di Antonello da Messina Ritratto d’ignoto, che è conservato nel Museo Mandralisca di Cefalù;la rivolta di Alcàra nato nel 1933,Sant’ Agata di Militello, in provincia di Messina in una “isola linguistica” gallo-romanza, abitata da discendenti di popolazioni lombarda,trasferito a Milano dal 1968,dove diventa consulente editoriale 295Milano, P.,Un Gattopardo progressista,«L’Espresso»,4 luglio 1976 Consolo, Vincenzo,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.53 In Lunaria vent’anni dopo,Valencia:Generalitat Valenciana-Universitat de Valencia,p.66 80 Li Fusi, avvenuta nel 1860, e un’inchiesta sui cavatori di pomice, che si ammalano di silicosi, che Consolo conduce per un settimanale. A questi si uniscono il dibattito politico e storico sul tema del “Risorgimento tradito”, sulla continuazione della secolare oppressione sotto una nuova veste, un dibattito che si stava ormai trasformando nella consapevolezza dell’esistenza di un secondo Risorgimento non compiuto e tradito: la Resistenza. I personaggi principali sono il barone Enrico Pirajno di Mandralisca, malacologo e collezionista d’arte, che era stato deputato nel 1848, un uomo che dovrà scendere nel carcere, labirintica chiocciola, per passare da un generico riformismo alla comprensione per le esigenze popolari, e l’avvocato Giovanni Interdonato, integerrimo rivoluzionario giacobino, esule dopo il ’48, impegnato a far da collegamento tra i vari gruppi di esuli e i patrioti dell’isola. I due si incontrano su una nave, nel 1852, dopo che il barone ha ricevuto in dono il Ritratto d’ignoto, attribuito ad Antonello da Messina, che la tradizione popolare chiama dell’Ignoto marinaio Mandralisca riconosce in Interdonato il sorriso ironico,pungente e amaro dell’uomo del dipinto, un sorriso che lo richiama continuamente all’azione politica, “il sorriso dell’intelligenza che si può rivolgere alla storia(e alla storia narrata nel romanzo).” I due personaggi si ritrovano in occasione della rivolta di Alcàra Li Fusi e del successivo processo, il barone prenderà le difese dei contadini insorti, che si sono mossi contro La proprietà,la più grossa,mostruosa,divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo e chiederà di aver clemenza a l’Interdonato, che doveva giudicare i rivoltosi, e lui estenderà loro l’amnistia, ritenendo la rivolta un atto politico. Consolo mette al centro del romanzo un aristocratico intellettuale, che riflette e giudica con un certo distacco, che può essere paragonato al principe Salina, ed un giovane rivoluzionario, l’Interdonato, che potrebbe richiamare molto lontanamente la figura di Tancredi, ma il rapporto tra i due personaggi, che era in Lampedusa di contrasto anche generazionale, nel romanzo di Consolo diventa un rapporto dialettico, Interdonato nella seconda parte della storia cercherà di indurre l’altro all’impegno. Negli anni Settanta, oltre alle critiche al mito risorgimentale, vi era stata una riscoperta anche storica dei fatti rivoluzionari, Sciascia, lo ricordiamo,aveva promosso la riedizione del lavoro di Radice sui fatti di Bronte, Vincenzo Consolo dando spazio alle rivolte contadine duramente Fu segretario di Stato per l’interno con Garibaldi,poi Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo e Senatore del Regno nel 1865. Roberto Longhi,storico dell’arte,polemizzava con la tradizione popolare perché i quadri era dipinti su commissione e quindi quello raffigurato non poteva che essere che un signore,un ricco. Segre, Cesare, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino:Einaudi,1991,p.73 Consolo Vincenzo ,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.118 81 represse, quella di Cefalù, del 1856 e quella di Alcàra, del 1860, segnala la differenza tra i moti borghesi di ispirazione carbonara e le sollevazioni contadine, in cui si rivendicava la terra, in cui ci si voleva liberare del peso dei balzelli e dell’usura, e che sfociavano in esplosioni di sangue. Ad Alcàra, dopo la rivolta e l’eccidio, sarà un Interdonato, generale garibaldino cugino dell’altro Giovanni Interdonato, a disarmare e imprigionare i rivoltosi, e sarà il castello di Sant’Agata di Militello, con i suoi sotterranei elicoidali, che li ospiterà. Il castello Immensa chiocciola con la bocca in alto e l’apice in fondo,nel buio e putridume La metafora della chiocciola,come ha notato Segre, attraversa tutto il romanzo e rappresenta l’ingiustizia, i privilegi della cultura, ed acquista una valenza di autocritica nei confronti di Mandralisca che se ne occupa, con amore, nelle sue ricerche. Vincenzo Consolo, rifiutandosi di narrare ciò che era stato già narrato, lascia spazio ai documenti, alle lettere, alle memorie attribuite a personaggi realmente esistiti ma inventate, che hanno il compito di sintetizzare gli avvenimenti, mentre il narratore deve soffermarsi sugli episodi, concedendosi il tempo della riflessione e della descrizione. La struttura del romanzo storico è quindi profondamente modificata, l’impasto linguistico è mirabile, l’effetto non è realistico. Nel 1968 era vivo il dibattito su quello che era il rapporto tra classi sociali e strumenti linguistici, si faceva sempre più evidente che gli oppressi non erano in grado di far sentire la propria voce, Vincenzo Consolo, in questo romanzo, tenta di dare voce a loro, ai braccianti, agli esclusi dalla Storia, che è “ una scrittura continua di privilegiati”, a chi ha visto la propria disperazione deformata da degli scrivani in “istruzioni,dichiarazioni,testimonianze”, la Storia infatti l’hanno scritta i potenti e non gli umili, i vincitori e non i vinti. L’impasto linguistico del romanzo mescola l’italiano sostenuto e barocco, dei primi capitoli, al dialetto siciliano, spesso sommariamente italianizzato, al sanfratellano, il poco noto idioma gallo-romanzo parlato da un brigante recluso, e al napoletano delle guardie o al latino. Mandralisca, poi, usa un siciliano che, con immagine dantesca si può chiamare “illustre” , letterariamente nobilitato e regolarizzato sul latino. In un’intervista Consolo ha affermato Ho voluto creare una lingua che esprimesse una ribellione totale alla storia e ai suoi miti. Ma non è il dialetto. E’ l’immissione nel codice linguistico nazionale di un materiale che non era registrato,è l’innesto di vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati306 il suo quindi è “ un lavoro da archeologo”, che riporta alla luce ciò che è sepolto nelle Ibidem,p. Sono di questi anni gli studi di Tullio De Mauro e La lettera ad una professoressa di Don Milani Consolo, Vincenzo,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.112 Lo nota G.Contini La lingua ritrovata :Vincenzo Consolo,a cura di M.Sinibaldi,«Leggere»,2,1988,p.12 82 profondità linguistiche dell’italiano, non è una corruzione dell’italiano, non va “verso il dialettismo di colore”, proprio di autori come Camilleri. Il libro si conclude con il proclama del prodittatore Mordini “agli italiani di Sicilia”, in vista del plebiscito del 21 ottobre del 1860, per l’unificazione. Il barone Mandralisca abbandonerà la sua turris eburnea, brucerà i suoi libri e le sue carte e si darà all’azione, aprirà una biblioteca, un museo e una scuola in modo tale che la prossima volta la storia loro,la storia,la scriveran da sé .
Vincenzo Consolo: romanzo e storia. Storia e storie.
JEAN FRACCHIOLLA
Dire che ogni scrittore vive di storie è un po’ un truismo. Che cosa fa in effetti qualsiasi narratore? Ci racconta delle storie: Sia delle storie che possono appartenere alla realtà quotidiana dell’epoca in cui ci trasporta il narratore, e allora si tratta di un romanzo realista, ciò che Stendhal definisce, per riprendere
la sua celebre immagine, come «le miroir qu’on promène le long d’un chemin».
Sia delle storie che si nutrono di miti radicati nell’immaginario collettivo, e allora abbiamo a che fare con dei racconti che rasentano il meraviglioso, il fantastico, il lirico, l’epico o il tragico… Come ogni romanziere Vincenzo Consolo non sfugge a questa regola: i suoi romanzi sono strapieni di storie, di racconti,
nonché di aneddoti, di notazioni, d’impressioni, come quelle che ci presenterebbe uno scrittore viaggiatore. E qui apro subito una breve parentesi per fare una costatazione che mi sembra importante: tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio. Tutte ci invitano ad un viaggio attraverso dei luoghi privilegiati, quasi sempre in Sicilia, il cui epicentro sembra essere la città di Cefalù; ma tornerò più avanti su questo punto. Però Vincenzo Consolo non è un semplice romanziere realista che si accontenta di registrare e di descrivere la realtà in cui vive (anche se questo gli capita, naturalmente, ad esempio quando egli denuncia il totale degrado in cui sono cadute oggi le grandi città di Sicilia, come Palermo o Siracusa), ma in generale le storie di Consolo affondano le loro radici nella Storia, quella della Sicilia degli anni e dei secoli passati, cioè di una Sicilia splendida nella bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi siti ancora intatti, di una Sicilia pura e vergine nei suoi costumi non ancora corrotti, di una Sicilia mitica (che ci ricorda e rimanda a quella di Verga e Vittorini), di cui il nostro scrittore esprime continuamente la straziante e lacerante nostalgia. Per altro questo rapporto con la Storia caratterizza tutta la tradizione del romanzo italiano moderno, dal Manzoni, passando poi per Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, perfino Sciascia, tradizione nella quale s’inserisce profondamente Vincenzo Consolo, ma in modo molto originale, come vedremo più avanti. Tutti i romanzi e tutte le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Così La ferita dell’aprile, il romanzo che, nel 1963, segna gli inizi letterari di Consolo, misto sapientemente dosato di autobiogafia e di storia, di quotidiano e di mito. La ferita dell’aprile è la storia di un adolescente e di un paese siciliano all’indomani della seconda guerra mondiale. La storia di un adolescente che, alla fi ne di un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e di dolori, giunge alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza. In effetti la «ferita», alla quale allude il titolo, è di sicuro la «ferita» della giovinezza, nella sua esperienza dolorosa di passaggio all’età adulta; ma è anche forse «la ferita» politica delle elezioni del 18 aprile 1948, profondamente risentita dallo scrittore impegnato Consolo, che rimane solidale delle vittime di una storia che gli appare immutevole e insensata. Tra La ferita dell’aprile e il suo secondo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976, dodici anni di silenzio, sui quali potremo chiedere dopo a Vincenzo Consolo qualche chiarimento. Poi viene Lunaria (1985), in cui Consolo tiene un discorso sottilmente politico e storico (notiamo anche, ‘en passant’, come nel nostro autore Storia e politica sono sempre strettamente legate). Lunaria ci presenta una Palermo del Settecento, in cui l’autore
mette in scena un mito poetico, quello della luna contro il potere. La caduta della luna mette in luce «la diversità» di un vicere che non crede nel potere, il ché lo avvicinerà ai suoi sudditi (contadini e popolani), e lo aiuterà a smascherare la falsa scienza ben diversa da quella vera scienza capace di audacia e di spirito concreto. Solo la gente umile, i poeti, i marginali saranno capaci di capire veramente la luna e la forza del suo mito. Ne La ferita dell’aprile, rileviamo questa frase: “Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte femmine, correte, prima che si squagliano”1 . Questa frase annuncia già Lunaria e ci rivela, in nuce, nel suo potente lirismo, due elementi essenziali della poetica di Consolo:
da una parte il faro che invita al viaggio, un viaggio rituale
dall’esistenza alla Storia, che invita quindi alla conoscenza del
mondo e di se stessi. Il faro, cioè la luce, e quindi per Consolo la
ragione che attrae, che illumina in modo intermittente le tenebre;
il faro che simboleggia il tentativo umano, mai completamente
appagato, di penetrare il mistero dell’esistenza.
dall’altra parte la luna, altro topos al quale il nostro autore
è particolarmente legato, che rappresenta il bisogno assoluto di
immaginazione, di creazione poetica. Qui, in quei repentini bagliori del faro di Cefalù che, con la sua luce, trafigge la luna e ne fa cadere le briciole, le molliche nel mare, possiamo rilevare
non soltanto una immagine intensamente poetica, ma anche una
prima e delicata immagine della «violazione» e della «caduta» della
luna che sono precisamente i temi centrali del racconto teatrale
Lunaria.
E qui vediamo anche come, da un’opera all’altra, si stabilisce una rete di corrispondenze e di echi interni. Anche Retablo (1987) è, a modo suo, un romanzo storico, ambientato nel Settecento, nella Sicilia occidentale, che per Consolo è quella della Storia. Retablo si presenta come un racconto di viaggio -forma che ritroveremo ancora ne L’olivo e l’olivastro- quello del Cavaliere Clerici, pittore milanese, in cui, come avviene nei romanzi di avventure, gli episodi si susseguono senza legami necessari tra di loro. Attraverso la Sicilia del Settecento, sontuosa e misera, accecante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e squallida, si delinea e dispiega il conflitto tra ‘avere’ e ‘essere’, vale a dire tra i falsi valori (della ricchezza, la nobiltà del nome, del potere) e i valori autentici, cioè quelli che si affermano per sé stessi e che caratterizzano un’umanità umile, marginale, diversa, vale a dire quella dei pastori, dei poeti, dei nobili vegliardi, dei briganti generosi o dei mercanti disinteressati. È con questi umili che simpatizza ovviamente il Cavaliere Clerici (come il vicere di Lunaria di cui costituisce un’eco), intellettuale illuminato del secolo dei lumi, eco anche lui del barone Mandralisca e di Giovanni Interdonato de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Le Pietre di Pantalica (1988), non più romanzo ma raccolta di novelle, conservano un legame molto stretto con la storia della Sicilia. L’opera si dipana su un arco di tempo che va dal periodo della liberazione fi no ai conflitti sociali del dopoguerra, dal «boom» economico degli anni’60, ai problemi, ai danni e al degrado causati da questo «boom» nella Sicilia e nell’Italia contemporanea. Siccome la Sicilia e i mali siciliani sono spesso, per non dire sempre, una metafora dell’Italia e dei mali italiani, ritroviamo, ne Le pietre di Pantalica, la critica contro la cultura dei privilegi e del potere; ritroviamo il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso ed endemico» di una Sicilia emblematica; ritroviamo la visione di una storia immobile ed immutevole nelle sue prevaricazioni, i suoi inganni e le sue menzogne, nelle sue ingiustizie e le sue esclusioni. Le pagine emblematiche del penultimo racconto, intitolato appunto “Le pietre di Pantalica”, ci offrono un ritratto terrificante delle città che una volta furono tra le più belle della Sicilia, si vuol parlare naturalmente di Siracusa e di Palermo: “Sono tornato a Siracusa dopo più di trent’anni, ancora come spettatore di tragedia. Allora, in quel teatro greco, nel momento in cui Ifi genia faceva il suo terribile racconto del suo sacrificio in Aulide, … o nel momento in cui il coro cantava… in questi alti momenti e in altri, nel teatro greco di Siracusa era tutto un clamore di clacson di automobili, trombe di camion, fischi di treni, scoppiettìo di motorette, sgommate, stridore di freni… Attorno al teatro, dietro la scena, dietro il fondale di pini e cipressi il paesaggio sonoro di Siracusa era orribile, inquinato, selvaggio, barbarico, in confronto al quale, il fragore del mare Inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin… E, usciti dal teatro, che cosa si vede? La distruzione e lo squallore: un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini. Le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche di Melilli e Priolo, alle porte di Siracusa, hanno corroso, avvelenato la città. Nel centro storico, nell’isola di Ortigia, lo spettacolo è ancora più deprimente. La bellissima città medievale, rinascimentale e
barocca, la città ottocentesca e quella dell’inizio del Novecento è completamente degradata: una città marcia, putrefatta”2 . E più avanti: “Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido, esala odore dolciastro di sangue e gelsomino, odore pungente di creolina e olio fritto. Ristagna sulla città, come un’enorme nuvola compatta, il fumo dei rifiuti che bruciano sopra Bellolampo… Questa città è un macello, le strade sono ‘carnezzerie’ con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati, legati mani e piedi come capretti, strozzati, decapitati, evirati, chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta…”3
Queste pagine annunciano ciò che diventerà il leitmotiv di un’opera successiva di Consolo, cioè L’olivo e l’olivastro, pubblicata nell’agosto del 1994. L’olivo e l’olivastro è una specie di odissea,
di ritorno nella patria natale; è un’immagine desolata, corrotta, apocalittica della Sicilia, quella che ci offre la prosa lirica e barocca di Consolo. Anche qui ritroviamo il tema del viaggio che costituiva la struttura portante di Retablo; però tutto quello che il poeta vede è soggetto a un paragone che oppone la Sicilia mitica di una volta, la Sicilia eterna, superba, splendida attraverso i suoi siti, la sua natura ed i suoi monumenti, alla Sicilia attuale che non è altro che squallore e abbrutimento.
Bisognerebbe citare tutte le pagine che segnano questa trasformazione, quella di Caltagirone, di Gela di cui Consolo ci presenta un ritratto terrificante per non dire raggelante, quella di Segesta, di Mazzara ed infine di Gibellina che si offre come l’ultimo esempio, in quest’opera, di un’antica, nobile e magnifica civiltà, sacrificata agli dei di un modernismo dello scandalo e dell’orrore.
L’olivo e l’olivastro, a parer nostro, costituisce, nel percorso letterario di Vincenzo Consolo, un’opera-somma in cui s’incrociano e si rispondono tutti i temi maggiori della poetica consoliana, e un’opera in cui l’uomo, il romanziere ed il poeta, gridano la loro indignazione ed il loro sgomento di fronte ai templi della bruttezza architettonica e morale di quel che si è soliti chiamare la civiltà moderna. L’olivo e l’olivastro è un libro-chiave per capire tutta l’opera di Consolo. Occorrerebbe poterne citare tutte le pagine, in particolare quelle in cui Consolo rivela al lettore il significato profondo della sua scoperta di Cefalù, ma sarebbe ovviamente troppo lungo, perciò ci accontenteremo di citarne un breve passo: “Si ritrovò così a Cefalù… Ricorda che lo meravigliava, man mano che s’appressava a quel paese, l’alzarsi del tono di ogni cosa, nel paesaggio, negli oggetti, nei visi, nei gesti, negli accenti; il farsi il tono più colorito e forte, più netto ed eloquente, più iattante di quello che aveva lasciato alle sue spalle. Aspra, scogliosa era la costa, con impennate montuose di scabra e aguzza roccia, fi no alla gran rocca tonda sopra il mare -Kefa o Kefalè-, al capo che aveva dato nome e protezione dall’antico a Cefalù… Alti, chiari, dai capelli colore del frumento erano gli abitanti, o scuri e crespi, camusi, come se, dopo secoli, ancora distinti, uno accanto all’altro miracolosamente scorressero i due fi umi, l’arabo e il normanno, siccome accanto e in armonia stavano il gran Duomo o fortezza o castello di Ruggiero e le casipole con archi, altane e finestrelle del porto saraceno, del Vascio o la Giudecca. S’innamorò di Cefalù. Di quel paese che sembrava anticipare nella Rocca il monte Pellegrino, nel porto la Cala, nel Duomo il Duomo, nel Cristo Pantocratore la cappella Palatina e Monreale, nell’Osterio Magno lo Steri chiaramontano, nei quartieri Crucilla e Marchiafava la Kalsa e il Borgo, anticipare la grande capitale. Abitò a Cefalù nell’estate. Gli sembrava, ed era, un altro mondo, un mondo pieno di segni, di messaggi, che volevano essere letti, interpretati”4 .
Così quindi Cefalù, centro del mondo di Consolo, sorta di Aleph borgesiano, citando Borgès: “in cui si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti sotto tutti i punti di vista”, Cefalù è per Consolo la città d’incontro e di scoperta, la città che diventerà la citta-simbolo di un intero universo.
E quale migliore transizione di Cefalù per parlare dei due romanzi senz’altro più compiuti e tra i più importanti di Consolo, e di cui volutamente non si è parlato finora, cioè Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) -cronologicamente il secondo di Consolo- e Nottetempo, casa per casa (1992 -Premio Strega 1992). Cefalù, alfa e omega di Vincenzo Consolo, terra di ogni scoperta e ogni delizia, Cefalù col suo faro, Cefalù e la sua cattedrale, che di opera in opera sono, come i ciottoli seminati da Pollicino, i punti di riferimento di Consolo, Cefalù caput mundi (kefalè=testa), Cefalù è il luogo privilegiato di questi due romanzi, romanzi storici per antonomasia, che costituiscono come ama a ricordarlo il loro autore: «Il dittico di Cefalù». Con Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato integralmente nel 1976, Consolo si tuffa letteralmente nella storia, quella del Risorgimento a Cefalù e in Sicilia, per tentare di capire le ragioni del fallimento parziale degli ideali di uguaglianza e di giustizia che avevano attraversato tutta la prima metà dell’Ottocento, per concretizzarsi momentaneamente nella data dell’undici maggio 1860, giorno dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il protagonista della prima parte del romanzo, quella di Cefalù, è Enrico Piraino, barone di Mandralisca, malacologo e archeologo, intellettuale impegnato a favore del nuovo corso della storia. Consolo ne fa il portavoce della propria ideologia, delle proprie convinzioni sull’idea di proprietà e delle ingiustizie che da essa derivano. Mandralisca va paragonato al Cavaliere Clerici di Retablo e al Vicere di Lunaria. Consolo è rimasto affascinato dalla statura morale di questo personaggio, decisamente più generoso del principe Salina ne Il Gattopardo di Lampedusa, e personaggio in cui egli sente, per via dell’amore comune che nutrono tutti e due per il viaggio (reale o metaforico), un fratello di elezione. Nei numerosi spostamenti del barone “da Lipari a Cefalù, dal mare alla terra, dall’esistenza alla storia”, come lo dice lui stesso, Consolo ha trovato un antecedente storico al proprio viaggio-scoperta-iniziazione, dalla regione di Messina dove è nato ed ha vissuto la propria infanzia (a Sant’Agata di Militello), e che rappresenta per lui il mondo della natura e del quotidiano, verso la regione di Palermo che rappresenta invece, tramite la tappa intermedia di Cefalù, autentica porta del mondo, la cultura e la Storia.
Mandralisca è l’intellettuale che si pone in modo problematico di fronte alla storia per cercare di capirne il corso e gli sviluppi. È lui peraltro che ha comprato il «Ritratto d’ignoto» d’Antonello da
Messina il cui sorriso e sguardo enigmatici, nel contempo complici e distanti, ironici e aristocraticamente benevoli, ci dicono a che punto quest’uomo la sa lunga sulla vita e i suoi segreti. D’altronde questo sorriso enigmatico dell’uomo misterioso dipinto da Antonello, Consolo lo fa rivivere sul viso di un altro personaggio importante del romanzo, il democratico Giovanni Interdonato, latore di tutti i valori positivi del cambiamento sperato: quello di una Sicilia migliore, in cui il lavoro e la capacità di sacrificio dei suoi abitanti potranno far regnare, alla luce della ragione e dello spirito (la cui sede è il capo, cioè Cefalù / kefalè), una maggiore giustizia. Il sorriso dell’ignoto marinaio ci offre, per lo meno nella sua prima parte, una visione allegra dell’esistenza, che Consolo ci comunica mediante parole che attingono la loro bellezza nella poesia dei luoghi descritti, nel lirismo dei gesti quotidiani, offerti al lettore senza compiacimento paternalistico, ma piuttosto attraverso un’estasi poetica profonda. La seconda parte del dittico, Nottetempo casa per casa (marzo 1992), arriva dopo anni di approfondimenti tematici e di sperimentazioni linguistiche molto personali: l’agonia della poesia in Lunaria, il tema e la metafora del viaggio, il rapporto scritturavita e le riflessioni esacerbate sull’alienazione della nostra epoca (Retablo e Le pietre di Pantalica). Nottetempo casa per casa è storicamente ambientato negli anni 20 del Novecento, scelta naturalmente non affatto casuale. Consolo stabilisce un parallelo implicito tra quel periodo ed il nostro, si serve del passato e della storia per parlarci meglio del presente: in effetti il clima di violenza e d’intolleranza, che s’instaura in Italia con l’avvento del fascismo, trova degli echi nella follia e l’oltraggiosa disconoscenza della dignità umana che regnano oggigiorno. Cefalù, come la Sicilia di Sciascia, diventa in questo romanzo metafora di una realtà generale non solo problematica e contraddittoria, ma anche, per certi aspetti, stretta e volgare. Per tutte queste ragioni, Petro Marano, il protagonista del romanzo, è naturalmente sconcertato -come lo è lo scrittore- davanti a questa realtà che perde la propria consistenza, che si sfrangia e si sfi laccia sotto i colpi dei movimenti irrazionalistici che sembrano fare dei proseliti anche tra i suoi compatrioti: “Sentiva d’esser legato a quel paese, pieno di vita, storie, trame, segni monumenti. Ma pieno soprattutto, piena la sua gente, della capacità di intendere e sostenere il vero, d’essere nel cuore del reale, in armonia con esso. Fino a ieri. Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo tra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania”5 . Mentre ne Il sorriso dell’ignoto marinaio i luoghi di Cefalù erano le contrade dell’utopia, della speranza appassionata di un cambiamento storico e sociale, in Nottetempo casa per casa gli stessi luoghi diventano come le regioni del disincanto, dell’assenza di ragione, della scomparsa temporanea della luce del faro, del
«chiarore della lanterna». Allora la scrittura di Consolo in Nottetempo casa per casa si mette in posizione di attesa, pur rimanendo costruttiva poiché continuare a scrivere, a raccontare, significa per Consolo denunciare la notte della ragione, ma anche continuare a sperare, non abbandonarsi al pessimismo più tetro che genera l’afasia, l’impossibilità di creare e d’inventare. A Cefalù Consolo ha compiuto un «rito di passaggio», di cui lui stesso ha abbondantemente parlato, che gli ha permesso di fare emergere, dal suo magma interno, l’altra parte della verità, l’altro colore dell’esistenza, l’emisfero nascosto della luna. Questo viaggio, senza alcun dubbio, più che un viaggio spaziale vero e proprio, ha un valore piuttosto simbolico di conoscenza e d’iniziazione. Cefalù, «rito di passaggio», unisce strettamente i due romanzi. D’altronde Consolo fa notare che nessun critico aveva notato che i due libri hanno lo stesso incipit: il primo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, inizia così: “E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci”6 . Inizia quindi con una congiunzione, «E», e un’aurora. In altri termini è un libro augurale ed aurorale, è un libro diurno e solare, perché si tratta del romanzo della speranza. il secondo invece, con un effetto di simmetria oppositiva,
inizia con una congiunzione, «E», e un notturno:
“E la chiarìa scialba all’oriente… Sorgeva l’algente luna”7 .
Inizia con il sorgere della luna, con l’apparizione di un personaggio inquietante, anche lui notturno, il padre di Petro Marano, notturno perché soffre di licantropia. Se Il sorriso dell’ignoto marinaio era il libro della speranza, Nottetempo casa per casa è il libro della disperazione e del dolore. Lascio ora la parola a Consolo che citerò lungamente: “Ho voluto rappresentare il dolore… e questo libro è stato da me concepito proprio come una tragedia: la scansione in capitoli del libro è proprio quella delle scene di una tragedia greca… Mi è stato soprattutto rimproverato da un critico, per altro molto acuto, che io cerco consolazione in un genere ormai scaduto, nel romanzo. L’ho trovato offensivo. La letteratura non è scaduta, essa è stata avvilita. Credo che la funzione della letteratura sia ancora quella di essere testimone del nostro tempo. Petro Marano è questo. Di fronte al fallimento dell’utopia politica, di fronte alla follia della storia e alla follia privata, alla sua follia esistenziale, al dolore che lui si porta dentro, capisce che il suo compito è quello dell’anghelos, del messaggero che nella tragedia greca ad un certo punto arrivava sulla scena e raccontava ciò che si era svolto altrove. Ecco, la funzione dello scrittore, di Petro Marano è quella di fare da anghelos, da messaggero. Nei momenti in cui cadono tutti i valori, la funzione della letteratura è di essere testimone non soltanto della storia, ma anche del dolore dell’uomo. È l’unica funzione che la letteratura può avere. La politica si preoccupa delle sorti immediate dell’uomo, la letteratura, invece, va al di là del tempo contingente. Di una letteratura, parlo di narrativa, quanto mai minacciata, oggi, da quella che è la mercificazione di questo genere letterario. È per questo che ho concepito il mio impegno letterario, non soltanto per un fatto di propensione verso il lirismo ma anche ideologicamente devo dire, come difesa dello spazio letterario.
Ho cercato di allontanarmi sempre di più da quel linguaggio senza memoria, insonoro, che i mezzi di comunicazione di massa oggi ci impongono e che ormai ha invaso tutti i settori della nostra vita. Il settore più minacciato, dicevo, è quello della narrativa. Credo che l’unica salvezza per questo genere fortemente appetito dai produttori dell’industria culturale -appunto perché è mercificabile- rimanga quella di avvicinare la narrazione alla poesia”. Ho tenuto a riferire lungamente le parole di Vincenzo Consolo perché, da sole, costituiscono un’ottima conclusione ai miei propositi di oggi. Propositi un po’ brevi e lapidari per una materia così ricca, sulla quale ci sarebbe ancora molto da dire. Ma il mio intento e la mia ambizione erano solo quelli d’introdurre un dibattito con l’autore in persona.
Quindi, per concludere, in Consolo narrativa e Storia sono intimamente legate. La Storia costituisce la trama intima del tessuto romanzesco. Ma Consolo non è uno storico e non è semplicemente, direi, un romanziere storico. È anche e soprattutto, per via di ciò che la sua prosa ha di lussureggiante, colorato, colto, prezioso, spesso barocco e lirico, è anche quindi un poeta della storia e del romanzo. La lettura di alcuni brani citati lo dimostra. I suoi legami e la sua dimestichezza di spirito e di penna con alcuni dei più grandi poeti contemporanei, quali Montale e soprattutto Lucio Piccolo, il grande poeta siciliano che fu amico di Consolo, lo attestano. Ma questo aspetto del nostro scrittore potrebbe essere oggetto di un’altra presentazione e di un altro dibattito.
1 CONSOLO, V. (1989: 31). 2CONSOLO, V. (1988: 165-6).
3CONSOLO, V. (1988: 170). 4 CONSOLO, V. (1994: 123-4).5 CONSOLO, V. (1992: 144). 6 CONSOLO, V. [(1976) ma 1997: 12]. 7 CONSOLO, V. (1992: 5).
BIBLIOGRAFIA:
CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1989): La ferita dell’aprile, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1992): Nottetempo, casa per casa, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1994): L’olivo e l’olivastro, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1997): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori
(«Scrittori italiani») [1 ed. 1976, Torino: Einaudi].

L’evidenza del nome nella scrittura di Vincenzo Consolo
Giulio Ferroni
Università La Sapienza
Nel capitolo VI de Il sorriso dell’ignoto marinaio si svolge un’intensa interrogazione del senso della scrittura dei «cosiddetti illuminati», dei «privilegiati» che pure tentano di dar voce ai villani che si sono ribellati alle ingiustizie; se ne rileva il carattere di impostura, di fronte alla
difficoltà e impossibilità di far parlare le lingue “altre”, di trovare «la chiave, il cifrario dell’essere», lo strumento di accesso al mondo delle classi subalterne, alla loro espressione, al loro essere, al loro sentire e al loro risentimento. Entro questa insuperabile difficoltà viene chiamata più specificamente in causa l’insufficienza dei nomi, delle parole del codice politico, fatto di termini che restano estranei alle classi popolari; anche le grandi parole come «Rivoluzione, Libertà, Egualità, Democrazia» mostrano la loro incorreggibile parzialità. Di fronte a questa situazione, si delinea l’attesa di parole nuove, di nomi capaci di afferrare quella realtà che sfugge al linguaggio attualmente disponibile, conquistati dagli stessi soggetti che da quello sono esclusi: “Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose”1 . I nomi vengono ad essere, in effetti, nella loro evidenza, gli strumenti essenziali di un contatto con le cose, qui con una proiezione utopica (che risente ancora delle utopie sessantottesche) verso il sogno di un legame futuro, solidale, tra nomi e cose, verso una conciliazione che cancelli ogni scissione, ogni lacerazione tra il linguaggio e la realtà. 56 Ben presto però, nell’esperienza di Consolo, al di là di questa proiezione in avanti, si impone un movimento opposto che conduce la scrittura, nel confronto con l’evidenza dei nomi, a risalire all’origine, o comunque ad un perduto passato di conciliazione tra la realtà e il linguaggio. Essi si porranno allora come segni persistenti di ciò che è stato lacerato, segni che recano in sé le stigme del dolore, che manifestano la necessità e insieme l’impossibilità di un riconoscimento, di una risposta all’offesa del male e della violenza. Nel testo eponimo de Le pietre di Pantalica lo sguardo agli oltraggi subiti da Siracusa rinvia ad uno scritto di Alberto Savinio (Nivasio Dolcemare), Fame ad Atene, con il terribile ricordo di uno degli oltraggi subiti da Atene nella seconda guerra mondiale (la morte per fame di ottocento persone), e al modo in cui lo scrittore cercò di rievocare e difendere la memoria della città proprio affidandosi ai suoi nomi: “Allora lo scrittore, per quest’offesa all’umanità, per quest’oltraggio alla civiltà, fa una rievocazione della sua Atene servendosi dei nomi: di vie, di piazze, di bar, di ritrovi; di persone, di oggetti; e soprattutto di cibi, di dolci. Nomi scritti nella loro lingua, in greco. Roland Barthes ci ricorda che in latino sapere e sapore hanno la stessa etimologia. E anch’io allora, come Nivasio Dolcemare, vorrei, se ne fossi capace, rievocare la mia Siracusa perduta attraverso i nomi: di piazze, di vie, di luoghi … Ma soprattutto di cibi, di dolci, magari servendomi di un prezioso libretto, Del magiar siracusano, di Antonino Uccello. Ma, Antonino, ha senso oggi trascrivere quei nomi?”2 . La coscienza della divaricazione tra l’originario mondo della tragedia greca e l’uso delle contemporanee rappresentazioni in traduzione (proprio nella disastrata Siracusa) fa poi sorgere un’allocuzione ai mitici personaggi di Argo, città «ridotta a rovine», il cui ricordo può persistere, come quello di Siracusa o di Atene, solo nella parola originaria della poesia: “Vi resti solo la parola, la parola d’Euripide, a mantenere intatta, nel ricordo, quella vostra città”
3 . 2. 3 Ibidem. 57
Il rilievo del nome sostiene l’ampio uso che Consolo fa della enumerazione caotica e dell’elencazione seriale, che dà assoluta evidenza ai sostantivi nei loro diversi tipi, dai nomi propri (luoghi, persone, dati della storia e del mito, ecc.) a quelli comuni di cose materiali e concrete a quelli di cose astratte e ideali, ecc. Queste enumerazioni di nomi si collegano talvolta a scatti improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro. Nel IV capitolo di Nottetempo casa per casa il «maestricchio» Petro Marano, chiuso nella torre del vecchio mulino avuto in lascito, meditando sul dolore della propria famiglia, dopo essersi abbandonato ad un urlo indistinto e senza scampo, si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere dato appunto dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del tempo: “E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno …» scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento 58 in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo”4 . Petro rinvia alla scaturigine dei nomi, che, quando designano cose concrete, sembrano mantenere ancora il nesso primigenio, la misura di quando nulla era ancora accaduto, di quando il male e il dolore non aveva ancora lacerato le possibilità dell’esperienza. E si noti come in questa elencazione, che la punteggiatura fissa in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi, riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio l’evidenza del nome si impone fi n dalle pagine iniziali, con lo sguardo del barone Mandralisca che si avvicina alla costa della Sicilia, la cui immagine si fissa nei nomi dei feudatari signori delle torri sormontate dai fani (si noti qui la quasi totale assenza degli aggettivi: c’è solo il generico grande e il numerale cinque). “Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte, i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo …”5 . Ai nomi dei feudatari che in quel momento dominano i luoghi succedono poi quelli delle città sepolte, evocate dalla sapienza archeologica del barone: “Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Calacte, Alesa… Città nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni”6 . 6 Ibidem. 59
Ecco poi più avanti un elenco dei pellegrini che procedono verso il santuario di Tindari e degli oggetti che recano con sé: “Erano donne scalze, per voto, scarmigliate; vecchie con panari e fiscelle e bimbi sulle braccia; uomini carichi di sacchi barilotti damigiane. Portavano vino di Pianoconte, malvasia di Canneto, ricotte di Vulcano, frumento di Salina, capperi d’Acquacalda e Quattropani. E tutti poi, alti nelle mani, reggevano teste gambe toraci mammelle organi segreti con qua e là crescenze gonfi ori incrinature, dipinti di blu o nero, i mali che quelle membra di cera rosa, carnicina, deturpavano”7 . E si ricordino ancora più avanti i nomi elencati dal Mandralisca di fronte ai pazienti visitatori della sua casa- museo: “Alle vetrine, alle teche delle lucerne e delle monete, dove il barone si lasciò andare ad una sequela infinita di date, di luoghi, di simboli e valori, quei quattro o cinque che appresso gli restarono, per troppa stima o estrema cortesia, afferrarono qualcosa come Mozia Panormo Lipara Litra Nummo Decadramma”8 . E del resto la figura stessa del Mandralisca, erudito e malacologo, raccoglitore e classificatore di oggetti, di dati e di date, è elettivamente disposta alla ricerca e alla sistemazione dei nomi, alla loro disposizione ed elencazione (e si può ricordare, sempre nel Capitolo primo, il sogno di farsi pirata per impadronirsi della «speronara» che sta trasportando chissà dove dei marmi: se potesse averli farebbe schiattare di rabbia altri collezionisti concorrenti, i cui nomi vengono anch’essi riportati in elenco)9 . Ma in tutta l’opera di Consolo si danno le più diverse variazioni, combinazioni, funzioni in questo uso dei nomi. Così nel racconto di cui qui presentiamo la traduzione di Irene Romera Pintor 7 Si noti qui la sottile scansione, con la successione dei tre membri introdotti nell’ordine da donne, vecchie, uomini, e poi il successivo elenco in cui risaltano i luoghi d’origine dei diversi prodotti, dove l’evidenza delle derrate alimentari è sottolineata dal complemento con il nome proprio, il tutto disposto in una sequenza di quattro settenari e di un endecasillabo: vino di Pianoconte,/ malvasia di Canneto,/ ricotte di Vulcano,/ frumento di Salina,/ capperi d’Acquacalda e Quattropani. 8 «Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina».
60 Pintor, Filosofiana, si può trovare una fitta presenza di nomi geografi ci e topografi ci, mentre fortissima suggestione ha l’elenco dei nomi delle erbe pronunciato dall’impostore don Gregorio: “E salmodiando, don Gregorio gettava sopra la balàta le erbe che prendeva a una a una dalla sporta, chiamandole per nome. «Pimpinella,» diceva «Petrosella, Buglossa, Scalogna, Navone, Sellerio, Pastinaca…»”10.
Ma vorrei insistere un po’ più diffusamente su Retablo, che prende avvio proprio da un nome, quello della donna amata da Isidoro, Rosalia, subito scomposto nelle sue due componenti, Rosa e Lia, poi ossessivamente ripetute. Ciascuna di queste due componenti dà avvio ad una serie di esaltate variazioni. La prima variazione scaturisce dal piano semantico di rosa, in un delirio floreale, carico di profumi e di colori, che dà luogo ad altre serie di termini moltiplicati. Dopo il nome e la sua scomposizione, rosa viene ripetuto quattro volte, ogni volta seguito da una relativa che ne specifica l’azione; poi si passa ad una negazione paradossale (Rosa che non è rosa) e a due nuove riprese di rosa, accompagnate ancora da relative, ma stavolta le relative danno luogo a predicati nominali, entro ciascuno dei quali si dispongono quattro termini con nomi di fiori (prima datura, gelsomino, bàlico e viola; poi pomelia, magnolia, zàgara e cardenia). A queste identificazioni della donna con i diversi fi ori succede l’immagine del tramonto, con il suo trascolorare (fissato nell’immagine della sfera d’opalina, cioè di un vetro traslucido e opalescente) e con l’addolcirsi dell’aria (forte l’espressività di sfervora, come se essa riducesse la sua febbre), seguita nel suo penetrare dentro il chiostro del convento e nel suo spandervi nuovi profumi (ancora con elencazioni seriali, prima dei predicati, coglie, coinvolge, spande, poi dei complementi aggettivati, odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi) che sembrano risultare da un’opera di
10 CONSOLO, V. (1988: 92). Vero tour de force quello della traduzione di Romera Pintor, in CONSOLO, V. (2008: 69): “Y mientras salmodiaba, don Gregorio echaba sobre la lápida las hierbas que tomaba una a una del capazo, llamándolas por su nombre./ «Pimpinella» decía «Petrosela, Buglosa, Chalote, Nabo, Apio, Pastinaca…»”. 61
distillazione (e i balsami sono grommosi perché sembrano carichi di incrostazioni, di una sensuale impurità): “Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha ròso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ah!, con la sua spina velenosa in su nel cuore”11. Sul secondo termine della scomposizione si svolge tutta una serie di variazioni foniche a partire dal significante lia, in un viluppo di termini che contengono la sillaba li o la sola labiale l (daliato a lumia a liana a libame, licore, letale, ecc., fi no a liquame). Dal nome Lia si svolge, come un vero e proprio denominale, il verbo liare (che indica un’azione simile a quella che fanno sui denti agrumi come il cedro e la lumia), a cui segue tutta una serie di sostantivi caratterizzati dalla posizione iniziale della sillaba li, da liana (che contiene in sé il nome Lia); si notino le voci dotte libame (latino libamen), «libagione» che agisce come una droga (oppioso), lilio per «giglio», angue per «serpente»; limaccia indica una «lumaca» che lo avvolge nei suoi vischiosi avvolgimenti, attassò, (siciliano da attassari, «assiderare, freddare»); lippo è il siciliano lippu, che indica il musco e in genere ogni pellicola viscosa che si attacca: “Lia che m’ha liato la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa, limaccia che m’invischiò nelle sue spire, lingua che m’attassò come angue che guizza dal pietrame, lioparda imperiosa, lippo dell’alma mia, liquame nero, pece dov’affogai, ahi!, per mia dannazione”12. 12 Ibidem. 62 Ruotando sul nome e scomponendolo, in queste cascate di sostantivi che solo in pochi casi sono accompagnati da aggettivi, si svolge così un canto d’amore cieco e sensuale che si riavvolge su se stesso e che trova una figura esemplare, nel serpe che addenta la sua coda, del riavvolgersi di ogni esperienza su se stessa (è una figura, questa, molto cara a Consolo, come quella simile della chiocciola, riavvolta su di sé, in un percorso circolare che sempre torna al punto di partenza). Dopo questa scomposizione del nome della sua Rosalia, il frate ricorda di averla cercata nei luoghi più diversi di Palermo, fino ad identificarla in modo blasfemo con l’immagine della santa protettrice della città, Rosalia appunto, venerandone il corpo racchiuso nel sepolcro di cristallo nel celebre santuario del Monte Pellegrino: esasperata sensualità, erotismo, ossessione funebre, ritualità spettacolare, senso del peccato e della dannazione si fondono qui in un nesso inscindibile. Il nome di Rosalia viene ripetuto poi più volte, in diversi punti del libro; e al diario della peregrinazione del pittore Fabrizio Clerici si intreccia una confessione di Rosalia, che si scinde e si confonde in un’immagine singola e doppia, la Rosalia di don Vito Sammataro e la Rosalia di Isidoro che è in realtà «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore»13. Nell’attraversare i luoghi della Sicilia, Fabrizio Clerici ne assapora i nomi propri, trae in luce i signifi cati che addensano in sé; e dalle più semplici etimologie può lasciar scaturire altre cascate di nomi, come qui, che dal nome di Salemi vengono fuori in successione altri nomi astratti, altri nomi geografi ci, altri nomi concreti: “Ma era certo insieme quel paese Salem e Alicia, luogo di sale e luogo di delizia, del rigoglio e del deserto, dell’accoglienza e dell’inospitale, della sterilità e del fico bìfero, ché subito, appena pochi passi oltre l’aridume, ove la terra veniva ristorata dalle fonti di Delia, Ràbisi, Gibèli, Rapicaldo, dal Gorgo della donna, la terra si faceva, come la Promessa, copiosa di frutti d’ogni sorta, e di pascoli, di vigne, d’olivi, di sommacco”14.. 63 Poco più avanti si ascolta don Carmelo Alòsi, esperto nell’arte «degli innesti e della potatura», elencare, come «un unico giardino, unico e sognato, tutti i giardini» che ha conosciuto e in cui ha lavorato: “di Francofonte o di Lentini, della Conca d’Oro o del Peloponneso, di Biserta o d’Orano, di Rabat o di Marrakech o di Valencia. Come pure i giardini di capriccio e d’ornamento, piccoli come quelli di Mokarta, del Patio de los Naranjos sotto la Giralda di Siviglia, del Generalife sopra all’Alhambra di Granada o quello delle latomìe del Paradiso in Siracusa”15. Ma la campionatura dei nomi di Retablo può agevolmente condurre dai nomi geografi ci e topografi ci a quelli mitici. Così da una epigrafe greca di Selinunte sgorga una serie di nomi di classiche divinità: “Vinciamo per Zeus, per Phobos, per Eracle, per Apollo, per Poseidon e per i Tindaridi, per Athena, per Malophoros, per Pasikrateia e per gli altri dèi, ma per Zeus massimamente…”16. Ci sono poi i nomi storici, come quelli delle famiglie nobili di Trapani di cui don Sciavèrio Burgio presenta le dimore, a cui seguono i nomi delle chiese: “- Del barone Xirinda –dicea– del duca Sàura, dei signori Scalabrino, del marchese Fardella, del barone Giardino, Piombo, della Cuddìa, di San Gioacchino, dei signori Pèpoli, Staìti; e ancora: Poma, Todaro, Reda, Milo, Salina, Bartalotta, Riccio, Pandolfina, Rapì, Arcudaci… Quindi le chiese, più belle, più imponenti: del Collegio, di san Lorenzo, di Santo Spirito, della Badia, del Monserrato…”17. In questo delirio dei nomi, quello del poeta Giovanni Meli, ricordato dal pastore Alàimo, dà luogo ad una serie di variazioni paronomastiche: 64 “D’un poeta di qua, mi disse dopo, da tutti conosciuto e frequentato, di nome Meli. Ma Mele dico ei doversi dire, come mele o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo male”18. Ecco poi gli elenchi di nomi di oggetti, come quelli che popolano la casa-museo del Soldano: “… mi parve d’entrare nel museo più stivato e vario. V’era per tutte le pareti, sopra mobili e mensole, capitelli e basi di colonne, dentro nicchie e stipi, pendenti fi nanco dal soffi tto, ogni più bello e prezioso o più orrido e peregrino oggetto. Integri e lucidi e con disegni limpidi, neri crateri sicoli e attici, anfore oriballi coppe pissidi lecane, teste e gambe e torsi di terre cotte e marmi, arcaici rilievi di frontoni, di corrose metopi, luminosi parii di dèe e divi e d’eroi mitici di grecanica, fattura nobilissima o nei rifacimenti de’ romani; tavole dorate bizantine, croci dipinte, pale dei Fiamminghi, e vaste tele delle scuole del Sanzio, del Merisi o del Vecellio; stemmi, pietre mischie, conche di porfido, retabli gagineschi, calici incensieri cantaglorie, teschi d’avorio o maiolica sopra le cartapecore di codici e messali; cereplaste di Vanitas, morbi, pesti, flagelli e di Memento mori…”19. Come sintesi esemplare di questa furia della nominazione che agisce in ogni momento di Retablo, che agisce allo stesso modo sul frate siciliano sfratato e sul viaggiatore milanese che attraversa la Sicilia (anche se questi mette in bocca molte di queste serie di nomi a siciliani, a ospitali personaggi incontrati durante il suo viaggio), si può ricordare la pagina seguente, che si svolge in accumuli successivi di nomi di ordini diversi, da nomi geografi ci a nomi di navi a nomi di merci di ogni sorta. Siamo davanti al porto di Trapani (come fatto riavvolgere su se stesso attraverso il gioco paronomastico porto/ porta, in più complicato dal superlativo importantissima), la cui immagine balena in tutta evidenza davanti al lettore grazie ad una sorta di litania, attribuita da quel don Sciavèrio che accoglie i viaggiatori (e proprio letàne viene chiamata, non senza una certa ironia, quasi un fuggevole. 65 do autoironico di Consolo alla propria così pervicace e suggestiva passione per i nomi): “In quel porto, ch’è porta importantissima d’ogni incrocio e scambio, d’ogni più vario mondo, d’ogni città di traffico e commercio d’infra e fuori Regno, del settentrione e del meridione, del levante e del ponente, d’ogni isola, costa o continente: di Cipro, Rodi, Candia, Malta e di Pantelleria, d’Amalfi , Procida, Livorno, Lucca, Pisa, Genoa e Milano, di Venezia e di Ragusa, di Barcellona, Malaga, Cadice, Minorca… Vascelli, brigantini, galeoni, feluche, palmotte, sciabecchi, polacche, fregate, corvette, tartane caricavano e scaricavano, nel traffi co, nel chiasso, nell’allegria della banchina, le merci più disparate: sale per primo, e in magna quantitate, poi tonno in barile, di quello rinomato di Formica, Favignana, Scopello e Bonaglia, e asciuttàme, vino, cenere di soda, pasta di regolizia, sommacco, pelli, solfo, tufi , marmi, scope, giummara, formaggi, intrita dolce e amara, oli, olive, carrube, agli, cannamele, seta cruda, cotone, cannavo, lino alessandrino, lana barbarisca, raso di Firenze, carmiscìna, orbàci, panno di Spagna, scotto di Fiandra, tela Olona, saja di Bologna, bajettone d’Inghilterra, velluto, fl anella, còiri tunisini, legnami, tabacco in foglie, rapè, cera rustica, corallo, vetro veneziano, mursia, carta bianca… Queste letàne me le cantò orgoglioso un trapanese, cònsolo del Corpo dei naviganti, patrone di vascelli, don Sciavèrio Burgio…”20.
20 CONSOLO, V. (1987b:132). 66 BIBLIOGRAFIA: CONSOLO, V. (1987a): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Introduzione di Cesare Segre, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (1987b): Retablo, Palermo: Sellerio. CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (2006): Nottetempo casa per casa, Prefazione di Giulio Ferroni, Torino: UTET, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. CONSOLO, V. (2008): Filosofiana (relato de Las piedras de Pantálica), Edición, introducción, traducción y notas de Irene Romera Pintor, Madrid: Fundación Updea Publicaciones
La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO
(Homenaje por sus 75 años)
Irene Romera Pintor (Ed.)