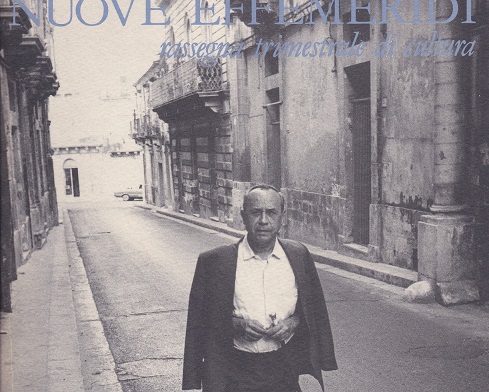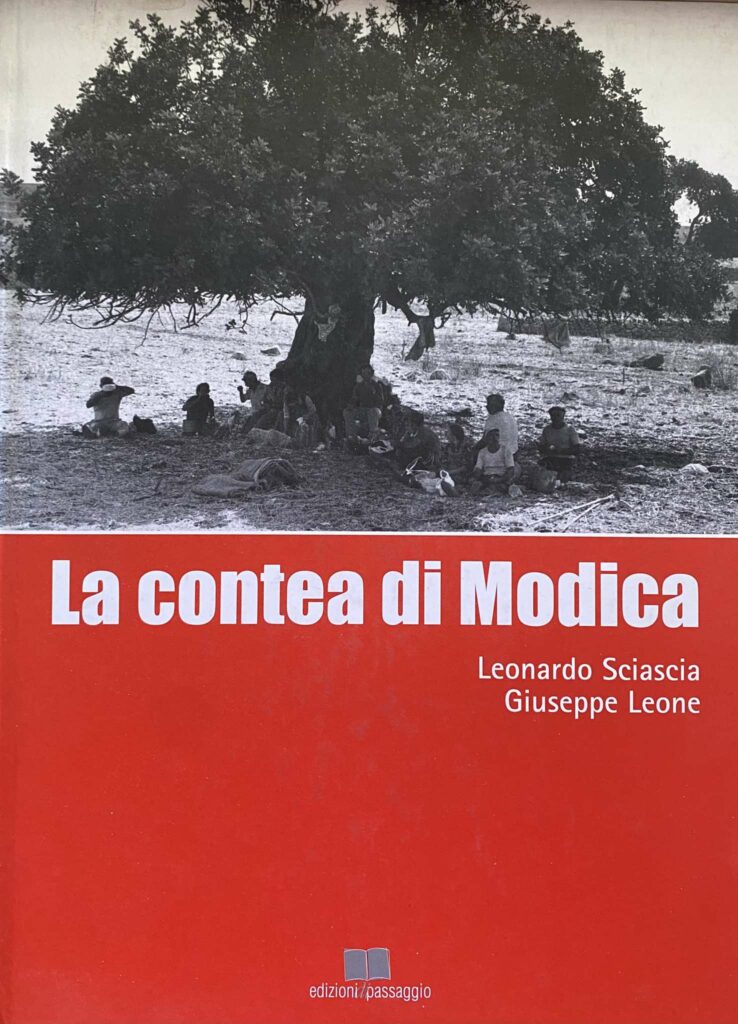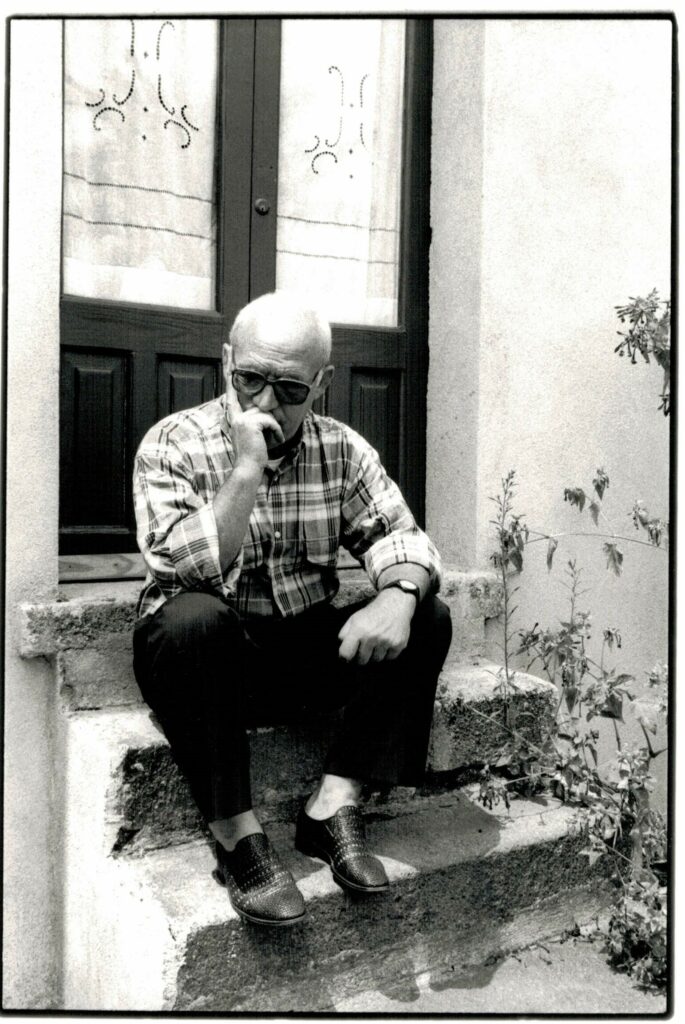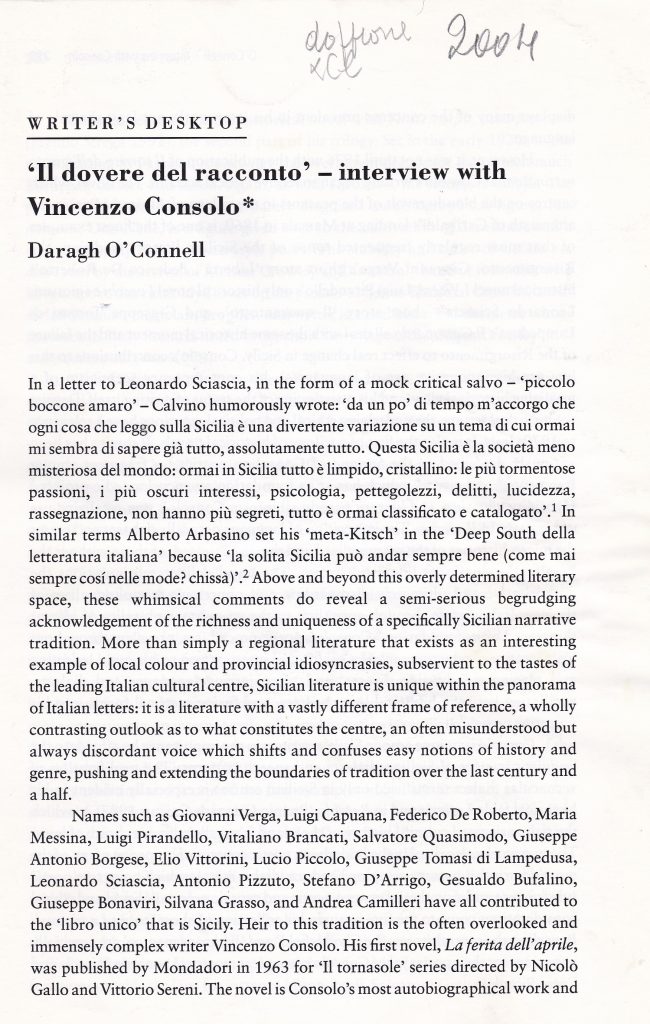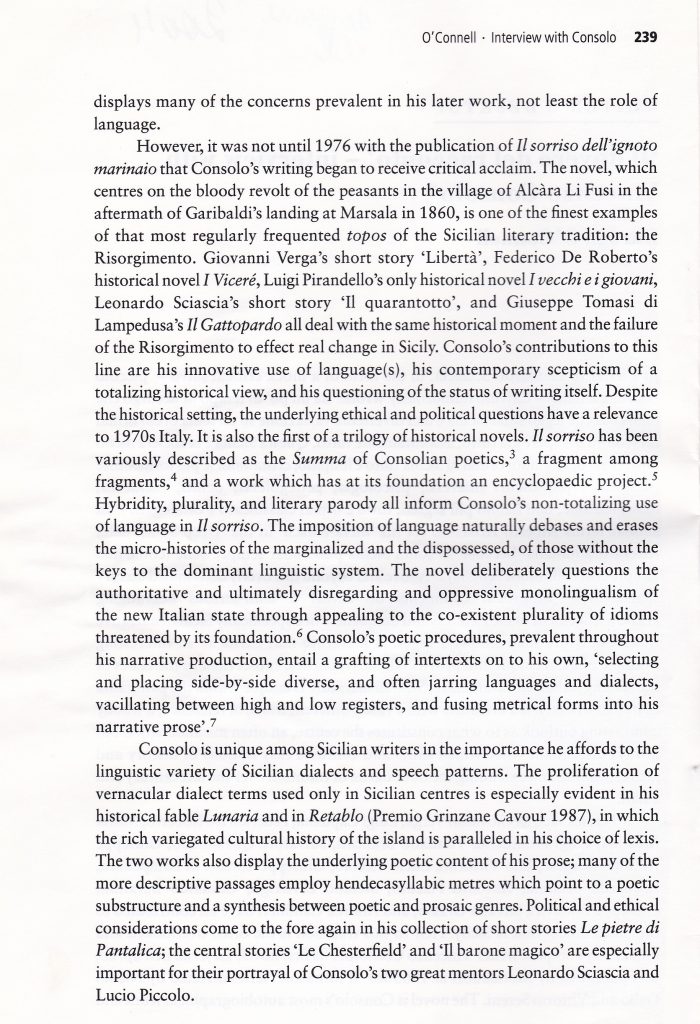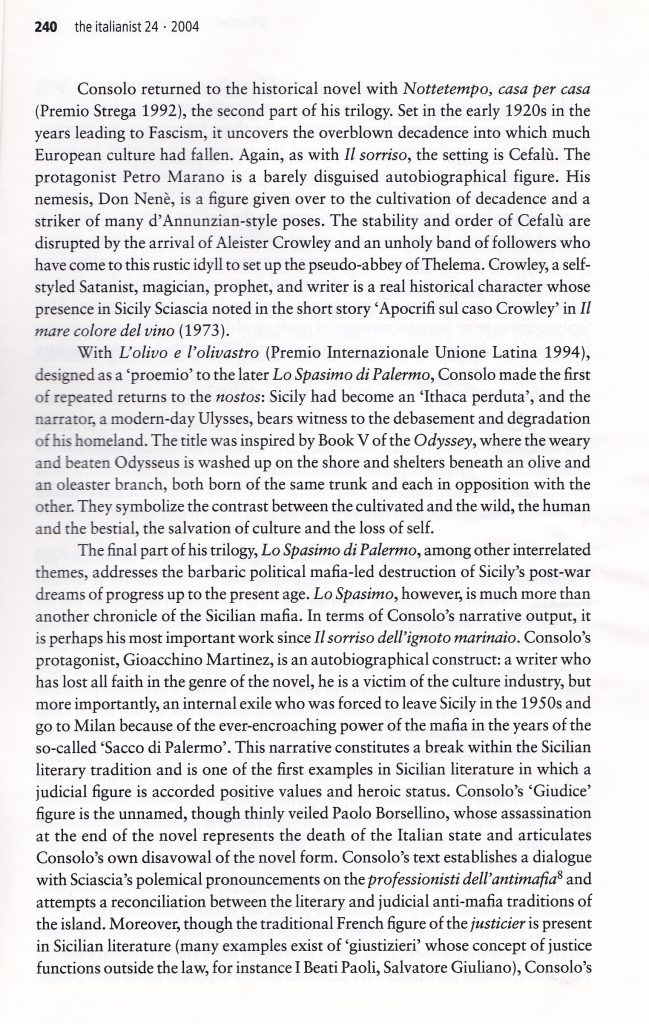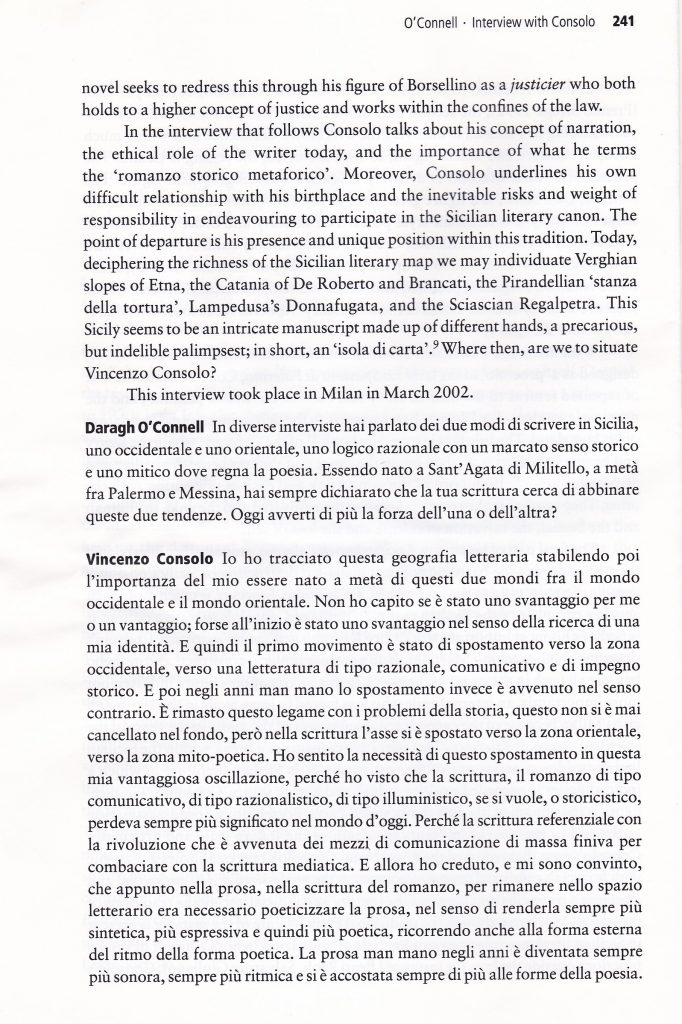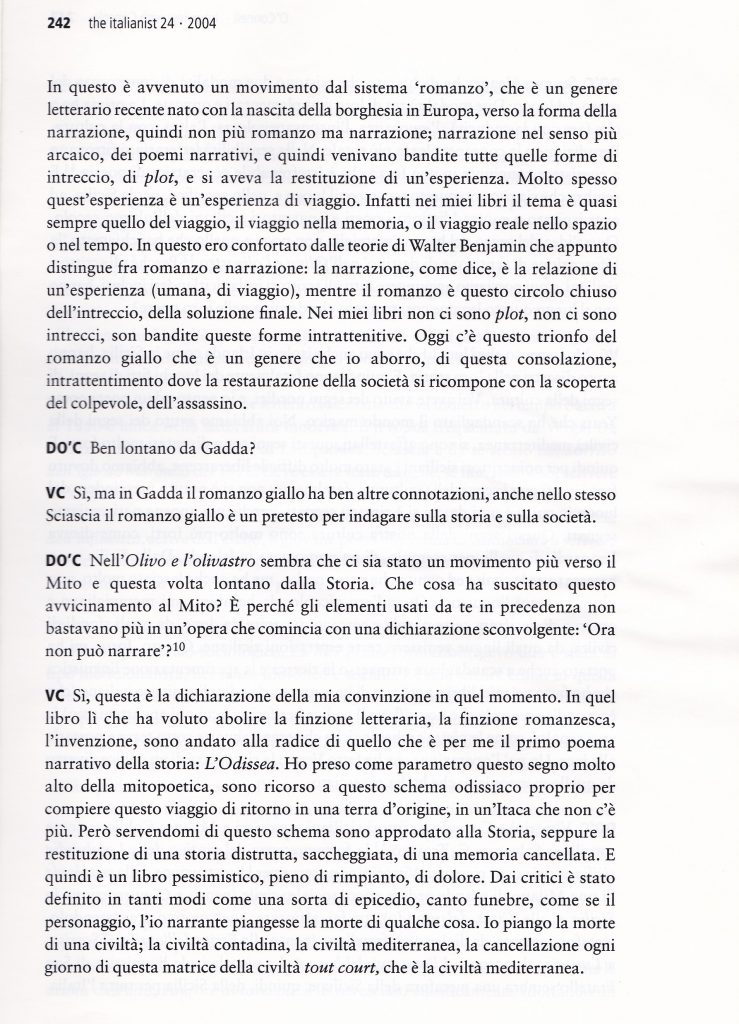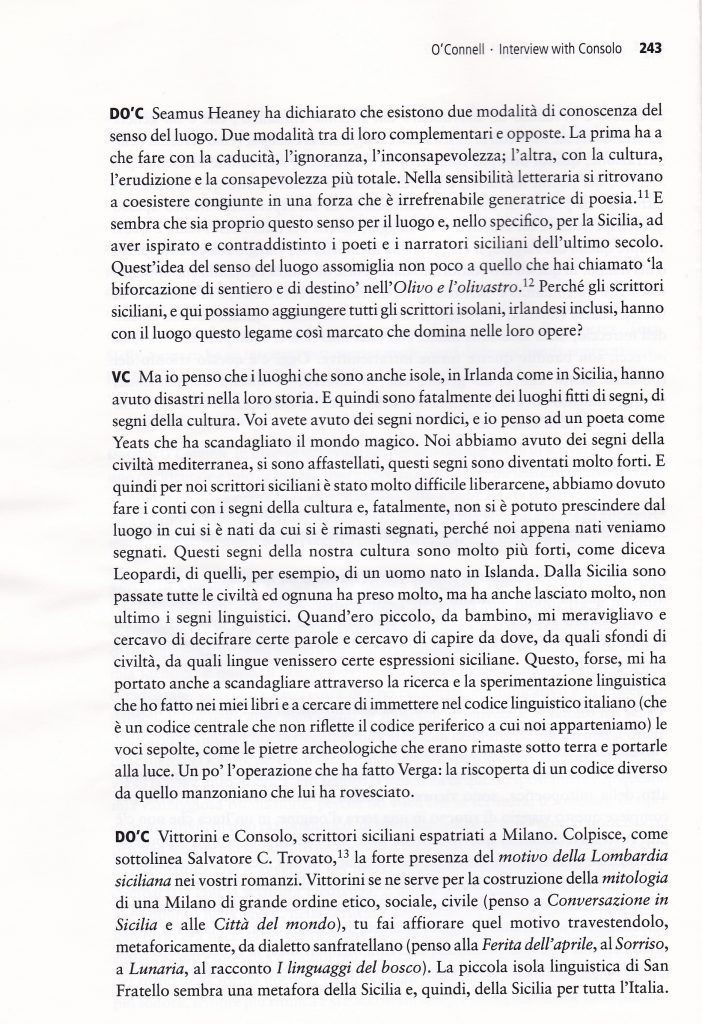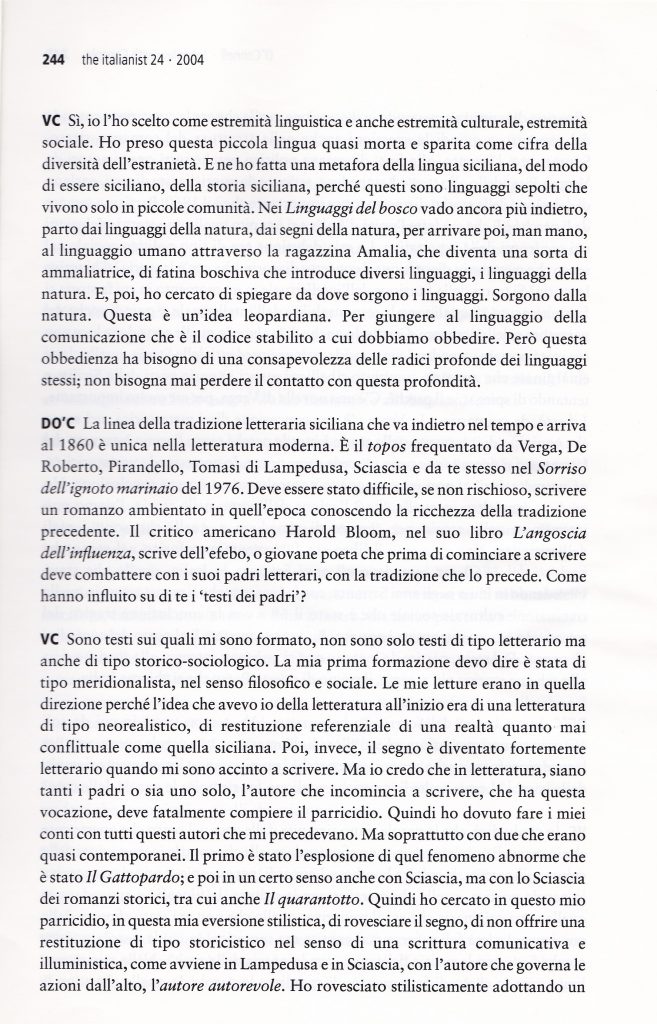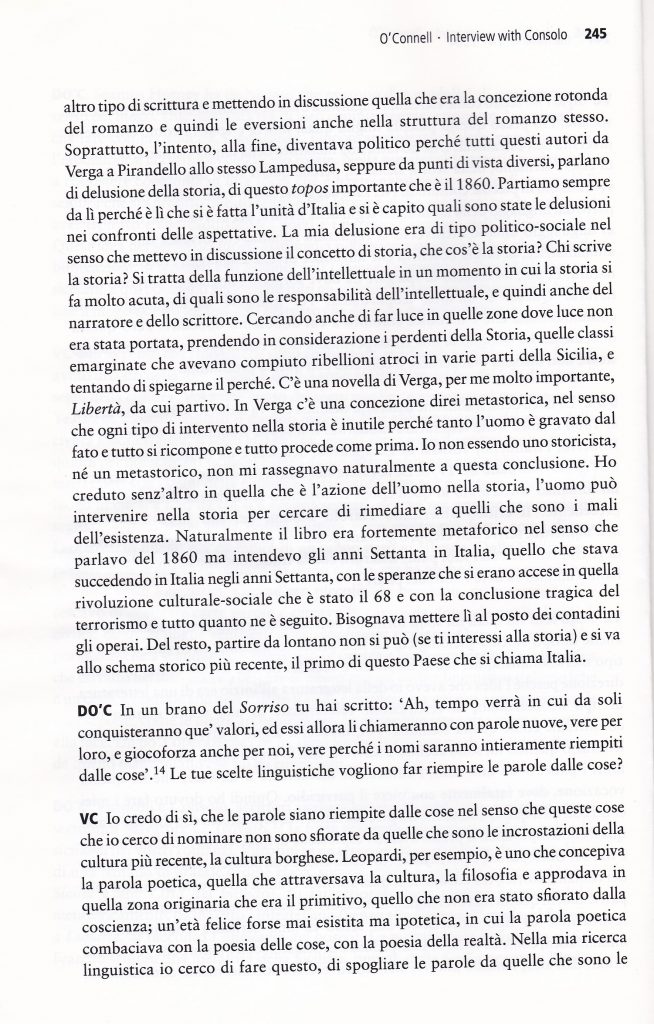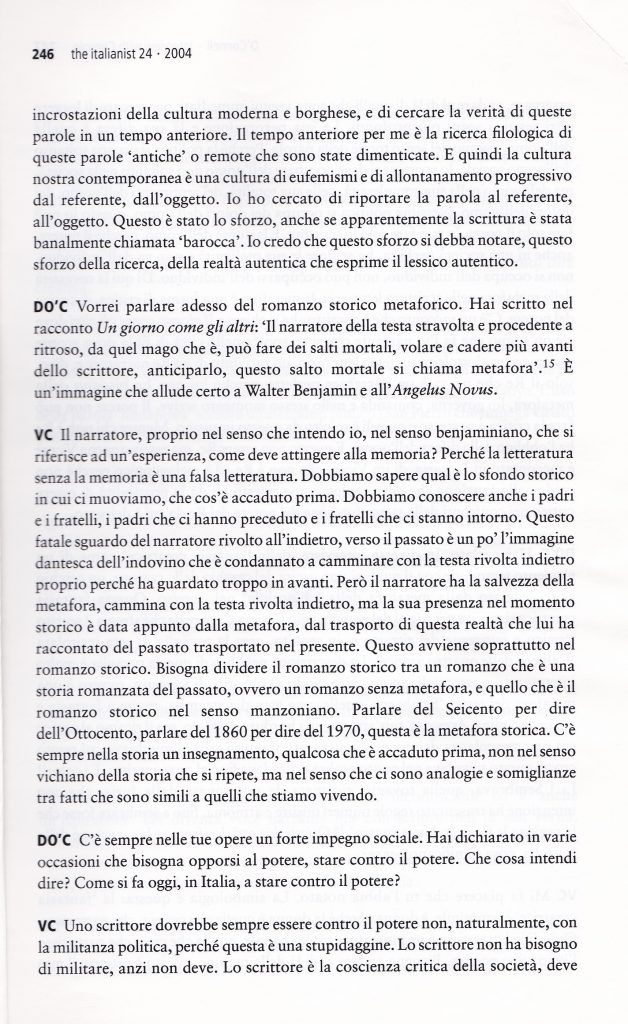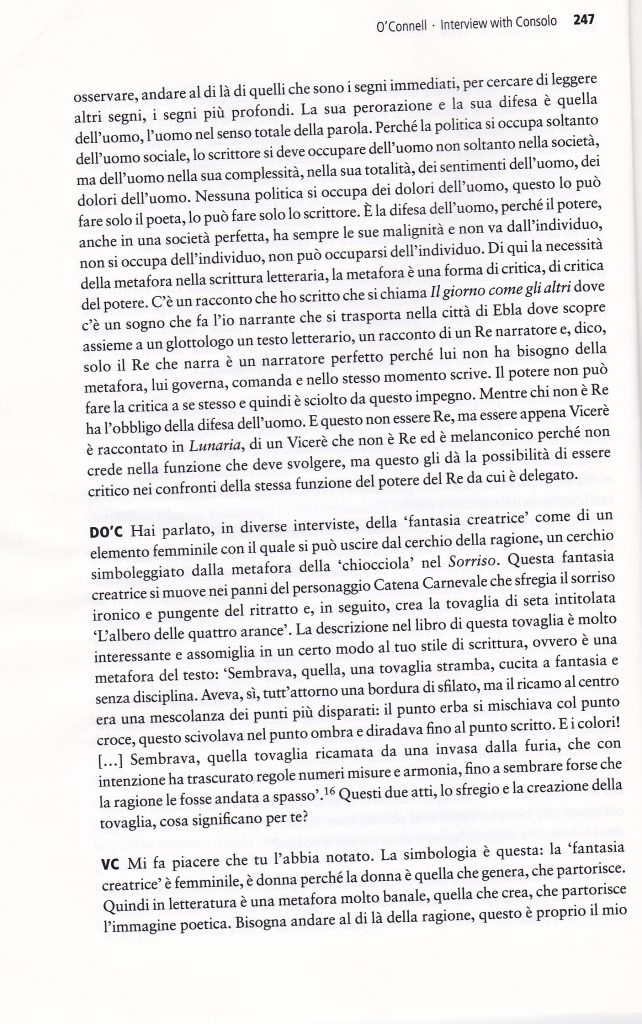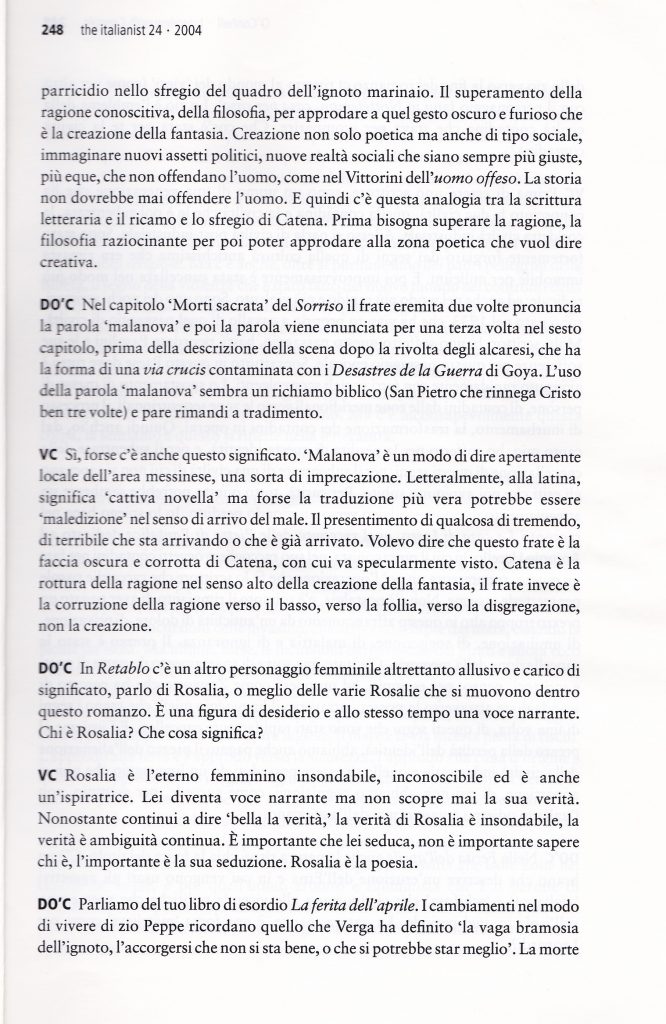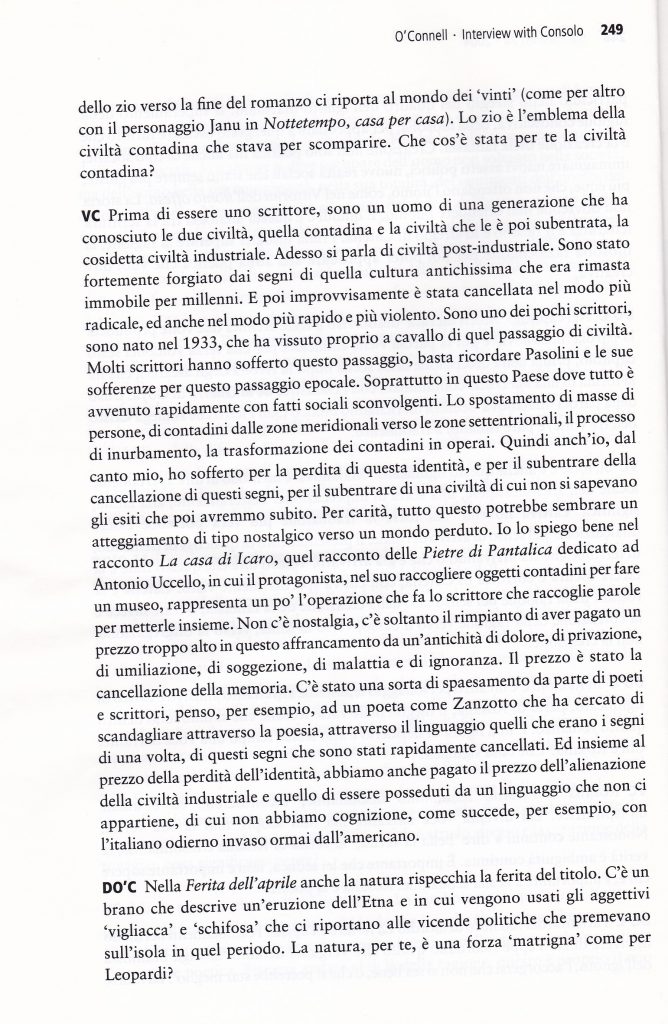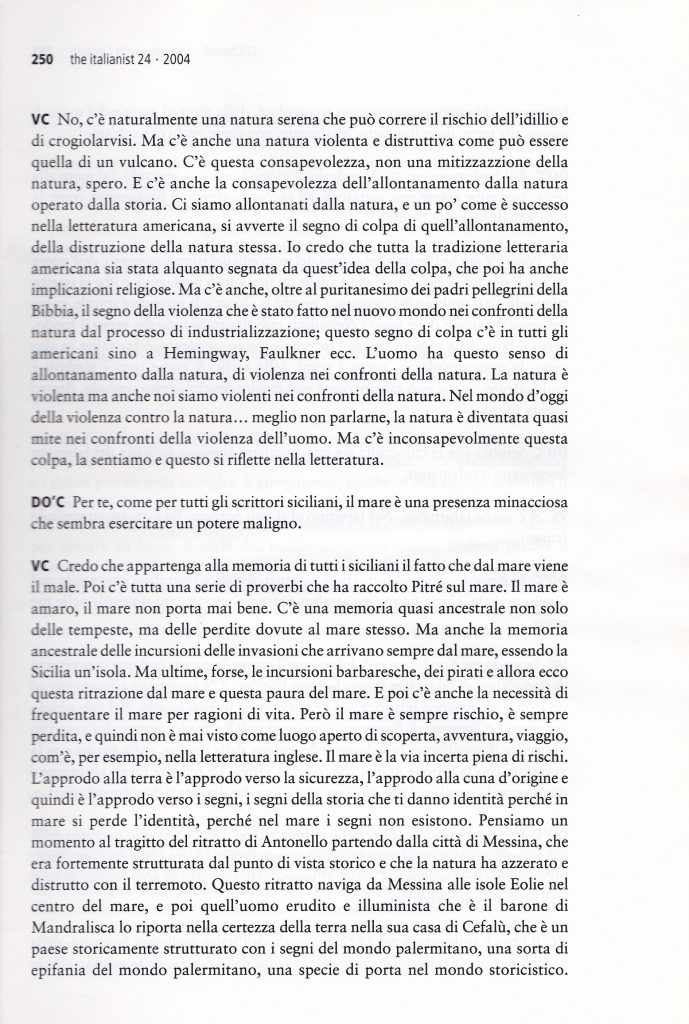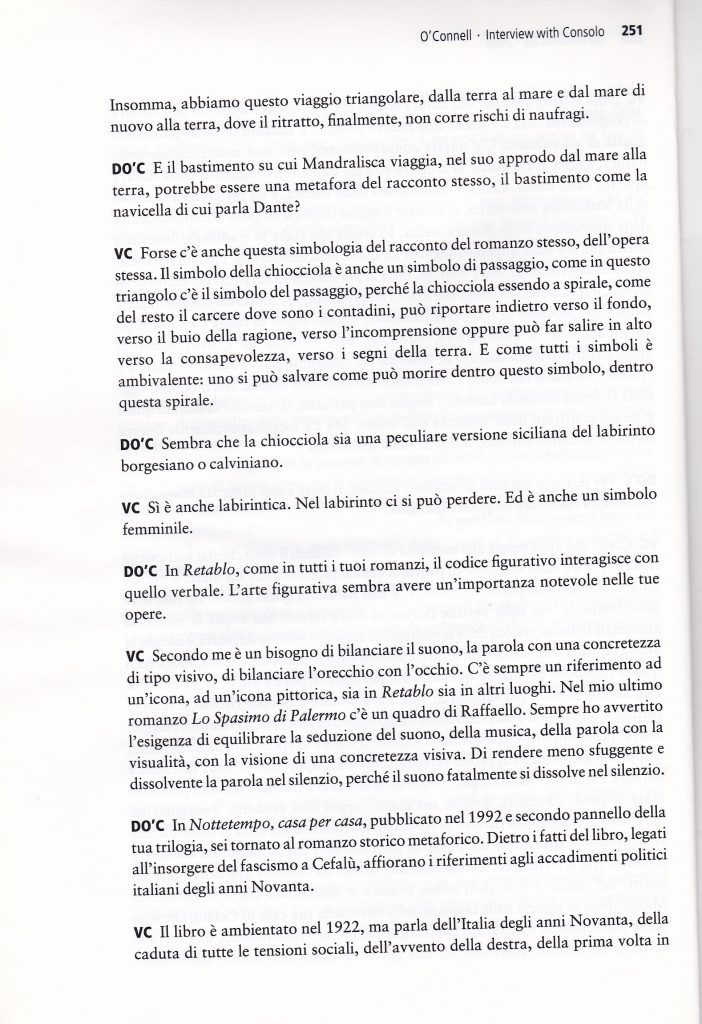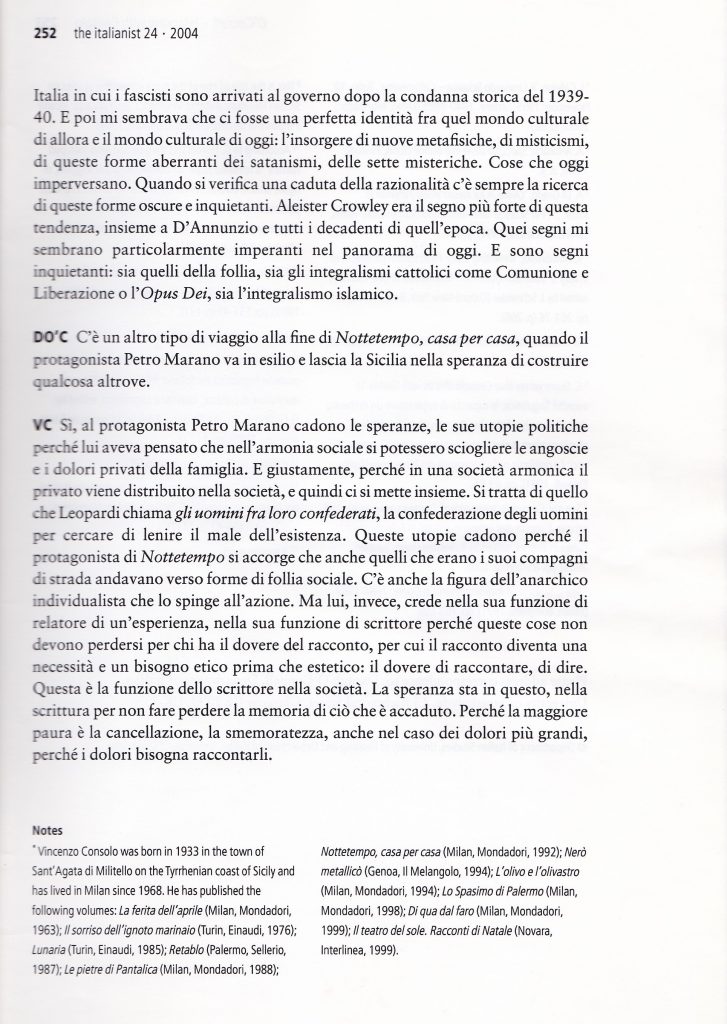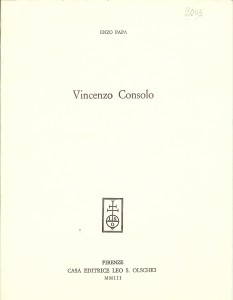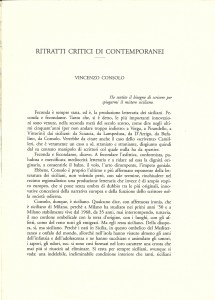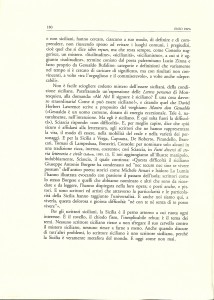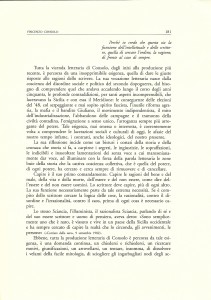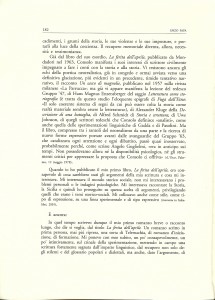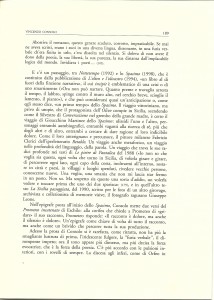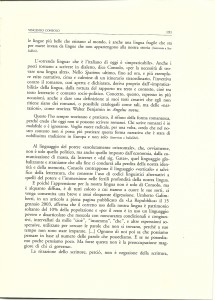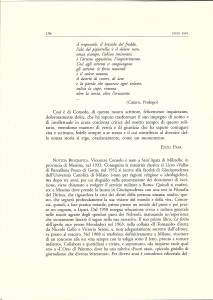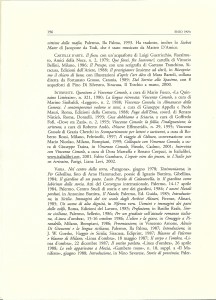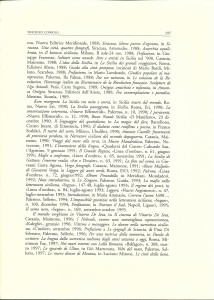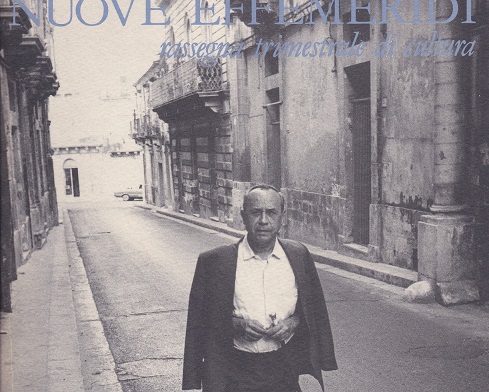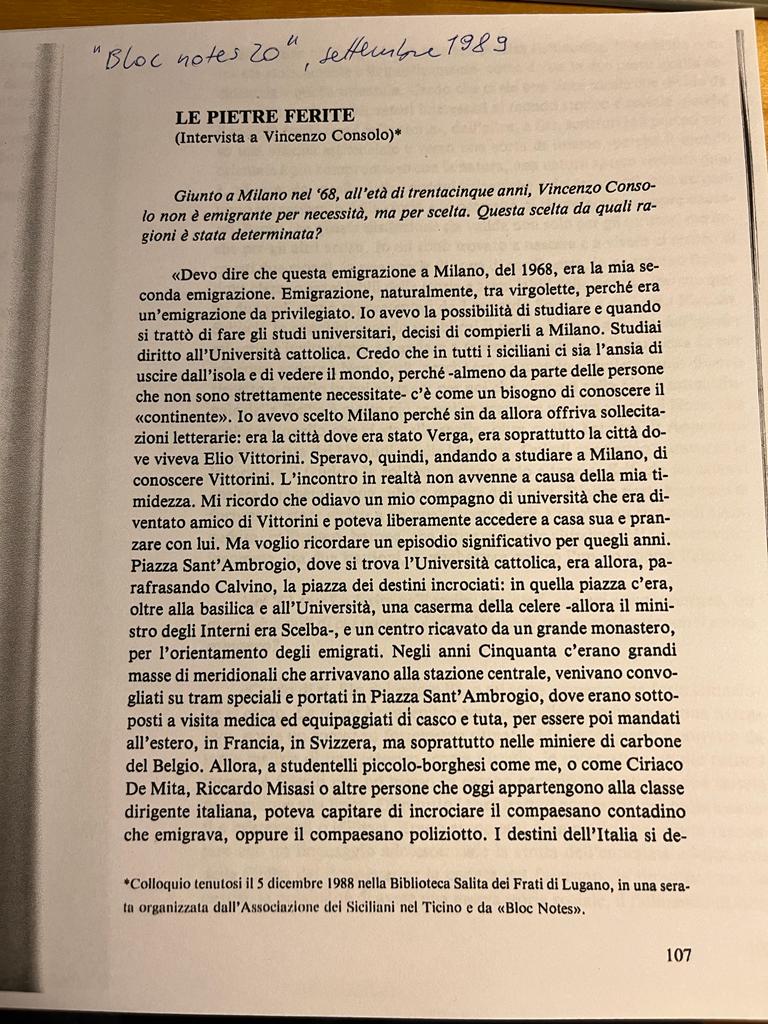Vincenzo
Consolo
Subito una citazione, un’epigrafe da porre
idealmente sul frontespizio di questo numero di Nuove Effemeridi dedicato a Leonardo Sciascia. È un azzardo la mia
scelta, perché lo scrittore, di sconfinata cultura e d’inarrivabile gusto, era
fra l’altro maestro delle epigrafi, delle citazioni, dei rimandi, delle
concatenazioni, degli infiniti echi letterari. Ma la mia epigrafe si giustifica
per il fatto di essere di Borges, uno degli scrittori più amati da Sciascia. È
una lirica, tratta da Fervore di Buenos
Aires, intitolata Rimorso per
qualsiasi morte:
“Libero dalla memoria e dalla speranza,
illimitato,
astratto, quasi futuro,
il
morto non è morto: è la morte.
Come il Dio dei mistici,
del
Quale si devono negare tutti i predicati,
il
morto ubiquamente estraneo
non
è che la perdizione e l’assenza del mondo.
Tutto
gli derubiamo,
non
gli lasciamo né colore né una sillaba…”
Rimorso per qualsiasi morte, rimpianto per
qualsiasi persona che non è più fra noi, con noi. Ma maggior rimorso e
rimpianto, è innegabile, quando quella persona era per tutti illuminazione e
insegnamento, coscienza ed esempio, probità e sapienza, fantasia e impegno…
Così com’era Leonardo Sciascia, come dovrebbero essere i veri grandi scrittori.
I quali non compaiono numerosi sulla scena della storia, e ancor più rari
diventano in questa nostra epoca in cui tutto congiura per far allontanare dal
mondo intelligenza e conoscenza, memoria e poesia.
L’antologia di scritti di Nuove Effemeridi, stesi al momento
emozionale della scomparsa dello scrittore, non è che un segno minimo – minimo
perché immediato – di ciò che quest’uomo per noi, per la nostra sfera
socio-culturale ha significato. Il tempo, il grande Tempo (“Che non consumi tu /
tempo vorace” scrivevano come epigrafe gli incisori di paesaggi con rovine), il
tempo confermerà, ahinoi, verità e grandezza alla sua opera, a quel prezioso e
generoso patrimonio che ci ha lasciato. Come ha dato, il tempo, l’orrore, lo
sgomento moderno della vita e della storia, verità e grandezza all’opera di
Kafka; come ha dato, il tempo, la crisi, lo smarrimento dell’identità
individuale e sociale, la perdita d’ogni certezza culturale e ideologica della
nostra epoca, sempre più verità e grandezza all’opera di Pirandello.
Difficile parlare delle tantissime voci che
affollano questa antologia. Voci italiane di amici, di estimatori, di consonanti
o di dissonanti con e dallo scrittore; e voci francesi, spagnole, tedesche,
inglesi. Tuttavia non possiamo esimerci dal fare qualche osservazione, qualche
commento brevissimo su alcune affermazioni contenute in questa preziosa
documentazione. Non siamo d’accordo con l’analisi di Moravia, su quel procedere
che egli vede in Sciascia, contrariamente al naturale processo illuminista o
razionalista, dalla chiarezza verso l’oscurità. Per noi è sbagliato enunciare
questa analisi senza aggiungere che il quai des brumes, il porto delle
caligini, l’approdo nell’oscurità e nel mistero non è di Sciascia ma del mondo,
della storia, del potere che muove la storia, e lo scrittore non fa che
rappresentarlo, che denunciarlo, così come Gadda rappresentava il barocchismo
del mondo.
Vogliamo sottolineare la limpidezza d’animo
e di mente, l’onestà personale e intellettuale che traspare dallo scritto di
Emanuele Macaluso. E ancora la fideistica, inscalfibile convinzione di un
critico letterario, peraltro fine, come Lorenzo Mondo, contro ogni prova
provata, ogni confessione e testimonianza giudiziaria dei protagonisti, contro
quanto sùbito intuito e sostenuto da Sciascia nel suo libro, che le lettere
scritte da Moro nella prigione delle Brigate Rosse non erano di testa e di mano
dello statista poi assassinato. Meglio non sottolineare invece, nel brano di
Enzo Forcella dal titolo Due facce della
medaglia, pubblicato da Repubblica,
il tipico coraggio che viene a certe persone, riproponendo una polemica ormai
sopita, nel momento in cui il sostenitore della tesi opposta viene a mancare ed
è quindi nell’impossibilità di controbattere. La polemica è quella nota su
Moro, sulla sorte di Moro. E se ne esce il giornalista, con una frase di
involontaria, cinica ironia. Dice con la sicumera che gli viene dall’alto del
potere del giornale per cui scrive: “Ma sul contrasto tra ‘intransigenti’ e
‘trattativisti’, avrebbe dovuto rendersi conto (Sciascia, naturalmente), proprio in nome della sua concezione laica
e problematica della vita, che si trattava di una decisione politica e come
tale opinabile”. Concezione problematica della vita
dice: e il problema era lì, proprio lì la vita di un uomo, di Aldo Moro, il
problema era quello di salvare quella vita, contro le strategie della politica,
contro la decisione del potere.
Ma torniamo all’intelligenza, di quella
della testa e di quella del cuore. Allora non possiamo non ricordare i lucidi
brani dei francesi, di Fusco, di Fernandez, di Bianciotti e di Schifano, che
sentono lo scrittore loro confratello di intelletto e di formazione, di metodo
e di stile. Come confratello di fantasia e di passione, familiare per natura e
per cultura lo sentono gli Spagnoli: Arias, Conte, Cruz, Gàandara, Savater,
Barràl.
E infine non possiamo non ricordare i
bellissimi brani degli amici, di quelli che da vicino, giorno dopo giorno,
hanno imparato a conoscere quest’uomo e questo scrittore e ad amarlo. Non
possiamo non ricordare il racconto straordinario dell’incontro, a Castellina in
Chianti, di Sciascia, la sua famiglia e Fabrizio Clerici, della scoperta, da
parte dello scrittore, nella chiesa accanto alla casa del pittore, del quadro
della tentazione di Sant’Antonio di Rutilio Manetti, che sarà certo l’esca che
incendierà il racconto Todo Modo e
che farà da copertina al libro.
Non possiamo dimenticare il tono commosso e
commovente delle parole di Elvira Sellerio, che con Enzo Sellerio e con
Sciascia e per Sciascia, ha creato qui a Palermo, in Sicilia, uno dei fatti più
straordinari e più memorabili di questi anni: la casa editrice Sellerio. Altro
non so dire, mi è difficile dire. Posso solo ora aggiungere, a queste pagine,
qualche mia pagina, scritta nel linguaggio che mi è più congeniale, più
agevole: quello memoriale, narrativo.
Viaggio a
Caltanissetta
Era l’ottobre del ’43 quando feci il mio
primo viaggio in Sicilia. Dico viaggio in Sicilia come se mi fossi mosso da
un’altra terra, da una qualche regione al di là dello Stretto, o al di là del
Faro, come si diceva una volta. E in effetti era, la zona da cui partivo, il
Val Demone, la Sicilia ai piedi della barriera appenninica dei Nebrodi e delle
Madonie, la Sicilia tirrenica, tutt’affatto diversa dall’altra, sconosciuta,
che si svolgeva al di là dei monti: la Sicilia delle grandi terre, dei grandi
altipiani, della nudità e della scabrosità, delle solitarie masserie, dei paesi
fittamente aggrumati sulle alture, dei cieli bassi, infiniti.
Su un camion sgangherato, io e mio padre, percorremmo strade dissestate dalla guerra (l’occupazione degli Alleati s’era conclusa a Messina verso la metà dell’agosto appena scorso), strade che si interrompevano sopra i torrenti e le fiumare dove i ponti, quasi tutti i ponti, erano stati fatti saltare (bisognava proseguire per alvei pietrosi, fangosi, polverosi o sopra fragili ponti di legno), strade con ancora ai margini carcasse di carri armati, di camion, di cannoni, d’altri ordigni: i segni della guerra erano ancora là, in quei simulacri squarciati e affumicati dei giorni bui e tremendi della storia. La nostra meta era l’interno dell’Isola, alla ricerca di frumento, di fave, di lenticchie (le famose lenticchie di Villalba) che da noi, terra di limoni e di olive, mancavano del tutto. Per quelle terre assolate e desolate, s’incontrava ogni tanto un contadino che con un cenno della mano ci invitava a fermarci per offrire, a noi viandanti, grappoli d’uva. Era ancora, quella, l’antica e nobile Sicilia contadina che neanche lo strazio della guerra era riuscita a cancellare.
Lasciato il bosco della Miraglia, per
Troina, Nicosia e Leonforte, dopo Vallelunga, Villalba e Mussomeli, arrivammo,
un tardo pomeriggio, a Caltanissetta.
Nella piazza Garibaldi, affollata di gente
(forse la stessa piazza dove, nell’alba silenziosa, alla partenza della
corriera, si diffondeva la voce “implorante e ironica” del venditore di panelle
di Il giorno della civetta), nella
piazza un uomo vendeva un giornale. “La forbice, La forbice!” strillava
l’uomo. Nella mia sapienza morfologica di diligente scolaro di terza
elementare, stigmatizzai dentro di me il dialettismo di quel nome di giornale
al singolare, non intuendone la sua valenza metaforica: Forbice come discussione critica, come fronda sui e ai fatti pubblici, i fatti nati nello spazio breve di
quella piazza, tra la Cattedrale e il municipio, e che riguardavano tutta la
comunità. Una conversazione pubblica e democratica subito ripresa dopo
l’interdizione del periodo fascista e l’interruzione della guerra.
Il mio secondo viaggio a Caltanissetta
avvenne alla fine di luglio del ’64 quando giunsi in treno dal mio paese in
questa città, con dentro ancora vivo il ricordo del primo viaggio di venti anni
prima, per incontrare Leonardo Sciascia.
Nell’isolamento e nella solitudine del
paese, nel vuoto storico d’una
zona
fortemente segnata dalla natura ma non dalla cultura, era grande la necessità –
al di là delle letture – di frequentazioni e di conversazioni, di confronti e
di verifiche, di consigli e di apprendimento.
Nell’imprevedibile gioco del caso, avevo
avuto la ventura, e la fortuna, dentro l’immobile vastità dello spazio e dentro
l’infinito scorrere del tempo, nella esigua geometria di quest’Isola e nel
tempo breve d’una vita umana, di trovarmi ad essere conterraneo e contemporaneo
di due grandi uomini, di un poeta e di uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo
Sciascia.
A causa della vicinanza, frequentai per
molto tempo il poeta di Capo d’Orlando. Ma, al di là della fascinazione e del
rapimento della poesia (e quella di Piccolo era particolarmente rapinosa; e il
poeta, il personaggio, straordinariamente affascinante e trascinante) sentivo
il bisogno, per difesa e forse anche per vocazione della prosa, d’una scrittura
scandita dalla logica, d’una narrazione sorto dalla realtà e dalla storia. La
prosa che avevo letto sulle pagine che giungevano dal cuore della Sicilia,
dalla piazza dove un giorno lontano avevo udito un uomo strillare un giornale
intitolato La Forbice, da questa
città, fra tutte in Sicilia crediamo la più carica e la più consapevole di e
della storia, della storia intendiamo come superamento, attraverso lo scontro
dialettico, delle carenze, degli squilibri di una comunità civile; la prosa, i
racconti che avevo letto nei libri – allora ancora pochi -, nuovi,
straordinari, straordinariamente ricchi di futuro, di Leonardo Sciascia.
Per conoscere questo grande scrittore e –
scoprii dopo – questo grande uomo, feci il mio secondo viaggio a Caltanissetta.
E dietro invito dello stesso scrittore, scaturito dalle fragili credenziali del
mio racconto, pubblicato nel ’63, a lui inviato e in cui, nella dedica, professavo
il mio debito ai suoi libri, al suo insegnamento, alla alta, civile sua conversazione in Sicilia.
Una
conversazione in Sicilia
C’è un testo importante nella storia della
letteratura italiana contemporanea, un testo che ha formato e a cui si è
conformata una generazione di scrittori: Conversazione
in Sicilia di Elio Vittorini.
Perché “conversazione”? Certo, conversazione
tra Silvestro e la madre Concezione, tra Silvestro e il fratello morto, tra
Silvestro e il panniere, l’arrotino e tutti i personaggi che il protagonista
incontra nel suo viaggio nella terra dell’infanzia, nella sua discesa agli
“inferi”; “conversazione” anche, crediamo, come memoria di domenicali piazze
siciliane ferventi di brulichio e brusio, al pari di alberi che, in certe ore
della giornata, sono invasi da nugoli di uccelli (la piazza del bel paese di
Nicosia e la piazza di Caltanissetta, affollata di uomini in tabarro e coppola,
che Vittorini farà fotografare a Luigi Crocenzi per l’edizione illustrata del
1953 del suo romanzo); ma “conversazione” ancora come riferimento culturale:
alle sacre conversazioni di tanta
pittura italiana, e soprattutto, pensiamo, alla conversazione “dentro” la Flagellazione di Piero della
Francesca, su cui ha indagato Carlo Ginzburg. Il quale scrive: “La scena della
flagellazione di Cristo è immediatamente riconoscibile, ma si svolge in secondo
piano e lateralmente. Una grande distanza, resa da Piero con maestria
prospettica straordinaria, separa il Cristo da tre misteriosi personaggi in
primo piano”. I tre personaggi, che regalano in secondo piano la scena sacra,
conversano, e sembra, la loro, una conversazione filosofica.
Ora,
al di là della identificazione dei tre personaggi e del significato da dare a
tutta la scena, ci sembra importante questo spostamento di piano dal sacro al
profano, dal divino all’umano, dal dramma alla speculazione.
Nella Conversazione
di Vittorini c’è anche, attraverso il dispiegamento dei dialoghi, che
tendono, come dice Calvino, “a realizzare una comunicazione assoluta, una
convivenza umana ideale”, c’è anche questa intenzione, questo tentativo di
uscire dal divino e approdare all’umano, uscire cioè dal mito e approdare alla
realtà, dalla natura alla storia, dal passato al presente, dalla memoria alla
contingenza, dalla immobilità all’azione: infine, dal simbolismo alla metafora.
Non ci interessa qui stabilire fino a che punto Vittorini ci sia riuscito, fino
a che punto la “conversazione” releghi in secondo piano il mito senza fratture
prospettiche, senza volontaristici scarti, fino a che punto sia piuttosto la
sua un’uscita dal mito per approdare all’utopia (che si mostrerà poi in tutta
evidenza ne Le città del mondo);
utopia che, oltre ad essere un progetto chiuso, conservativo, come ci avverte
Lewis Mumford, è ancora mito, mito del futuro speculare a quello del passato,
destinato anch’esso a infrangersi contro gli scogli della storia.
Vittorini aveva scritto Conversazione anche, crediamo, contro la
concezione deterministica, antistorica verghiana, contro il 2mito2 letterario
di Verga (non è stato Sklovskij a dire che la storia della letteratura è una
successione di uccisioni di padri?).
A piazze siciliane, accennavamo sopra.
Quelle praticate da Vittorini e dai vittoriniani, le piazze dei paesi della
parte orientale dell’Isola, del Messinese, del Catanese, del Siracusano o del
Ragusano, sono quasi sempre piazze “belle”, ricostruite, dopo un qualche
disastro della natura – eruzione di vulcano o terremoto -, secondo un progetto
e con un’aspirazione alla bellezza e all’armonia (le piazze barocche) o sono
“spiazzi” di sperduti villaggi contadini o di masserie, luoghi privi di segni
storici, assolutamente “naturali”. Le
“conversazioni” allora, in quelle piazze e in quegli spiazzi, si scostano man
mano dalla comunicazione e tendono verso l’espressione, si formalizzano, si
stilizzano, abbandonano man mano il rigore logico della prosa e si spostano
verso i fraseggi del canto, i ritmi della poesia. Le piazze dell’Occidente siciliano, e
soprattutto quelle della zona delle zolfare, del Nisseno e dell’Agrigentino, al
contrario, sono piazze “brutte”, nate senza un progetto architettonico, ma
spontaneamente da una necessità, dove gli edifici, non più in arenaria dorata
come a Noto, a Scicli o a Siracusa, sono in grigiastra pietra gessosa. In queste piazze di paesi agrigentini dello
zolfo, come Grotte o Racalmuto, dove alla vecchia cultura contadina s’era
sostituita la nuova cultura operaia dei minatori, la “conversazione” nasce da
una necessità sociale, si svolge nel modo più secco e disadorno, più diretto e
chiaro, più logico e dialettico. Ci è
capitato di affermarlo più volte e con noi il critico Claude Ambroise: se non
si può capire uno scrittore come Pirandello senza la realtà della zolfara,
tanto meno si può capire uno scrittore come Leonardo Sciascia (ché lui ha mosso
questo nostro discorso partito da lontano), questo scrittore letteratissimo e
antiletterario, antimitico e antilirico, loico e laico, civile e “politico”,
questo grande scrittore da poco scomparso.
Tutta l’opera di Sciascia è una necessaria,
essenziale, lucida e serrata – anche se man mano sempre più disperata – conversazione in Sicilia. Una conversazione, questa volta sì, che tende
“a realizzare una comunicazione assoluta”, una convivenza sociale, piuttosto
che ideale, vale a dire utopica, più giusta, vale a dire più umana: una
convivenza dove nessuno, individuo, Stato, o potere d’ogni tipo, politico, giudiziario,
religioso o finanziario deve infrangere le regole della convivenza sociale,
deve offendere il cittadino, l’uomo. Una
conversazione che ha le sue radici nel profondo della miniera, che dal profondo
emergendo, come Ciàula che scopre la
luna, nonché trovare conforto nella “chiarità d’argento”, trova forza nella
luce diurna della ragione: luce solare, cruda, che, come in un quadro di
Picasso, scandisce i piani e rivela la natura cubica della realtà.
Con Sciascia, la società ideale e utopica è
posta “in secondo piano e lateralmente”; la conversazione, per consapevolezza
storica e per pratica della realtà distanziata “con maestria prospettica
straordinaria” dagli assoluti, si svolge intorno al relativo e al contingente.
È stato detto più volte, e lo dice lo stesso
Sciascia, che tutta la sua “poetica” – e usiamo la parola nel senso
etimologico, nel senso cioè del fare – è contenuta nel primo libro: Le parrocchie di Regalpetra. E in
effetti lì si trovano tutti i temi che Sciascia svilupperà negli altri suoi
libri. E vogliamo osservare qui che è raro trovare in un autore, sin dagli
esordi, una così sicura scelta di campo, di campo letterario, e ad essa
rimanere fedele; trovare un tono, un linguaggio, una scrittura così impostata
sin dall’inizio, così certa e inconfondibile. Per quest’ultima, Sciascia stesso
scrive: ”non ho mai avuto problemi di espressione, di forma, se non subordinati
all’esigenza di ordinare razionalmente il conosciuto più che il conoscibile e
di documentare e raccontare con buona tecnica (per cui, ad esempio, mi importa
più di seguire l’evoluzione del romanzo poliziesco che il corso delle teorie
estetiche)”. Per quanto riguarda i temi, scrive ancora: “Tutti i miei libri in
effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del
passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una
continua sconfitta della ragione e di colore che nella sconfitta furono
personalmente travolti e annientati”. Un
unico libro sulla Sicilia, dunque: partendo, come nell’esordio, sempre da Regalpetra, da Racalmuto. Da Racalmuto
snodando quel filo ad alta tensione che attraversa la Sicilia, l’Italia, tutto
il contesto socio-culturale in cui si trova immerso il destinatario della sua
narrazione o del suo ragionamento. Dove si trova il suo interlocutore.
Ora, c’è un luogo in Regalpetra, un luogo
privilegiato da cui si osserva la realtà sociale, in cui di essa realtà si
conversa: il Circolo della Concordia.
Concordia come sanzione della ricomposizione di una discordia: nel 1866 il
circolo era stato bruciato dalla popolazione che vedeva nei civili, nei nobili
degli antagonisti, dei dispensatori di ingiustizie. Un circolo quindi non come luogo di scontro emozionale ed
irrazionale, come oggetto di violenza, ma come luogo di conversazione, di
scontro dialettico, come immagine, come rappresentazione e teatro della
democrazia parlamentare: il migliore dei sistemi possibili di convivenza
civile. Nel circolo lo scrittore sta ad osservare e ad ascoltare, nel circolo e
del circolo conversa lucidamente, criticamente, ironicamente; del circolo
registra le vicende, le involuzioni e le evoluzioni, i periodi di apertura
democratica e di chiusura.
Il patto concordatario su cui si fonda il
circolo, lo stato democratico, viene violato quando, chi ha la responsabilità
della sua gestione (individui, organi o gruppi di potere), agisce contro lo Statuto: da cui i temi sciasciani del
potere politico e del potere giudiziario degenerati, il tema di organizzazioni
criminali come la mafia che minano lo statuto. E da qui, quando alla
degenerazione segue l’omicidio (il massimo dell’infrazione sociale perché viola
il primo e sommo principio del patto sociale: il rispetto della vita umana), da
qui l’interesse di Sciascia per il romanzo poliziesco, la narrazione di più
alto valore civile. Perché l’indagine
poliziesca non è che il tentativo di ricucire i fili dello strappo, operato nel
tessuto sociale, attraverso l’individuazione e la condanna del colpevole. Ma
così non vanno le cose in Sicilia, in Italia, dove l’omicidio non è che
l’ultima manifestazione di una serie di delitti che il potere politico
degenerato mette in atto attraverso quel suo braccio armato che è la mafia. L’individuazione dell’assassino o degli
assassini comporta l’individuazione dei mandanti, comporta l’indagine del
potere su se stesso (come in quel romanzo giallo di Fernand Crommelynck che si
chiama Monsieur Larose est-il l’assasin?),
la messa sotto accusa di se stesso e la sua condanna. Nei gialli di Sciascia
dunque gli assassini non sono quasi mai individuati e mai puniti perché vi si
tratta di delitti politici, perché i suoi sono gialli politici.
Tra il ’61 e il ’74 Sciascia pubblica
quattro romanzi gialli: Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il
contesto, Todo Modo. Attraverso essi si può vedere la storia dell’Italia di
quegli anni, il processo di degenerazione del potere politico e degli organi
dello stato parallelamente all’evolversi e all’ingigantirsi di quel fenomeno,
di quel cancro della società civile che è la mafia, che sul corpo dello stato
sembra aver operato la sua metastasi.
Dei quattro, il libro di più alta tensione
politica e letteraria ci sembra Todo Modo (“Todo modo è destinato a entrare
nella storia letteraria del Novecento come uno dei migliori libri di Sciascia”,
scriverà Pasolini). In quel libro lo
scrittore va al cuore del potere politico in Italia, al cuore del potere di un
partito; alla matrice metafisica a cui il partito si ispira e da cui deriva il
suo potere; e nel momento critico in cui i più alti rappresentanti di quel
potere manifestano la loro fede nella metafisica attraverso gli esercizi
spirituali. Ma tutto il romanzo, come nella realtà, è rovesciato: la metafisica
del bene diventa la metafisica del male; il Diavolo prende il posto di Dio; gli
esercizi spirituali diventano esercizi criminali.
Il testo è ricchissimo di intertestualità,
di riferimenti, di significati espliciti e impliciti. Il personaggio narrante,
un pittore, è “nato e per anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi
pirandelliani – al punto (dice) che tra le pagine lo scrittore e la vita che
avevo vissuto fin oltre la giovinezza non c’era più scarto, e nella memoria e
nei sentimenti)”. Parte dunque da Agrigento, da Racalmuto la narrazione. E da
qui il protagonista, uomo solo – ripercorrendo à rebours tutta una catena di casualità e riapprodando all’infinita
possibilità musicale di certi momenti dell’infanzia, dell’adolescenza, appunto
con la frase o tema musicale di Giacomo De Benedetti nella mente – compie un
suo atto di libertà e parte.
Ma occorre qui citare il passo che Giacomo
De Benedetti scrive riguardo al mondo pirandelliano e da cui Sciascia muove per
iniziare la sua narrazione: “A somiglianza di una celebre definizione che fa
dell’universo kantiano una catena di casualità sospesa a un atto di libertà, si
potrebbe riassumere l’universo pirandelliano come un diuturno servaggio in un
mondo senza musica, sospeso ad una infinita possibilità musicale: all’intatta e
appagata musica dell’uomo solo”. Parte dunque, dicevamo, il protagonista di
Todo Modo, e dopo tre giorni di vagabondaggio in macchina, arriva all’eremo di
Zater. Qui la possibilità musicale è fermata dal frastuono di un concerto di
pallottole, tonde e levigate come quelle parole per tre volte iterate da
Sant’Ignazio nella Primera anotaciòn
dei suoi Esercizi Spirituali: “Todo
modo, todo modo, todo modo […] para buscar y hallar la voluntad divina…”:
esercizi, metodo, iniziazione, portano verso il cammino della noche oscura, la teologia mistica, la
contemplazione. Vogliamo qui subito soffermarci sulla frase à rebours. A rebours ci richiama alla mente il titolo del famoso romanzo di
Huysmans, il padre della letteratura decadente francese, autore anche di Làbas, dove “esplora le provincie più
tenebrose e remote del satanismo”, come dice Praz. Non siamo, come si vede, nel
cattolicesimo di Manzoni o di Pascal, ma in quello decadente e decaduto (anche
a livello stilistico o linguistico) che porta all’oscurità, alla disgregazione,
all’annientamento; porta sulla zattera
della Medusa; perché, dice don Gaetano, il deuteragonista, “il naufragio
c’è già stato” e il secolo, il mondo, per i cattolici, “è l’orlo dell’abisso:
dentro e fuori di noi. L’abisso che invoca l’abisso”.
Mai, come in questo libro, la struttura
gialla del racconto si è attagliata
All’argomento,
dialetticamente, come costruzione razionale contro la disgregazione della
ragione, l’indagine contro lo sgomento, la memoria contro l’oblio, la cultura
contro l’ignoranza, il logos, la parola contro l’inesprimibile, il silenzio. Ma
è questo, al contempo, il giallo più misterioso di Sciascia, dove cioè non è
più possibile l’individuazione dell’assassino perché la ragione indagativa si
arresta davanti al muro della metafisica: metafisica religiosa e metafisica del
potere. Allora siamo, qui si, sulla zattera
della Medusa dove può esplodere il cannibalismo, ma siamo anche nell’ambito
letterario, l’unico dove ancora si può “immaginare e fare”, dove l’autore o
l’io narrante, in un gesto di libertà e di liberazione, come quello del gidiano
Lafcadio, può assurgere ad angelo sterminatore, angelo giustiziere.
In Todo
modo, come in altri libri di Sciascia, ci sono come delle anticipazioni
(profezie sono state chiamate) di fatti che nella realtà puntualmente
accadranno, sono accaduti. Todo modo
dunque anticipa fatti e genera necessariamente altri due libri: Candido (1977) e L’affaire Moro (1978).
Per quanto riguarda Candido, c’è in Todo modo come
l’autocitazione, se pure antifrasticamente, di un libro a venire. Dice il
narratore: “E forse si possono oggi scrivere tutti i libri che sono stati
scritti; e altro non si fa […] Tutti. Tranne Candide”. I fatti, i fatti italiani, costringeranno invece il
nostro scrittore a riscrivere anche Candide:
Candido – ovvero un sogno fatto in
Sicilia. Quei fatti che lo costringeranno a scrivere anche, dolorosamente,
pietosamente, di quel morto ammazzato sulla
zattera della Medusa che è stato Aldo Moro.
L’affaire Moro, la militanza politica e
l’impegno civile al Parlamento italiano di Sciascia, che si conclude con la sua
stesura della relazione di minoranza della commissione parlamentare sul “Caso
Moro”, sembrano segnare una svolta nell’itinerario letterario di Sciascia. Lo
scrittore sembra
rinunziare
alla narrazione, al racconto cosiddetto “puro”. Rinunziare alle sue celebri e
magistrali narrazioni “gialle” o poliziesche che leggevano, interpretavano o
divinavano la realtà politica e civile contingente e futura. Il mondo, il mondo
civile sembra dire lo scrittore, si è fatto così tenebroso, così orrendamente e
indecifrabilmente antisociale e criminale che non è più possibile, stando nella
piazza, al circolo, alla luce del sole, alcuna narrazione che possa
rappresentarlo e interpretarlo. A meno che, con mortale rischio morale, non si
voglia scendere nei giardini sotterranei, nei bui meandri del potere di
misteriose e criminose sette di balzachiani Devorants.
I cultori della romanzeria, i fanatici
della letterarietà rimproverano allo scrittore la sua ritrazione, la sua
rinunzia al romanzo sull’attualità, imputando questa ritrazione, piuttosto che
a nobile inquietudine, a crisi morale, a una banale stanchezza artistica o
espressiva. Invece, dal ’78 in poi, l’attività letteraria di Sciascia, al di
fuori e contro la cosiddetta narrazione pura, è quanto mai fervida e ricca di
frutti. Il suo ritorno alla narrazione di tipo storico, come Dalle parti degli infedeli o Il teatro della memoria, La strega e il capitano o Una sentenza memorabile, 1912+1 o Porte aperte, il suo ritorno alla saggistica con Nero su Nero, Cruciverba, Stendhal e la Sicilia o Alfabeto pirandelliano; la sua ricognizione memorabile come Kermesse o Occhio di capra segnano le punte più alte dell’intelligenza, della
sapienza e, perché no?, della poesia, l’aspra poesia di Leonardo Sciascia.
Nel decennio tra il 1979 e il 1989, mentre
lo scrittore si rifugiava nelle sue narrazioni storiche, nei suoi saggi e nelle
sue memorie, sembrava che il cancro, contemporaneamente, continuasse a divorare
parallelamente l’uomo. Il cancro dell’uomo si faceva metafora del cancro della
società e viceversa.
Parlavamo sopra di solitudine e di
disperazione dello scrittore (ma che ha sempre sperato nella forza della
ragione, nella funzione della scrittura), solitudine e disperazione che sono
evidenti (è la parola giusta) negli ultimi suoi due racconti: finale e
struggente passo d’addio; estremo, sottile e tragico ritorno al racconto: Il cavaliere e la morte e Una storia semplice.
Evidenti attraverso due citazioni
iconografiche: rispettivamente di Dürer e di Klinger. Amava le incisioni,
Sciascia, le gravures (e i due termini,
l’italiano e il francese, certamente per lui si caricavano di altro
significato), e amava soprattutto le acqueforti e le puntesecche (ancora altri
termini significativi) che, con il loro segno nero, si potevano accostare alla
scrittura; una scrittura che, passando dal negativo della lastra inchiostrata
al positivo del foglio bianco, portava in sé una componente di imprevisto,
poteva acquistare altro senso al di là delle intenzioni, e della mano,
dell’artista. Era per lui, l’incisione, l’affascinante scrittura iconica più
simile alla scrittura segnica, l’acquaforte più simile allo scrivere: allo
scrivere che è “imprevedibile quanto il vivere”.
Una famosa incisione del Dürer fa da leitmotiv a Il cavaliere e la morte. “Si era ormai abituato ad averla di
fronte, nelle tante ore d’ufficio. Il
cavaliere, la morte e il diavolo. Dietro, sul cartone di protezione,
c’erano i titoli, vergati a matita, in tedesco e in francese: Ritter, Tod und Teufel; Le chevalier, la mort ed le diable. E
misteriosamente: Christ? Savonarole?
Il collezionista o il mercante che si era interrogato su quei nomi pensava
forse che l’uno o l’altro Dürer avesse voluto simboleggiare nel
cavaliere?”. Queste considerazioni
sull’incisione di Dürer sono del protagonista del racconto, Vice (questore),
condannato a morire da una inesorabile malattia, ma ucciso prima dal potere
politico-mafioso. Quel cavaliere del Dürer (inciso dall’artista
tedesco insieme al San Gerolamo nello
studio e alla Melanconia I tra il
1513 e 1514: le tre incisioni maestre sono state chiamate) ha suscitato pagine
di riflessioni, suggestive interpretazioni al grande critico Panofsky, ha dato
modo all’italianista Lea Ritter Santini (Le
immagini incrociate) di rimandare a tanti scrittori, filosofi che con
quell’immagine si sono incontrati: Nietzsche, Mann, Hofmannsthal, D’Annunzio…
Per noi quel cavaliere del Dürer, insidiato dalla Morte e dal Diavolo, che solido dentro la sua armatura, sicuro in
groppa al suo robusto cavallo procede solitario verso la turrita città in cima
alla lontana collina, la città ideale o d’utopia che mai raggiungerà, rimanda a
un altro cavaliere, al Cavaliere
disarcionato di Max Klinger: l’uomo è a terra, schiacciato dal corpo del
suo cavallo, inerme anche per la spada (la penna) che gli è caduta di mano,
solo e moribondo in mezzo alla foresta, un nugolo di neri corvi che gli
volteggiano sopra, pronti a ghermirlo. L’inquietante Max Klinger (un Klinger
che ha letto Poe e che è stato letto da Hitchcock), Sciascia cita nel suo
ultimo racconto il congedo, Una storia
semplice : “L’interruttore. Il guanto. Il brigadiere nulla sapeva, né
l’avrebbe apprezzata, di una famosa serie di incisioni di Max Klinger appunto,
intitolata Un guanto, ma nella sua
mente il guanto del commissario trascorreva, trasvolava, si impennava come
allora nella fantasia di Max Klinger”.
Non un guanto ma, come per
traslitterazione, neri uccelli volteggiavano sopra quel cavaliere disarcionato
che sta per morire, che muore. I neri uccelli del potere, fra cui, il più
sinistro e il più famelico o divorante, un goyesco “buitre carnivoro”.
Sorvolando sopra quei corvi e
quell’avvoltoio, anche se non siamo dotati di ali, consideriamo qui la caduta del
cavaliere lungo il cammino verso la città “relegata in secondo piano”, verso la
città ideale. Consideriamo la sua
grande, civile, generosa conversazione intrattenuta con noi, per noi, e ora
interrotta. Ma nel suo silenzio, come nel silenzio di tutti i veri scrittori e
veri poeti che ci hanno lasciati, se non vogliamo essere sopraffatti e storditi
dal chiasso del mondo, cerchiamo di risentire le sue parole. Cerchiamo di non
dimenticarle. Parole limpide, di luce, che ci giungono dalla periferia
dell’Europa, dal cuore di un’isola sperduta e perduta; parole sorte tra uomini
neri, che odorano di zolfo.
“Una nave
di malinconia apriva per me vele d’oro, pietà ed amore
trovavano
antiche parole”.
Così Sciascia in una lirica della sua
giovinezza.
Questo testo è stato letto il 5 aprile allo Steri di Palermo in occasione della presentazione del n. 9 di “Nuove Effemeridi”, interamente dedicato alla figura e all’opera di Leonardo Sciascia.