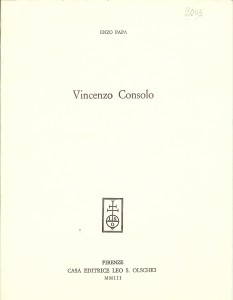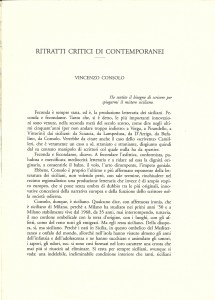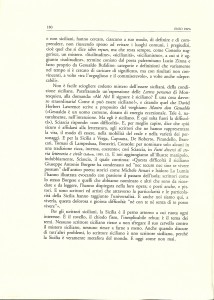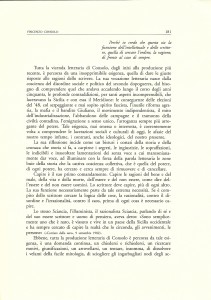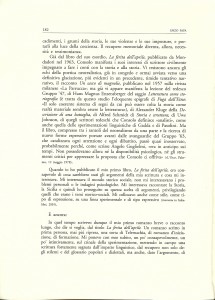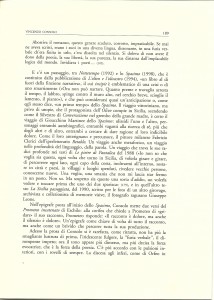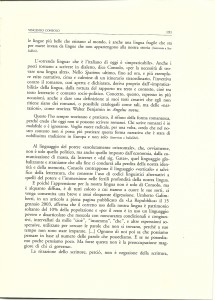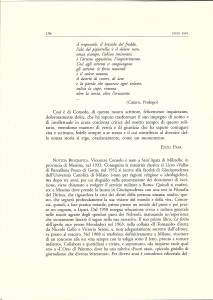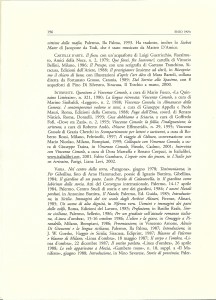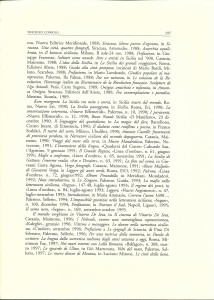Categoria: Rassegna stampa
Vincenzo Consolo, Cochlias Legere
Nello spirito informale di questo convegno preferisco esprimere pensieri “spettinati”, come diceva il polacco Stanislaw Jerzy Lec. Le mie esperienze di letture infantili sono state profondamente diverse da quelle ricordate da alcuni dei relatori di oggi. Non ho avuto l’opportunità di incontrare personaggi straordinari, professori, scrittori nell’estrema provincia siciliana in cui sono cresciuto. Sono vissuto nel vuoto, in una solitudine assoluta sino a un’età matura. Nessuno, durante l’infanzia, mi ha letto I promessi sposi e tanto meno La Divina Commedia. Anzi, mio padre, che era un piccolo borghese commerciante con otto figli, e con l’assillo di mantenerli decorosamente, non concepiva proprio che al mondo ci fossero dei libri. Io dormivo in una stanza accanto a quella dei miei genitori, la sera da ragazzino, leggevo con un’abat-jour accesa fino ad ora tarda, clandestinamente. Mio padre vedeva filtrare la luce sotto la porta della sua stanza, allora si alzava e veniva a spegnerla. Non lo faceva per avarizia, ho capito solo dopo che questo bambino che leggeva era per lui motivo di inquietudine. Vedeva in me un deviante, probabilmente si chiedeva «ma questo chi è? di che razza è uno che legge?». Naturalmente mi voleva uomo pratico, commerciante come lui, o magari piccolo industriale, perché l’ambizione del mio clan – la famiglia Consolo era una sorta di clan – era quella di diventare piccoli industriali dell’olio. Quindi questo ragazzino che leggeva libri di letteratura appariva anomalo, diverso dai fratelli più grandi. In casa non avevamo una biblioteca, c’erano solo i libri di scuola delle mie sorelle e dei miei fratelli, neanche in paese c’era una biblioteca pubblica, e i preti, presso i quali studiavo, conservavano solo opere rare, libri ecclesiastici, vite di santi.,. La mia grande voglia di sapere, di conoscere, di leggere restava immancabilmente inappagata. Avevo sviluppato, in quegli anni, una sorta di ossessione per la lettura, che sola mi avrebbe permesso di conoscere il mondo, di sapere chi ero, da dove venivo, dove volevo andare. Mi venne in soccorso un cugino di mio padre che viveva davanti a casa nostra: don Peppino Consolo, proprietario terriero e originale figura di scapolo, forse un po’ folle, Possedeva una grande biblioteca, molto partigiana. Tolstojano e vittorhughiano, aveva libri fondamentali, come Guerra e pace, I miserabili. Quando capì che questo ragazzino era un deviante, mi chiamò, dicendomi: «Vincenzino, vieni qua ho dei libri, se tu vuoi leggere». Allora io presi l’abitudine di attraversare la strada e di andare da lui. Mai mi diede un libro in prestito, mi faceva leggere solo a casa sua, in cucina, su un tavolo di marmo: questo fu il mio impatto con il mondo dei libri (non prendo in considerazione quelli di scuola che, oltre ad essere noiosissimi, erano contrassegnati dal marchio della dittatura fascista). Il primo che lessi fu I miserabili, mi sconvolse la vita, mi aprì straordinari. orizzonti. Don Peppino Consolo, ripeteva spesso «Victor Hugo, non c’è che lui!». La seconda biblioteca in cui mi sono imbattuto, all’epoca delle scuole medie – gli americani erano già arrivati – è stata la biblioteca del padre di un mio compagno che si chiamava Costantino. Era il figlio dell’ultimo podestà del mio paese, diventato, ovviamente, sindaco democristiano. Io andavo a casa sua a fare i compiti, cioè ero io a fare i compiti a Costantino. Nello studio con le poltrone di pelle, suo padre aveva una biblioteca ricchissima, i libri erano tutti rilegati. Costantino, di nascosto, in cambio dei compiti che io facevo per lui, me li prestava. Lessi dei libri importanti che a quell’età, undici, dodici anni, non riuscivo a capire nella loro profonda verità, nella loro bellezza. Quei libri mi sono serviti moltissimo, per il mio nutrimento adolescenziale e per diventare un uomo con un’ossatura abbastanza accettabile, per non restare gracile. Quando in età adolescenziale ci si imbatte in libri importanti come Guerra e pace, La Certosa di Parma di Stendhal, Shakespeare, Don Chisciotte, anche se non si coglie il loro significato profondo, li si attraversa come quando da giovane si attraversa un bosco e senza rendersene conto si incamera l’ossigeno che serve per la costruzione dello spirito e del corpo. Quindi, in qualsiasi modo la lettura dei libri importanti, di quelli che si chiamano classici. in ogni caso e a qualsiasi età può servire per formare la struttura del pensare. Leggere e scrivere sono per me elementi inscindibili, e in parte sono la stessa cosa. Credo che derivino dalla consapevolezza o dalla sensazione che noi uomini siamo persone fragili, finite, esposte a qualsiasi tipo di insulto e qualsiasi tipo di offesa. Io credo che da questa stessa debolezza e impotenza sia nato il bisogno del metafisico, siano nate 1e religioni. Forse sarò blasfemo, ma credo che le religioni scaturiscano da questa esigenza che ci sia altro, al di là di noi che possa soccorrerci, da qui nasce anche quella che Leopardi chiama <<da confederazione degli uomini fra di loro», perché proprio a causa di questa fragilità l’uomo sente il bisogno di mettersi insieme e darsi delle regole per un reciproco aiuto. La stessa esigenza genera le società, la storia, la letteratura. I grandi scrittori sono i teologi che hanno elaborato per noi il sistema religioso della letteratura. Perché la letteratura è una religione, l’ho sentito e capito da adolescente, raggiungendo uno stato febbrile di piacere della lettura, di incandescenza dello spirito, paragonabile all’estasi dei santi. La lettura di quegli anni felici era assolutamente gratuita e disinteressata, disordinata, caotica, poteva capitare il capolavoro come il libraccio orrendo e sbagliato. Ma anche il libro peggiore, non quello falso ma quello mancato, serviva. In quell’età irripetibile dell’adolescenza, nessuno può consigliarti cosa devi leggere, è uno stato di assoluta libertà. Virginia Woolf ha detto: <<l’unico consiglio che si può dare ad un giovane lettore è quello di non accettare nessun consiglio». Ma il tempo della lettura disinteressata e gratuita, come diceva Pavese «della libera fame», si riduce sempre di più, soprattutto per noi che abbiamo scelto il mestiere di scrivere. Siamo obbligati a letture che chiamiamo professionali, fatte con razionalità, consapevolezza, funzionali al lavoro. Certo ci sono anche le riletture, grazie alle quali scopri delle cose che ti erano sfuggite: attraversare per la seconda volta La ricerca del tempo perduto, Don Chisciotte, Shakespeare, sono esperienze straordinarie che, in età matura, nell’età della consapevolezza, nell’età del lavoro, danno un’altra felicità, diversa da quella adolescenziale, assolutamente inconsapevole, gratuita, anarchica e libera. Del resto, si parte quasi sempre dai libri per scrivere un altro libro, che si configura come una sorta di palinsesto costruito sull’esperienza di altri libri. Pensiamo al Don Chisciotte, il più grande libro della letteratura occidentale: tutto comincia con la lettura dei libri di cavalleria per cui don Chisciotte impazzisce, diventa quell’hildalgo dalla trista figura che noi conosciamo. C’è un episodio chiave, a proposito di libri; al ritorno di don Chisciotte dal primo viaggio, la nipote e la governante cercano di eliminare tutti i libri rischiosi e pericolosi che 1o avevano indotto a credere di essere un cavaliere. Come Minosse, le due donne destinano questi libri al Paradiso, al Purgatorio o all’Inferno. Alcuni infatti vengono salvati, altri vengono tenuti in sospeso, quelli condannati, vengono subito eliminati e buttati via. Un criterio di ripartizione molto saggio, a mio avviso. Tutti abbiamo avuto i nostri libri dell’inferno, nel senso dell’erotismo, dell’enfer francese, i libri dannati, da eliminare, da bruciare. Anche se i libri non si dovrebbero mai bruciare, purtroppo oggi il loro livello si abbassa sempre di più, in quest’epoca della visualità in cui si tende ad intrattenere piuttosto che a far capire che cosa è la bellezza della poesia, la bellezza della parola scritta. A ragione Aldo Bruno ha parlato di libri da supermarket, che ci vengono propinati dall’industria editoriale le cui scelte sono sempre di più all’insegna del profitto e non della qualità. Ho dedicato al tema dei libri utili e dei libri inutili, alcune pagine di un mio romanzo, che io chiamo narrazione, nel senso in cui la intende Walter Benjamin. Credo che il romanzo oggi non sia più praticabile, perché non è più possibile fare appello a quello che Nietzsche, a proposito della tragedia greca, chiama lo spirito socratico. Lo spirito socratico è il ragionamento, la riflessione sull’azione scenica. Parlando del passaggio dalla tragedia antica alla tragedia moderna, dalla tragedia di Sofocle e di Eschilo a quella di Euripide, Nietzsche sostiene appunto che in quella di Euripide c’è l’irruzione dello spirito socratico, cioè l’irruzione del ragionamento e della filosofia. Nel romanzo tradizionale settecentesco-ottocentesco l’autore usava interrompere il racconto con le sue riflessioni. Pensiamo alle celebri riflessioni manzoniane sull’azione scenica. Io credo che oggi questa riflessione non si possa più fare, lo spirito socratico non può più esserci nelle creazioni moderne perché l’autore non sa più a chi rivolgersi in questa nostra società di massa. Ho teorizzato perciò lo spostamento della narrazione verso la forma della poesia; la narrazione non è più un dialogo ma diventa un monologo, con l’aspetto formale di un’organizzazione metrica della prosa. La pagina che vi propongo è tratta dal mio romanzo che si chiama Nottetempo, casa per casa, dove narro dell’imbattersi in libri inutili, in libri fasulli e di un’erudizione che non appartiene alla cultura, non appartiene alla letteratura e che forma quella che è La zavorra del sapere, a volte l’errore del sapere. Il protagonista è un giovane intellettuale socialista, nel periodo de1’avvento del fascismo, che per il suo impegno politico, sarà costretto ad andare in esilio in Tunisia. Il suo antagonista è un barone decadente dannunziano che, nella ricca biblioteca di famiglia, cerca insistentemente un libro sui mormoni che non trova e allora dice:
Erano primieramente libri ecclesiali, per i tanti monaci, parroci, arcipreti, canonici, ciantri, provinciali, vescovi dentro nel suo casato, dalla parte dei Merlo e dei Cìcio. Erano controversie storiche, teologiche, vite di santi, di missionari martiri, dissertazioni, apologie, come ad esempio, e solo fra quei in volgare, Delle azioni eroiche, virtù ammirabili, vita, morte e miracoli del B, Agostino Novello Terminese capi dieci, Apologia dell’Accademico Tenebroso fra i Zelanti intorno alla nascita di santa Venera in Jaci contro gli argomenti del p. Giovanni Fiore, L’ardenza e tenacità dell’impegno di Palermo per contendere a Catania la gloria di aver dato alla luce la regina delle vergini e martiri siciliane S.Agata, dimostrate nell’intutto vane ed insussistenti in vigor degli stessi principi e dottrine de’ Palermitani scrittori.
Il barone tirava fuori dagli scaffali i volumi con disgusto, 1l fazzoletto al naso per la polvere che s’alzava da quelle carte. E c’era poi tutto quanto riguardava Cefalù, il suo Circondario, da Gibilmanna a Gratteri, a Castelbuono, a Collesano, fino a Làscari, a Campo Felice, a Pòllina… E copia del Rollus rubeus dei diplomi del Re Ruggero, degli atti del processo al vescovo Arduino, le storie di Cefalù del Passafiume, dell’Aurìa, del Pietraganzili… Libri di scienza come la Flora palermitana, la Stoia naturale delle Madonie, I Catalogo ornitologico del Gruppo di Malta, il Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali delle Madonie e luoghi adiacenti, il Catalogo dei Crostacei del Porto di Messina, il Trattato sui novelli pianeti telescopici… E ancora le istruzioni per adoperare gli specchi inclinati, i rimedi contro la malsanìa dell’aria, la memoria intorno ai gas delle miniere di zolfo… Che puzza, che polvere, che vecchiume! Ne avrebbe volentieri fatto un grande fuoco don Nené, per liberare, ripulire, disinfestar la casa. E pensò ad altre case del paese in cui v’erano simili libri. Alle antiche case di tutta la mastra nobile, da la guerra fino ad oggi serrate, fredde come tombe, abitate da mummie, da ombre, da cucchi spaventati dalla maramaglia dei reduci, dei villani, che di questi tempi s’eran fatti avversi, minaccianti. Pensò alla casa del Bastardo con tutti quei libri i, ogni stanza, di filosofia, di politica, di poesia, alla villa a Santa Barbara che lo zio don Michele, un pazzo! aveva lasciato a quel Marano, al figlio della gna Sara. Pensò ai gran, palazzi di Palermo, alle canoniche, ai monasteri, ai reclusori, agli oratori, ai conventi. Pensò a Monreale, a San Martino delle scale, all’Arcivescovado, allo Steri, all’Archivio Comunale, ad ogni luogo con cameroni, studi, corridoi, anditi tappezzati di stipi traballanti, scaffali di pergamene scure, raggrinzite, di rìsime disciolte, di carte stanche, fiorite di cancri funghi muffe, vergate di lettere sillabe parole decadute, dissolte in nerofumo cenere pulviscolo, agli ipogei, alle cripte, alle gallerie sotterranee, ai dammusi murati, alle catacombe di libri imbalsamati, agli ossari, allo scuro regno r6so, all’ imperio ascoso dei sorci, delle càmole dei tarli degli argentei pesci nel mar del1e pagine dei dorsi dei frontespizi dei risguardi. E ancora alle epoche remote, ai luoghi più profondi e obliati, ai libri sepolti, ai rotoli persi sotto macerie, frane, cretti di fango lave sale, aggrumati, pietrificati sotto dune, interminate sabbie di deserti. Oh l’incubo, l’asfissia! Dalla sorda e inarrestabile pressura di volumi inutili o estinti, dai cumuli immensi di parole vane e spente sarà schiacciato il mondo, nell’eloquio demente d’una gran Babele si dissolverà, disperderà nell’universo. Per fortuna, don Nené aveva come antidoto, contrasto, il suo segreto enfer, aveva per sollazzo il suo Micio Tempio, e aveva soprattutto, per nutrimento d’anima, di vita, il suo D’Annunzio.
E dove siete, o fiori
strani, o profumi nuovi?
Don Nenè, l’eccentrico pazzo tolstojano – ecco il cugino di mio padre che ritorna
nella narrazione – lascerà in eredità la sua preziosa biblioteca a Pietro Marano, il protagonista, figlio di contadini. Il ragazzo attingerà a questi libri, realizzando la sua educazione sentimentale: <<E i libri, tutti quei libri in ogni stanza lasciati dal padrone don Michele, ‘Vittor Ugo”, diceva ‘Vittor Ugo…” e “Gian Valgiàn, Cosetta…” “Tolstòi” e ‘Natascia, Anna, Katiuscia…”, e narrava, narrava le vicende, nell’inverno, torno alla conca con la carbonella. Narrava ancora di fra Cristoforo, Lucia, don Rodrigo… dei Beati Paoli, Fioravanti e Rizziere, Bovo d’Antona…>> (ecco che ritorna il nostro Manzoni). Ci si può imbattete talvolta nei falsi libri, nei libri ammuffiti, pietrificati, che non significano nulla ma si può avere la fortuna, di incontrare, di attraversare i libri che Harold Bloom chiama canonici. Certo si leggono i libri per la trama, per quello che rappresentano; si legge Stendhal per la passione d’amore, per la sua visione di energia del mondo; si legge Proust per la rappresentazione di un mondo che stava declinando; si legge Kafka per quanto Kafka abbia di profetico, di entusiastico. L’entusiasmo viene da en-theòs, si dice quando si è posseduti dal Dio e molto spesso gli scrittoti sono entusiasti, sono quelli che riescono attraverso la metafora ad essere profetici. A proposito, io ho capito il senso della parola metafora una volta, mentre mi trovavo ad Atene, invitato dall’Istituto Italiano di Cultura, e mi sono visto sfilare davanti agli occhi un camion su cui c’era scritto netaforòi, cioè trasporti! I libri che hanno questa vita – Vittorini diceva che sono libri arteriosi -, che hanno la forza della metafora, riescono ad essere profetici perché con il passare degli anni diventano veramente interpreti del tempo che stiamo vivendo. Don Chisciotte o I promessi sposi, o le opere di Pirandello diventano sempre più attuali in quest’epoca in cui stiamo smarrendo la memoria, l’identità, in cui il potere ci costringe a vivere in un infinito presente, privandoci della conoscenza dell’immediato passato, impedendoci di immaginare l’immediato futuro. Ho intitolato questo mio intervento Cochlias legere, in antico si diceva questo quando si andava per i lidi a raccogliere le conchiglie come un gioco dilettoso. Io credo che la parola “leggere” significhi andare dentro i libri per raccogliere conoscenza, raccogliere raccogliere, sapienza, bel1ezza, poesia; noi leggiamo queste chiocciole che raccogiamo sulla spiaggia, che ci portano dentro il labirinto dell’umanità., dentro il labirinto della storia, dentro il labirinto dell’esistenza. Capire questo significa esorcizzare la nostra consapevolezza della finitezza, la nostra paura, perché io credo che le aggregazioni umane, le società, nascano proprio da questi sentimenti di insicurezza, dalla debolezza della nostra condizione umana. La lettura dei classici ci conforta, ci arricchisce, ci apre nuovi orizzonti. Oggi, in questa epoca della visualità, sembra che i libri non siano più tanto praticati, soprattutto in questo nostro paese che ha avuto una storia particolate. II nostro è un paese culturalmente terremotato che ha avuto una storia diversa da ogni altro paese europeo. La nostra cultura era una cultura in cui affluenti venivano da una cultura alta e da una cultura popolare. L’incrocio di questi due affluenti formava quella che era la cultura tout court. La trasformazione radicale, profonda e veloce del nostro paese – Pasolini ce l’ha spiegato a chiare lettere – da plurimillenario contadino a paese industriale, lo spostamento di masse di persone dal meridione ai settentrione, verso le zone industriali, ha generato uno sconvolgimento culturale: la cultura popolare è stata cancellata: nessuna nostalgia, ma era comunque una ricchezza. Il mondo contadino era un mondo di pena, di sofferenza, di ignoranza, però la cultura popolare era una vera cultura. Poi c’era la cultura alta. Oggi viviamo una cultura media che è stata sicuramente appiattita dall’ossessione per la comunicazione, per la velocità. Io credo che oggi i classici, da Cervantes a Shakespeare a Dante, siano veramente, come dire, i segni, i monumenti di una gande civiltà che nel nostro contesto, nel contesto occidentale è al tramonto. Non sappiamo cosa avverrà dopo questa nostra epoca. Bill Gates ha profetizzato già che il libro sparirà e questo mi ricorda una frase di Victor Hugo in Notre-Dame de Paris, che riguardava l’invenzione della stampa: «ceci tuera cela», questo ucciderà quello, cioè il libro avrebbe ucciso l’architettura. Questo non è avvenuto,
l’ architettura ha continuato ad essere insieme al libro, una delle grandi espressioni umane dell’arte; ma oggi con la comunicazione assoluta, con i mezzi di informazione di massa (internet, televisione) non so quello che avverrà, se la tecnologia, l’elettronica uccideranno il libro, la carta stampata. Ci auguriamo che questo non avvenga e che ci saranno ancora, come diceva Stendhal, «i felici pochi» che possano attingere a questi monumenti dell’umanità che sono i libri di letteratura e la poesia, i romanzi, il teatro. Speriamo che le nuove generazioni, voi, possiate continuare, come i monaci del medioevo, a trascrivete i codici importanti della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro sapere e della nostra poesia.
estratto da Sincronie VII,13
Rivista semestrale di letterature, teatro e sistemi di pensiero
Vecchiarelli Editore 2003
Roma 18/2/2003
Università Tor Vergata
La Sicilia di Vincenzo Consolo
di Valentina Pinello
Di Vincenzo Consolo si sente già la mancanza. Era una presenza, un punto di riferimento, un’intelligenza sulla quale poter contare per avere una riflessione lucida e illuminante su quello che sta succedendo nel nostro paese e nella sua Sicilia. Da Milano scrutava, studiava, rifletteva e, solo quando aveva qualcosa da voler comunicare, parlava o scriveva. Non è mai stato uno scrittore prolifico, tra “Il sorriso dell’ignoto marinaio” e “Retablo” sono passati dieci anni. La Sicilia era il suo chiodo fisso anche se aveva deciso di lasciarla, come racconta in un’intervista inedita, che adesso vogliamo riproporvi, di qualche anno fa, ma di estrema attualità perché, come diceva Consolo, «c’è un impegno morale nel rappresentare il nostro tempo da parte dello scrittore; anche se scrive libri di storia, non deve essere la storia romanzata, deve essere una storia metaforica come ci ha insegnato Manzoni, cioè si parla del passato per rappresentare la nostra contemporaneità».
A distanza di una settimana dalla sua morte, ci manca il suo modo di saper cogliere e raccontare la realtà, avremmo voluto chiedere il suo punto di vista su tanti temi di estrema attualità, dal movimento dei Forconi che agita da settimane la Sicilia fino all’immigrazione, al quale è stato sempre particolarmente sensibile. Alcune di queste domande trovano una risposta in quell’utile, unica e senza tempo chiacchierata di qualche anno fa, nella sua casa siciliana a Sant’Agata di Militello, di fronte alle Isole Eolie.
LA
SICILIA DI
VINCENZO CONSOLO.
INTERVISTA ALLO SCRITTORE DEL “SORRISO DELL’IGNOTO
MARINAIO”
Trascorrere un paio d’ore conversando con Vincenzo Consolo è stato come aver riletto pagine significative di storia e di letteratura della Sicilia e averle fatte proprie. Il suo modo di parlare con semplicità di fatti non sempre comprensibili ai non siciliani,, denota una linearità di pensiero che solo un attento conoscitore di quell’Isola può possedere. Ascoltarlo provoca un piacere diverso rispetto a leggere i suoi libri, noti invece per una prosa ricercata, non di immediata comprensione, anche se musicale, intessuta di riferimenti linguistici che derivano radici culturali della terra siciliana.
Consolo vive a Milano da più di trent’anni, ma torna spesso a Sant’Agata di Militello, suo paese d’origine, dove l’abbiamo incontrato.
«Ormai siamo diventati degli Ulissidi, espropriati della nostra identità e alla ricerca della nostra Itaca. Quando torniamo però Itaca non c’è più; la patria è ormai diventato un luogo interiore .Vedendo la realtà siciliana fatta di ingiustizie ho deciso di spostarmi a Milano, patria di Beccaria. Qui da noi il diritto si trasforma in favore che ti lega ad una persona, in alcuni casi, anche per tutta la vita. Sono andato via per questo. Lo sradicamento (solamente fisico, le mie memorie sono qui) è doloroso, però alla fine necessario. Non è facile ricostruire legami in luoghi che non sono i tuoi. Ma stando qui si fa un danno a se stessi. Bisogna però tornare e quando si torna si è più forti, forse anche meno vulnerabili, o meglio, meno ‘ricattabili’».
“Sciascia è lo scrittore che è perché è nato a Racalmuto”, si legge in uno dei suoi saggi; e anche per quanto riguarda Pirandello lei sottolinea la sua provenienza dalla provincia di Agrigento, una zona ricca di miniere di zolfo. La vita delle miniere entra in molti romanzi siciliani, a tal punto che si parla di una “letteratura dello zolfo”. Dopo questa premessa, com’è stato influenzato lei dalle sue zone d’origine, sempre presenti nei suoi romanzi?
«Tutta una serie di scrittori di cui io parlo sono stati influenzati dalla condizione delle zolfare, in cui esisteva un rapporto di assoggettamento totale dell’operaio al padrone. La realtà delle zolfare poggiava principalmente sulle spalle di due soli lavoratori: il picconiere e il caruso. Dalla condizione di carusi, sfruttati come servi della gleba, era quasi impossibile riscattarsi. Col tempo però questi presero coscienza della loro condizione e dal mondo delle zolfare si sollevarono le prime proteste operaie. La prima riunione di sindacati (allora si chiamavano Società di Mutuo Soccorso) avvenne a Grotte. Per l’occasione vennero gli operai del nord a portare la loro solidarietà, come oggi avviene per gli operai della Fiat di Termini Imerese.
Nella Sicilia occidentale è nata una letteratura diversa rispetto a quella orientale. Così Pirandello parla del mondo delle zolfare e dei primi scioperi (ne “I vecchi e i giovani”); ma non è l’unico. Altri esempi sono Alessio Di Giovanni in “Gabrieli lu carusu” o Angelo Petix, nel dopoguerra, in “La miniera occupata”. Anche Verga ne parla, in “Dal tuo al mio”o in “Rosso Malpelo”; ma lo scrittore catanese non è un uomo di zolfo e per lui la lotta di classe non serve a niente. Verga parla piuttosto di una metafisica della roba e la sua è una concezione conservatrice.
In scrittori della parte orientale della Sicilia, anche se di forte impegno civile, mi riferisco a Brancati o a Vittorini, è invece più marcata la propensione ad una scrittura lirica (vedi “Conversazione in Sicilia”).
Arrivando a me: quando ho deciso di intraprendere questa strada, provenendo da un paese intermedio tra queste due realtà da me descritte seguendo una sorta di geografia ideale, ho dovuto decidere da che parte stare. Nella mia zona, quella di Sant’Agata di Militello, non c’è stato il problema del latifondo, della distruzione della natura; c’era la piccola proprietà terriera, ma non ci sono mai stati grandi scontri sociali. Per me si pose quindi il problema se rimanere chiuso in quest’ambito, sviluppando temi di tipo esistenziale, oppure avvicinarmi alle zone di Messina o Catania, oppure ancora spostarmi verso le zone occidentali. Bene, alla fine ho concepito una sorta di ibrido, una ‘chimera’ , tra mondo occidentale, di impegno civile, e mondo orientale, lirico».
Al di là dei suoi orientamenti stilistici, di quale Sicilia ama parlare?
«Si ha della Sicilia un’immagine eccessivamente colorata, nel senso più negativo. Un po’ come avviene per il sud America: del Brasile, per esempio, si parla per il Carnevale di Rio e si rischia di non andare oltre. La Sicilia vera, quella di cui mi piace parlare, è quella dell’uomo che ha cercato di riscattarsi, di ritrovare la sua identità. Niente colorismo alla Camilleri! Rischiamo di farci espropriare del nostro patrimonio umano. L’identità non deve però essere compiacenza di sé, ma comprensione dell’altro partendo da una migliore conoscenza di noi stessi».
Al tema dello scontro tra civiltà, non pensa che la storia della Sicilia abbia dato una risposta, intessuta com’è di cultura e di tradizioni arabe? Basti pensare alle tecniche per la coltivazione degli agrumi o ai sistemi di pesca del tonno.
«Chi solleva lo scontro di civiltà mostra ignoranza e malafede. Confondere l’integralismo islamico con la religione islamica è lo stesso di confondere il Cristianesimo con l’Inquisizione e l’Autodafè. Parlare di crisi dell’Islam significa alimentare razzismi e xenofobie. Sciascia, citando Amari, “Storia dei musulmani in Sicilia”, dice che la storia della nostra isola inizia con l’arrivo degli arabi musulmani, nell’827; da lì è iniziato un risveglio culturale, economico e artistico. Non si può cancellare questa storia. I normanni, intelligentemente, non hanno cancellato questa dominazione. Nel periodo normanno a Palermo c’erano ancora numerose moschee , oltre che sinagoghe e chiese cristiane, e un riconoscimento reciproco. Con gli spagnoli è venuta meno questa pacifica convivenza.
Nel corso degli anni ci sono stati degli intellettuali che hanno cercato di creare dei fossati di odio e di vendetta; la Fallaci appartiene a questa schiera e purtroppo interpreta il pensiero di molti».
Nella Sicilia attuale, dei condoni edilizi, delle case costruite sulla Valle dei Templi, del clientelismo, delle coste sempre più deturpate dal cemento (da cui anche i tonni sono scappati!), pensa che “l’olivastro”, il selvatico, abbia completamente asfissiato “l’olivo”, usando la distinzione presente nel suo libro, “L’olivo e l’olivastro”, appunto.
«Credo di sì. Ho paragonato Falcone e Borsellino a persone che hanno cercato di disboscare, con l’ascia della legge, il selvatico. Ma sono stati uccisi. A Palermo si è diffuso un clima di assoluto fastidio verso i magistrati. Si è passati dall’indignazione degli anni di Falcone, alla dimenticanza. E’ un brutto segno quando in una società non si riconosce l’importanza della magistratura e quando non si riconosce l’indipendenza dell’Antimafia».
Valentina Pinello
15 gennaio 2012 pubblicata su Golem
Foto di Giovanna Borgese
La Lingua della scrittura a Vincenzo Consolo
a cura di Annagrazia D’Oria
La pubblicazione di Oratorio presso le edizioni Manni e un incontro a Milano in un’atmosfera tutta siciliana (la signora Caterina ha gentilmente offerto autentico latte di mandorla preparato in casa; sulla scrivania palpitavano pagine di appunti su una donna della Sicilia) sono state occasioni per questa breve intervista a Vincenzo Consolo. Di seguito anticipiamo il “Prologo” da Catarsi in Oratorio, a giorni in libreria.
Oggi la lingua letteraria è quella nazionale del linguaggio televisivo. Viene comunque usata dalla maggior parte degli scrittori: alcuni (pochi) la usano in maniera strumentale con un chiaro intento di opposizione, altri l’accettano per conformismo, come unica possibilità di esistere nel mercato. Tu che cosa pensi? Quali sono le tue idee sulla narrativa italiana?
In questo nostro tempo si è rotto il rapporto tra testo letterario e contesto situazionale e quindi non è più possibile adottare le forme de romanzo tradizionale (oggi si producono e si consumano cosiddetti “romanzi” che non hanno più nulla da spartire con la letteratura); non è più possibile raccontare in una prosa comunicativa, usare una lingua che è divenuta povera, rigida (la famosa nuova lingua italiana come lingua nazionale di cui ci ha detto Pasolini), una lingua priva di profondità storica, invasa dal potere dei media e del mercato.
C’è una soluzione per continuare a scrivere?
Oggi, l’unico modo per rimanere nello spazio letterario da parte di uno scrittore è quello di scrivere non più romanzi, ma narrazioni. Dico narrazione nel senso in cui l’ha definito Walter Benjamin. In Angelus Novus, nel saggio sull’opera di Nicola Leskov, Benjamin fa una precisa distinzione tra romanzo e narrazione. La narrazione, dice, è un genere letterario preborghese affidato all’oralità (racconti orali erano la Bibbia, i poemi omerici). Per ragioni mnemoniche, la prosa allora prendeva man mano forma ritmica, poetica. Nella narrazione insomma è assente quello che Nietzsche chiama “spirito socratico”.
Che cosa intende per “spirito socratico”?
Cos’è? È la riflessione, il ragionamento, la “filosofia” che l’autore mette in campo interrompendo il racconto. Questo è avvenuto, cioè l’irruzione dello spirito socratico, ci dice Nietzsche, nel passaggio dalla tragedia antica di Eschilo e di Sofocle alla moderna tragedia di Euripide. Questo è avvenuto nella nascita del primo grande romanzo della nostra civiltà occidentale, nel Don Chisciotte. “Il povero don Chisciotte aspira a un’esistenza mitica, ma Sancio lo riporta coi piedi per terra, introducendolo violentemente nella sua realtà, grazie alla quale era nato un nuovo genere: ‘il romanzo” scrive Américo Castro in Il pensiero di Cervantes. Ora, nella narrazione moderna o postmoderna, non è che si ritorni all’antica tragedia o al mondo mitico, ma si riflette, si commenta o si lamenta non in forma diretta, comunicativa, ma in forma espressiva, vale a dire indirettamente, vale a dire metaforicamente. Questo significa accostare la prosa alla forma poetica, contraendo la sintassi, verticalizzando la scrittura, caricando di significati le parole e caricando la frase di significante, di sonorità.
Ho espresso questa mia concezione della narrativa nel saggio La metrica della memoria e l’ho messa in pratica in tutti i miei libri narrativi, ma soprattutto nell’ultimo, Lo spasimo di Palermo ed anche, in senso metaforico, nell’opera teatrale Catarsi.
Parlaci di Catarsi…
E’ messo in scena, in quest’opera, un Empedocle contemporaneo (con riferimento, certo, a quello di Hölderlin) nel momento estremo del suicidio e nell’estremità spaziale del cratere dell’Etna. Momento e spazio che non permettono più comunicazione, frasi, parole, ma soltanto urla o suoni bestiali. Antagonista di Empedocle, il giovane suo allievo Pausania, ipocritamente invece continua a comunicare con un immaginario pubblico della cavea, si fa insomma falso messaggero, impostore. In tutti i miei libri, dicevo sopra, a partire da La ferita dell’aprile, e quindi ne Il sorriso dell’ignoto marinaio e negli altri vi sono degli “a parte”, brani in cui s’interrompe il racconto, il tono si alza, la prosa si fa ritmica.
Insomma un cantuccio come i cori della tragedia manzoniana, un intervento liberatorio della poesia che ha ancora una forza…
Sì, sono questi insomma dei cantica o Cori, digressioni lirico-poetiche, commenti non filosofici ma lirici. La filosofia per me consiste nel creare un testo che sia un iper-testo, che abbia cioè in sé rimandi, citazioni, espliciti o no. Ne Il gran teatro del mundo di Calderon, gli attori, all’inizio del dramma, indossano in scena i costumi e quindi cominciano a recitare. Questa invenzione mi aveva colpito e quindi in Lunaria, un’altra mia opera teatrale, ho capovolto li gesto: gli attori alla fine della rappresentazione si spogliano dei costumi in scena. Il senso è la fine dell’illusione. Dell’illusione necessaria, che dura il tempo di una rappresentazione teatrale o della lettura d’una poesia e che ci difende dall’angoscia dell’esistenza e dalla malinconia della storia. Finita l’illusione, c’è il ripiombare nella dura realtà. Che per noi moderni è diventata insopportabile, e scivoliamo quindi nell’alienazione o nella violenza. Soltanto i greci avevano una grande capacità di sopportazione della realtà.
Torniamo agli scrittori, al linguaggio, ma soprattutto al legame con la propria terra. Nel tuoi libri a Sicilia è una realtà viva e concreta, metafora del mondo e delle sue leggi ingiuste e violente…
Allora ci sono scrittori che chiamerei di tipo orizzontale, nel senso che essi possono parlare indifferentemente di qualsiasi luogo. E sono spesso anche grandi scrittori come Stevenson, Conrad, Hemingway o Graham Greene, per fare solo alcuni nomi. Ci sono scrittori invece che non sanno o non possono staccarsi dal luogo della propria memoria, con questo luogo devono fare i conti, di questo luogo fanno metafora. Per tanti scrittori, ed anche per me, questo luogo è la Sicilia. La quale è un’isola terribilmente complessa. Ha una complessità storico-culturale dovuta alle varie civilizzazioni che in essa si sono succedute. La presa di coscienza della sua complessità è stata la ricchezza e insieme la dannazione degli scrittori siciliani.
C’è un esempio importante dell’ineludibilità del tema Sicilia, ed è quello di Verga. Lo scrittore divaga per meta della sua vita, affronta temi cosiddetti mondani e scrive in un impacciato italiano. A Milano, nel 1872, avviene la sua famosa crisi e, nella crisi, “sente il bisogno di risalire alle origini e risuscitare le memorie pure della sua infanzia”., Il bisogno al ritornare con la memoria “al mondo intatto e solido della sua terra” scrive Sapegno. E inventa un “italiano irradiato di dialettalità”
, come dice Pasolini. Ogni scrittore siciliano ha declinato dunque la Sicilia in modo diverso. Detto semplicisticamente, in modo storicistico o esistenziale. Verga ha una concezione metastorica, una visione fatalistica della condizione umana, e si è parlato quindi di fato greco, ma in Verga non avviene assoluzione della colpa, non c’è liberazione. Per verga, bisognerebbe piuttosto parlare di fatalismo islamico. “Quel che è scritto è scritto” recita il Corano.
E la Sicilia di Pirandello?
Pirandello ha interpretato la complessità della condizione siciliana, complessità che provoca smarrimento, perdita di identità. Riguardo a Pirandello bisognerebbe piuttosto parlare di grecità. Nel teatro greco c’era il Prosopeion o Prosopon, ch’era insieme la maschera e la faccia, ma anche il modo come gli altri ti vedono.
Il Prosopon Pirandello l’ha trasferito nel mondo siciliano: non sai chi sei, sei di volta in volta colui che gli altri decidono, sei uno, nessuno e centomila; sei poi costretto, nel gioco sociale, a portare la maschera…
E negli altri scrittori siciliani?
La concezione esistenziale e insieme determinista che, partendo da Verga passa per Pirandello contraddetta da una versi fino a Lampedusa, è contraddetta da una forte linea storicistica, che da De Roberto, per Brancati e Vittorini, arriva fino a Sciascia. Nella concezione metastorica di
Lampedusa c’è una forte ambiguità. L’autore del Gattopardo doveva chiudere i conti, secondo me, con De Roberto, con Viceré (De Roberto dice, contraddicendo Verga: non ce nessun mondo dei vinti. Nella storia siciliana ha vinto sempre il cinismo. l’opportunismo, il trasformismo della classe dominante, dei nobili. vincitori sono sempre loro, mentre i perdenti e gli eternamente ingannati e sfruttati sono i popolani). Lampedusa dunque scrive un romanzo storico con una visione positivista del mondo. Afferma che dalle classi sociali di volta in volta ne emerge una, si raffina man mano nel tempo, arriva alla perfezione (estetica, culturale), quindi decade, tramonta, si spegne come si spengono le stelle in cielo. E quindi emerge un’altra classe (ineluttabilmente insomma alla nobiltà succede la borghesia). C’è una sorta di meccanicismo, di determinismo in questa concezione. Ai leoni e ai gattopardi devono necessariamente succedere gli sciacalli (che diverranno gattopardi a oro volta), ai Salina devono succedere i Sedara. Con questa sua concezione, Lampedusa assolve la classe a cui apparteneva, la nobiltà feudale, principale responsabile di tutti i mali della Sicilia. E assolve anche i borghesi mafiosi alla Sedara: era ineluttabile che questi arrivassero a potere, il loro emergere, è un esito del determinismo storico (con buona pace di “quell’ebreuccio”, di Marx, di cui Salina non ricorda il nome).
E Sciascia?
Sciascia, da illuminista, non accetta nessun meccanicismo nella storia, storia in cui le responsabilità dei mali sociali sono da attribuire al potere, alla sua volontà. Da qui i suoi primi temi illuministi sulla pena di morte, sulla tortura o l’impostura de ll consiglio d’Egitto e di Morte dell’inquisitore, da qui i suoi romanzi polizieschi, necessitati dalla contingenza in Sicilia, in Italia, del potere politico degenerato, dei legami tra potere politico e mafia, dei delitti e dele. stragi del potere politico-mafioso. Ma i romanzi polizieschi di Sciascia sono singolari, opposi ai romanzi polizieschi classici: non vi si arriva mai all’individuazione dell’assassino o degli assassini perché i romanzi di Sciascia sono polizieschi politici. L’individuazione degli assassini comporterebbe l’indagine e quindi la condanna del potere di se stesso. S’e mai visto un potere politico che condanna se stesso? Parliamo dei tuoi libri. In tutti ci sono dei temi fissi: la storia, la riflessione sul potere, sull’emarginazione, sull’oppressione dei deboli, sull’impegno politico e civile dell’intellettuale e usi sempre una lingua particolare, ricca di metafore. Quali sono le tue radici culturali?
Dopo questa lunga premessa parliamo anche di me, un poco, non tanto, come invece vuole di sé Zavattini.
Sono nato come scrittore nel ’63 e già dal primo libro mi sono mosso con la consapevolezza della letteratura, soprattutto della siciliana, di cui abbiamo sopra discorso, che mi aveva preceduto e di quella che si stava svolgendo intorno a me. Mi sono mosso con una precisa scelta degli argomenti da narrare (stori-co-sociali) e del modo in cui narrarli.
Sono nato, biologicamente, in una zona di confluenza del mondo orientale e del mondo occidentale della Sicilia, di incrocio vale a dire tra natura e storia. Potevo quindi optare per l’oriente, per i disastri dei terremoti dello stretto di Messina e delle eruzioni dell’Etna, optare per la violenza della natura ed affrontare temi metastorici, esistenziali, temi verghiani insomma. Ho optato invece per il mondo occidentale, dove sulla natura prevalgono i segni forti della storia. E sono approdato a Cefalù (con I sorriso dell’ignoto marinaio), che era per me la porta del gran mondo palermitano, del mondo occidentale.
Ho voluto narrare argomenti o temi storico-sociali e lo stile da me scelto non è stato comunicativo, non ho adottato una scrittura di tipo illuministico o razionalistico, ma lirico-espressiva con l’assunzione o innesto di parole o formule di lingue del passato che nel dialetto siciliano si sono conservate (dico del greco, latino, arabo, francese o spagnolo). Al contrario degli scrittori che immediatamente mi precedevano, scrittori illuministi o razionalisti (Moravia, Morante, Calvino o Sciascia, quest’ultimo a me più vicino), mi collocavo nella linea sperimentale, quella che, partendo da Verga, giungeva a Gadda, Pasolini, Mastronardi, Meneghello, D’Arrigo..
Ho voluto compiere insomma un azzardo, far convivere cioè argomenti storico-sociali con un linguaggio lirico-espressivo. Questa convivenza era nella realtà rappresentata da due personaggi, un poeta e uno scrittore: Lucio Piccolo e Leonardo Sciascia.
Hai scritto: “Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e si articola come la storia di una continua sconfitta della ragione”.
Ma, alla fine, i tuoi libri non comunicano una sconfitta al lettore, bensì una passione civile, l’esortazione ad usare sempre di più, anche se amaramente, anche se sconfitta, la ragione.
E questo fin dal primo romanzo… ” primo mio romanzo, La ferita dell’aprile, di formazione o iniziazione, è di personale memoria (il Dopoguerra, la ricostituzione dei partiti, le prime elezioni regionali in Sicilia, la vittoria del Blocco del popolo, la strage di Portella della Ginestra, le elezioni del 48 e la vittoria della Democrazia cristiana…), un racconto scritto in una prima persona che non ho mai più ripreso.
Ho quindi immaginato e attuato il mio progetto letterario che è rappresentato principalmente da una trilogia – Il sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo- che riguarda tre momenti cruciali della nostra storia, il Risorgimento, il Fascismo, gli anni Settanta, con la contestazione e il terrorismo, fino agli anni Novanta, con le due stragị politico-mafiose di Palermo, le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Stragi di cui quest’anno, in questo bel nostro tempo di governo di centro-destra, ricorre il decennale. Anno e governo che s’inaugurano con gli atroci fatti di Genova.
Vincenzo Consolo
Prologo
Un velo d’illusione, di pietà,
come il sipario del teatro,
come ogni schermo, ogni sudario
copre la realtà, il dolore,
copre la volontà.
La tragedia è la meno convenzionale,
la meno compromessa delle arti,
la parola poetica e teatrale,
la parola scritta e pronunciata.’
Al di là è la musica. E al di là è il silenzio.
Il silenzio tra uno strepito e l’altro
del vento, tra un boato e l’altro
del vulcano. Al di là è il gesto.
O il grigio scoramento,
il crepuscolo, il brivido del freddo,
l’ala del pipistrello; è il dolore nero,
senza scampo, l’abisso smisurato;
è l’arresto oppositivo, l’impietrimento.
Così agli estremi si congiungono
gli estremi: le forze naturali
il deserto di ceneri, di lave
e la parola che squarcia ogni velame,
valica la siepe, risuona
oltre la storia, oltre l’orizzonte.
In questo viaggio estremo d’un Empedocle
vorremmo ci accompagnasse l’Empedokles
malinconico e ribelle d’Agrigento,
ci accompagnasse Hölderlin, Leopardi.
Per la nostra inanità, impotenza,
per la dura sordità del mondo,
la sua ottusa indifferenza,
come alle nove figlie di Giove
e di Memoria, alle Muse trapassate,
chiediamo aiuto a tanti, a molti,
poiché crediamo che nonostante
noi, voi, il rito sia necessario,
necessaria più che mai la catarsi.
Tremende sono le colpe nostre
e il rimorso è un segno oscuro
o chiaro che in questa notte spessa
tutto non è perduto ancora.
In questo viaggio estremo d’un Empedocle
vorremmo ci accompagnasse Pasolini,
il suo entusiasmo, il suo oracolo, la sua invettiva.
Ci accompagnasse l’urlo di Jacopone,
la chiara nudità, il gesto largo,
che tutto l’aere abbraccia, l’armonia,
del soave mimo, del santo mattaccino.
1 Pasolini, Affabulazione
da Catarsi in Oratorio, 2002
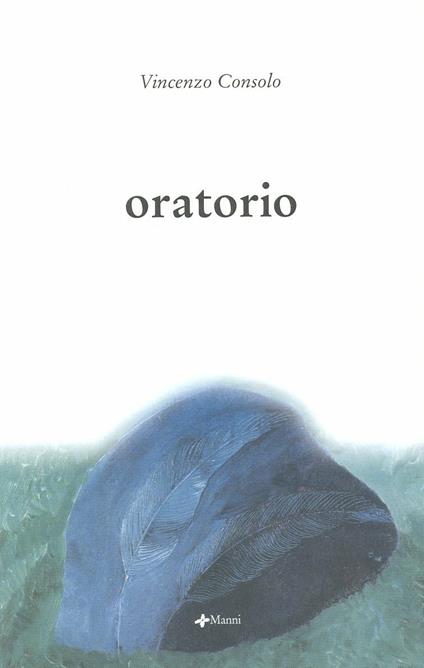
Le 9 liriche del grande Piccolo Vincenzo Consolo
In fotografia, Lucio Piccolo e Vincenzo Consolo immortalati da Ferdinando Scianna. Riproduzione riservata © Ferdinando Scianna/Magnum Photos.
Le 9 liriche del grande Piccolo
Successe che scesero dai monti sulla costa, dove già vi erano i castelli, al rumore di ferro del convoglio che affumava gallerie d’aranci, scuoteva torri in disuso ardite sugli scogli, crepavano i muri, cadevano le mensole e gridando cercava altro riparo il gabbiano.
Qui costruirono case intricate su vicoli segreti, inchiodarono agli angoli di spalliere sui terrazzi teste mozze di mori che la sera avevano il fiato agre di cedronella; nei pozzoluce murarono i tarì.
D’ Alcara solo due, e uno era sciancato. Il resto era rimasto sotto terra al castel Turio (pietà , cristiani!), le gole aperte con le cesoie per la lana dai pastori il giorno della vendetta amara, da sempre covata, nello spiazzo d’ Adelasia Regina (e questo fu il sessanta).
Poi si seppe -ma loro non lo ammisero- ch’erano i campieri di Gallego, d’Aragona e Branciforti.
I più erano scemi, altri si incattivirono o impazzirono a covare le primavere le zagare con gli occhi (ah! le risate dei potatori di Gioiosa, così liberi, beffardi, ingiuriosi).
E ogni giorno crebbero con noi, e fu uno sforzo staccarseli di dosso, così ingombranti, prepotenti, fastidiosi. Talchè, in un attacco di acuta giovinezza, meditammo -estrema soluzione- la deflagrazione del Casino. Di don Stapìno si diceva ch’era figlio di sgarro della marchesa Fi.
Girava, don Stapìno, per i paesi, Capo d’ Orlando, Olivieri, Montalbano, con la cassetta orizzontale sulla pancia (ch’aveva incavata) a vendere aghi, cordelle, stringhe, bottoni di madreperla; affittava il canocchiale -un tanto la guardata- che portava allungato sotto l’ascella.
Nei giorni di luglio, quando Lipari e Salina scivolano sull’acqua e tornano alla costa (gli aprono la strada schiere di pomice e meduse), passava sulla spiaggia, sotto il faro del Capo (luceva al sole la sua giacchetta d’alpagà ) e poneva sopra l’occhio velato d’una lacrima quel tubo nero che conteneva solo la notte, parlando nell’orecchio : scorgi se vuoi, ad ovest, caicchi levantini, il brigantino svevo, la danza dei delfini; ad est, nel nero delle terre, cisterne senza acqua, colonne di calce reggenti il pergolato, infino il fiore di cappero e l’uva vizza della malvasia.
A casa (viveva nelle segrete, al castello dove la notte, tra l’edere, dai fiori del becco soffiava il gufo mai veduto), leggeva la ventura della gente. e apparire faceva facce di morti nell’acqua del bacile, marciare a tempo i trespoli del letto, parlare turco un gatto con voce di bambina.
Col tempo (avevo avuto la ventura di capire ciò che mio padre non aveva saputo fare), mi rimase solo nel cuore don Stapìno. I campieri -ed i padroni d’essi- erano già passati nella testa, dove l’amore e l’odio hanno la porta chiusa.
Don Stapìno morì (trovarono quaderni che gli spazzini gettarono nel crine che bruciava del suo letto) e ritornò a vivere.
Era del Capo, ma veniva sempre al mio paese, prima in landò, dal tempo screpolato, e poi in motoretta. Correva sempre, correva, il volto chiuso in una gioia incomprensibile. M’accadeva di incontrarlo spesso, e allora mi fermavo e lo seguivo con gli occhi finchè spariva.
Mi trovavo un giorno nella bottega del tipografo con sette dita (tre gliele aveva mangiate la rotativa) quando entrò il barone : anche così fermo, davanti a un banco a un passo da me, fuggiva. Parlò, e parlò di poesie, che Settedita gli doveva stampare con i suoi caratteri “frusti e poco leggibili”, legare i fogli in una copertina marrone marmorizzata, a fingere un bloc-notes, in sessanta copie e non di più. E nei silenzi continuava a parlare, gli affiorava alle labbra un respiro intriso di parole smozzicate, sillabe, suoni, bolle d’un suo discorso interno irrefrenabile.
Uscì il barone, ed io, incantato, non rispondevo a Settedita che mi chiedeva i soldi per l’Ariosto rilegato e che ora aveva dodici dita e il tredicesimo già gli fioriva, storto, sopra il dorso della terza mano.
Questo fu verso la fine del ’53 : era morto Stalin, i Rosemberg erano stati assassinati, le acque avevano sommerso la Calabria, in Sicilia la Madonna piangeva al capezzale dell’ operaio e per un soffio, alle elezioni, la legge del Poliziotto non scattò.
Capii che la nobiltà diversa del barone era la poesia, in lui doppiamente magica. E fastosa sognante maliosa, di preziosa favola, di canto mai sentito.
Tutti sappiamo quale sorte ebbe poi quel bloc-notes intitolato 9 liriche, ce lo racconta Montale in appendice al volume dello ‘Specchio’ Gioco a nascondere – Canti barocchi.
(Le sessanta copie di quel libretto originario, 9 liriche, si dispersero al vento come spore, non si sa in quali bui e sordi recessi andarono a finire. Dopo anni -una vita- ho avuto in dono dal figlio dello stampatore Zuccarello una copia di quel raro, prezioso libretto).
Lucio Piccolo di Calanovella è nato a Palermo nel 1903 e ha vissuto nella sua villa -bianca e gialla, su un’ altura, dove si arriva per una stradina a spirale dentro fitti alberi, che domina la piana di limoni; le Eolie, Milazzo e Cefalù nel cerchio dell’orizzonte; nelle sale tra quadri e busti di antenati, drappi, tondi, casse, bacheche dove brillano, all’incerta luce, piatti e brocche arabe, ceramiche Daruta e di Faenza, panciuti vasi Ming su tavoli e credenze – alla Piana di Capo d’Orlando.
Troviamo dapprima questi Piccolo (allora Pizzoli) a Messina, dove vi erano venuti con gli Aragonesi. Verso il Quattrocento s’ imparentarono più volte coi Lancia di Brolo e così si diramarono nei territori di Naso e Ficarra.
Nell’ Ottocento di trasferirono a Palermo, dove abitarono in un villino in via Libertà , presso piazza Croci.
Il nonno del poeta sposò Agata Notarbartolo Moncada, mentre la madre era una Tasca Filangeri di Cutò (una cui sorella andava sposa al pricipe Tomasi di Lampedusa). Nel 1930 ritornarono definitivamente a Capo d’Orlando.
Così, nel poeta, convivono due anime, quella palermitana, spagnola, barocca, delle vecchie chiese, dei conventi, degli oratori, tutta scenografia interna che fa da sfondo alla sua infanzia-adolescenza; e quella messinese, greca, della campagna, della natura, scenografia esterna che fa da sfondo alla sua giovinezza-maturità , ma che egli riduce -è bene dirlo- sempre alla cifra barocca.
“I campi siciliani sono metropoli vegetali” dice Brancati, e bisogna aver visto questi del territorio di Capo d’Orlando (in novembre, quando l’ odore d’ olivo pigiato impregna l’ aria) per capire quale brulichio, quale sfrenatezza, quali intrichi e contorcimenti può avere la vita vegetale (e si legga al riguardo, Veneris venefica agrestis o Anna perenna).
Dopo Gioco a nascondere – Canti barocchi, il poeta ha pubblicato un’ altra raccolta di liriche, Plumelia. E, infine, un balletto, Le esequie della luna. Diciamo balletto per convenzione, ma potrebbe bene esso creare una nuova categoria letteraria. Pomposo, Fantastico, Pastorale ne formano i tre tempi. La luna, fanciulla che si ammala, cade sfaldandosi (il simbolo è palese) : ne vediamo gli effetti alla corte di un vicerè, in un convento di trepide suore e in una campagna, dove infine la luna, fanciulla ricomposta, in un’ urna viene sepolta presso le acque.
La prosa è limpida, quasi modesta, da relazione, ma che, a tratti, ha momenti di accensione lirica, di presa suggestiva sul lettore. E l’ ironia è la sua forza, l’ ironia che incide, ad esempio, tre figurette amabili, la suor Crocefissa, la speziale e, ultima, donna Pasqua, “fimmina di badia”, che ci lascia incantati e perplessi con la visione della sua tonda faccia di luna, stupita per interne dolci commozioni, dietro la grata, tra la malvetta e il garofano.
Questo scritto, ampliato da Vincenzo Consolo, era apparso in Delle cose di Sicilia, Palermo, Sellerio, 1986.
Vincenzo Consolo
Lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo risponde a Oriana Fallaci
Articolo pubblicato da “Liberazione“del 2 Ottobre 2001
Lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo risponde a Oriana Fallaci
“ Parole che conducono alla violenza “
« Che rimescolio di razze, di lingue in questa turba vitale, invadente, in questi dominatori venuti dal mare, dai deserti lontani, in questi guerrieri audaci e sereni coltivatori di palme, d’ulivi, di cedri! Sono insieme arabi, persiani, egizi, libici, sudanesi, berberi, spagnoli, tutti uniti nella fede in Allah. Sono rudi, incolti, feroci e sapienti, dottissimi, cultori di numeri, astronomie, raffinati poeti (…) Palermo fu, per questi ispirati invasori, il divano della loro nostalgia delle sabbie e delle oasi, ricordo e ricreazione del Cairo, di Baghdad, Medina, Damasco, della Mecca. » Tra le pagine più intense dell’opera di Vincenzo consolo, vi sono quelle che lo scrittore siciliano ha dedicato alla presenza araba e musulmana nel mezzogiorno d’Italia. In particolare è alla Sicilia normanna che Consolo guarda come ad un’epoca di sviluppo, fondata sull’incontro tra le culture, su una convivenza vissuta come ricchezza, meticciato, crescita nel confronto reciproco. Un periodo in cui Palermo era «una città dalle trecento moschee, in un bosco di minareti da cui muezzin modulano il loro richiamo, di chiese bizantine e romane, di sinagoghe ebraiche».
Per un intellettuale che ha fatto di queste radici multiple la chiave del proprio approccio alla storia siciliana e la base della sua stessa personale esperienza culturale, le violente parole usate da Oriana Fallaci sul “Corriere della Sera” di sabato 29 – e destinate a diventare un istant-book – contro il mondo musulmano e gli immigrati che vivono in Italia, non possono suscitare che disgusto e indignazione.
«Non varrebbe nemmeno la pena di commentare un simile sproloquio violento e viscerale – spiega Consolo – se non fosse che queste parole sono cadute in un momento delicato non solo per l’Italia ma per tutto il mondo. Credo che tutto derivi dalla situazione personale della Fallaci, quella di una persona molto malata, lo dico perché è lei stessa a parlarne, condizione che, unita al fatto che lei si trovava a Manhattan al momento degli attacchi, l’ha portata però a esacerbare certe reazioni non razionali. Siamo tutti concordi nel deprecare il terrorismo e la violenza, ma questo non c’entra nulla con ciò che lei ha detto. Mi sono sembrati in particolare brutti e molto bassi suoi giudizi contro gli immigrati, ad esempio quando parla delle piazze di Firenze. La Fallaci ha evidentemente ben poca consapevolezza di quelle che sono le culture del mondo. E’ vero, si è fatta una larga esperienza come corrispondente nei luoghi più orrendi del pianeta, ma io ricordo che in tutti i grandi corrispondenti c’era soprattutto un senso di pietà, penso ad un fotografo come Robert Kapa e a tanti altri. Invece questo atto della Fallaci è solo violento, ingiusto, non solo non è improntato alla ragione o alla cultura, ma può spingere i meno avveduti a agire di conseguenza, in particolare contro gli immigrati».
Le frasi della Fallaci non sono però isolate, arrivano dopo quelle di politici che, da Bush a Berlusconi, hanno voluto proprio sottolineare l’idea che ci si trovi di fronte a uno “ scontro di civiltà” e che in questo conflitto si esprima “ la superiorità” della cultura occidentale. Lei, anche negli scorsi anni, era già intervenuto contro una simile deriva, ad esempio dopo le parole del cardinale di Bologna Biffi sui pericoli dell’immigrazione musulmana.
«Io vengo da una terra che ha conosciuto il passaggio di tante culture, di tante civiltà, e di questo si è molto arricchita. Ovunque nel mondo il genere umano è cresciuto e progredito attraverso lo scambio: ha dato e ricevuto altre culture. Quanto ad estremismo e fondamentalismo, è sotto gli occhi di tutti che si tratta di fenomeni che ci sono e sono criminali da tutte le parti. Sulla questione della “gerarchia” delle culture, credo che né Bush, né Berlusconi abbiano mai letto alcun libro sul mondo musulmano; Bush è lontano, ma un europeo dovrebbe sapere cosa ha rappresentato questo incontro per noi, in particolare proprio in Italia. Inoltre è incredibile e assurdo che da noi qualcuno se la prenda con gli arabi o esistano xenofobia e razzismo, visto che siamo stati tutti figli di immigrati. E’ chiaro che l’attacco dell’ 11 settembre ha dato la stura ha quello che già c’era precedentemente. Tutti ricordiamo Biffi e Bossi e la criminalizzazione dei clandestini: chi arriva oggi nel nostro paese è giudicato nemico e ostile. Vorrei ricordare a tutti quanto è già accaduto nel passato dell’Europa, quando questa idea che la diversità fosse da eliminare ha prodotto vergogne che nessuno potrà mai cancellare».
La Sicilia che lei ha descritto in molti dei suoi romanzi appare quasi come un modello all’inverso, rispetto a questo clima da crociata, frutto di molteplici contaminazioni, di una convivenza feconda di stimoli.
« Il cammino della civiltà è stato tracciato con l’incrocio tra le culture e, in particolare la Palermo del periodo dei normanni, ospitava le lingue e etnie più varie e fu uno dei periodi più alti della civiltà dell’isola, come del resto è accaduto in Andalusia o più recentemente a Sarajevo: tutte città cosmopolite arricchite dalle culture del mondo, mentre la chiusura verso gli altri conduce alla Vandea e alle forme di intolleranza più idiota. Anche Beirut era una di queste città cosmopolite, come lo sono Londra o Parigi oggi, centri che mostrano tutta la ricchezza di un simile processo. Paesi e città monoculturali sono invece destinati alla regressione».
Si ha l’impressione che le valutazioni violente che vengono espresse in questi giorni sull’Islam, servano a dipingere la cultura musulmana per quello che si vorrebbe fosse, per costruire “un nemico” a cui opporsi, piuttosto che definire i contorni di una civiltà estesa in tutto il mondo.
«A questi temi è dedicato il mio ultimo libro, che raccoglie una serie di saggi dedicati alla storia dei rapporti tra Sicilia e Maghreb e dell’emigrazione meridionale della fine dell’800 che si indirizzò verso la Tunisia, l’Algeria e il Marocco. Si trattava di masse di braccianti e lavoratori meridionali che arrivarono dal nord africa ancora prima dell’inizio del protettorato francese e furono accolti benissimo. Molti nutrivano speranze verso quella terra al di là del mare: ci fu anche un’emigrazione politica di persone che parteciparono ai moti risorgimentali e che si rifugiarono nel Maghreb. Oggi sta succedendo il contrario, è da quelle coste che approdano qui da noi e subito ci allarmiamo, diciamo che sono dei criminali. Tornando a quanto è accaduto: per affrontare questi argomenti ci vogliono ragione e cultura e io credo che Oriana Fallaci sia priva sia dell’uno che dell’altra».
Guido Caldiron
AGRIGENTO, BARRICATE NELLA VALLE DEI TEMPLI PER FERMARE LA DEMOLIZIONE.
AGRIGENTO, BARRICATE NELLA VALLE DEI TEMPLI PER FERMARE LA DEMOLIZIONE. ABBATTUTE TRE CASE
Abusivi contro le ruspe in nome di Padre Pio
Abusivi contro le ruspe in nome di Padre Pio Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, siamo giunti al dramma pirandelliano, all’ assurda situazione in cui le ruspe del Genio Militare, già pronte per abbattere le case abusive, sono bloccate perché dentro quelle case si sono asserragliati i proprietari con le famiglie. Siamo alle verità differenti e contrapposte, allo Stato che ha il dovere di ripristinare finalmente, dopo trent’ anni, la legalità violata e che appare ingiusto, impietoso, e ai violatori della legge che ora appaiono povere vittime di un sopruso. UN DRAMMA PIRANDELLIANO Dov’ è più, in questa penosa, torturante dialettica la ragione? La ragione, quella, cozzando contro il duro cemento delle case abusive, si è frantumata e, tra i suoi cocci, come sempre, è fiorita l’ emozione, la commozione. Gli abusivi, di fronte alla «minaccia» dello Stato, hanno cercato rifugio nella chiesa abusiva di Santa Rosa, conforto e forse anche consiglio nella parola del loro parroco, don Vito Guaragna, hanno pregato e invocato il soccorso di Padre Pio: che veda e interceda almeno lui dal cielo, il Beato, che faccia il miracolo d’ allontanare dalle loro case abusive quelle crudeli macchine della ragione dello Stato, poiché già, racconta il parroco, fra gli espropriandi, un uomo è morto di crepacuore e una donna, ricevuto l’ avviso di esproprio, è entrata in coma… I bulldozer hanno abbattuto qualche «scheletro», qualche casa non completata, ma sono rimasti poi con la terribile lama sospesa a mezz’ aria di fronte alle case occupate. «Non siamo abusivi – dice uno dei proprietari – ma costruttori spontanei». E il leader della protesta, che ha guidato un corteo reggendo uno stendardo con l’ immagine del frate di Pietralcina, si chiama Nunzio Speranza. Frase e nome che dilatano ancora di più il gioco pirandelliano, rimandano al paradosso, all’ assurdo della «Sagra del Signore della Nave». Agrigento, il Caos: in quel luogo empedocleo (il caos in cui i quattro elementi della natura, afferma l’ antico filosofo, per la forza della discordia si scompongono) non poteva che nascere Pirandello, nel teatro della sua Girgenti lo scrittore non poteva non cogliere l’ incessante dialettica, le verità contrastanti. In quell’ antica, classica città, che Pindaro chiama «splendida, la più bella delle città», sembra che a un certo punto la storia si arresti, che in quella opulenta Atene sul mare africano, in quella Sibari siceliota, i cui abitanti, si diceva, si dedicavano ai piaceri come se dovessero morire il giorno dopo e costruivano le case come se dovessero vivere per l’ eternità, sembra che sia avvenuta una inarrestabile, infinita decadenza: che lì sia cessato il campanelliano conato e che vi sia subentrata una stasi metafisica. Ma Agrigento, dopo tanto sonno, dopo tanta antica immobilità, all’ improvviso, nei recenti anni Sessanta si scuote, è presa da una frenetica febbre costruttoria. Costruiscono prima, gli agrigentini, sull’ antica Rupe, sopra il tufo che occultava il vuoto delle caverne. E avviene il disastro, il crollo dei nuovi palazzi. Quindi il cemento, non trovando più spazio in alto, scivola e invade la Valle: case e case, prime e seconde, chiese, alberghi, vengono costruiti in mezzo agli antichi templi. Gli amministratori comunali e costruttori, felici, s’ ingrassano, come i devoti della famosa «Sagra». Ma ora, nell’ attuale situazione di confronto, di contrapposizione, di scontro tra le ragioni o la ragione dello Stato e l’ emozione degli abusivi, siamo al dramma, che è sì pirandelliano, per quel che di umoristico ha in sé, ma che è anche l’ eterno, ricorrente, penoso dramma italiano, quello vale a dire di un Paese che sa che le leggi dello Stato ci sono sì, ma che si possono bellamente eludere, poiché tanto poi qualcuno, uomo politico o Padre Pio, penserà a far perdonare, a far assolvere. Racconta il parroco della chiesa abusiva della Valle dei Templi che una volta l’ onorevole Andreotti, ospite a Villa Athena, ammirando la Valle, avrebbe esclamato che là era tutto meraviglioso, che nessuna bruttura urbanistica la deturpava. La Villa Athena, da cui Andreotti avrebbe ammirato quella meraviglia, ricordiamo che fu, negli anni Sessanta, oggetto di dura polemica: era una vecchia masseria trasformata in albergo. E lo slogan, all’ inaugurazione, era stato: «Il tempio nella vostra stanza». Era vero. Se aprivi la finestra, ti trovavi «dentro la stanza» il tempio della Concordia.
Vincenzo Consolo
(17 gennaio 2001) – Corriere della Sera
Le interviste di ITALIALIBRI VINCENZO CONSOLO
«Devo dire che sono nato in una famiglia piccolo borghese…»
(Vincenzo Consolo)
Gli anni della formazione
Lei è nato in Sicilia nel 1933 sotto il regime fascista e a sette anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Che tipo d’infanzia ha vissuto?
Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Qual è il tema della sua tesi di laurea?
D. La prima domanda è questa: Lei è nato in Sicilia nel 1933 sotto il regime fascista e a sette anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Che tipo d’infanzia ha vissuto?
1933. Benito Mussolini tra la folla
evo dire che sono nato in una famiglia piccolo-borghese. Mio padre era un commerciante, lavorava insieme ai fratelli ed era stato l’unico trasgressore di quelle che erano le regole di comportamento della piccola borghesia di allora, in un paese siciliano. Si era innamorato di una ragazza che era di condizioni economiche un po’ inferiori alle sue. Era senza dote e suo padre voleva che sposasse un’altra ragazza. Mio padre ha insistito, ha voluto quella ragazza di cui si era innamorato e hanno fatto la famosa fuitina, sono scappati e poi hanno regolarizzato il matrimonio successivamente. Mi ricordava mia madre che si erano sposati in sagrestia perché quelli che facevano questo atto trasgressivo non potevano fare il matrimonio in chiesa. Hanno fatto poi otto figli, e questo è un segno del loro amore. Noi eravamo gli unici figli di questa autorità che era rappresentata dagli zii e dal nonno. Eravamo sovrastati da questa plurima autorità. Io ero il sesto di otto figli.
Mio padre non era un intellettuale, era un uomo di poca cultura, pratico, però aveva visto che i fascisti erano le persone meno rispettabili del paese, che sotto il regime avevano trovato la collocazione più giusta e l’alibi per i loro fallimenti personali. I ricordi più vividi sono del periodo della guerra quando, al momento dello sbarco degli americani in Sicilia, comincia il periodo dei mitragliamenti, dei bombardamenti e quindi la paura per queste forme che io bambino non riuscivo a capire. Sentivamo i mitragliamenti di notte, le incursioni e anche i bombardamenti dal mare. Le corazzate americane si piazzavano e bombardavano il paese e tutta la costa. C’era il terrore da parte mia. Per un bambino di quell’età – nel ‘42/’43 avevo 10/11 anni – era una violenza inaudita. Finalmente mio padre si convinse e ci trasferimmo in campagna. Lì mi sentii più rassicurato. Ci furono però dei morti anche in campagna perché le bombe venivano sganciate alla cieca. Mi ricordo la notte terribile, prima che arrivassero gli americani, di questi incessanti cannoneggiamenti, mitragliamenti, bombardamenti. Un mio zio mi fece vedere attraverso un cannocchiale i militari americani che scendevano dalla montagna di San Fratello e quindi ebbi la visione di questi liberatori. Andai con mio padre – ero un ragazzino curioso e petulante – in paese per vedere i danni subiti dalle nostre case. La strada del paese dove si affacciava la nostra casa era ingombra di macerie, fili della luce. Non c’erano state però ruberie. Mio padre, quando finimmo l’ispezione a casa nostra dove era crollato un pezzo di casa, mi disse: tu aspettami qui e non prendere niente in mano. Io ero lì immobile. Passò una colonna di americani. Vidi per la prima volta in vita mia un negro e rimasi sbalordito. Questo nero, vedendo lo stupore del bambino da solo sul marciapiede, mi tirò un tubetto di caramelle. Mi colpì sulla pancia, mi fece male, ma io incuriosito dapprima toccai il tubetto con il piede e poi lo presi in mano. Lo scartocciai e vidi che erano le caramelle con il buco. Quando venne mio padre non gli dissi di aver trasgredito il suo ordine di non toccare niente. Tornammo poi in campagna. Questi ricordi della guerra li ho trasferiti nell’ultimo mio libro, Lo spasimo di Palermo,una sorta di flashback.
Mi ricordo del secondo dopoguerra di noi ragazzini, come eravamo esposti a infiniti pericoli, a causa delle bombe sparse di qua e di là e la nostra occupazione preferita era quella di giocare con queste armi, con le micce che incendiavamo, le bombe a mano che buttavamo. Molti miei compagni sono rimasti segnati per la vita da questi giochi proibiti. Mi ricordo un compagno a cui era saltata una mano, un altro che era diventato cieco. Mi ricordo un ragazzino completamente bruciato perché aveva preso fuoco con le micce. Ho un ricordo terribile di queste ulteriori vittime, che erano i bambini, un po’ come in tutte le guerre. Frequentai la scuola media in un istituto religioso di salesiani dove c’era anche l’oratorio. Questa educazione cattolica forzata, i reduci che tornavano, queste sono le mie memorie che ho raccontato nel mio primo libro in cui mi sono liberato di questa memoria dell’infanzia, e che si chiamaLa ferita dell’aprile.
Finiti gli studi della scuola media la mia scoperta del mondo fu andando a studiare a 80 km dal mio paese dove frequentai il ginnasio e il liceo. Fu la rivelazione di un mondo nuovo e diverso. Barcellona era spagnola, catalana, sia di nome che di fatto, gli abitanti erano diversi da quelli del mio paese. Avevano un senso più libertario, erano delle persone più intraprendenti, meno ancorate a una geometria di accortezza, parca, che era il mondo del mio paese.
C’era un nucleo di anarchici e c’era un anarchico che era un professore di veterinaria dell’Università di Messina, un poeta, che era andato in carcere durante il periodo del fascismo e che poi aveva capeggiato, nel secondo dopoguerra, una rivolta di braccianti, aveva ingaggiato una battaglia con i carabinieri, i carabinieri sparando e lui colpendoli con le tegole del tetto di casa sua. E poi fu imprigionato e liberato dalla prigione da Togliatti che lo fece mettere in lista per le elezioni di ’48. Diventò poi deputato. Questo personaggio mi aveva molto affascinato ed è stato molto importante nella mia vita. Con il suo libertarismo mi aveva fatto conoscere un altro modo per leggere il mondo, un modo più libero, più libertario, soprattutto di opposizione a quelli che sono i periodi di dittatura, di oppressione e di repressione.
D. Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Qual è il tema della sua tesi di laurea?
«Sono capitato in uno scaglione di ex detenuti e di persone che facevano il militare in ritardo, perché magari erano andati all’estero ed erano tornati, quasi tutti analfabeti. Io diventai lo scrivano del plotone, scrivevo le lettere per le famiglie di questi militari».
(Vincenzo Consolo)
Gli anni della formazione
Lei è nato in Sicilia nel 1933 sotto il regime fascista e a sette anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Che tipo d’infanzia ha vissuto?
Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Qual è il tema della sua tesi di laurea?
D. Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Qual è il tema della sua tesi di laurea?
a tesi, in Filosofia del Diritto, riguardava la crisi dei diritti della persona umana, della dichiarazione della Società delle Nazioni – allora non si chiamava ancora ONU. Verteva sulla crisi di questi diritti dell’uomo. Non mi sono laureato all’Università Cattolica, bensì all’Università di Messina. Qui a Milano, all’Università Cattolica, ho fatto tre anni. Vi sono approdato non per convinzioni religiose ma casualmente, perché avevo desiderio di lasciare l’isola e conoscere il famoso continente. Il continente per noi siciliani era una sorta di mito. C’era stato il cognatino del mio fratello maggiore che era approdato prima di me alla Cattolica e quando in casa si fece la riunione per stabilire dove mandarmi a studiare, mio fratello maggiore disse: «Lo mandiamo a Milano», perché c’era il precedente del cognatino.
All’Università Cattolica c’erano molti studenti meridionali delle zone più depresse, della Calabria, della Lucania, della Puglia. Molti siciliani. Molti erano «a posto gratuito» perché avevano il certificato di povertà che rilasciavano i parroci. Questi miei compagni di scuola divennero poi, con gli anni, classe dirigente italiana. Molti eminenti uomini politici, democristiani, c’erano i fratelli De Mita, Gerardo Bianco, i fratelli Prodi. Era l’Italia che riprendeva le sue fila. Io sono arrivato a Milano nel ’52 e quindi era ancora una Milano che si stava ricostruendo dopo la ferita della guerra.
Poi ho dovuto interrompere gli studi per un disguido di carattere burocratico – non avevo presentato i documenti di iscrizione all’Università per avere l’esenzione militare – ero stato chiamato militare, sono dovuto partire e sono capitato in uno scaglione di ex detenuti e di persone che facevano il militare in ritardo, perché magari erano andati all’estero ed erano tornati, quasi tutti analfabeti. Io diventai lo scrivano del plotone, scrivevo le lettere per le famiglie di questi militari. Finito il periodo militare che allora era lunghissimo, durava 18 mesi, mi trasferii a Messina dove mi laureai con un professore di filosofia del diritto, uno che aveva fatto parte della Costituente, un socialista. Mi laureai. Come alibi, per ritardare l’impegno con il lavoro, mi mise a fare la pratica notarile, prima presso un notaio del paese e poi andai a fare la pratica presso mio cognato che era notaio a Lipari, e ho vissuto questa bella stagione di peregrinazione per le isole Eolie, dove andavamo a fare i contratti, testamenti, compravendite e così via. Non diventai notaio. Quegli anni mi servirono per coltivare quella che era la mia passione per la lettura. Fu in quegli anni che cominciai a scrivere il mio primo romanzo, La ferita dell’aprile.
D. Questo è il momento in cui ha maturato l’idea di diventare uno scrittore di professione?
«Capii attraverso le letture e l’aggiornamento attraverso le riviste letterarie, cosa era successo: la conclusione di un’estetica letteraria che andava sotto il nome di neorealismo e la possibile collocazione come scrittore sulla linea di una scrittura comunicativa oppure di una scrittura espressiva o sperimentale, che dir si voglia».
(Vincenzo Consolo)
L’avventura della scrittura
Questo è il momento in cui ha maturato l’idea di diventare uno scrittore di professione?
Cosa L’ha spinta a ritornare a Milano, nel 1968? Come all’inizio si guadagnava da vivere? E come questo ritorno a Milano ha influito sulla sua scrittura?
A questo punto, nella sua scrittura sono presenti dei percorsi che Lei stava già evolvendo. Ci può aiutare a individuarli?
Abbiamo detto che la scrittura di questo libro ha preso più di 10 anni…
D. Questo è il momento in cui ha maturato l’idea di diventare uno scrittore di professione?
ì, rifiutai di fare qualsiasi attività di leguleio, avvocato o fare concorso di giudice o notaio. Ho insegnato nelle scuole agrarie. L’insegnamento in scuole sperdute, in paesini di montagna, mi serviva per conoscere meglio il mondo contadino che io volevo raccontare. Negli anni in cui avevo deciso di fare lo scrittore, gli schemi, gli esempi, gli archetipi nostri erano da una parte Carlo Levi con Cristo si è fermato a Eboli e con il libro siciliano Le parole sono pietre, che parlano appunto dei due mondi contadino sotto il fascismo e dall’altra parte i miti di Pavese, diVittorini, soprattutto il Vittorini di Conversazioni in Sicilia. Io volevo conoscere questo mondo, volevo assolutamente rappresentarlo.
L’idea era di una scrittura di tipo sociologico, «alla Carlo Levi», però poi quando mi misi a scrivere, con la consapevolezza che acquisii di quello che era successo letterariamente prima che io cominciassi a scrivere, di quello che si stava svolgendo allora in Italia, in campo letterario, capii attraverso le letture e l’aggiornamento attraverso le riviste letterarie, cosa era successo: la conclusione di un’estetica letteraria che andava sotto il nome di neorealismo e la possibile collocazione come scrittore sulla linea di una scrittura comunicativa oppure di una scrittura espressiva o sperimentale, che dir si voglia. La mia opzione è stata sulla scrittura espressiva che aveva come archetipo un mio conterraneo, Giovanni Verga, che è stato il primo grande rivoluzionario stilistico nella letteratura moderna. Da lui si passava, attraverso altri scrittori, come Gadda e Pasolini di quegli anni. Pasolini nel ’61 aveva pubblicato il suo saggio sulla lingua italiana che si chiamava Nuove questioni linguistiche, dove diceva della trasformazione della lingua italiana. In parallelo, quello che era accaduto nel nostro Paese sul finire degli anni ‘50, inizio ’60, della grande trasformazione italiana, della grande emigrazione.
D. Cosa l’ha spinta a ritornare a Milano, nel 1968? Come all’inizio si guadagnava da vivere? E come questo ritorno a Milano ha influito sulla sua scrittura?
uesto mondo, l’ho espresso in parte con il mio primo libro, il libro dell’iniziazione La ferita dell’aprile, dove ho raccontato quello che era il clima sociale, politico del secondo dopoguerra, le prime elezioni regionali in Sicilia del ’47 e le elezioni del ’48. Sappiamo che in Sicilia si era perpetuato un sistema economico di tipo medioevale che era quello del latifondo e del feudalesimo. Già alla fine dell’800 si erano tentate delle riforme agrarie mai attuate. Il fascismo, trionfalisticamente, aveva cercato di adottare una riforma agraria che andava sotto il nome di «assalto al latifondo» ma era stato un inganno e una finzione. Nel secondo dopoguerra, queste istanze popolari, soprattutto del mondo contadino, si erano di nuovo ricreate. La storia di quegli anni è nota, restituita ormai dai libri di storia, dalla filmografia, l’ultimo film che abbiamo visto in questi giorni è stato Placido Rizzotto ma ci sono stati tanti «Placido Rizzotto» in Sicilia, tanti sindacalisti uccisi dalla mafia alleata con il potere degli agrari. Il movimento indipendentista siciliano cercò un escamotage per staccare la storia della Sicilia dalla storia italiana e farla diventare un’isola indipendente, dove il gioco del potere nella conservazione sarebbe stato più facile.
L’opposizione dei contadini a questo movimento indipendentistico culmina con la storia di Giuliano, il bandito ingaggiato da questi agrari indipendentisti, che insieme alla mafia gli avevano armato la mano per fare sparare sui contadini che a Portello delle Ginestre festeggiavano il Primo Maggio. Questo episodio riguardava l’elezione del ’47, in cui c’era stata la vittoria della sinistra che andava sotto il nome di «Blocco del popolo», seguita dal revanchismo della conservazione alle elezioni nazionali del ’48 e la vittoria della DC, grazie anche all’episodio della strage di Portello delle Ginestre, che aveva fatto da intimidazione alle forze progressiste. Io ho cercato di raccontare questo periodo della storia siciliana in questo mio libro. Poi si era attuata la riforma agraria, nel ’50, ancora una volta una riforma fittizia, perché i contadini assegnatari non avevano modo né strumenti né mezzi per coltivare queste terre, che erano terre che non davano profitto perché erano terre aride, dove mancava l’acqua. Così i contadini sono stati costretti a fare la loro valigia di cartone, a emigrare . E questo è stato il grande esodo meridionale.
Il mito del mondo contadino, mentre ero lì, mi era sparito sotto gli occhi. Il mondo contadino finiva, la gente era costretta ad andare, c’era questo famoso «treno del sole» che si riempiva di emigranti che arrivavano a Milano e venivano smistati nell’Europa centrale, nelle miniere del Belgio, in Francia e in Svizzera oppure andavano a Verona e venivano convogliati in Germania. Da contadini si trasformavano in operai e andavano nelle fabbriche del centro Europa, oppure rimanevano nel triangolo industriale nel Nord Italia. Ci sono tanti libri e inchieste su questa emigrazione interna nostra e su tutto quello che era avvenuto in quegli anni. Ho assistito alla fine, de visu, di questo mondo contadino e ho quindi visto l’inutilità del mio stare in Sicilia. Io volevo vedere da vicino questa grande trasformazione della realtà italiana.
Sollecitato anche da due intellettuali, Vittorini e Calvino, che allora pubblicavano una rivista che si intitolava «Menabò», che invitavano i giovani intellettuali italiani a studiare questa nuova realtà italiana, il processo di industrializzazione del nostro paese, l’inurbamento delle masse meridionali sono arrivato a Milano nel ’68 perché volevo vedere questa grande trasformazione. Mi sono inurbato e prima di partire mi sono consultato con due miei grandi amici, due persone assolutamente diverse e opposte come nascita. Erano due scrittori: uno era Leonardo Sciascia e l’altro era, un poeta, un barone, Lucio Piccolo di Cala Novella, che era cugino diLampedusa e che ho frequentato per tanti anni, perché abitava a Capo d’Orlando vicino al mio paese. È stato un grande maestro per me perché era un uomo sapientissimo, conosceva la letteratura e la poesia mondiale in un modo meraviglioso. Conosceva parecchie lingue, era stato scoperto da Montale, pubblicato da Mondadori. Quando decisi di partire, Sciascia mi spinse a partire, qui non c’è più speranza, se io fossi più giovane e non avessi famiglia partirei anch’io. Io ero più giovane, ero libero e quindi più disinvolto. Piccolo invece, che aveva una concezione romantica della letteratura, mi diceva: non parta, perché rimanendo lontani si ha più fascino, se raggiunge i centri culturali, lì diventa uno come tanti altri. Lui non pensava che potessi avere delle altre necessità, di vedere questo nuovo mondo che stava nascendo.
Sono arrivato a Milano nel ’68 perché volevo vedere questa grande trasformazione. Nel ’67 avevo fatto un concorso alla fatidica RAI. La chiamo fatidica perché gran parte degli scrittori sono passati attraverso questa grande madre corruttrice che è stata la RAI. Io feci questo concorso per funzionari e lo vinsi. Fummo in 5 su una pletora di concorrenti. Nel concorso si chiedeva tutto lo scibile umano: storia della letteratura, storia del cinema, del teatro, con una commissione molto ampollosa dove c’erano Strehler, Paolo Grassi, il Prof. Apollonio, dirigente della Rai, Leone Piccione e tanti altri. Sono stato assunto a 150.000 lire al mese e nel ’68 presi servizio alla sede di Milano.
D. A questo punto, nella sua scrittura sono presenti dei percorsi che Lei stava già evolvendo. Ci può aiutare a individuarli?
«Al di qua della morte, mentre siamo in vita, il dovere dell’intellettuale è quello di essere partecipe a quelli che sono i destini di infelicità dell’uomo, che risiedono nelle zone di marginalità della società, nelle classi meno privilegiate, meno abbienti, e quindi bisogna capire quali sono le condizioni di questi emarginati e perché questi emarginati in certi momenti tragici arrivano a dei gesti estremi».
(Vincenzo Consolo)
L’avventura della scrittura
Questo è il momento in cui ha maturato l’idea di diventare uno scrittore di professione?
Cosa L’ha spinta a ritornare a Milano, nel 1968? Come all’inizio si guadagnava da vivere? E come questo ritorno a Milano ha influito sulla sua scrittura?
A questo punto, nella sua scrittura sono presenti dei percorsi che Lei stava già evolvendo. Ci può aiutare a individuarli?
Abbiamo detto che la scrittura di questo libro ha preso più di 10 anni…
D. A questo punto, nella sua scrittura sono presenti dei percorsi che Lei stava già evolvendo. Ci può aiutare a individuarli?
uando io ho pubblicato il mio primo libro, La ferita dell’aprile, ero consapevole di cosa sarebbero stati gli argomenti della mia scrittura e cosa mi interessava. Mi interessava il mondo storico sociale, non mi interessavano i problemi personali o le indagini psicologiche. Mi interessava raccontare la Storia, la Sicilia e quindi ho proseguito su questa scelta di argomenti, privilegiando quelli che erano i temi storico-sociali. Mi collocavo anche come stile, come tipo di espressione, su una linea sperimentale e di tipo espressivo.
In quegli anni, negli anni in cui pubblicai il primo libro, era venuto alla ribalta il Gruppo avanguardistico «63», la cui prima riunione si era svolta a Palermo. C’erano nomi che sono poi diventati famosi: c’era Umberto Eco, Alberto Arbasino, Edoardo Sanguineti, Angelo Guglielmi. Io andai a sentire questi avanguardisti nel momento in cui avevo finito di scrivere il mio libro e mi convinsi, ascoltandoli, che non avevo niente da spartire con loro, la mia scelta era diametralmente opposta alla loro. Pasolini ha fatto una chiarificazione molto netta tra sperimentalismo e avanguardia, due cose assolutamente diverse tra loro. La mia scelta stilistica si poneva sul versante, della sperimentazione. Quindi i temi che sono confluiti nel mio secondo libro, Il sorriso dell’ignoto marinaio.
Lo sfondo del libro è storico. Rievoca il 1860, l’arrivo di Garibaldi in Sicilia, che doveva sottrarre al giogo del regno borbonico le zone meridionali, il Regno delle Due Sicilie, le speranze che si erano accese al suo arrivo, come i contadini siciliani avevano inteso l’Unità d’Italia. L’avevano intesa come trasformazione sociale. Finalmente sarebbe stata restituita loro la giustizia che gli era sempre stata negata. Il protagonista del mio libro era uno scienziato che si chiamava Mandralisca, un personaggio storico che, seppure nel passato, da giovane, avesse vissuto una vicenda da rivoluzionario risorgimentale (aveva partecipato ai moti rivoluzionari del ’48), poi invece si era rinchiuso nella sua casa di Cefalù e si era dato allo studio delle lumache. Era un collezionista d’arte perché la moglie era di Lipari, dove lui comprava o reperiva oggetti archeologici. La sua casa era diventata una sorta di museo. Ma soprattutto il barone possedeva un quadro: un ritratto di Antonello da Messina. Ho fatto convergere questi elementi per imbastire la mia narrazione, in cui il personaggio del mio romanzo, questo Barone di Mandralisca, si discosta dal Principe di Salina deIl Gattopardo, il quale guarda questi medesimi avvenimenti storici con estremo disincanto. Per il Gattopardo niente ha valore perché sempre c’è questo appuntamento col momento della morte, perciò i cambiamenti storici sono assolutamente inutili. C’era una visione metastorica in Salina. Io ho voluto dire il contrario: al di qua della morte, mentre siamo in vita, il dovere dell’intellettuale è quello di essere partecipe a quelli che sono i destini di infelicità dell’uomo, che risiedono nelle zone di marginalità della società, nelle classi meno privilegiate, meno abbienti, e quindi bisogna capire quali sono le condizioni di questi emarginati e perché questi emarginati in certi momenti tragici arrivano a dei gesti estremi. Cercare di capire quali sono i motivi che li spingono a tanto, loro che non hanno il potere della scrittura, perché la storia è una scrittura continua dei privilegiati, la storia la scrivono sempre quelli che vincono, e quindi era anche un meta-romanzo nel senso che la riflessione era anche sul potere della scrittura letteraria e quindi c’era un’impostazione stilistica e strutturale del libro che metteva in luce queste domande che allora si agitavano nei dibattiti culturali e sulle riviste letterarie.
D. Abbiamo detto che la scrittura di questo libro ha preso più di 10 anni…
Per la verità non è che tutta la stesura… la vicenda del Sorriso io avevo scritto i primi 3 capitoli e lì mi ero bloccato, non ero andato più avanti perché non volevo finire questo libro. Racconto questo episodio perché è interessante: mentre io ero giù in Sicilia e lavoravo al giornale «L’Ora», il giornale mi aveva mandato a seguire un processo in Corte d’Assise a Trapani, io dovevo fare la cronaca, e spedire da Trapani, perché c’era una redazione del giornale a Trapani, spedire due articoli. Spedire significava scrivere velocemente in albergo questi due articoli, uno di cronaca, del processo, e poi dirò di che processo si tratta, e uno di considerazioni, di riflessioni. Finiti gli articoli dovevo correre alla stazione per spedirli per treno, perché allora non si dettava al telefono, non c’erano i fax, eravamo ancora in un mondo arcaico.
Il processo era il processo al cosiddetto «Mostro di Marsala» ed era un tipo, uno di Marsala, un alienato che aveva ucciso tre bambine, che non aveva violentato, non era un caso di pedofilia. Questo criminale deficiente aveva preso queste tre bambine e le aveva buttate in una cava, dove erano morte di inedia. Un delitto inspiegabile. Il pubblico ministero in quel processo era un giudice che si chiamava Ciaccio Montalto, che è stato poi ucciso dalla mafia. La sua tesi era che il padre di una bambina, che si chiamava Valente, era un corriere della droga. A un certo punto lui aveva voluto smettere con questi legami, con questi che avevano il monopolio della distribuzione della droga, che erano i mafiosi, e quindi era emigrato in Germania. I mafiosi per fare tornare in Sicilia questo Valente avevano detto a questo deficiente di rapire la bambina. E la bambina usciva di scuola ed era in compagnia di altre due amichette. Lui aveva preso tutte e tre e avevano fatto una fine tragica. Questa era la tesi di Montalto. Un giorno, alla fine di una delle sedute di questo processo, Ciaccio Montalto mi fa segno di avvicinarmi e mi dà una pianta, dicendomi: questa è la pianta di casa mia, dove abito – abitava a Val d’Erice – stasera venga a cena che le voglio parlare. Venga da solo – c’era mia moglie con me. Mi sentivo già in un’atmosfera da romanzo poliziesco alla Sciascia, mi sembrava di vivere dentro un film di Francesco Rosi. La sera, con la mia piccola Dyane, andai a Val d’Erice, a cena da Ciaccio Montalto e lui, dopo cena – abbiamo parlato di letteratura, politica – mi disse: io ricevo minacce, sia con lettere anonime sia per telefono, minacce di morte, se mi capita qualcosa lei lo scriva. Fatto è che il processo finì, io tornai a Milano e dopo non so quanti anni questo poveretto viene ucciso, proprio nel momento in cui decide di lasciare la Sicilia e doveva essere trasferito in Toscana. Lui stava indagando sui rapporti di «Cosa Nostra» trapanese con la mafia americana, sul traffico della droga. Ciaccio Montalto viene fatto fuori e io lo scrivo sul «Messaggero» di Roma e scrivo questa vicenda di lui che mi aveva detto così. Io a Ciaccio Montalto avevo detto: «ma scusi, perché lo dice a me e non ai suoi superiori, ai magistrati?» e lui candidamente mi dice: dei miei superiori non mi fido. Quindi la situazione della magistratura era quella che era. Io ho raccontato la vicenda sul Messaggero e Sciascia allora era deputato a Roma e fa un’interrogazione alla Camera su questa vicenda che avevo raccontato. Il Ministro degli Interni, Rognoni, disse che non gli risultava che Ciaccio Montalto avesse ricevuto delle minacce anonime. Giacomo Ciaccio Montalto era un giovane straordinario, intelligente, colto. Dicevo, che mentre ero lì, mi arrivano le bozze dei primi due capitoli del mio libro che io avevo dato a uno stampatore di Milano che era un bancarellaio, un libraio di origine siciliana, si chiamava Manusei e volevo finire questo libro, volevo spendere questi due capitoli con questi due racconti in un’edizione numerata con un’incisione di Guttuso. Mi arrivano le bozze di questo libro e capita in Sicilia, in quel frangente, un mio amico che era Corrado Stajano. Arriva a Palermo con la moglie, mi telefona e con mia moglie e con lui ci incontriamo a Palermo. Avevo corretto le bozze e le consegno a lui da portare su a Milano a questo stampatore, lui legge questi due capitoli del libro e rimane molto colpito e scrive un articolo su «Il Giorno». Dopodiché io ricevo parecchie lettere da editori, fra cui anche Einaudi, e allora io sono stato costretto, tornando a Milano, a finire questo romanzo nell’arco di poco tempo e quindi dal terzo capitolo in poi la scrittura è stata molto più rapida, veloce.
D. Negli anni della neoavanguardia e della seconda rivoluzione industriale, sulle pagine di «Menabò», Calvino lanciava alla letteratura contemporanea la famosa «Sfida al labirinto», ossia al caos: invitava alla ricerca di soluzioni razionali di problemi dell’uomo o almeno di un «ordine mentale abbastanza solido per contenere il disordine», nella speranza di «saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, dargli spazio», così come scriveva nelle Città invisibili. A quel tempo qual era la sua posizione al riguardo?
«Si arrivava a una sorta di afasia, di impraticabilità della scrittura che era speculare (sia quella dei futuristi che quella del «Gruppo ‘63») alla pseudo afasia del potere. Erano due pseudo afasie che corrispondevano. Gli uni per impraticabilità di questo linguaggio, gli altri per occultamento della verità, perché il potere occulta sempre la verità».
(Vincenzo Consolo)
Poetica di Vincenzo Consolo
Negli anni della neoavanguardia e della seconda rivoluzione industriale, sulle pagine di «Menabò», Calvino lanciava alla letteratura contemporanea la famosa «Sfida al labirinto». A quel tempo qual era la sua posizione al riguardo?
Lei ha scritto diversi romanzi che sono stati definiti “storico-metaforici” e inRetablo (1976) scrive «Sembra un destino, quest’incidenza, o incrocio di due scritti…» Lei sente di rivivere nella scrittura la scrittura di altri autori e attraverso il romanzo storico le vicende del presente?
È questo un modello su cui sente sia impostata anche la sua vita?
Per tanti anni, nonostante la sua permanenza in una grande città del Nord Italia, Lei è stato soprattutto testimone di una realtà siciliana e insulare, insieme drammatica e malinconica. In quale punto e in quale delle sue opere sente che queste due realtà si siano avvicinate maggiormente?
D. Negli anni della neoavanguardia e della seconda rivoluzione industriale, sulle pagine di «Menabò», Calvinolanciava alla letteratura contemporanea la famosa «Sfida al labirinto», ossia al caos: invitava alla ricerca di soluzioni razionali di problemi dell’uomo o almeno di un «ordine mentale abbastanza solido per contenere il disordine», nella speranza di «saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, dargli spazio», così come scriveva nelle Città invisibili. A quel tempo qual era la sua posizione al riguardo?
a mia posizione era perfettamente aderente a quello che era stato il suggerimento calviniano. Io seguivo molto in quegli anni i temi che si dibattevano su questa rivista che era appunto «Menabò», pubblicata da Vittorini e Calvino.
Vittorini aveva visto soprattutto la trasformazione linguistica e pensava alla nascita di una nuova koinè dall’incrocio dei dialetti meridionali con quelli settentrionali. Lui aveva poca fiducia nei dialetti meridionali perché diceva che erano portatori di rassegnazione e anche di furbizia e corruzione morale. Non aveva tutti i torti perché i dialetti meridionali sono quasi sempre ammiccanti, eufemistici mentre lui trovava i dialetti del Nord Italia, proprio perché crescevano su una realtà sociale diversa, molto più espliciti e più leali, più comunicativi. Non immaginava Vittorini, come poi ha visto Pasolini, che su questa ipotetica koinè sarebbe poi sorta una super-koinè che sarebbe stato il nuovo italiano di tipo tecnologico e aziendale che i mezzi di comunicazione di massa, che allora esplodevano, avrebbe diffuso nel nostro paese, trasformando la lingua italiana.
Il suggerimento di Calvino di dare ordine al caos era un suggerimento del tipo razionalistico-illuministico e alla fine anche un suggerimento di ordine etico e morale. Perché io credo che questa sia la funzione dell’intellettuale e dello scrittore, quella di cercare l’ordine, la ragione di fronte al caos di sempre, non solo dell’epoca di cui parlava Calvino. Al contrario c’era in quegli anni un’avanguardia, rappresentata dal Gruppo ‘63, i cui esegeti, i cui teorici proclamavano che bisognava rompere i nessi di tipo semantico o di tipo sintattico perché questa frattura dei nessi, questo caos linguistico e strutturale rappresentava il caos della società. Uno di questi teorici era Angelo Guglielmi. Questo programma del Gruppo ‘63, non faceva altro che ripetere quello che era stato il programma dei futuristi, soprattutto di Marinetti, il quale aveva dettato un decalogo per poter accedere alla scrittura e proclamava: primo, abolire i verbi, mettere i verbi all’infinito, secondo, abolire gli avverbi; terzo, abolire non so che cosa. Si arrivava a una sorta di afasia, di impraticabilità della scrittura che era speculare (sia quella dei futuristi che quella del Gruppo ‘63) alla pseudo afasia del potere. Erano due pseudo afasie che corrispondevano. Gli uni per impraticabilità di questo linguaggio, gli altri per occultamento della verità, perché il potere occulta sempre la verità.
L’ha studiato molto bene Pasolini con il suo saggio del 1961 Nuove questioni linguistiche, prendendo come esempio del cambiamento linguistico italiano un brano del discorso di Aldo Moro nel momento significativo dell’inaugurazione dell’Autostrada del Sole. Si capiva che era un linguaggio tecnologico aziendale astratto dove quella che era la realtà e la logicità veniva messa in secondo piano – se c’era – veniva occultata da questo linguaggio assolutamente illogico, di tipo «caotico».
D. Lei ha scritto diversi romanzi che sono stati definiti “storico-metaforici” e in Retablo (1976) scrive «Sembra un destino, quest’incidenza, o incrocio di due scritti, sembra che qualsivoglia nuovo scritto, che non abbia una sua tremenda forza di verità, d’inaudito, sia la controfaccia o l’eco d’altri scritti». Per restare alla metafora di Retablo, che è poi la metafora del palinsesto, (che è poi la situazione dell’intellettuale contemporaneo «politically correct», che scrive sul retro di fogli già utilizzati) Lei sente di rivivere nella scrittura la scrittura di altri autori e attraverso il romanzo storico le vicende del presente?
ì. La scelta dei temi, che sono temi storici metaforici e la scelta di questo tipo di linguaggio che è un linguaggio di tipo palinsestico, che è una scrittura su altre scritture, è quello che distingue lo scrittore, del mio tipo, impegnato con la storia, impegnato con le vicende della società e d’altra parte anche uno scrittore di tipo sperimentale, molto attento alla forma, che non ha una scrittura di tipo razionalistico-illuministico. Voglio dire che gli scrittori illuministi come Moravia, Calvino, Sciascia usano, indifferentemente per qualsiasi tipo di argomento, questo strumento linguistico estremamente razionale, referenziale, comunicativo. Lo scrittore di tipo sperimentale usa un controcodice, che è un codice espressivo che tiene conto della tradizione letteraria e linguistica e quindi cerca di portare nella sua scrittura tutti gli echi che fanno parte della nostra tradizione letteraria. Gli avanguardisti al contrario operano una sorta di azzeramento dei linguaggi e su questo azzeramento poi costruiscono un linguaggio artificiale, che è quello di cui parlavo prima e che diventa un linguaggio poco praticabile e incomprensibile. Lei ha riportato quella frase di Retablo che è emblematica. Gli sperimentalisti tengono conto di quello che è la tradizione letteraria e su questa tradizione cercano di elaborare sperimentando e cercando di far coincidere quelle che sono le istanze del nostro tempo e di trasferirle sulla scrittura, di far coincidere cioè il libro con il tempo in cui opera, anche se il romanzo è di sfondo storico, in cui vi sia quella vitalità, quella gente che attualizza il romanzo storico attraverso la metafora e lo fa sembrare lo fa essere specchio della contemporaneità, del momento in cui lo scrittore si trova a rappresentare un fatto, a raccontare un evento. Il padre del romanzo storico nella letteratura italiana moderna è stato Alessandro Manzoni, lui ci ha insegnato cos’è il romanzo storico metaforico. Naturalmente c’è un’assoluta diversità tra i romanzi di Walter Scott da cui sembra che Manzoni abbia preso l’idea e I promessi sposi del Manzoni. In Scott non c’è metafora, sono delle storie romanzate, mentre il romanzo storico è un romanzo immediatamente metaforico perché si parla del passato per illuminare il presente perché i fatti di quel passato che si è scelto di raccontare somigliano terribilmente ai fatti della nostra contingenza, del nostro presente: Manzoni parlava del ‘600 per parlare dell’800 perché nell’800 c’erano gli stessi rischi C’erano i rischi delle stesse follie, degli stessi marasmi sociali, degli stessi fanatismi, delle stesse pesti, delle stesse condanne, delle stesse torture.
D. È questo un modello su cui sente sia impostata anche la sua vita?
«Il romanzo storico è un romanzo immediatamente metaforico perché si parla del passato per illuminare il presente perché i fatti di quel passato che si è scelto di raccontare somigliano terribilmente ai fatti della nostra contingenza, del nostro presente».
(Vincenzo Consolo)
Poetica di Vincenzo Consolo
Negli anni delle neoavanguardie e della seconda rivoluzione industriale, sulle pagine di «Menabò», Calvino lanciava alla letteratura contemporanea la famosa «Sfida al labirinto». A quel tempo qual era la sua posizione al riguardo?
Lei ha scritto diversi romanzi che sono stati definiti “storico-metaforici” e inRetablo (1976) scrive «Sembra un destino, quest’incidenza, o incrocio di due scritti…» Lei sente di rivivere nella scrittura la scrittura di altri autori e attraverso il romanzo storico le vicende del presente?
È questo un modello su cui sente sia impostata anche la sua vita?
Per tanti anni, nonostante la sua permanenza in una grande città del Nord Italia, Lei è stato soprattutto testimone di una realtà siciliana e insulare, insieme drammatica e malinconica. In quale punto e in quale delle sue opere sente che queste due realtà si siano avvicinate maggiormente?
D. È questo un modello su cui sente sia impostata anche la sua vita?
ì, la consapevolezza di sapere che la storia è maestra di vita anche se poi continuiamo a fare gli stessi errori. Se guardiamo la storia vediamo però che gli uomini, in un determinato momento, si sono comportati in un determinato modo, hanno fatto quegli errori e allora la consapevolezza storica può suscitare una certa saggezza, evitare gli errori, dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista collettivo. Questo nostro tempo è un tempo in cui il passato e la storia diventano uno scandalo, qualcosa da rimuovere e da cancellare, perché il potere politico ci impone di vivere in un infinito presente, dove non si ha consapevolezza del passato, della storia. Era Pasolini che parlava dello scandalo del passato, della rievocazione del passato e invitava a rievocarlo, a trasferirlo nel presente e questo passato diventa scandaloso e ingombrante, irritante da parte del sistema del potere. La letteratura in sé, in questo nostro contesto, è qualcosa di perturbante, qualcosa che crea scandalo perché non è dominabile.
D. Per tanti anni, nonostante la sua permanenza in una grande città del Nord Italia, Lei è stato soprattutto testimone di una realtà siciliana e insulare, insieme drammatica e malinconica. In quale punto e in quale delle sue opere sente che queste due realtà si siano avvicinate maggiormente?
ho espresso, ho cercato di raccontarlo nel mio libro L’olivo e l’olivastro che è un libro al di fuori della finzione narrativa, in cui il protagonista non ha nome. È scritto in terza persona ma si capisce che l’io narrante è il protagonista di questo viaggio nella realtà. Non c’è finzione letteraria. È un viaggio in Sicilia, una ricognizione della mia terra, vedere quali sono stati i processi di imbarbarimento, di perdita, di orrori. Però nel libro Ho raccontato la fuga, dopo un terremoto, quello della Valle del Belice nel ’68, l’anno in cui sono arrivato a Milano. Era un terremoto anche metaforico. Il ritorno del protagonista che non fa che verificare con questo viaggio in Sicilia, che le realtà, sia pure economicamente diverse, le realtà che si chiamano di desiderio sono assolutamente uguali. Si desiderano le stesse cose, si parla lo stesso linguaggio e quindi c’è l’omologazione assoluta, l’uniformità in tutte le dimensioni sia nella terra del terremoto sociale sia nella terra della ricchezza. Ci sono solo differenze economiche anche se Sicilia e Lombardia, se Sicilia Nord Est fanno parte dello stesso contesto di primo mondo. All’interno ci sono differenze: maggiore disoccupazione, meno consumi, ma quello che gli economisti chiamano la «offlimità», cioè i desideri provocati, indotti sono uguali sia al Nord che al Sud. Al Sud c’è forse più frustrazione perché i desideri non si possono soddisfare. Non si può avere la macchina o la cucina o la seconda casa. Al Nord ci sono altri tipi di infelicità. Il fatto di ridurre l’uomo soltanto alla dimensione del lavoro, della produzione e del consumo, dove non si aprono altri spazi, spiragli di libertà, come quella sorta di visione kafkiana della colonia penale. Le società sviluppate, affluenti, pagano duramente questo prezzo di venire condannate alla colonia penale. Ogni tanto mi viene di pensare alla società giapponese, a queste creature, questi uomini che vivono roboticamente in questa assoluta condanna al lavoro, al consumo senza nessuna libertà. Mi sono accorto, durante l’ultimo viaggio, come questa nostra nevrosi, questa alienazione, in Spagna non è arrivata del tutto. La gente ama ancora stare insieme, chiacchierare, andare nei bar, perdere tempo. Forse è dovuto al ritardo loro, alla dittatura di Franco, non c’è il dominio della televisione. La gente sta in mezzo alla strada, non si chiude in casa a vedere la tele. Eppure Madrid è una città fredda, è un clima continentale.
E quindi poi tutto questo l’ho trasferito con la finzione narrativa che diventa Lo spasimo di Palermo, questo ritorno nell’isola da parte di questo protagonista che si chiama Gioacchino Martinez, che ritorna nella sua Itaca, da cui era stato costretto a scappare. Sono due libri che bisogna mettere insieme, un primo e un secondo tempo.
D. Alcuni dei personaggi dei suoi romanzi si muovono al confine dell’afasia. Anche il protagonista de Lo spasimo di Palermo è chiuso nel silenzio e non riesce più a scrivere. Lei stesso ha affermato, riferendosi all’opera teatrale Catarsi, che scrisse nel 1989: «La tragedia rappresenta l’esito ultimo della mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Un esito in forma teatrale e poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite dell’intelligibilità, tenda al suono, al silenzio»…
«È necessario comunque scrivere, ma scrivere in una forma che sia non più dialogante, riducendo la parte dialogica, comunicativa , spostarsi sempre di più verso la parte espressiva, la parte poetica, perché la poesia è un monologo e quindi ti riduci nella parte del coro dove non puoi che lamentare la tragedia del mondo».
(Vincenzo Consolo)
Dalla parola al silenzio
Alcuni dei personaggi dei suoi romanzi si muovono al confine dell’afasia. Lei stesso ha affermato: «La tragedia rappresenta l’esito ultimo della mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Un esito in forma teatrale e poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite dell’intelligibilità, tenda al suono, al silenzio»…
Si può dire cheCatarsi non sia un esperimento isolato…
In un certo senso anche Lunaria era un esperimento?
Nel 92 Lei ha scritto Nottetempo casa per casa.
D. Alcuni dei personaggi dei suoi romanzi si muovono al confine dell’afasia. Anche il protagonista de Lo spasimo di Palermo è chiuso nel silenzio e non riesce più a scrivere. Lei stesso ha affermato, riferendosi all’opera teatrale Catarsi, che scrisse nel 1989: «La tragedia rappresenta l’esito ultimo della mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Un esito in forma teatrale e poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite dell’intelligibilità, tenda al suono, al silenzio»…
o sento molto che oggi lo scrittore è stato espulso dalla società e quindi non ha più parole per comunicare con questa società e quindi la tentazione è proprio l’afasia, nel senso che si è rotto il rapporto tra il testo letterario e il contesto situazionale. Questo tema dell’afasia l’ho espresso in questa mia operetta che si chiamaCatarsi dove prendevo spunto dalla morte di Empedocle e parlavo di un Empedocle moderno, contemporaneo, che tenta il suicidio sulle falde dell’Etna. È un Empedocle che si trova in una situazione estrema. Estrema perché è vicino al cratere di un vulcano ed estrema perché è sul punto di chiudere la sua vita con il suicidio. Quindi il suo linguaggio è un linguaggio che non è più comunicabile. Perché sono arrivato a questa conclusione? Perché penso che oggi il testo letterario, naviga nell’assoluta insonorità di un contesto situazionale. Non trova più il suo referente, non trova più l’ascolto. Portavo l’esempio della tragedia greca perché lì c’è un personaggio l’«Anghelos» (il messaggero) che arriva sulla scena e racconta agli spettatori presenti nella cavea un fatto accaduto in un altro momento, in un altro luogo. Da questo racconto, molto comunicativo, del messaggero, può avere inizio la tragedia, cioè i personaggi della tragedia si muovono e poi c’è il coro che commenta in un tono più alto, con un tono poetico e con il canto e con la danza commenta e lamenta l’azione scenica. Questo è la tragedia per esempio moderna di Euripide dove dice Nietsche ne La nascita della tragedia che c’è appunto nella tragedia di Euripide, in questa articolazione della tragedia del messaggero dei personaggi e del coro, c’è l’irruzione dello spirito socratico, c’è il ragionamento. Il ragionamento è quello del messaggero, che si rivolge ai personaggi della cavea. Oggi dico che nel nostro contesto, nella civiltà di massa, il pubblico della cavea non c’è più. La tragedia si svolge in un teatro vuoto. Non ci sono più spettatori. L’unico modo per rappresentare la tragedia è quella di relegarla nella zona del coro, con un lamentare e commentare la tragedia del nostro tempo in un tono alto, con una forma musicale. Cioè far agire soltanto quello che Nietsche chiama lo «spirito dionisiaco», che è proprio della poesia. Io credo che questa forma letteraria che si chiama romanzo, narrazione, oggi si possa praticare soltanto in una forma poematica. Non è più possibile praticare una scrittura comunicativa che era quella del messaggero, che era lo scrittore di una volta, che narrava e narrando faceva poi delle riflessioni sull’azione narrativa. Quello che faceva Manzoni con le sue riflessioni o tutta la letteratura dell’800. Era lo scrittore che interveniva con la sua autorevolezza e commentava la vicenda che stava raccontando. Oggi non si può più raccontare. Io contesto le teorie di Milan Kundera che considera il romanzo come una commistione di narrazione e filosofia. Io credo che questo spirito socratico, riflessivo e comunicativo oggi non sia più possibile. Credo che si possa narrare soltanto in forma poetica e quindi nella forma meno mercificabile e meno comunicabile possibile.
D. Si può dire che Catarsi non sia un esperimento isolato…
on è isolato perché poi questa idea l’ho sviluppata ed esplicitata maggiormente ne Lo spasimo di Palermo dove nell’epigrafe Prometeo incatenato dice: «Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore». Significativamente il protagonista è uno scrittore che ha praticato un tipo di scrittura sperimentale (naturalmente è autobiografico) espressiva che decide di non scrivere più perché arriva all’ultimo stadio della sua sperimentazione, non solo letteraria ma anche all’ultima esperienza della sua vita. Decide di tornare nell’isola da cui era partito e che aveva lasciato anni prima, dovuto a necessità, a distacco da una terra che era diventata invivibile, barbarica. Torna e trova la sua conclusione, la sua fine. È un Ulisse che viene ucciso dai Proci, da quelli che Pirandello ha chiamato «i giganti della montagna» che possono essere di qualsiasi tipo. Quindi è uno scrittore afasico, uno scrittore che decide di non scrivere in forma narrativa e di scrivere in altre forme: saggistica, ricerca storica… e si propone di fare delle ricerche su altri temi.
È necessario comunque scrivere, ma scrivere in una forma che sia non più dialogante, riducendo la parte dialogica, comunicativa , spostarsi sempre di più verso la parte espressiva, la parte poetica, perché la poesia è un monologo e quindi ti riduci nella parte del coro dove non puoi che lamentare la tragedia del mondo. Questa forma più alta che non sia la forma comunicativa. Parlo di forma non di contenuto, la forma poetica. Per questo la mia prosa è organizzata in senso ritmico, come se fossero dei versi.
D. In un certo senso anche Lunaria era un esperimento?
Ho scelto questo argomento degli anni ’20, della nascita del fascismo perché mi sembrava che nel momento in cui scrivevo il libro ci fossero tutti i segni che corrispondessero a quei segni di allora, nel senso di crisi delle ideologie, si parlava allora di riflusso e quindi insorgere di nuove metafisiche, di settarismi, … … si cominciava a parlare di new age e queste cose qui, che mi sembrano tutte forme di irrazionalismo che preludono – speriamo che non avvenga – a delle forme fascistiche di assetti politici di tipo fascistico».
(Vincenzo Consolo)
Dalla parola al silenzio
Alcuni dei personaggi dei suoi romanzi si muovono al confine dell’afasia. Lei stesso ha affermato: «La tragedia rappresenta l’esito ultimo della mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Un esito in forma teatrale e poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite dell’intelligibilità, tenda al suono, al silenzio»…
Si può dire cheCatarsi non sia un esperimento isolato…
In un certo senso anche Lunaria era un esperimento?
Nel 92 Lei ha scritto Nottetempo casa per casa.
D. In un certo senso anche Lunaria era un esperimento?
nche quello era un esperimento, nel senso che c’era un rifiuto. Questo l’ho sempre teorizzato e praticato, il rifiuto della forma romanzesca, perché credo che oggi non si possono scrivere romanzi. Chi scrive romanzi è in malafede o è ignorante. Voglio essere radicale, per un volta, credo che nel nostro contesto non si possa più praticare questa forma narrativa che è stata di nobilissima tradizione in Europa e non solo. In questa mia concezione della narrazione non romanzo si inquadrano queste due opere che vengono dette «teatrali» ma molto teatrali non sono, nel senso che non hanno una loro rappresentabilità ma sono opere da leggere. In Lunaria che è una sorta di racconto fantastico dove si riprende un tema leopardiano della caduta della luna che significa la caduta di una cultura, di una civiltà, non ho voluto adottare la forma narrativa e ho ridotto il racconto alla forma dialogica per cui fatalmente prendeva un aspetto teatrale. Quindi io nego che l’operetta possa essere rappresentata perché è un teatro di parola secondo il Manifesto pasoliniano, è un linguaggio molto alto e pieno di riferimenti culturali. È stato senz’altro rappresentato, ma io non parto da presupposti teatrali, parto da presupposti narrativi e dico che è una fiaba raccontata in forma dialogica, senza quelle parti diegetiche che ci sono nelle narrazioni tradizionali.
Io ho cercato di scrivere delle narrazioni nel modo in cui intende questo genere Walter Benjamin, un tipo di scrittura o di racconto che appartiene ancora a una società pre-borghese.
D. Nel 92 Lei ha scritto Nottetempo casa per casa.
uesto è il secondo momento della trilogia, dell’arco storico che ho voluto rappresentare. È un romanzo che si svolge negli anni ’20 e che vuole raccontare la nascita del fascismo vista da un paesino della Sicilia. Per la seconda volta mi sono trovato il paese di Cefalù come teatro per i miei personaggi. Personaggi storici veri e come sempre succede nei romanzi storici anche con personaggi di invenzione, come diceManzoni, personaggi che debbono avere il colore del tempo. La vicenda è presto detta: c’è una famiglia che si chiama Marano, il protagonista è un giovane maestro di scuola che si chiama Pietro Marano. Ho adottato questo nome perché ha due significati per me. Marano significa marrano, cioè è l’ebreo costretto a rinnegare la sua religione e a cristianizzarsi, perché in Sicilia con la cacciata degli Ebrei nel 1492 – così come in Spagna, – ci furono quelli che andarono via ma anche quelli che rimasero e furono costretti a convertirsi. È stata una forma di violenza. Ho dato il nome di Marano a questa famiglia con questa memoria di violenza iniziale e poi per rendere omaggio allo scrittore Jovine che chiama il suo personaggio principale Marano ne Le terre del sacramento, quindi è un omaggio a una certa letteratura meridionalista. Questo maestro ha una famiglia infelice, malata, perché oltre alla memoria genetica di questa violenza iniziale della costrizione a cambiare cultura e religione, c’è anche il passaggio di classe di questa famigliola che da contadina diventa famiglia di piccoli possidenti, grazie a un eccentrico signore locale, un barone, un libertario, un tolstojano, che aveva privilegiato questa famiglia, piuttosto che il nipote, che era un perfetto imbecille, uno di questi baronetti di provincia. Questo cambio di classe da contadini a piccoli proprietari terrieri li porta a dover ubbidire alle regole della piccola borghesia, per cui i comportamenti devono essere assolutamente diversi, il padre si ammala di depressione, che nel mondo contadino arcaico viene chiamata licantropia. Questo fenomeno è stato studiato dalla principessa di Lampedusa, che era una psicanalista che ha associato la licantropia alla depressione: nel mondo rurale questi poveretti che soffrivano terribilmente, uscivano fuori di casa, magari urlavano e venivano scambiati per lupi mannari. Il padre di questo ragazzo soffre di depressione, malinconia e, preso da questo lacerante dolore dell’esistere, la notte esce. La sorella che si chiama Lucia non può sposare il giovane pastore di cui è innamorata perché non appartiene più alla sua classe e quindi c’è questa sorta di mutilazione sentimentale e la ragazza impazzisce. Il ragazzo si trova di fronte a questa infelicità familiare e immagina – in questa sua solitudine, nel sopportare questo peso di dolore – che in una società più giusta e più armonica, questo dolore privato e familiare si possa distribuire nella società, trovare consolazione nella società. Quindi abbraccia il credo socialista di quegli anni e trova inganno anche lì perché trova dei massimalisti, degli estremisti che lo portano verso deviazioni per cui questo giovane maestro è costretto a scappare e a rifugiarsi in Tunisia, esule, perché ricercato dalla polizia. Intanto fallisce il socialismo in questo primo dopoguerra, c’è la crisi delle ideologie, una crisi sociale, disoccupati, reduci che reclamano diritti e c’è un decadentismo culturale, l’insorgere di nuove metafisiche, di sette religiose. Un personaggio emblematico è un inglese satanista che approda a Cefalù, dopo una vita di peregrinazioni per il mondo inseguendo questi esoterismi, e immagina che a Cefalù, creando una chiesa, l’Abbazia di Telema, si possa soppiantare il cristianesimo ed instaurare l’era di Satana. Questo personaggio inglese che si chiamava Aleister Crowley, che aveva conosciuto tutti i maggiori intellettuali dell’epoca, del primo dopoguerra, da Ferdinando Pessoa a Yates a Katherine Mainsfield, faceva parte di sette segrete, era approdato in Sicilia. Questo personaggio storico è simbolico di un certo decadentismo culturale, dell’insorgere in certi momenti di crisi ideologica, di nuove metafisiche, di nuovi misticismi sia di segno nero sia di segno bianco. Quando si sceglie un argomento storico non è che si sceglie a caso. Io ho scelto per Il sorriso dell’ignoto marinaio il 1860 perché mi sembrava che il tempo corrispondesse al tempo che stavamo vivendo in Italia negli anni ’70 e ho scelto questo argomento degli anni ’20, della nascita del fascismo, perché mi sembrava che nel momento in cui scrivevo il libro ci fossero tutti quei segni che corrispondessero ai segni di allora, nel senso di crisi delle ideologie, si parlava allora di riflusso e quindi insorgere di nuove metafisiche, di settarismi, si cominciava a parlare di new age e queste cose qui, che mi sembrano tutte forme di irrazionalismo che preludono – speriamo che non avvenga – a delle forme fascistiche di assetti politici di tipo fascistico. Ho cercato di raccontare cosa sono i decadentismi culturali e cosa sono le forme politiche che insorgono quando ci sono queste forme di decadentismo culturale e di crisi ideologiche.
D. Lei, Consolo, è considerato uno scrittore “colto”, intendendo il collegamento e l’intertestualità della sua scrittura con la scrittura di altri grandi scrittori, Gadda,Verga, Pirandello, Sciascia, Manzoni e così via. Per poter apprezzare pienamente la sua scrittura occorre avere una padronanza di questa mappa letteraria. A quale lettore ideale Consolo scrittore pensa quando scrive?
«Io penso a un lettore che mi somigli, che sia simile a me, che abbia lo stesso tipo di conoscenza».
(Vincenzo Consolo)
La questione linguistica
Lei, Consolo, è considerato uno scrittore “colto”. Per poter apprezzare pienamente la sua scrittura occorre avere una padronanza di questa mappa letteraria. A quale lettore ideale Consolo scrittore pensa quando scrive?
In un’intervista Dacia Maraini ha affermato: « [La] separazione tra lingua scritta (l’italiano delle Accademie) e lingua parlata (il dialetto) ha impedito lo svilupparsi di una letteratura realmente popolare e nazionale». Lei ha dato la sua adesione alManifesto in difesa della lingua italiana.Non pensa che ogni intervento di tipo dirigistico non faccia altro che mantenere questa situazione e aggravarla?
In un articolo sulla rivista «Autodafé» Lei riporta questa citazione di Roland Barthes: «la lingua non è né reazionaria né progressista: è semplicemente fascista, il fascismo infatti non è impedire di dire ma obbligare a dire»…
A sei mesi di distanza dalla presentazione del «Manifesto in difesa della lingua italiana » ha rilevato sintomi che fanno presagire un’inversione di tendenze nell’uso dell’italiano?
D. Lei, Consolo, è considerato uno scrittore “colto”, intendendo il collegamento e l’intertestualità della sua scrittura con la scrittura di altri grandi scrittori: Gadda,Verga, Pirandello, Sciascia, Manzoni e così via. Per poter apprezzare pienamente la sua scrittura occorre avere una padronanza di questa mappa letteraria. A quale lettore ideale Consolo scrittore pensa quando scrive?
o penso a un lettore che mi somigli, che sia simile a me, che abbia lo stesso tipo di conoscenza. Io credo che capiti a tutti gli scrittori di immaginare un altro da sé, che sia un suo doppio. Calvino addirittura diceva che lui pensava a un lettore che la sapesse più lunga di lui. Qui c’è tutta l’ironia calviniana. Lui pensava a un lettore che avesse la stessa consapevolezza, la stessa conoscenza della letteratura che aveva lui ed era molto difficile. Io penso a uno che sia veramente il mio doppio che abbia la mia stessa storia, la mia stessa cultura, le mie stesse letture che faccia parte di una stessa sfera culturale. Quello che non mi riesce di fare, perché mi sembra ingannevole, è di essere condiscendente, di mettere in atto delle cose, delle strategie che diventano delle trappole, questi sono confini che non riesco a valicare. Questa rigidità però paga poco.
D. In un’intervista a «La Libreria di Dora» Dacia Maraini ha affermato: « [La] separazione tra lingua scritta (l’italiano delle Accademie) e lingua parlata (il dialetto) ha impedito lo svilupparsi di una letteratura realmente popolare e nazionale». Lei ha dato la sua adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione «La bella lingua» che si è concretizzata nel Manifesto in difesa della lingua italiana. Non pensa che ogni intervento di tipo dirigistico non faccia altro che mantenere questa situazione e aggravarla?
ì, io non credo al dirigismo nella lingua. I francesi hanno tentato in tutti i modi di arginare l’invasione dell’americano con il solito loro sciovinismo, Nell’introduzione del mio libro avevo adottato un vocabolo inglese che si adattava benissimo al contesto, al tipo di racconto. L’hanno censurato e hanno messo un vocabolo francese.
La mia adesione a quel movimento per la salvaguardia della lingua italiana era un po’ mettere un allarme, di dire: stiamo attenti che questa nostra lingua sta sparendo. E in effetti è così. C’è però, paradossalmente, da una parte l’invasione della nostra lingua, che è una lingua fragile, perché la nostra è una società fragile dal punto di vista economico, rapportato ai paesi più potenti. Noi non abbiamo dei bacini di utenza della nostra lingua vasti come quelli inglesi o come quelli spagnoli. Non abbiamo avuto colonie, per fortuna, e quindi l’italiano si parla solamente in questa nostra piccola penisola. Dove avviene che con la rivoluzione tecnologica, con lo sviluppo economico questa nostra lingua, che è una lingua bellissima, una lingua complessa, forse una delle lingue più belle che esistano al mondo, che è una lingua complessa, è anche una lingua fragile, che sta per essere invasa da lingue che non appartengono alla nostra storia.
La bellezza della nostra lingua risiedeva nel fatto che aveva due affluenti: la lingua colta delle accademie, la lingua di cultura, quella che Dante chiama «la lingua grammaticale» e dall’altra parte le lingue popolari, i dialetti, che confluivano verso la lingua centrale. Due affluenti che determinavano un arricchimento continuo.
Oggi questi due canali sembra che si siano essiccati e così la nostra lingua è diventata una lingua orizzontale, rigida e anche fragile perché invasa da un super-potere che è un potere economico, che non è il nostro. Questa lingua viene assunta così, senza nessuna critica, matericamente da alcuni scrittori, soprattutto giovani, che non tengono più conto di quello che è l’aspetto linguistico. Da una parte abbiamo questo tipo di letteratura giovanile, giovanilistica, che diventa quasi una scrittura di tipo verbale, che mi ricorda un po’ i neonaturalisti, se si può usare questo termine, di assumere passivamente sulla carte quelli che erano i segni della società, senza nessun vaglio, nessuna ricreazione. Dall’altra c’è il bisogno, da parte di scrittori ma soprattutto dei poeti, di non praticare questa lingua e usare un’altra lingua, che è una lingua di ricerca, che è assolutamente diversa dal gergo di consumo che usiamo normalmente per cui un personaggio come Edoardo Sanguineti che viene dal Gruppo 63 può paradossalmente dichiarare di «fare l’elogio della lingua di Maurizio Costanzo» (popolare conduttore televisivo ndr), proclamando contemporaneamente che la lingua letteraria italiana, di alcuni scrittori italiani, credo del mio tipo, o di tipo sperimentale o meno, è una lingua paludata.
Questa esigenza di una lingua ormai impraticabile la sentono di più i poeti, infatti oggi i poeti sono tornati a scrivere in dialetto, che non è il dialetto che usavano i poeti dialettali, oggi si chiamano poeti «in dialetto” perché lo scelgono con molta consapevolezza e molto rigore per la necessità di trovare una lingua altra che non sia l’italiano impraticabile di oggi. Quando Pasolini scriveva in friulano, allora c’era una realtà dialettale che era quella della sua regione, fortemente connotata linguisticamente perché non era un dialetto ma quasi una lingua, il ladino o friulano che si parlava nella sua zona. L’adozione per esempio del romanesco o la polifonia gaddiana, questo orchestrare tutti i dialetti, perché sentivano che la lingua italiana era fortemente compromessa con il dannunzianesimo, aveva altri tipi di compromissioni, quindi perGadda c’era l’esigenza di orchestrare la polifonia dialettale italiana.Leopardi diceva che la ricchezza della nostra lingua stava nel fatto che non era una sola lingua ma tante lingue.
D. In un articolo sulla rivista «Autodafé» Lei riporta questa citazione di Roland Barthes: «la lingua non è né reazionaria né progressista: è semplicemente fascista, il fascismo infatti non è impedire di dire ma obbligare a dire»…
Portavo l’esempio anche di una mia esperienza personale nel secondo dopoguerra in questo saggio su «Autodafé», di come i preti all’oratorio dove ho frequentato le scuole medie ci impedivano di parlare in dialetto».
(Vincenzo Consolo)
La questione linguistica
Lei, Consolo, è considerato uno scrittore “colto”. Per poter apprezzare pienamente la sua scrittura occorre avere una padronanza di questa mappa letteraria. A quale lettore ideale Consolo scrittore pensa quando scrive?
In un’intervista Dacia Maraini ha affermato: « [La] separazione tra lingua scritta (l’italiano delle Accademie) e lingua parlata (il dialetto) ha impedito lo svilupparsi di una letteratura realmente popolare e nazionale». Lei ha dato la sua adesione alManifesto in difesa della lingua italiana.Non pensa che ogni intervento di tipo dirigistico non faccia altro che mantenere questa situazione e aggravarla?
In un articolo sulla rivista «Autodafé» Lei riporta questa citazione di Roland Barthes: «la lingua non è né reazionaria né progressista: è semplicemente fascista, il fascismo infatti non è impedire di dire ma obbligare a dire»…
A sei mesi di distanza dalla presentazione del «Manifesto in difesa della lingua italiana » ha rilevato sintomi che fanno presagire un’inversione di tendenze nell’uso dell’italiano?
D. In un articolo sulla rivista «Autodafé» Lei riporta questa citazione di Roland Barthes: «la lingua non è né reazionaria né progressista: è semplicemente fascista, il fascismo infatti non è impedire di dire ma obbligare a dire»…
a trovavo quanto mai attuale. Portavo l’esempio anche di una mia esperienza personale nel secondo dopoguerra in questo saggio su «Autodafé», di come i preti all’oratorio dove ho frequentato le scuole medie ci impedivano di parlare in dialetto. Ed era un retaggio del periodo fascista perché il fascismo voleva cancellare i dialetti e dare una lingua unica a questo paese. Dare una lingua unica a una società che unica non è, che armonica non è… Questo si è potuto verificare in alcuni paesi dove c’era armonia sociale, per cui si è creata una lingua unica, uguale per tutti, senza queste digressioni dialettali, mi riferisco a un paese come la Francia. L’affermazione di Barthes scaturiva da un’affermazione di Renard, che diceva che la lingua francese è incapace di assurdi, di paradossi, perché è una lingua razionale, ma vivaddio è una lingua democratica, contestandola. Barthes diceva che la lingua in sé, il codice linguistico non è reazionario, né progressista, è semplicemente fascista. Appunto perché il codice linguistico che ci è imposto, ci impone di parlare in un determinato modo. Oggi più che mai la lingua che noi usiamo è una lingua fascistica perché appunto è elaborata soltanto dal potere economico e quindi dalla tecnologia. Oggi la lingua la impone il sig. Gates. I ragazzini assorbono tutta l’idiozia dei messaggi pubblicitari, nel linguaggio quotidiano ripetono passivamente questi messaggi. Quello è fascismo. Non sono linguaggi elaborati da loro, loro li ripetono come delle macchine, dei pappagalli.
D. A sei mesi di distanza dalla presentazione del «Manifesto in difesa della lingua italiana » ha rilevato sintomi che fanno presagire un’inversione di tendenze nell’uso dell’italiano?
on ci sono sintomi. Mi fa impressione sentire – in confronto all’analisi che aveva fatto Pasolini sul politichese di Aldo Moro, su questa lingua astratta di tipo tecnologico aziendale – sentire i discorsi dei giovani politici di oggi. Già Aldo Moro aveva un background di tipo umanistico. Sentire oggi parlare signori come Berlusconi [Berlusconi Silvio, cavaliere, magnate dei mezzi di comunicazione, deputato, controverso fondatore del partito-azienda «Forza Italia» ndr], sembra di ascoltare il linguaggio dei robot. I suoi slogan, mi sembrano appartenere a un linguaggio robotico, pubblicitario, di assoluta forza persuasiva, con un’articolazione ridotta al minimo. I nessi sintattici sono pressochè inesistenti. Non c’è articolazione di pensiero, sono solo affermazioni apodittico che servono solo a intimidire e a persuadere. Così erano gli slogan che aveva coniato il nostroD’Annunzio per il Sig. Mussolini. Erano delle urla, delle frasi che cercavano di intimidire e persuadere.
D. Che origine ha e come si colloca l’influenza artistico visiva sulla sua opera e che reazione generò questo suo avvicinamento al mondo della storia dell’arte? Come si è sviluppato a come prosegue ai giorni nostri?
«Man mano negli anni ho capito che la visualità, la pittura, era per me un modo per fare da contrappeso alla mia ricerca stilistica nel campo della scrittura, nel senso che io inseguo una sorta di musicalità della frase, della prosa, di dare una scansione, un tempo, un ritmo alla frase, di modo che la mia scrittura si avvicina molto a quella che è la scrittura poetica e di bilanciare questa sonorità con una parte visiva, di creare una sorta di equilibrio fra suono e visione».
(Vincenzo Consolo)
Letteratura e arte figurativa
Che origine ha e come si colloca l’influenza artistico visiva sulla sua opera e che reazione generò questo suo avvicinamento al mondo della storia dell’arte? Come si è sviluppato a come prosegue ai giorni nostri?
Quale luogo scenario, ambiente interno o esterno, ricorre più frequentemente nei suoi romanzi e che funzione/valore viene ad assumere nei suoi testi?
D. Che origine ha e come si colloca l’influenza artistico visiva sulla sua opera e che reazione generò questo suo avvicinamento al mondo della storia dell’arte? Come si è sviluppato a come prosegue ai giorni nostri?
Raffaelo, Lo spasimo di Palermo (dettaglio)
a avuto un’importanza enorme l’arte visiva, la pittura. Io sono nato in una sorta di deserto culturale, in un paesino della provincia siciliana dove non c’era una biblioteca, una pinacoteca, niente, insomma. Le uniche cose che vedevo erano le pitture religiose nelle chiese, per le quali non avevo molta attenzione. Da ragazzino andavo in villeggiatura a Cefalù e per la prima volta varcai un museo, il Museo Mandralisca, come il protagonista del mio romanzo e per la prima volta mi sono trovato davanti a questo ritratto di Antonello da Messina che mi impressionò molto Io ero un adolescente, avrò avuto 15-16 anni. Mi impressionò molto perché era un ritratto enigmatico un po’ sul tipo della Gioconda. Quando uno si trova davanti a questo quadro ci sono delle cose che ti muovono, che ti impressionano, che ti emozionano. Io non sapevo spiegare perché il sorriso di questo ignoto signore, detto popolarmente «l’ignoto marinaio», mi incuriosisse tanto. Perché notavo delle fisionomie che mi erano familiari: poteva essere la faccia di mio padre, dei miei zii, di mio nonno, era il tipo mediterraneo. Questo sguardo acuto del personaggio e questo sorriso ironico era un archetipo.
Da lì cominciò la mia curiosità nei confronti della pittura. Quando venni a studiare a Milano cominciai a frequentare le gallerie, le pinacoteche, ero molto incuriosito dalla pittura. Poi il ritratto di Antonello diventò per me un elemento di narrazione molto importante, fa da filo conduttore di tutto il romanzo (Il sorriso dell’ignoto marinaio NdR), e poi man mano negli anni ho capito che la visualità, la pittura, era per me un modo per fare da contrappeso alla mia ricerca stilistica nel campo della scrittura, nel senso che io inseguo una sorta di musicalità della frase, della prosa, di dare una scansione, un tempo, un ritmo alla frase, di modo che la mia scrittura si avvicina molto a quella che è la scrittura poetica e di bilanciare questa sonorità con una parte visiva, di creare una sorta di equilibrio fra suono e visione. Questa era l’esigenza.
In Retablo c’è addirittura un pittore come protagonista del romanzo, ma anche in Nottetempo, casa per casa c’è ancora il ritorno di Antonello da Messina, e ci sono anche altri riferimenti pittorici.
Ne L’olivo e l’olivastro ci sono due squarci narrativi, dove si entra nella finzione letteraria. Uno è il racconto della fuga di Caravaggio dall’Isola di Malta quando approda in Sicilia, arriva a Siracusa e gli viene commissionato dal Senato il Seppellimento di Santa Lucia. Io cerco di raccontare in forma narrativa questo soggiorno a Siracusa di Caravaggio, il momento in cui lui dipinge questo grande quadro che oggi si trova al Museo Bellomo. Infine poi ne Lo spasimo di Palermo c’è un quadro di Raffaello che si chiama Lo spasimo di Sicilia, un quadro che Raffaello aveva dipinto per la chiesa degli Olivetani di Palermo e che poi andò al re di Spagna Filippo IV ed ora si trova al Prado. Questo quadro commissionato dai padri olivetani era destinato alla chiesa che si chiama «Lo spasimo di Palermo». Raffaello intitolò il quadro Lo spasimo di Sicilia e questa parola «spasimo» prende una connotazione quasi universale, lo spasimo del mondo, quello che è il dolore del mondo.
D. Quale luogo scenario, ambiente interno o esterno, ricorre più frequentemente nei suoi romanzi e che funzione/valore viene ad assumere nei suoi testi?
è questo ipogeo, c’è la visione dell’ipogeo continuamente e credo che sia dovuto al fatto che io cerco di partire sempre dalle radici più profonde e quindi anche le immagini di questi luoghi sotterranei, di queste caverne, siano un po’ il corrispettivo della profondità della lingua e della profondità della storia. Andare fino alle radici per poi risalire verso le zone della comunicazione, le zone della società. Sono luoghi che mi hanno sempre affascianto. È indecente raccontare i propri sogni, però devo dire che un mio sogno ricorrente è un sogno archeologico, un sogno che poi ho scoperto faceva anche il padre della psicanalisi assieme a Freud che era Jung. Nel sogno io mi calo in dei sotterranei dove scopro degli oggetti antichi, vasi o rotoli di pergamena, che mi danno molta gioia. Ho interpellato un mio amico psicanalista e mi ha detto che è un sogno positivo e quindi evidentemente questo sub-conscio emerge nella mia scrittura. La mia ricerca linguistica anche in quel senso, io cerco le parole che vengono da lontananze storiche, di lingue antiche, greco, latino, arabo e quindi c’è questo bisogno di ripartire dalla profondità. In tutti i miei libri c’è l’evocazione di questi luoghi sotterranei.
D. Arriviamo all’attualità…
Non pensa che sia la faziosità nevrotica a condannare i cittadini alla dipendenza da personaggi incapaci o corrotti? E infine non pensa che questa stessa faziosità fosse già insita nel DNA degli italiani, quando si fronteggiavano Guelfi e Ghibellini?
Mauro, il figlio terrorista de Lo spasimo di Palermo si fa portare in carcere arance e libri. Quali libri chiederebbe che le si portassero in un’analoga situazione?
Emilio Tadini sostiene che il sistema attuale e dell’editoria e della distribuzione, puntando sui bestseller, abbia finito per escludere i testi di valore – testi, invece, che vengono accolti da Internet, dove vi sono siti che grazie alle loro migliaia di contatti stanno creando intorno al Testo una comunità capace di discutere e di «abbozzare ciò che noi si chiamerebbe “ critica”». Qual è la sua opinione al riguardo?
Lei, vive con un disagio gli intervalli, talora anche consistenti, che intercorrono tra l’uscita dell’uno e l’altro dei suoi romanzi?
Il teatro non è un genere che Lei abbia esplorato gran ché. Come mai?
D. Arriviamo all’attualità. Lei sembra vivere la politica in maniera viscerale. Siamo alla vigilia di un’elezione che verrà vinta al 90% dall’opposizione. Non pensa che sia a destra sia a sinistra in Italia sembri contare di più la fedeltà ad oltranza ad uno schieramento (o lo spregio per uno schieramento opposto) che la capacità di determinare l’effettiva competenza e affidabilità di una squadra di governo? Non pensa quindi che sia proprio questa faziosità nevrotica a condannare i cittadini alla dipendenza da personaggi incapaci o corrotti? E infine non pensa che questa stessa faziosità fosse già insita nel DNA degli italiani, quando si fronteggiavano Guelfi e Ghibellini?
Orologio geo-politico
La copertina di questo autorevole settimanale britannico, in edicola nei giorni in cui è esce l’intervista, colloca l’Italia, di fronte all’incognita del voto del maggio 2001, in un’atmosfera di evidente apprensione, condivisa anche dalla comunità internazionale.
ontesto il fatto che io viva in modo viscerale la politica. Ho sempre cercato di esercitare la razionalità, ho avuto sempre i miei principi politici e la mia ideologia nella quale ho sempre creduto e ho cercato di interpretare la mia azione nella società rimanendo fedele alla mia ideologia. Sono stato e sono un marxista, più gramsciano che marxiano. Penso che questo sia un Paese che non ha mai avuto un’effettiva democrazia. Parlavamo poco fa della mancanza di una società. È un Paese che vive in una sorta di immobilismo seicentesco, in una sorta di eterno controriformismo. Facciamo dei passettini avanti nel senso della democrazia e della uguaglianza e poi immediatamente c’è una sorta di ritorno indietro e tutto questo diventa disperante.
Da qui nasce la faziosità della nostra civiltà ancora comunale di guelfi e ghibellini e da questa continua crisi italiana nascono i mestatori, i profittatori, gli opportunisti, i vili, i trasformisti, i delatori e tutto quanto di orrore c’è in questo paese. Non siamo arrivati con la dittatura fascista alla teorizzazione dell’orrore assoluto come in Germania, però si sono scatenati in questo Paese tutte le meschinità, le vigliaccherie, con l’avvento della dittatura fascista, che sono proprie del carattere italiano. Quindi possiamo diventare feroci. Siamo considerati «italiani brava gente» quando bravi non siamo. Il nostro segno più evidente penso sia quello della viltà, siamo un popolo vile e questo lo dico non mitizzando l’eroismo, ma siamo un Paese irrazionale, un Paese che nella sua storia non ha mai raggiunto la maturazione o la maturità. Non ci sono state forme di ribellismo, non c’è mai stata una rivoluzione, ci sono stati tentativi di illuminismo, in Piemonte e in Lombardia e a Napoli che sono naufragati perché erano delle forme elitarie che non hanno mai raggiunto gli strati popolari e quindi destinati al fallimento.
Ci sono stati degli ideologi, come Mazzini e Pisacane che hanno cercato di liberare gli strati popolari e sono stati uccisi, come Pisacane, da quegli stessi popolani che loro volevano liberare. La storia italiana è fatta di questa viltà, di questa ignoranza, di questa incomprensione. Un Paese dove non c’è stata una rivoluzione borghese e ancora adesso piangiamo di questa mancata rivoluzione.Moravia riportava una frase molto bella di Brancati. Pronunziata nel secondo dopoguerra, parlando della Sicilia diceva: «In Sicilia per essere almeno liberali bisogna essere comunisti».
Questa frase si può estendere a tutta l’Italia. Per essere almeno liberali bisogna essere comunisti. Non comunisti nel senso in cui lo dice Berlusconi (1) con orrore, ma nel senso di pensare a una società giusta dove non ci sia il sopraffattore, il feudatario, non ci sia quello che ti fa lavorare in nero, quello che sfrutta, lo xenofobo e così via.
D. Mauro, il figlio terrorista de Lo spasimo di Palermo si fa portare in carcere arance e libri. Quali libri chiederebbe che le si portassero in un’analoga situazione?
Chiederei il libro assoluto, letterario, che per me è La Divina Commedia. Chiederei il Don Quijote de la Mancha con il rammarico di non poterlo gustare nella sua lingua originale, non conosco lo spagnolo. Voglio essere partigiano e ritornare alla mia terra: rileggerei I Malavoglia e mi piacerebbe rileggere I promessi sposi di Manzoni. Questi credo siano l’ossatura della nostra cultura, della nostra letteratura. Non tralascerei naturalmente Leopardi sia nello Zibaldone che nella poesia. Credo che sia una continua ossigenazione del nostro pensiero e del nostro sentimento.
D. In un elzeviro dal titolo I testi di valore salvati dalla rete, pubblicato venerdì 2 febbraio 2001 sul «Corriere della Sera», Emilio Tadini, dopo aver fatto una distinzione tra testo e libro ed aver affermato la priorità del primo sul secondo, sostiene che il sistema attuale e dell’editoria e della distribuzione, puntando sui bestseller, abbia finito per escludere i testi di valore – testi, invece, che vengono accolti da Internet, dove vi sono siti che grazie alle loro migliaia di contatti stanno creando intorno al Testo una comunità capace di discutere e di «abbozzare ciò che noi si chiamerebbe “ critica”». Qual è la sua opinione al riguardo?
«In internet credo che avvenga questo: chiunque può immettere un proprio testo senza nessun vaglio perché non c’è il vaglio dei lettori editoriali delle case editrici, non c’è il vaglio della critica per cui il prodotto pseudo-letterario viene immesso subito alla fruizione dei lettori e non ha nessuna griglia e quindi, come si fa a giudicare un prodotto così? Non so se siamo di fronte alla democrazia assoluta in questo senso. Io credo che nella cultura, in letteratura non possa esistere la democrazia. Ci vuole una aristocratica selezione».
(Vincenzo Consolo)
Conclusione
Non pensa che sia la faziosità nevrotica a condannare i cittadini alla dipendenza da personaggi incapaci e corrotti? E infine non pensa che questa stessa faziosità fosse già insita nel DNA degli italiani, quando si fronteggiavano Guelfi e Ghibellini?
Mauro, il figlio terrorista de Lo spasimo di Palermo si fa portare in carcere arance e libri. Quali libri chiederebbe che le si portassero in un’analoga situazione?
Emilio Tadini sostiene che il sistema attuale e dell’editoria e della distribuzione, puntando sui bestseller, abbia finito per escludere i testi di valore – testi, invece, che vengono accolti da Internet, dove vi sono siti che grazie alle loro migliaia di contatti stanno creando intorno al Testo una comunità capace di discutere e di «abbozzare ciò che noi si chiamerebbe “ critica”». Qual è la sua opinione al riguardo?
Lei, vive con un disagio gli intervalli, talora anche consistenti, che intercorrono tra l’uscita dell’uno e l’altro dei suoi romanzi?
Il teatro non è un genere che Lei abbia esplorato gran ché. Come mai?
D. In un elzeviro dal titolo I testi di valore salvati dalla rete, pubblicato venerdì 2 febbraio 2001 sul «Corriere della Sera», Emilio Tadini, dopo aver fatto una distinzione tra testo e libro ed aver affermato la priorità del primo sul secondo, sostiene che il sistema attuale e dell’editoria e della distribuzione, puntando sui bestseller, abbia finito per escludere i testi di valore – testi, invece, che vengono accolti da Internet, dove vi sono siti che grazie alle loro migliaia di contatti stanno creando intorno al Testo una comunità capace di discutere e di «abbozzare ciò che noi si chiamerebbe “ critica”». Qual è la sua opinione al riguardo?
on conosco, ed è una mia mancanza, il mondo di Internet. Questa osservazione di Tadini ho l’impressione che riprenda un discorso che faceva pochi giorni fa Yaroslaw Kapuchinsky, questo giornalista straordinario e bravissimo che parlava della globalizzazione. Lui poggiava l’accento sui libri e sulla cultura. Oggi non importa più sapere se un libro è buono o cattivo ma importa sapere, con un criterio di tipo merceologico, quante copie ha venduto. La stessa cosa si può dire dei dischi, della musica.
Oggi vale più il numero della qualità. Questo è un andazzo che mette in apprensione. Non vi sono criteri estetici, etici per giudicare un libro. Il discorso del bestsellerismo è un discorso che si morde la coda per cui non importa più se il libro ha dei contenuti, del valore letterario o meno, importa che un numero di lettori abbia raggiunto questo libro, per cui diventa una reazione a catena, un elemento di persuasione per tutti gli altri per cui i lettori, o almeno gli acquirenti, diventano sempre di più. Ho detto tanti anni fa questo: il momento della mutazione è avvenuto in Italia tanti anni fa con il fenomeno de Il nome della rosa. Il fenomeno de Il Gattopardo aveva altri significati, altre spiegazioni, Il nome della rosa ha segnato il momento della mutazione, è diventato un bestseller a carattere internazionale, poi è venuta la Tamaro, oggi c’è Camilleri, si potrebbe andare all’infinito, Baricco ecc. Non discuto sul valore intrinseco del libro parlo come fenomeno di bestseller. Diventa una reazione a catena. Ci sono tanti motivi per spiegare il fenomeno ma c’è qualcosa di extra-letterario che induce, persuade, che innesca questo fenomeno della reazione catena per cui bisogna comprare quel libro e il fatto che lo comprino in centomila, ci sono altri centomila che vogliono quel libro. Si va poi all’infinito. Moraviacercava di dare una spiegazione al fenomeno del bestseller. Cos’è il bestseller? Lui diceva che non è che uno scrittore si cala dall’alto e cerca di mettere in atto gli elementi per creare il bestseller. Questo non riesce quasi mai. Invece una persona che dal basso dà il meglio di sé in quel momento, incontra il gusto corrente di quel momento. Così avviene il bestseller.
Al di là di questo ci sono anche fenomeni di induzione oggi. I messaggi pubblicitari, i fatti extra-letterari, che sono la presenza dello scrittore nelle ribalte mediatiche, il fatto di essere personaggio, sono tante connotazioni che possono spiegare il fenomeno del bestseller. Questo discorso di Kapuchinsky è stato ripreso pochi giorni fa da Arbasino su «la Repubblica» e quindi credo che il discorso di Tadini sia la conseguenza di questo articolo di Kapuchinsky. Io parlavo della fine della letteratura in questo senso, parlavo delle sacche di resistenza di fronte a questa globalizzazione. In Internet credo che avvenga questo: chiunque può immettere un proprio testo senza nessun vaglio perché non c’è il vaglio dei lettori editoriali delle case editrici, non c’è il vaglio della critica per cui il prodotto pseudo-letterario viene immesso direttamente alla fruizione dei lettori e non ha nessuna griglia e quindi, come si fa a giudicare un prodotto così? Non so se siamo di fronte alla democrazia assoluta in questo senso. Io credo che nella cultura, nella letteratura non possa esistere la democrazia. Ci vuole una aristocratica selezione.
D. Lei, vive con un disagio gli intervalli, talora anche consistenti, che intercorrono tra l’uscita dell’uno e l’altro dei suoi romanzi?
Non sono uno scrittore con l’assillo della pubblicazione annuale o semestrale. Io penso di pubblicare un libro quando penso che il libro sia necessario, che abbia una sua necessità ma soprattutto che abbia una sua consequenzialità nel senso che si possa riallacciare a quello che era stato il mio libro precedente.
D. Io aggiungerei solo una cosa. Nonostante la tragedia sia il genere che potrebbe maggiormente classificare i suoi testi – e in effetti è una strada che Lei ha percorso, d’altra parte Lei utilizza decisamente una metrica nei suoi scritti e, in un certo senso si tratta di versi, anche se non si presentano in forma di poesia, ma di prosa – eppure il teatro non è un genere che Lei abbia esplorato gran ché. Come mai?
Le zone deputate al teatro sono impraticabili perché è un mondo così invaso dal profitto e dagli estetismi che è impraticabile. Le mie opere sono tragedie, Lo spasimo di Palermo è una tragedia e questo l’hanno detto i critici, sia italiani che francesi. È appena uscita la traduzione spagnola e un critico sul «El País» ha parlato di tragedia in prosa. L’ho fatto esplicitamente con Catarsi ma anche con altri pezzi che ho scritto per dei musicisti. Ho scritto Elegia per note musicata da un musicista, morto di recente, Francesco Pennise. Mi piace scrivere questi testi che hanno una destinazione per gli oratori, per la musica che è una forma molto alta e bella e che mi riporta alla tragedia greca, con questa parte di composizioni cantate e recitate. Ultimamente anche un giovane musicista che si chiama Matteo D’Amico ed è un pronipote di Pirandello ha musicato dei brani de Lo spasimo di Palermo. Mi ha fatto tradurre lo Stabat Mater di Jacopone da Todi in italiano e ha fatto un oratorio, delle parti musicate, delle parti recitate da un’attrice molto brava che è Maddalena Crippa. Sono andato a Roma per sentire questo concerto e devo dire che era di grande efficacia. Si svolgeva nell’aula magna dell’Università La Sapienza di Roma. Forse in futuro svilupperò questa mia propensione verso l’espressione musicale, fornire dei testi per dei compositori.
Gennaio,febbraio,marzo2001
italialibri
La nostra memoria storica è radicata nella cultura dell’olivo e dell’olio
La grande vacanza orientale-occidentale
Vincenzo Consolo
Una costa diritta, priva di insenature, cale, ai piedi dei Nèbrodi alti, verdi d’agrumi, grigi d’ulivi. Una spiaggia pietrosa e un mare profondo che a ogni spirare di vento, maestrale, tramontana o scirocco, ingrossava, violento muggiva, coi cavalloni sferzava e invadeva la spiaggia. Era un correre allora dei pescatori dalle loro casupole in fila là oltre la strada di terra battuta, era un chiamare, un clamoroso vociare. Le donne, sugli usci, i bambini2 in braccio, ansiose osservavano. I pescatori, i pantaloni fino al ginocchio, tiravano svelti le barche, in bilico sui parati,3 fino alla stradina, fin davanti ai muri delle case. D’inverno era ferma la pesca, le barche stavano sempre tirate sulla spiaggia. Una accanto all’altra, il nudo albero contro il cielo, gli scalmi consunti, strisce e losanghe lungo i fianchi, grandi occhi stupefatti o poppute sirene alle prore. Era il Muto il pittore di barche. Con buatte4 e pennelli, la mano ferma, l’occhio appuntato, faceva spuntare sul legno purrito5 quelle sue creature fantastiche. Ferma la pesca per il mare furioso, i pescatori dovevano allora piegarsi a un altro lavoro. Andare, in novembre, in dicembre, dentro i frantoi. Li vedevi salire in paese, passar per le strade un po’ mesti, avviliti, entrare nei magazzini dei padroni di terre per fare i facchini. Col sacco unto a cappuccio, portavano a spalla pesi enormi d’olive, sansa, otri grondanti. Con la buona stagione, riprendeva la pesca. Salpavano al vespero, con cianciòli,6 lampare,7 andavano a forza di remi a ottanta, novanta passi per la pesca di sarde e anciòve. 8 Le lampare, la notte, una appresso all’altra all’orizzonte, sembravano la luminaria per la festa del Santo. Ed erano sferzate, a tempo, dalla fascia lucente del faro di Capo d’Orlando. Gli altri due fari remoti, di Cefalù e Vulcano, quand’era sereno, sciabolavano lievi incrociandosi in mare. Ma contro la pesca v’era anche la luna, quando crescendo giungeva al suo pieno, e tonda, sfacciata, schiariva ogni tenebra, suscitava dai fondali ogni branco, assommava9 per la vastità del mare i pesci allocchiti.10 E pure nella stagione11 capitava il fortunale. Nuvoloni s’ammassavano, gravavano sull’acqua, vorticavano a tromba, lampi e tuoni segnavano il fondo. Il mare improvviso gonfiava, mugghiava, sulle creste spingeva, nei valloni affossava gozzi e caicchi,12 l’onda violenta schiumava contro le pietre della spiaggia. Suonavano allora le campane,13 del Castello,14 della Matrice, e tutti accorrevano sulla spiaggia con corde e torce, in aiuto dei pescatori in pericolo. Amavo quella spiaggia del mio paese, amavo la vita di mare dei pescatori, pur non essendo della marina, ma d’altro ambiente e quartiere, di quello centrale di proprietari, bottegai, artigiani. La fascia più alta, delle ultime balze dei colli, era invece di contadini, carrettieri, ortolani.
Tre quartieri, tre mondi separati tra loro, che s’univano15 soltanto in occasioni di feste e calamità, incendio o naufragio, che tutti smuoveva. Le vacanze, les grandes vacances, secondo le professeur, che indicavano un termine, mentre in me le immaginavo e volevo d’un tempo infinito, le passavo giorno e sera su quella spiaggia pietrosa coi figli dei padroni di barche, pescatori da sempre, generazione dopo l’altra, ciascuno con storie, imprese, leggende, nomi e soprannomi precisi: Corso, Contalànno,16 Scaglione…17 Più tempo in acqua passavo con loro che sopra la terra, con loro sul gozzo a remare, andare da una parte o dall’altra, verso Acquedolci, Caronia,18 a Torre del Lauro o verso Torrenova,19 Capo d’Orlando,20 Gioiosa… Andavamo il giorno, con ami ed esche, a ricciòle,21 àiole,22 pettini, e la sera23 con lontro24 e acetilene, a tòtani e calamari. Tornavamo inzuppati per gli spruzzi rabbiosi di quelle bestie appena fuori dall’acqua. Su quella spiaggia era la mia libera vita, più bella, ma in essa era anche il ricordo recente del tempo più nero: su quel mare, quella spiaggia era passata la guerra. Dal mare venivano i lampi, i fischi allarmanti, gli scoppi che fracassarono case. Nel mare mitragliarono la barca dei Corso, ferirono uomini. Fu allora che la gente si mise a sfollare, sparpagliarsi per le campagne, a Vallebruca, Fiorita.25 Sulla spiaggia il mare rigettò un morto annegato, un tedesco, corroso alla testa, alle mani, il gonfiore del corpo che premeva contro il panno, i bottoni della divisa, le nere polacche,26 gli pendeva dal collo un cordone a cui era appeso un fischietto. Lo coprirono i militi con un pezzo di vela. Dal mare sbarcarono gli anfibi con sopra gli americani, bianchi, neri, donne con biondi capelli che scendevano da sotto l’elmetto. Poi la vita si staccò da quella spiaggia, dai compagni, dalle avventure. Rientrai nel centro e, acculturato, fui preso dal desiderio di conoscere il mondo che mi stava alle spalle, la terra che si stendeva al di là della barriera dei Nèbrodi. Immaginai quella terra come una infinita teoria di rovine, di antiche città, di teatri, di templi al sole splendenti o bagnati dal chiarore lunare, immersi in immensi silenzi. Silenzio come quello di Tindari, su alla chiesetta della nera Madonna27 sul ciglio roccioso del colle che netto precipita in mare.28 E nella greca città che alta domina il golfo, sta di fronte a Salina, Vulcano, Lipari, celesti e trasparenti sull’orizzonte. Nella cavea del Teatro, risuonavano i miei passi e, al Ginnasio, le statue acefale, togate là sotto l’arco, erano fantasmi che mi venivano incontro da un tempo remoto. Silenzio, solitudine, estraneamento ancora giù in basso nella landa renosa, 29 fra le dune e i laghi marini d’ogni verde e azzurro, nel folto di canne da cui svolavano gabbiani e garzette.30 Sull’aperta spiaggia erano legni stinti, calcinati, relitti di barche che un qualche fortunale aveva travolto, sospinto su quelle sabbie. Brulichìo e clamore incontrai invece a oriente, a Naxos, Taormina, Siracusa, Gela e pure nel cuore dell’isola, a Enna e Casale di Piazza Armerina. Il deserto, il silenzio era all’interno tra una stazione e un’altra, i soli rumori, in quella nudità infinita, in quel giallo svampante, lo sferragliare, sbuffare e fischiare del treno. Un trenino mi portò ancora a Segesta, a Selinunte, a Marsala. In questo «porto di Allah», sapevo, avrei dovuto incontrare il Minosse prima d’esser proiettato, oltre il breve braccio di mare, su Mozia. Bussai alla porta e fui introdotto in un piccolo studio. Apparve poi l’uomo imponente, che rispose al saluto31 con un cenno del capo. Si sedette dietro la scrivania e mi scrutò per un po’. Cominciò quindi, severo, a fare32 domande:33 chi ero, da dove venivo, che sapevo di Mozia, dei Fenici, quale interesse mi spingeva a visitare l’isola dello Stagnone. Risposi puntuale a ogni domanda. M’osservò ancora, e cominciò quindi a dire: così giovane in giro da solo, e non avevo con me neanche un baedeker,34 una macchina fotografica come tutti i turisti, neanche un cappello di paglia per il sole cocente… Scosse la testa, sorrise, prese quindi la penna scrisse su un foglio. Il colonnello Lipari, amministratore della famiglia inglese Whitaker, proprietaria di Mozia, mi aveva finalmente dato il permesso di accedere all’isola. Mi portai sul molo dello Stagnone, fra i cumuli del sale, mi misi a sventolare il fazzoletto. Si staccò dopo un po’ una barca dall’isola e puntò verso il molo. L’uomo ai remi mi aiutò a salire. Nel tragitto, si vedeva il fondo basso del mare, spiccavano tra l’ondeggiare delle poseidonie i bianchi lastroni di pietra dell’antica strada sommersa. All’approdo, l’uomo mi disse che al tramonto avrebbe suonato una campana, che era quello il segnale della chiusura, dell’ultima barca per tornare all’Infersa, 35 la salina di fronte. Andai lungo le mura di calcare coi capperi cascanti dagli interstizi, lambite dal mare, salii sulla scala della torre, oltre la postierla, 36 giunsi alla porta37 che introduce alla strada per il Santuario. Tutto intorno allo spiazzo dei basamenti, dei blocchi di pietra e del pietrame dell’area sacra era un verde tappeto di giummàre38 sovrastato dai pini di Aleppo, e da quel verde s’alzavano stormi di gazze e calandre.39 Per la fornace dei vasai giunsi poi alla Necropoli e al Tofet. Affioravano qui le bocche dei vasi imprigionati nel terreno argilloso, urne contenenti le ossa dei fanciulli che quei Fenici sacrificavano alla gran madre Astarte o al gran padre Baal. Furono i Siracusani che, dopo la vittoria di Imera, imposero a quei «barbari» di cessare il rito crudele. E Montesquieu, nel suo Esprit des lois, così esultava: «Le plus beau traité de paix dont l’histoire ait parlé est, je crois, celui que Gélon fit avec les Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la coutume d’immoler leurs enfants. Chose admirable!… »40 Ammirevole sì, quel trattato, ma l’illuminato barone francese dimenticava che quegli stessi Siracusani, dopo la vittoria, avevano crocifisso tutti i greci che avevano combattuto accanto ai Fenici-Cartaginesi. È crudeltà, massacro, orrore dunque la storia? O è sempre un assurdo contrasto? Quei fenici41 che sacrificavano i loro figli agli dèi erano quelli che avevano inventato il vetro e la porpora, e la scrittura segnica dei suoni, aleph, beth, daleth… l’alfabeto che poi usarono i greci e i latini, usiamo anche noi, quei Fenici che, con i loro commerci, per le vie del mare portarono in questo Mediterraneo occidentale nuove scoperte e nuove conoscenze. A Porta Sud scoprii quindi la meraviglia di quel luogo, il Cothon, il porto artificiale di quegli avventurosi navigatori, di quei sagaci commercianti. Era una piscina rettangolare in cui dal mare, per un breve canale, affluiva l’acqua.
Ai quattro lati, sui bordi, i blocchi squadrati, s’ergevano le mura di magazzini, darsene, s’aprivano scale. Non resistetti e mi tuffai in quell’acqua spessa di sale, nuotai e sguazzai in quel porto fenicio. Al sole poi, davanti a quel mare stagnante, mi sembrava di veder sopraggiungere, a frotte, le snelle barche dalle vele purpuree, il grande occhio apotropaico dipinto sulle alte prore. Occhi come quelli che dipingeva il Muto sulle barche dei pescatori del mio paese.42 L’ultimo approdo43 della lontana mia estate di privilegio — privilegio archeologico come quello ironicamente invocato da Stendhal, a me concesso da un padre benevolo — fu fra le rovine di Selinunte. Dal mattino al tramonto vagai per la collina dei templi, in mezzo a un mare di rovine, capitelli, frontoni, rocchi di colonne distesi, come quelli giganteschi del tempio di Zeus che nascondevano sotto l’ammasso antri, cunicoli; e fra boscaglie d’agave, mirto intorno ai templi di Hera, d’Atena… Raggiunsi poi, sotto il sole di mezzogiorno, l’Acropoli sull’altra collina oltre il Gorgo di Cottone, esplorai altri templi, are, case e botteghe, percorsi strade, piazze, tutta la cinta muraria, quelle mura per cui erano penetrati i soldati d’Annibale e avevano distrutto la superba città. Sostai al fresco di una postierla per mangiare il panino, bere la gassosa, ormai calda e schiumante. Formiconi trascinavano sopra il grasso terriccio le molliche di pane. Dopo la sosta di fresco e ristoro, scivolai per il pendio che porta, oltre il fiume Selino, alla Gaggèra, dov’erano i templi più antichi, della Malophoros, di Ecate, di Zeus Meilichios. E poi, lungo il viottolo che costeggia il Selino, arrivai alla spiaggia di sabbia dorata, al porto sepolto. E mi sembrò d’arrivare, dopo tanta calura, fatica, estraneamento per il viaggio nel remoto tempo di Selinunte, alla remissione, alla landa priva dei segni del tempo, ma che conteneva ogni tempo, compreso quello della mia memoria, di fronte all’infinito del mare, ch’era solcato di barche e, lontano, da una nave bianca, che forse andava, per quel Canale di Sicilia, verso Tunisi, Malta o Algeri Per la spiaggia, affondando i passi nella vergine sabbia, m’avviai nel villaggio di Marinella, dove giunsi quando il sole era appena calato nel mare lasciando nel cielo un fuoco dorato. Una strada di terra battuta separava la locanda dalla trattoria di tavole e frasche costruita sulla battigia. Dissi alla padrona che volevo alloggiare, passare la notte, e anche mangiare. «Solo sei?»44 mi chiese scrutandomi. Dissi di sì. «Iiihhh, così piccirillo,45 da solo?» Ero piccolo, sì, di statura, e anche magrino, ma dissi a quella, rizzando la testa, che avevo già quindici anni. «Uh, va be’» disse ridendo. E: «Siediti. Aspetta qua, che vado a preparare il letto» e traversò la strada, entrò nella locanda. Il mare sbatteva contro le palafitte di quel capanno e si ritraeva con lieve risacca. La solitudine e quello sciacquìo a cadenza mi facevano chiudere gli occhi per il sonno. Entrò un uomo baffuto, mi vide là sonnacchioso. «Chi sei, che vuoi?» mi chiese. Dissi che aspettavo la signora, là nella locanda, che volevo mangiare e dormire. «Mia moglie» disse. E squadrandomi: «I soldi ce li hai?». «Certo, certo…» e li tirai fuori dalla tasca, glieli feci vedere. Arrivò un pescatore con una cesta di pesci sopra un letto di alghe. «Le sarde, le vuoi?» mi chiese il padrone. Annuii. Ne prese due misure di piatto fondo. Si mise poi davanti all’uscio a preparare la brace con i sarmenti di vite, arrostì le sarde sulla graticola spalmandole d’olio, limone e origano. Quando tornò la padrona, ci sedemmo tutti e tre a un tavolo e mangiammo. Lui, il marito, ingoiando una sarda dopo l’altra con forti risucchi, beveva e beveva, beveva pure la moglie e anche a me diedero non so quante volte quel vino nero di Partanna.
«Bevi, bevi!» diceva lui. «Bevi, bevi!» diceva lei «Mette sangue ‘sto vino, fa crescere» e rideva. Alla fine non sentii, non capii più nulla, crollai con la testa sul tavolo. Mi risvegliai l’indomani nel letto della locanda. Per la finestra, la prima scena che vidi del mondo fu la collina dell’Acropoli coi templi già illuminati dal sole. 44.
1. Uscito dapprima su Alias, 32, 12-13, supplemento di Il Manifesto, 7 agosto 1999 (d’ora in poi 1999), con l’occhiello editoriale: «Le spiagge di Consolo. Un periplo dell’adolescenza in mare, dai Nèbrodi a Naxos a Mozia», il racconto — con lo stesso titolo, ma in una versione ampliata — ha poi circolato in formato di minuscolo libro. Il lepidum novum libellum è stato pubblicato da una nota libreria partenopea in un’apposita collana: «Storie in trentaduesimo. III», Napoli: Edizioni Libreria Dante & Descartes, 2001 (d’ora in poi 2001). Il testo qui riportato è quello che, a conclusione delle giornate di studio sivigliane, lo stesso A. ha letto ricorrendo a 2001, di cui così potrebbe considerarsi l’apografo salvo però indicazione contraria. Nell’attuale edizione le eventuali varianti sono, nel testo, segnalate dal corsivo e, nelle note, identificate dalla data di quelle precedenti. Note a cura di Nicolò Messina. 2. bimbi 1999.
3. Tecnicismo marinaro. Grossi pezzi di legno, su cui poggiano altri assi, utilizzati per tirare in secco o varare le imbarcazioni. 4. Adattamento di sic. buatti, pl. di buatta «(recipiente di) latta», di chiara ascendenza transalpina: cfr. fr. boite. Sono qui le latte di vernice per dipingere e decorare le fiancate delle barche. 5 Adattamento di sic. purritu «imputridito, marcio, fradicio».
6. Tipo di rete circolare per la pesca notturna, simile alla lampara intesa lato sensu (cfr. infra). 7. Grosse lampade ad acetilene o gas per la pesca notturna di pesci e cefalopodi, attirati appunto dalla loro luce; per estensione, anche le imbarcazioni munite di lampade ovvero le reti usate. Termine di non stretto uso meridionale. 8. Adattamento di sic. anciovi, pl. di anciova «acciuga, alice», quasi calco di cat. anxova con l’opposizione /t∫/: /∫/ nel segmento mediano. Cfr. anche sp. anchoa. Conferma l’origine catalana Alberto VÀRVARO, Vocabolario etimologico siciliano, I, con la collab. di Rosanna SORNICOLA, Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1986, p. 50-52. Cfr. inoltre Andreas MICHEL, Vocabolario critico degli ispanismi siciliani, Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1996, p. 216. 9. È l’assommare marinaresco «tirare a galla, tirare su dal fondo». Cfr. anche nell’uso intrans. sic. assummari «venire a galla, in superficie». 10. Come è noto, allocchito vale «allibito, sbalordito, attonito», con allusione ai grandi occhi dell’allocco, rapace notturno del genere Strigiformi. Ma come escludere il palpitare in sostrato di sic. alluccuti nel senso più pregnante di «storditi, intronati»? 11. Nella copia personale di 1999, conservata nell’Archivio Consolo (d’ora in poi 1999 Archivio) e verosimilmente compulsata prima di 2001, l’A. pare voler precisare, interpolando così a matita: nella buona stagione. L’aggiunta non passa però in 2001, né pertanto viene qui tradita. La lezione unanime sembra peraltro calco di sic. a staciuni, «l’estate»: la stagione per eccellenza del bel tempo, proprio il periodo che l’A. rimemora. D’altronde il «tempo» ricordato è chiarito un po’ piú sopra, là dove si legge appunto: con la buona stagione. 12. Imbarcazione di tipo orientale, a vela o remi (< turco kayik). 13. campane, con /,/ biffata a matita 1999 Archivio. 14. castello 1999, castello corretto a matita Castello 1999 Archivio. 15. s’univan 1999. Al settenario (che […] soltanto) rinuncia 2001. 16. Contallànno 1999. 17. Corso, Contallànno, Scaglione sottolineati a matita 1999 Archivio. 18. Caroni 2001, Caronia 1999. In 2001, indubbio refuso tipografico facilmente emendabile. Si tratta infatti di Caronia, ovviamente Marina, frazione del Comune di Caronia (prov. di Messina) come le altre due località: Acquedolci e Torre del Lauro. 19. Torrenova: 1999, Torrenova: corretto a penna nera Torrenova, 1999 Archivio. 20. D’Orlando 1999. 21. Adattamento di sic. rriccioli, pl. di rricciola «leccia o seriola», specie di pesce della famiglia dei Carangidi (Seriola dumerili). 22. L’accento diacritico evita di confondere con l’omografo it. aiòle, variante di aiuole, il lemma sic. adattato aiuli, pl. di aiula «mormora», tipo di pesce (Litognathus mormyrus). 23. sera, 1999. 24. Assente anche dall’autorevole Grande Dizionario della Lingua Italiana, è ancora una volta un sicilianismo adattato. Cfr. Vocabolario Siciliano, ed. Giorgio PICCITTO e continuatori, II, Catania — Palermo: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 1985, p. 542, s.v. lòntraru e lontru «rete per la pesca dei totani». L’informazione non sembra però corretta, perché il lontro serve per la pesca dei cefalopodi in generale, ma non è una rete, bensì un attrezzo dal corpo affusolato con una o due corone di ami rivolti verso l’alto. Il termine ricorre anche in Campania, dove però designa un’imbarcazione dal fondo piatto e con la prua rialzata, adatta alla navigazione in acque fluviali o lacustri. 25. Fiorita. Sanguinera aggiunto in margine a matita 1999 Archivio. 26. polacche. 1999. Adattamento di sic. polacchi, pl. di polacca, it. polacchina «stivaletto».
27. È la nigra et formosa del cap. I di Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori, 2004, p. 11: «Ora, sopra la rocca, sull’orlo del precipizio, il piccolo santuario custodiva la nigra Bizantina, la Vergine formosa chiusa nel perfetto triangolo del manto splendente di granati, di perle, d’acquemarine, l’impassibile Regina, la muta Sibilla, líbico èbano, dall’unico gesto della mano che stringe il gambo dello scettro, l’argento di tre gigli.» 28. Cfr. Salvatore QUASIMODO, Vento a Tindari, v. 2-3 e 6: «mite ti so | fra larghi colli pensile sull’acque | dell’isole dolci del dio?[…] | Salgo vertici aerei precipizi». 29. Agg. derivato da rena «sabbia», esito di [l’a]rena < l’arena. La forma piena del lemma, senza l’errata discrezione dell’articolo, è un crudo latinismo, calco letterario di lat. (h)arena. Pur tuttavia si avanza anche l’ipotesi non certo audace di un semplice adattamento di sic. rrinusu < rrina, unico modo dato ai siciliani di significare «sabbioso, sabbia». Il collocarsi in un’area di contatto tra diacronismo alto e colto e diatopismo ancora vivo e usato in forma adattata non è tendenza infrequente in Consolo e può anzi considerarsi uno dei tratti distintivi della sua lingua. 30. Uccello del genere Egretta, airone minore. 31. salute 1999. 32. far 1999. 33. le domande: 1999.
34. Deonomastico allusivo al libraio-editore tedesco Karl Baedeker (1801-1859), fondatore di una collana di guide turistiche tascabili per viaggiatori dell’Ottocento. Uso ironico-colto del sinonimo comune guida, che fa pensare alla seriosità dei tanti visitatori centro e nordeuropei del sito archeologico di Mozia. Il giovane Consolo ha un’aria ben diversa, non ha certo l’attrezzatura di rigore, ma è pur sempre animato da grande curiositas. 35. Inferra 1999, 2001. Refuso tipografico passato dall’una all’altra edizione e da emendare. È una delle due saline di fronte all’isola. L’altra è la salina Ettore. 36. La piccola porta secondaria nei pressi della monumentale Porta nord della città di Mozia. 37. Porta 1999. 38. Adattamento di sic. ggiummari, pl. di ggiummara «palma nana» (Chamaerops humilis), palma dalle foglie palmate e pieghettate. 39. Uccello del genere Melanocorifa che si fa notare per il canto. 40. la costume 2001, 1999. Il brano (De l’esprit des lois, ed. Laurent VERSINI, Libro X, cap. V) è citato anche nell’episodio In Mozia de’ Fenici di Retablo, Palermo: Sellerio, 1987, p. 121. Da Retablo si rileva la lezione corretta la coutume contro l’altra, in cui il trascurabile refuso tipografico sarebbe tutt’al piú agevolvemente emendabile in le costume. 41. Fenici 1999. 42. del mio paese, della spiaggia, delle spiagge perdute della mia memoria. aggiunge ed explicit 1999. 43. L’ultimo approdo […] illuminati dal sole. omette 1999. 44. Tipica Wortordnung siciliana con il verbo in posizione finale. 45. L’adattamento di sic. picciriddu «piccolino» rende il lemma semanticamente più comprensibile, perché rievoca il più noto napoletanismo piccirillo.