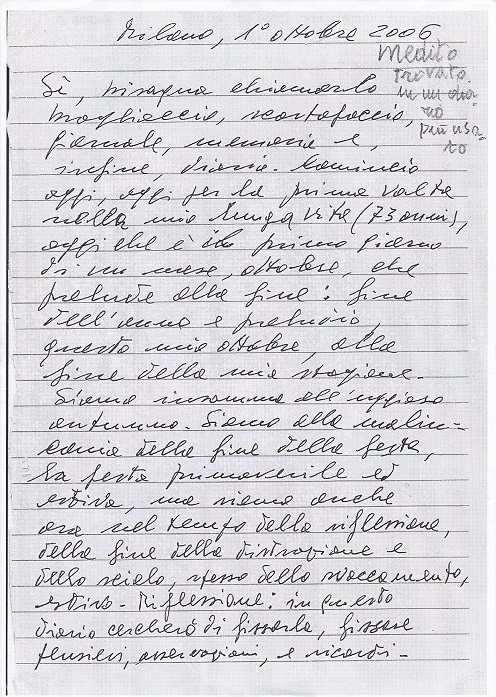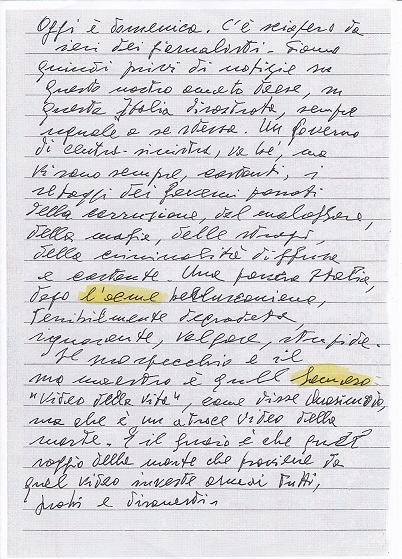di Natale Tedesco
Laudatio per Vincenzo Consolo di Natale Tedesco in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Filologia moderna (Palermo, Steri 20 giugno 2007)
“Vincenzo Consolo: l’irrequietudine e il sigillo della scrittura” di Natale Tedesco.
Due sono gli elementi che in generale caratterizzano e qualificano l’elaborazione inventiva, l’opera, di Vincenzo Consolo: il legame con la tradizione letteraria dei grandi siciliani che ha rappresentato la condizione umana dell’isola come mondo ma che con una costitutiva e persistente disposizione a riscrivere la storia della Sicilia e dell’Italia, cioè portando avanti una ricognizione del suo percorso civile e politico, finisce col delineare come una controstoria nazionale. L’altro elemento è quello di una peculiare formalizzazione della scrittura isolana, la cui forte originalità è soprattutto di carattere linguistico.
In verità, la tradizione realistica della narrativa siciliana è molto meno compatta e unitaria di quanto non si creda: lirismo e prosa d’arte, sperimentalismo e ricerca linguistica, formalismo in genere, s’intrecciano con il realismo di base e a volte lo sopraffanno ed espungono anche nella varia produzione di uno stesso autore. Proprio per Consolo c’è da dire che prima ancora che Lunaria, un’opera del 1985, si presenti come una deliberata antinarrazione, questo intreccio è evidente nel primo romanzo, La ferita dell’aprile, del 1963, ambientato nel periodo difficile dell’immediato dopoguerra, in una Sicilia dove le tensioni sociali si manifestano drammaticamente in uno con le “ferite” di un gruppo di adolescenti inquieti. Già qui le forme del romanzo si scontravano con gli intenti poematici, nello sperimentalismo di una fraseologia autobiografica vernacolare, con un lirismo che ritaglia un Verga poetico. E pure Il sorriso dell’ignoto marinaio, il romanzo del 1976 ritenuto il suo capolavoro, segnato da ricercatezze lessicali e costrutti regionali d’antica e recente formazione, è intersecato da piani stilistici differenziati.
Nel Sorriso dell’ignoto marinaio, opera significativa di tutto un tempo dell’elaborazione della prosa italiana, dominata dal dissidio tipico dell’ideologia letteraria del decennio Settanta, tra rifiuto della letteratura e fede nella scrittura, la narrazione che vuole essere oggettiva della situazione storica, cioé impegnata a rappresentare le rivolte contadine a metà dell’Ottocento e la loro repressione classista, si mescola con un immaginario barocco, o neobarocco che dir si voglia, di accentuato vigore. Protagonisti del romanzo sono Enrico Pirajno di Mandralisca, un aristocratico liberale ed illuminista, e l’avvocato Giovanni Interdonato, un borghese cospiratore antiborbonico (figura di ascendenza sciasciana dell’intransigenza morale ed intellettuale), e pure diversamente sorpresi e scolpiti nel sorriso ambiguo dell’uomo siciliano del quadro di Antonello da Messina.
In realtà, in quest’opera, al Verga del primo libro, allo Sciascia del secondo, è subentrato più prepotentemente come nume tutelare Lucio Piccolo e con lui entra in profondità nella prosa la poesia, con lacerti di lui e di altri poeti, e con modulazioni e ritmi che sono di essa. Non si tratta solo di singole parole, magari recuperate nel segno di ambiguità e ambivalenze, come “datura”: fiore bianco e veleno. Rispetto ai passi, ai luoghi esibiti di altri poeti, la citazione di versi piccoliani non è virgolettata, perché sono fatti propri come immagini, figure, di un consentaneo e simpatetico universo espressivo. Si vedano come sono incastonati emistichi o versi come “l’eco risorta…” o “velieri salpati alla speranza di isole felici…”.
Di fatto, ancora diverso, è l’insistito preziosismo lessicale, con un particolare assaporamento dell’aggettivazione che isola i particolari, già andando contro il costruire prosastico più disteso. Per questo non ci si può limitare a godere o a saziarsi di questa ricchezza, senza nemmeno sospettare le ragioni di una scelta che è ideologica, di una poetica che è già contrastativa e in cui vive l’invettiva contro la valanga di libri ‘privi d’anima’.
Se nell’opera di Consolo vi sono modulazioni barocche e, più, rococò in un misto isolano di dolcezze da ‘arte minore’ e di Serpotta, soprattutto nell’impegnato neoclassicismo preromantico di fine Settecento sono da vedere le sue ascendenze esemplari. Penso ai romanzi Le avventure di Saffo, Notti romane al sepolcro degli Scipioni del periodo romano di Alessandro Verri, pur sempre anti-pedantesco e anticruscante transfuga dalla Milano in cui aveva combattuto contro i “parolai”, che tuttavia i suoi ‘racconti filosofici’ vergò con penna neoclassica.
Retablo, sequenza di accadimenti e di figure, di scritti, di uno scritto che s’incrocia con un’altro, è un incrocio di passato e di presente, di un goethiano “viaggiare alla ricerca degli stampi”. Al fondo di tutta la condizione cognitiva e formale di Retablo, sembra fermentare anche un retaggio di Leopardi, quel privilegiamento dell’antico e quella poetica della rimembranza, che fanno diverso il suo classicismo rispetto agli stessi ultimi settecenteschi, e che,dunque, mettono su altri profili quei riferimenti ai neoclassici preromantici, di cui si è detto per Consolo.
L’antico è per il nostro scrittore il ritrovamento della dimora isolana, come ancestralità storica e metastorica, che, sul piano individuale, vuol dire recuperare l’infanzia dei giardini messinesi, dei carbonari dei Nebrodi.
Se è vero, come affermava Salvatore Battaglia, che “Il poeta, secondo il paradigma leopardiano, è un restauratore di antiche remote impressioni, idealità, fantasmi, in cui egli si rifugia per evitare la depressione della vita presente”, sembrerebbe che Consolo viva passionalmente questa condizione. Per questo parrebbe che Retablo risolva pure quel peculiare contrasto della crisi della cultura, dell’ideologia letteraria degli anni Settanta, tra negazione della letteratura e fiducia nella scrittura. Senza volere togliere nulla al rilievo che Il sorriso ha nella produzione consoliana, alla luce degli ultimi libri dello scrittore messinese, si deve tuttavia affermare che Retablo gode di un’ispirazione unitaria che porta ad esiti più compiuti almeno una parte, forse la più autentica della sua tematica, soggetta a spinte centrifughe altrettanto vere. Invero, essendo un elemento costitutivo fortemente ineludibile, il problema di Consolo rimarrà la necessità di comporre di volta in volta la tensione poetica con la scrittura referenziale di un chiaro discorso politico. Il dilemma che pur nella ambiguità permeava Il sorriso dell’ignoto marinaio con forza e fascino, appare risolto univocamente in Retablo.
Ma ritorna, anzi quasi contemporaneamente persiste al modo di Vittorini, nelle Pietre di Pantalica. Fascinosamente ambiguo è altresì il linguaggio anticato, ma in modo che non sia sempre attibuibile ad un’area linguistica storicamente determinata, e paia venir fuori da un mondo sommerso e ricreato con l’immaginazione, vago e concretissimo insieme. Un linguaggio che in realtà, anche quando va da movimento a stabilità, non accetta di consistere del tutto; come l’ideologia dello scrittore che, sempre vittorinianamente, rifiuta la quiete nella non speranza, e invero si agita, si sbilancia tra disperazione e speranza. Per questo la sua memoria del tempo andato non è ferma, ma si spinge a contestare, con il presente, anche se stessa.
Con questa raccolta del 1988 Vincenzo Consolo ha reinventato peraltro il progetto che già fu di Vittorini; ha scritto le sue “città del mondo”, che intanto paiono più nostre. Così sembra che abbia pure ripreso in prima persona il viaggio che il suo personaggio Clerici aveva compiuto in Retablo. Dunque, ottobre ottantasette Retablo, ottobre ottantotto Le pietre di Pantalica: un anno appena d’intervallo. Ma bisognerebbe dire dei suoi reali tempi di composizione; rimane il fatto che Le pietre di Pantalica conservano e rinsaldano una mobilità e plurivocità che saranno riprese in futuro. Peraltro, se in gran parte esso pare venir fuori dalla costola plurilinguistica del Sorriso dell’ignoto marinaio, con qualche ricordo dell’autobiografismo della Ferita dell’aprile, pure usufruisce di quella ricerca prosodica che dal barocco e rococò perviene ad una scrittura che vuol farsi classica pur bagnando la penna nell’ inquietudine ideale e nell’ insoddisfazione espressiva della contemporaneità.
Sorgono da amore, dolore e sdegno, dunque, le pagine di diverso memorialismo della raccolta: come I linguaggi del bosco e Le pietre di Pantalica, la prosa eponima del libro. Un memorialismo complesso, intricato e intrigante: un domestico, privato, autobiografico ricordo che è anche civile, antropologica memoria della vita e della storia. Si tratta di una memoria non cristallizzata, né soddisfatta di sé, ma dialettica, soprattutto agonistica. Un inusitato agonismo della memoria, perché non muove solo contro il presente, ma questa volta si agita e tenzona anche al suo interno, in forza della dinamica plurivocità delle componenti contenutistiche ed espressive.
Il decennio Novanta vede subito Consolo riproporre con forza un romanzo di argomento storico, ambientato nell’isola negli anni dell’avvento fascista. Pietro, un maestro elementare, dopo un attentato a proprietari e fascisti, fugge esule in Tunisia. L’opera in qualche modo riprende la tematica democratica di rivisitazione della nostra storia, come già nel Sorriso dell’ignoto marinaio, ma in una chiave formale diversa. Nottetempo casa per casa (1992) è stato considerato un romanzo postmoderno perché fondato sulla citazione letteraria da scrittori pur diversi (Manzoni, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Montale), sulla parodia, il rifacimento e l’alternarsi di usi linguistici molteplici, per concludere che tuttavia non si riteneva una soluzione postmoderna il prevalere in esso dell’italiano letterario, la scelta di uno stile eletto. Invero la convinzione consoliana che sia la letteratura a difenderci dal generale degrado e imbarbarimento sempre più pervasivi, non era una novità. L’idea della letteratura come “impostura” stava bene in piedi nel contesto particolare dell’opera del 1976, sia il contesto interno dell’opera, sia il contesto esterno.
Nell’Olivo e l’olivastro,l’autobiografismo dell’autore, che torna nella maturità a prorompere più apertamente, per farsi giudizio metapersonale viene traslato in terza persona. Affidarsi all’Ulisse mitico, della poesia omerica, serve all’Odisseo, al Nessuno di oggi, a procurarsi un’identità che, perduta nel presente, si può solo ricostruire nel passato, col passato. E solo così, nel naufragio, nella catastrofe generale, si può trovare una salvezza individuale. La poesia moderna si è servita della “enumeraciòn caotica” perché nominando le cose ha ritenuto di riconoscerle, di riguadagnarle. Oggi si ha il sospetto che si nominano le cose per segnalare la definitiva perdita di esse. Per questo lo scrittore o si serve di un linguaggio referenziale che ( “tradendo il campo” con “stanca ecolalia”) ha solo un compito informativo, oppure inventa un linguaggio metaforico che si deve descrittare nelle sue valenze interiori. In questo linguaggio irreale, dominato dalla dannazione dell’inesprimibile, ora le epifanie danno solo il senso della ricerca di una verità misteriosa da identificare. Con ciò e perciò la pratica di una scrittura visionaria, anche a partire da un apparente, semplice dato di cronaca.
Lo Spasimo di Palermo conclude, dopo Il sorriso e Nottetempo, il trittico narrativo in cui Consolo affronta la storia dell’isola dalla parte dei vinti e della Storia rinnega e demistifica storture e menzogne. La forma è sempre più ellittica e problematica, e tende allo scavo interiore e alla vertigine espressiva: il frutto di questa sfida sempre più impervia ai linguaggi piatti e strumentali della comunicazione è una scrittura insieme febbrile e raziocinante, accesa e vigile, tramata di poesia e di engagement. Di quest’ultimo fa fede il palese riferimento alle coraggiose e sfortunate inchieste del pool giudiziario di Palermo e alla tragica strage di via D’Amelio, in cui confluiscono le vicende e i destini dipanati nel romanzo.
Simbolo dell’immane fallimento d’una società e insieme d’una generazione che avrebbe voluto e potuto modificarla -è l’assassinio del coraggioso giudice, intravvisto dal protagonista – testimone, che è uno scrittore sfiduciato e votato al silenzio, nonché un padre altrettanto deluso e autocritico. La crisi della scrittura coincide così con lo “spasimo” estremo di una civiltà: un punto di non ritorno, ovvero di avvio di modalità espressive e di tensioni civili da rifondare.
In tutta la produzione di Vincenzo Consolo di manifestazioni vigorosamente mitopoietiche ve ne sono tantissime. Anzi si può dire che l’aspetto più precipuo della sua formalizzazione è il raccontare creativo, questo riprendere miti ricreandoli. Al principio dell’invenzione di Consolo ci furono la ferita (sì, La ferita dell’aprile, titolo della sua prima opera, è pure figura di un dato esistenziale) e la folgorazione poetica. Nella produzione di Consolo, a quanto se ne sa, si isolano due episodi di versificazione poetica vera e propria.
Mi riferisco a Marina a Tindari , del 1972, che dunque si colloca tra La ferita dell’aprile e Il sorriso dell’ignoto marinaio. Questo testo in versi, quasi sconosciuto, contiene molti, forse i principali temi dell’intera sua opera, anche certi usi lessicali: il vorticare; certe pratiche linguistiche. L’altro testo splendido è L’ape iblea- elegia per Noto, da cui è scaturito L’Oratorio composto da uno straordinario Francesco Pennisi ed eseguito a Firenze il 19 giugno 1998 al teatro Verdi. Nella tradizione passata e recente egli si ritaglia Verga e Vittorini poetici – già il siracusano riprendeva Montale – e propriamente il ‘vorticare’ lirico di Lucio Piccolo. Da quell’ulcerazione ne vennero i grumi di dolore da rappresentare per trame intense di una ricerca, appunto mitopoietica. La cognizione del dolore per avere tregua, per vivere delle soste, si riporta peraltro al mondo della natura. Al malessere alla perdita, cioè all’assenza della persona, si risponde con la presenza delle figure del mondo naturale. La scrittura ridona la memoria delle cose, e non sai se è ricordo umano o memoria di fisicità ancestrale, una presenza che prepara eventi, o appena un trasalimento di evanescenze.
Alla base di questa sua ricerca mitopoietica, certo, c’è un’opzione della positività umana, del vivere sociale che merita l’impegno civile del letterato, ma la maturazione di Consolo avviene tra rifiuto della letteratura che risulta nonostante le intenzioni, sempre esornativa, e fede nella scrittura che ripostula il mondo nel suo continuo inventare. Essa si colloca nell’alveo del rapporto fra tradizione e innovazione, tra norma ed eccezione. Non è paradossale per Consolo, come per tutti i siciliani, che nella superstite fedeltà alla norma l’eversione sposi uno sperimentalismo che invece di coniugarsi con l’avanguardia, la neo avanguardia, si muove nel solco di una tradizione che pure può stare stretta. Avverte tuttavia Consolo:
La tradizione non si può cancellare, e chi pretende di cancellarla agisce sull’idea stessa di letteratura, dico sul senso nobilmente bachtiniano di una letteratura che trama contro le cancellazioni dell’oblio. E’ questa la vera funzione della letteratura, nella quale si sperimenta un altro tipo di memoria.
E’ ovvio che fra tradizione e innovazione, anche nel pieno dell’eversione, il cemento è il reale, anzi, nel crogiuolo materiale, là dove i miti siciliani non sono arsenali, armamentari dell’arte isolana, ma costituiscono il seno materno di essa, per dirla con Karl Marx, il cemento è la realtà esistenziale dell’autore, il profondo e radicato vissuto biografico. La particolarità del rapporto che Consolo istituisce tra la sua effettuale vicenda biografica e la rappresentazione letteraria che ne dà, consiste nel fatto che tale vicenda piuttosto che essere, quasi ovviamente, deterministicamente ancorata ad una situazione storica – la nostra, terribile – risulta dolorosamente uncinata da questa.
In ciò è da riconoscere la condizione di sofferenza che qualifica e fa vibrare esistenzialisticamente il lavoro dello scrittore contemporaneo. Nella misura di questa sofferenza e nella modalità di esitarla, di uscirne anche, liricamente, sta il significato complesso e complessivo dell’operazione scrittoria di Consolo, cioè della sua invenzione che si costruisce sempre più in grumi di dolore e di rifiuto. L’invettiva contro il presente storico insopportabile, si coniuga, anzi ha radice in un malessere esistenziale personale, tra perdita e assenza. In tal senso è esemplare l’incontro con la madre nell’ Olivo e l’olivastro. Ad ogni modo in Consolo la carta della letteratura si giuoca nell’irrequietudine e questa ha il suo sigillo nella scrittura mitopoietica.
Palermo 20 GIUGNO 2007
Lo specchio di carta
Osservatorio italiano sul romanzo contemporaneo
nella foto Sergio Spadaro e Vincenzo Consolo