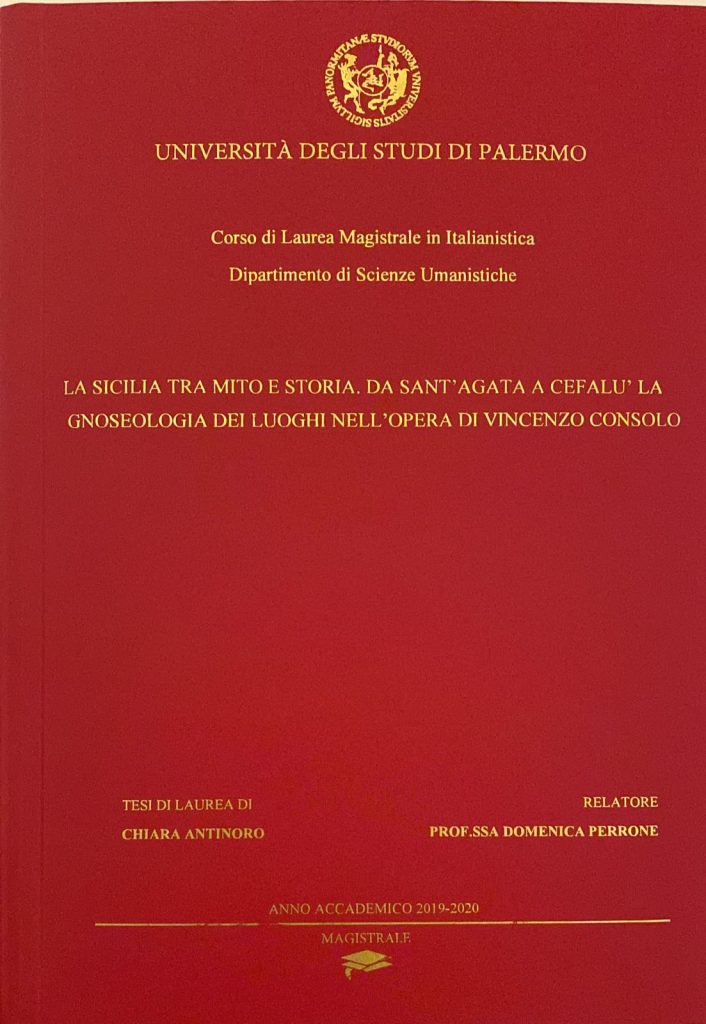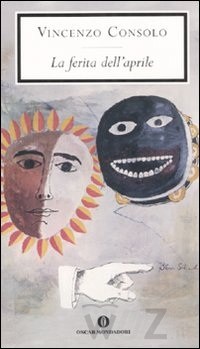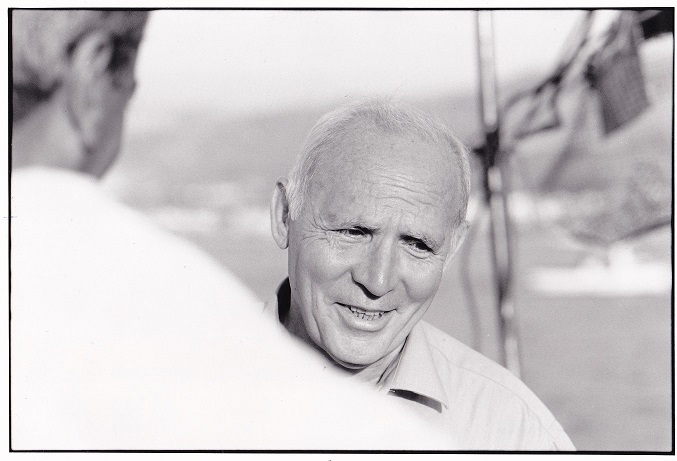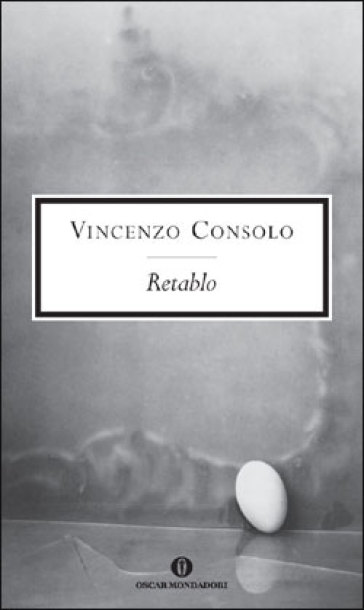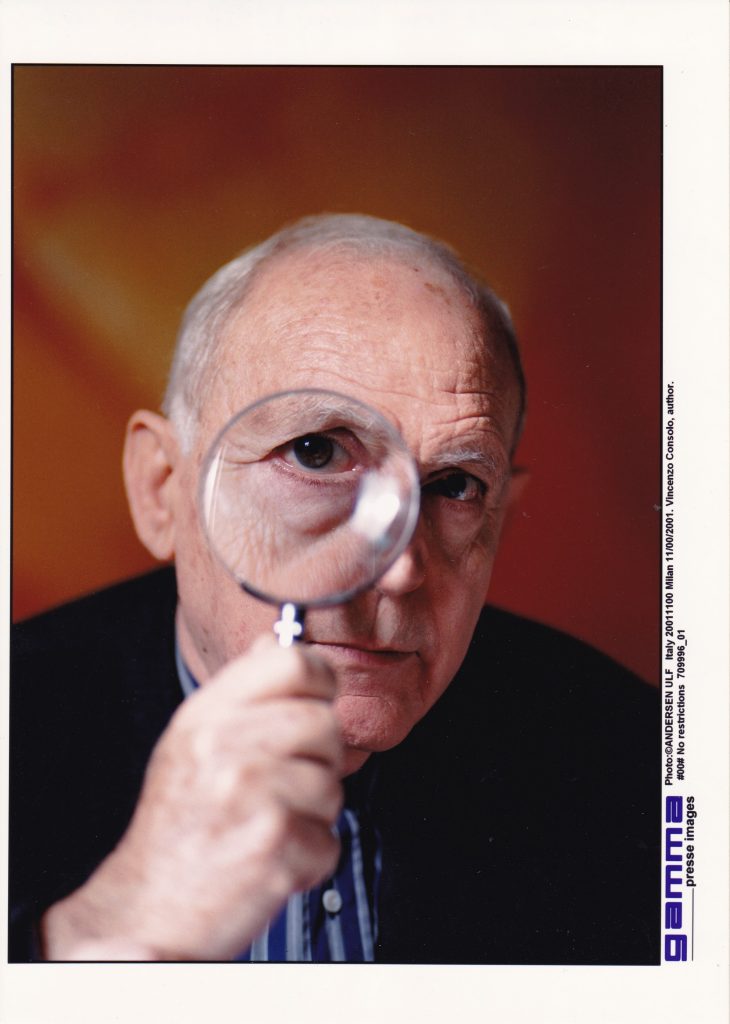
L’articolo indaga l’intenso dialogo tra i romanzi consoliani e le arti figurative, in particolare la pittura. Un dialogo che si avvale di strategie molteplici, le icone autoriali annunciate spesso dai titoli tematici dei romanzi, il ricorso all’ekphrasis nascosta, gli inserti critici riferiti alle opere d’arte. Con particolare riferimento a Il sorriso dell’ignoto marinaio ed a Retablo prende in esame, per altro, l’uso che lo scrittore fa dell’ekphrasis, il suo valore metanarrativo e metadiegetico.
L’opera di Consolo riserva ampio spazio alle citazioni figurative.[1] Lo scrittore, intervistato da Giuseppe Traina, ha dato una spiegazione della ricchezza dei riferimenti pittorici riscontrabili nei suoi romanzi ricorrendo ad un assunto semiologico, affermando la volontà di superare la contrapposizione tra lo svolgimento temporale del linguaggio verbale e lo svolgimento spaziale dell’opera figurativa. Per Consolo la continua evocazione dell’immagine riscontrabile nella sua scrittura risponde all’esigenza di equilibrio tra temporalità e spazialità:
Credo ci sia bisogno di equilibrio tra suono e immagine, come una sorta di compenso, perché il suono vive nel tempo, invece la visualità vive nello spazio. Cerco di riequilibrare il tempo con lo spazio, il suono con l’immagine. Poi sono stati motivi d’ispirazione, di guida, le citazioni iconografiche di Antonello da Messina o di Raffaello. In Retablo c’è l’esplicitazione dell’esigenza della citazione iconografica: il “retablo” appartiene alla pittura ma è anche “teatro”, come nell’intermezzo di Cervantes.[2]
La stessa perigrafia dei romanzi consoliani rinvia spesso a suggestioni figurative o a palesi citazioni pittoriche, evidenti fin dai titoli: com’è noto Il sorriso dell’ignoto marinaio fa riferimento al dipinto di Antonello da Messina, il ritratto virile d’ignoto custodito nel Museo Mandralisca di Cefalù. Anche Retablo, romanzo pubblicato nel 1987 per i tipi Sellerio, evoca la pittura fin dal titolo. Il termine catalano retablo indica infatti una pala d’altare inquadrata architettonicamente: essa può articolarsi in diversi scomparti formando un dittico, un trittico o un polittico costituito da tavole dipinte, talvolta da sculture o dall’alternanza di dipinti e bassorilievi, tenendo insieme, in quest’ultimo caso, imagines pictae e fictae. Il titolo scelto da Consolo, facendo riferimento ai polittici iberici, denunzia in primo luogo la vocazione pittorica del libro. Ma retablo è inteso dall’autore come un significante polisemico, come un lessema evocativo di rara e remota sonorità che contiene, ad un tempo, riferimenti figurativi, teatrali e letterari: «La parola retablo (parola oscura e sonora, che forse ci viene dal latino retrotàbulum: il senso, per me, dietro o oltre le parole, vale a dire metafora) l’ho assunta nelle varie accezioni: pittorica, shahrazadiana, cervantesiana».[3] Tra l’altro il lemma spagnolo rinvia alla memoria del Retablo de las meravillas di Miguel de Cervantes. L’evocazione cervantesiana può essere intesa anche come un riferimento al tratto illusorio dell’arte, motivo a cui il romanzo dedica più di una riflessione. Attraverso la scelta di un titolo di carattere tematico[4] l’autore allude, infine, all’organizzazione narrativa del libro, articolato per scene e quadri successivi che potrebbero essere considerati come delle tavole sovrapposte, pur mantenendo la loro autonomia narrativa. Il testo consoliano si configura dunque come un polittico, come una successione di quadri narrativi al centro dei quali sta il motivo odeporico, ovvero il viaggio del cavaliere Fabrizio Clerici nella Sicilia del XVIII secolo, e una tarsia di citazioni che ne fanno uno dei romanzi più complessi e levigati della letteratura italiana del secondo Novecento.

Per dare un titolo all’ampia intervista concessa all’IMES nel 1993, lo scrittore, ancora una volta, ha usato un riferimento pittorico evocando Fuga dall’Etna di Guttuso.[5] Consolo ha riproposto il nome che il pittore siciliano ha dato ad una tela di vaste dimensioni realizzata tra il 1938 e il 1939, la sua prima composizione corale, lungamente meditata e preparata attraverso studi, ritratti e paesaggi realizzati tra la Sicilia e la Sila.[6] Nel dipinto un’eruzione etnea assume un più ampio significato sociale e diventa l’occasione per rappresentare masse di contadini in fuga concitata, arditi scorci di cavalli che negli stilemi e nell’esemplificazione formale rivelano la memoria di Guernica di Picasso: un’allusione alla sofferenza del mondo contadino e al dramma della migrazione, anch’esso un vulnus iscritto nella storia del Novecento. Non è un caso che Consolo si sia ricordato del telero guttusiano: nell’intervista, infatti, l’autore ripercorre il suo itinerario biografico e intellettuale, parla dell’allontanamento dall’isola natale, della condizione di erranza, della metafora odissiaca che attraversa i suoi romanzi, del nostos impossibile e del trasferimento giovanile a Milano. La citazione di Fuga dall’Etna testimonia, tra l’altro, dell’amicizia tra lo scrittore e Guttuso che si traduce nelle argute allusioni presenti in diversi romanzi. Si veda, ad esempio, il cenno, incastonato nelle pagine di Retablo, al «pittore celebrato […] della Bagarìa», anacronisticamente collocato in un elenco di artisti siciliani d’epoca manierista o barocca: «Siete meglio del Monrealese, meglio dello Zoppo di Ganci, del Monocolo di Racalmuto, meglio di quel pittore celebrato (non ricordo il nome) della Bagarìa».[7] L’allusione consoliana, che qui assume le connotazioni di un ammiccante gioco a nascondere, non è dissimile dalla scelta di fare dell’amico Clerici, pittore lombardo inquieto e surreale, il protagonista del libro.

Anche l’ultimo romanzo di Consolo, Lo Spasimo di Palermo, fa riferimento a un’opera pittorica, il dipinto di Raffaello un tempo custodito nella chiesa palermitana di Santa Maria dello Spasimo e oggi esposto nelle sale del Museo del Prado. Secondo la narrazione del Vasari la tavola dell’Urbinate sarebbe giunta in Sicilia per mare, attraverso fortunosi accadimenti.[8] La citazione dello Spasimo (ovvero della raffaellesca Andata al Calvario di Cristo) è usata per conferire una connotazione martirologica alla narrazione. Il romanzo, infatti, si confronta col tema dell’impotentia scribendi, con lo smarrimento del protagonista e, nelle pagine conclusive, allude alla strage di via D’Amelio, all’attentato che determinò la morte di Paolo Borsellino. Il simbolismo sotteso dal riferimento pittorico è intensificato dalla riproduzione di una pagina dello spartito del Dies irae del compositore augustese Manuele d’Astorga.[9] La citazione pittorica, il ricercato recupero di un testo musicale d’epoca barocca, i riferimenti cinematografici portano al massimo grado l’orchestrazione plurima dei codici, facendo culminare la narrazione in una successione di suggestioni sinestetiche che conferiscono forza al tragico explicit.
Oltre alla perigrafia, alle tarsie intertestuali ed alle note icone autoriali di Consolo, ovvero alle esplicite costruzioni ecfrastiche dedicate al ritratto virile di Antonello da Messina nel Sorriso dell’ignoto marinaio, all’oratorio serpottiano di San Lorenzo in Retablo, al caravaggesco Seppellimento di Santa Lucia ne L’olivo e l’olivastro ed alla tavola raffaellesca nello Spasimo, Miguel Ángel Cuevas ha messo in evidenza il ricorso, da parte dello scrittore, alla strategia dell’«ekphrasis nascosta».[10] Cuevas, attraverso lo studio variantistico delle opere consoliane, ha sottolineato come l’autore tenda all’occultamento dell’originario costrutto ecfrastico, restituendo al lettore non la descrizione di un’immagine, ma la sua immediatezza:
L’occultamento della dimensione ecfrastica del testo finisce per far diventare l’immagine un’alterità senza equivalenze, senza punto di riferimento: un’alterità assoluta; le figure si palesano in una loro ambiguità atopica, all’interno della quale la persistenza di segni elocutivi descrittivi potrebbe essere interpretata – non solo, ma almeno anche – come indizio del flusso di coscienza, come l’apparire, in ogni caso, di una diversa voce narrante: che paradossalmente provoca effetti di denarrativizzazione.[11]
Se l’ekphrasis, figura di pensiero per aggiunzione che la retorica ha considerato da sempre il mediumtra la letteratura e le arti, è la descrizione verbale di una rappresentazione visuale, se, come ha affermato Mengaldo, la «descrizione verbale non mima l’opera, ma lo sguardo che percorre l’opera»,[12] la strategia di opacizzazione referenziale adottata da Consolo rende ancora più complessi i rapporti intercorrenti tra testo e immagine. Il ricercato equilibrio tra temporalità e spazialità, di cui lo scrittore ha parlato nell’intervista concessa a Traina, rivela risvolti assai complessi considerando che spesso, nelle narrazioni consoliane, la visività verbale si pone come controfigura di un’immagine non dichiarata: «rapporti, in definitiva, basati su convergenze o parallelismi che incrinano, mostrandone l’obsolescenza, le tradizionali ed escludenti collocazioni delle immagini su un asse spaziale in rapporto al logos che si svolge sulla temporalità».[13]
In sintesi il rapporto tra i romanzi di Consolo e la pittura si avvale di strategie molteplici: la retorica della citazione e le icone autoriali che spesso sono preannunciate dal titolo tematico dell’opera; le ekphrasis nascoste, incastonate in una scrittura sempre caratterizzata da forte pittorialità; inserti critici e metadiegetici riferiti alle opere d’arte che testimoniano la raffinata formazione dell’autore e contribuiscono ad accentuare l’antinarratività delle sue opere dalla densa struttura ‘palinsestica’.[14] Un’ulteriore riflessione, sulla scorta degli studi di Michele Cometa dedicati alla retorica visuale, si impone in rapporto alle diverse forme di integrazione dell’ekphrasis nelle opere consoliane.
1. Il sorriso dell’ignoto marinaio: la funzione metapoetica e metanarrativa dell’ekphrasis
Si è già notato che Il sorriso dell’ignoto marinaio fa riferimento, fin dal titolo, ad un dipinto antonelliano, il ritratto virile custodito al Museo Mandralisca di Cefalù. La tavola quattrocentesca, che una tradizione suggestiva ma infondata indicava come il ritratto di un marinaio, è alla base dell’ordine delle somiglianze che attraversa il romanzo. Fin dall’incipit il protagonista, barone Enrico Pirajno di Mandralisca, tiene la tavola dipinta sotto braccio, riportandola da Lipari, dove l’ha fortunosamente scoperta, al suo palazzo cefaludese. L’antefatto del primo capitolo fa da sintesi del viaggio dell’aristocratico collezionista e vi dà un’esatta collocazione cronotopica, datandolo 12 settembre 1852: «Viaggio in mare di Enrico Pirajno barone di Mandralisca da Lipari a Cefalù con la tavoletta del ritratto d’ignoto di Antonello recuperata da un riquadro dello stipo della bottega dello speziale Carnevale».[15]
Leggendo il romanzo si scopre che il volto effigiato nel dipinto è somigliante a quello del patriota Giovanni Interdonato, l’uomo che il barone ha scorto, travestito da marinaio per sfuggire alle rappresaglie borboniche, nell’imbarcazione che lo riportava alla sua dimora. L’Interdonato avrà un ruolo essenziale nel determinare la presa di coscienza politica del Mandralisca. Otto anni dopo il viaggio alle Eolie, infatti, nel crinale storico del 1860, il Pirajno abbandonerà i suoi studi eruditi, la passione per la malacologia, il suo interesse per il collezionismo di mirabilia naturalia et antiquaria perseguito secondo l’habitus aristocratico e, essendosi rispecchiato nel volto dell’amico, muoverà da un generico liberalismo ad una più profonda comprensione della questione sociale.
Incastonata nel primo capitolo del Sorriso è la celebre ekphrasis del quadro di Antonello, ospitato tra le collezioni del Mandralisca:
Apparve la figura d’un uomo a mezzo busto. Da un fondo verde cupo, notturno, di lunga notte di paura e incomprensione, balzava avanti il viso luminoso. […] L’uomo era in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diventerà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto. L’ombra sul volto di una barba di due giorni faceva risaltare gli zigomi larghi, la perfetta, snella linea del naso terminante a punta, le labbra, lo sguardo. Le piccole, nere pupille scrutavano dagli angoli degli occhi e le labbra appena si stendevano in un sorriso. Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà. Al di qua del lieve sorriso, quel volto sarebbe caduto nella distensione pesante della serietà e della cupezza, sull’orlo dell’astratta assenza per dolore, al di là, si sarebbe scomposto, deformato nella risata aperta, sarcastica, impietosa o nella meccanica liberatrice risata comune a tutti gli uomini.[16]
La descrizione del ritratto è anche una sua interpretazione oscillante tra etopea e prosopografia, ricca di connotazioni fisiognomiche che verranno riproposte per stabilire il complesso gioco di rifrazioni e proiezioni identificative tra i personaggi del romanzo.

La giusta età della ragione, l’ironia che si pone come tertium tra l’eccesso di severità e il riso aperto, sarcastico o spietato, anticipa il percorso di maturazione politica ed esistenziale del protagonista. Consolo piega così a particolare partitura quella vocazione fisiognomica presente nei romanzi di molti scrittori siciliani, da De Roberto a Tomasi di Lampedusa, da Sciascia ad Addamo. Del resto a indirizzare il lettore verso un’attenta interpretazione del testo è la citazione in esergo, tratta dall’Ordine delle somiglianze di Sciascia: «Il giuoco delle somiglianze è in Sicilia uno scandaglio delicato e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza […]. I ritratti di Antonello “somigliano”; sono l’idea stessa, l’arché della somiglianza […]. A chi somiglia l’ignoto del Museo Mandralisca?».[17] Nell’economia narrativa del Sorriso sono diverse le ipostasi del riconoscimento e del rispecchiamento che stabiliscono la tensione speculare tra i personaggi principali. Significativamente il momento in cui l’aristocratico individua nell’Interdonato il marinaio già scorto nel viaggio del 1852 è anche il momento in cui egli si accorge della straordinaria somiglianza tra il patriota e l’uomo effigiato nella tavola antonelliana.[18]
Il ritratto di Antonello, nella Memoria che il Mandralisca invia all’Interdonato sui fatti di Alcàra Li Fusi, vero e proprio nucleo ideologico del romanzo, diventa anche l’emblema di una ragione distaccata, condizionata dalla nascita, dalla posizione di casta o dalle necessità di carriera. Rispecchiandosi nel ritratto antonelliano, in altre parole, il Mandralisca pone una spietata critica a se stesso, alla sua classe sociale, alle sue «imposture»,[19] alla stessa intellettualità progressista che concepisce comodi ideologemi e interessate teleologie, a partire dalla stessa retorica risorgimentale.
Cuore di molteplici tensioni narrative, simboliche e proiettive, la tavola di Antonello assolve dunque ad un ruolo capitale nel romanzo, ben lontana dall’essere una semplice citazione iconica. Usando il linguaggio di Cometa è utile indagare, in quest’opera consoliana, l’«integrazione per trasposizione»[20] dell’ekphrasis.La riflessione dello studioso, sulla scorta della rilettura di un testo classico come le Immagini di Filostrato, categorizza diverse forme di integrazione ecfrastica, da intendersi come integrazione da parte del lettore nel suo repertorio.[21] Scrive Cometa: «Il lettore è dunque invitato non solo a penetrare con lo sguardo nell’immagine ma anche a integrarla con le proprie preconoscenze e con la propria esperienza pregressa».[22] Naturalmente nel Sorriso si possono riconoscere forme molteplici di integrazione dell’ekphrasis, e tra esse l’«integrazione ermeneutica»,[23] forse il procedimento più ricercato alla base del patto ecfrastico: nel Sorriso la descrizione dell’opera d’arte si avvale delle consapevolezze critiche, iconografiche e iconologiche di Consolo, in dialogo con quel lettore colto che le possieda e le sappia intendere. Come vedremo in seguito gli inserti critici e metadiscorsivi hanno una parte significativa nel Sorriso. Ma il romanzo del 1976 rimane un caso esemplare in cui l’opera d’arte assume un vero e proprio ruolo genetico, al punto che l’intero plot è stato concepito attraverso costanti rinvii ad essa. È parimenti evidente che la descrizione del ritratto antonelliano assolve alle funzioni metapoetica e metanarrativa, nel senso postulato da Cometa che ha recuperato motivi propri della poetologia schlegeliana e romantica, secondo cui l’ekphrasis permette di prefigurare ed anticipare il senso di un romanzo, costituendo un dispositivo in cui l’opera letteraria si «rispecchia», una lente in cui si scorge un’«immagine unitaria della narrazione».[24]
Oltre al caso dell’icona antonelliana, si possono individuare nel Sorriso molteplici esempi di ekphrasis nascosta; per tutti la descrizione, incastonata nel primo capitolo, di un cavatore di pomice liparitano sofferente, osservato dal Mandralisca durante il viaggio da Lipari a Cefalù. Come ha messo in evidenza Cuevas, nella descrizione dell’uomo si riconosce un dettaglio della Crocefissione di Anversa, una tavola antonelliana in cui il ladrone di sinistra si attorce in un ultimo spasimo che precede la morte.[25] Vi è nel Sorriso un’essenziale e ben nota triangolazione di riferimenti figurativi: il ritratto antonelliano, la Crocefissione di Anversa e Los desastres de la Guerra di Goya, i cui titoli scandiscono la narrazione del settimo capitolo, dedicato alla sanguinosa rivolta contadina di Alcàra Li Fusi ed alla sua repressione.[26] Come ha sottolineato Rosalba Galvagno alcune ekphrasis del Sorriso possono essere ricondotte alle incisioni de Los desastres.[27] Ma il novero dei rinvii meno evidenti alle arti plastiche e figurative è molto ampio. Non manca chi ha individuato nella rappresentazione dello studiolo del Mandralisca un probabile riferimento al San Gerolamo di Vittore Carpaccio, alle opere di Filippino Lippi o a quelle del ceroplasta siracusano Matteo Durante.[28]
Tra i tanti riferimenti espliciti alle arti sono riscontrabili cenni alla statuaria ed alla produzione ceramica greca, all’icona marmorea del Giovane con la tunica del Museo Whitaker di Mozia ed al cratere del Pittore di Lipari rappresentante la vendita del tonno. Altri riferimenti evocano il Trionfo della morte di Palermo (l’affresco tardogotico di Palazzo Sclafani che ha ispirato Guernica di Picasso, citato spesso anche da Sciascia e Bufalino), le sculture rinascimentali di Francesco Laurana ed Antonello Gagini, le tele del secentista Pietro Novelli. La descrizione delle collezioni messe insieme dal Mandralisca restituisce una fitta successione di citazioni pittoriche:
Venne il momento della visita al museo. Guidati dal barone Mandralisca, fecero il giro della quadreria disposta in doppia fila alle pareti. Sentirono distratti elogiare la luce dell’Alba a Cefalù del Bevelacqua, l’espressione intensa della Sant’Anna del Novelli, la sapienza prospettica dell’Ultima Cena della scuola del Ruzzolone, dove le figure erano così tonde e grosse, così sazie, che sembrava quella sì un’ultima cena, ma il cui inizio non si conosceva, con portate continue di maccheroni al sugo. E così avanti, per le tavole bizantine, per ignoti siciliani, per i napoletani e gli spagnoli, fino a quello della giovane formosa che offre alle labbra di un vecchio rinsecchito il capezzolo rosa d’una mammella bianca che sbuca dallo scuro in piena luce.[29]
Nella rappresentazione dei dipinti non mancano increspature ironiche, come nel rapporto che viene stabilito, con un improvviso abbassamento del tono della narrazione, tra il motivo iconografico dell’Ultima cena e le «portate continue di maccheroni al sugo»: un’allusione al succulento banchetto che è probabilmente l’unico motivo per cui gli ospiti hanno accettato l’invito del barone a recarsi nella sua dimora e «godere la visione di una nuova opera unitasi alla loro collezione».[30] La stessa capacità rovesciante è rivelata nella descrizione di un dipinto che fa riferimento alla lactatio, tradizionale emblema di una delle Virtù Teologali, la Carità. Lo statuto iconografico che, nella tradizione figurativa barocca era l’occasione per rappresentare la nudità e la procacità femminili, esplicita qui il suo sottointeso erotico e diventa un’allusione alla ben poco edificante brama di un «vecchio rinsecchito»,[31] con un evidente riferimento alle Sette opere di Misericordia di Caravaggio.
Consolo, nel Sorriso, recupera un motivo letterario e parodico, quello dell’antiquario, della sua greve erudizione, della sua mania collezionistica che ha un archetipo nella goldoniana Famiglia dell’antiquario e conosce significative riprese anche nei romanzi di Capuana e De Roberto.[32] Non è un caso che, scorgendo una statua classica tra i marmi accatastati in un’imbarcazione, immaginando di accaparrarsela, il Pirajno si ponga in fantasiosa competizione con altri aristocratici dediti alla raccolta di nobilia opera del passato. Rappresentando la brama del Mandralisca, lo scrittore incastona nella narrazione un elenco dei maggiori collezionisti siciliani realmente esistiti ed attivi tra il XVIII e il XIX secolo:
Uh, ah, cazzo, le bellezze! Ma dove si dirigeva quella ladra speronara, alla volta di Siracusa, bianca, euriala e petrosa, o di Palermo, rossa, ràisa e palmosa? Pirata, pirata avrebbe voluto essere il barone, e assaltare con ciurma grifagna quella barca, tirarsela fino all’amato porto sotto alla rocca […]. Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale, il Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina.[33]
L’ironia consoliana raggiunge il culmine nella descrizione dei crateri attici radunati nella collezione Mandralisca, con le loro scene erotiche ed altre raffigurazioni ispirate ai baccanalia, certamente non confacenti alla morale del XIX secolo:
Oltre al Venditore di tonno, oltre a matrone languide, sdraiate, con ancelle attorno che le aiutavano a fare toilette, i vasi neri e rossi mostravano fauni impudichi e sporcaccioni, con tutta l’evidenza dritta della infoiatura, che abbrancavano per la vita, per le reni ninfe sgambettanti per portarsele, poverette, chissà dove; altre scene di fughe e rapimenti, altre di ragazze estatiche davanti a giovanotti inghirlandati e con bordoni in mano di cui non si capivano le intenzioni. Gli uomini si davano gomitate, facevano ammiccamenti, azzardavano sottovoce interpretazioni, mentre il barone li informava sull’epoca e sul luogo della provenienza di quelle antichità.[34]
Concependo il suo romanzo come un «antiromanzo storico»,[35] sullo sfondo di un Risorgimento gramscianamente inteso come mancata rivoluzione, Consolo ha usato la sua conoscenza della storia dell’arte per fare il verso al barone collezionista, per rappresentare la vacuità della sua classe sociale. L’integrazione ermeneutica dei costrutti ecfrastici vuole il concorso esegetico del lettore, la sua comprensione dei passaggi ironici. La «plurivocità» del Sorriso,[36] oltre che nei processi parodici, è ravvisabile nella stessa contraddittorietà e complessità di un personaggio come il Mandralisca che, in ultimo, riuscirà ad allontanarsi dalla concezione erudita ed esornativa della cultura propria della sua classe sociale, destinata ad un ineluttabile declino, acquisendo un’acuta e demistificante consapevolezza politica.
2. Retablo, o delle rifrazioni ad infinitum
Consolo ha fatto del pittore milanese Clerici il protagonista di Retablo. Le allusioni a Clerici e Guttuso non sono casuali. Ad ispirare il romanzo, infatti, è stato un viaggio in compagnia dei due artisti nella Sicilia orientale, un’occasione in cui lo scrittore ha rivisto i templi dorici di Segesta, Selinunte e Agrigento percorrendo alcune delle tappe canoniche del Grand Tour d’Italie.[37] Consolo, dunque, ispirandosi ad un fatto realmente accaduto, ha dato un doppio letterario al suo amico. A complicare il gioco di allusioni vi è la perigrafia, la scelta di illustrare la prima di copertina della prima edizione del libro con un dettaglio di un dipinto di Clerici,[38] ed ancora la scelta di incastonare nel testo diverse ekphrasis ispirate all’opera dello stesso artista. Non sembra un caso che il pittore milanese sia stato anche il protagonista di un romanzo di Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, ed abbia fatto conoscere a Sciascia La tentazione di Sant’Antonio, la tela del manierista Rutilio Manetti in cui è effigiato il diavolo con gli occhiali, investito di forti valori simbolici nel romanzo Todo modo.[39]Le vertiginose rifrazioni del libro consoliano sono degne della teoria di rispecchiamenti de Las Meninas di Velázquez, dipinto emblematico della temperie barocca.
La rappresentazione di un viaggio in Sicilia nel XVIII secolo, la ricchezza di riferimenti figurativi e la diffusa retorica dello sguardo fanno di Retablo l’opera consoliana in cui il rapporto tra letteratura e pittura si fa più intenso e insistito.[40] I rimandi figurativi, per altro, agiscono in profondità, fino a dare forma alla stessa architettura ed alla focalizzazione del racconto. Il romanzo, infatti, è ripartito in tre capitoli o tavole: Oratorio, Peregrinazione e Veritas. A ciascuna di queste parti corrisponde una diversa voce narrante, quella di Isidoro in Oratorio, quella di Clerici in Peregrinazione e quella di Rosalia in Veritas. Un intreccio di voci che restituisce al lettore gli stessi accadimenti osservati da angolazioni diverse, moltiplicando prismaticamente le visioni e le possibili interpretazioni della realtà.
Ad incipitdi Oratorio è posto il celebre inno che Isidoro innalza a Rosalia: una petitio amorosa, una laica preghiera, una litania o un delirio in cui la scomposizione del nome dell’amata in Rosa e Lia, il moltiplicarsi delle figure fonetiche ed etimologiche, l’intertestualità non priva di echi danteschi e petrarcheschi, l’investimento ambiguo ed ambivalente della donna si spingono ad un parossistico virtuosismo. Subito dopo Isidoro, dedito alla questua e alla vendita delle bolle, narra in prima persona l’amore concepito per la giovane che, quotidianamente, gli appariva alla finestra insieme alla madre. Le due donne hanno ordito il raggiro dell’inesperto questuante facendogli credere di poter sposare la ragazza e, fattesi consegnare il denaro delle bolle, sono scomparse nel nulla. Cacciato dunque dal convento, il fraticello è ridotto alla condizione di facchino alla Cala di Palermo. Qui, finalmente, gli appare il cavaliere Clerici, sceso da una nave che ha il nome simbolico di Aurora.[41] L’aristocratico viaggiatore prende con sé Isidoro, lo allontana dalla vita dura ed ambigua del porto e ne fa il suo accompagnatore nel viaggio in Sicilia volto all’osservazione e alla riproduzione dei monumenti antichi. Quando Clerici fa conoscere al fraticello il cavaliere Serpotta e gli mostra l’oratorio palermitano di San Lorenzo, questi scorge nella statua della Veritas il sembiante dell’amata Rosalia, va in escandescenze e sviene.
Come si vede da questa veloce sintesi il primo capitolo di Retablo consegna subito al lettore una pluralità di toni: l’incipitlirico, la seduzione e il raggiro di Isidoro che rinvia all’archetipo novellistico di Boccaccio, la rappresentazione della baraonda della Cala, non priva di dettagli bassi, spuri e scatologici, la descrizione dettagliata dell’oratorio serpottiano. Il primo apparire di Rosalia tra i vicoli di Palermo è una delle tante ekphrasis nascoste che costellano la narrazione, annunciata da un preciso riferimento al «riquadro», ovvero alla finestra da cui si sporge la ragazza in compagnia della madre:
Alzai gli occhi e vidi nel riquadro, ah, la mia sventura!, la donna che teneva la funicella del panaro e accanto una fanciulla di quindici o sedici anni, la mantellina a lutto sulla testa che lei fermava con graziosa mano sotto il mento. E gli occhi tenea bassi per vergogna, ma da sotto il velario delle ciglia fuggivan lampi d’un fuoco di smeraldo. Mai m’ero immaginato, mai avevo visto in vita mia, in carne o pittato, un angelo, un serafino come lei.[42]
La scena, più che un generico riferimento all’Annunciata antonelliana di palazzo Abatellis, rinvia ad un’opera di Bartolomé Esteban Murillo, Las Gallegas, ovvero Due donne galiziane alla finestra, custodita alla National Gallery di Londra: un riferimento fino ad oggi non evidenziato dalla letteratura critica, tuttavia ricco di impliciti che contribuiscono a connotare la figura di Rosalia. Nel dipinto appaiono due donne, una giovane e una matura, che affacciandosi alla finestra ammiccano al passante-spettatore: un espediente che, attraverso lo sguardo muliebre, tende ad oltrepassare lo spazio della tela, come spesso accade nelle opere del secentista spagnolo. Si tratta di un dipinto di genere popolaresco, una scena di seduzione in cui è forse raffigurata una giovane prostituta con la sua mezzana. Il dettaglio della mantellina fermata con la mano sotto il mento è puntualmente riscontrabile nella descrizione di Retablo e si fa indice dell’esatta referenzialità del testo consoliano. L’ekphrasis delinea dunque l’immagine ambivalente della giovane, il cui atteggiamento, in apparenza pudico, dissimula una capacità seduttiva rivelata dallo sguardo che, «sotto il velario delle ciglia», emana, secondo una significativa sinestesia, «lampi d’un fuoco di smeraldo».[43]

Fin dalla prima apparizione, dunque, Rosalia è rappresentata secondo le valenze ambigue della donna levatrice e sprofondatrice, una duplicità iscritta nel suo stesso nome composto che rinvia alla patrona palermitana, quella Santa Rosalia nella cui iconografia, inventata nei primi decenni del Seicento, confluiscono non pochi statuti rappresentativi della Maddalena.[44] Un percorso iconografico certo non ignoto a Consolo che, nell’inno di Isidoro, si avvale dell’oscillazione tra la figura laica e quella profana di Rosalia, facendo riferimento alla statua marmorea della santa venerata nel santuario di Monte Pellegrino.[45]
Già in Oratorio, dunque, la giovane donna appare ad una finestra, tecnema della visione non dissimile dalla cornice di un dipinto,[46] viene ricordata attraverso il simulacro marmoreo della santa, la si immagina rappresentata in una delle figure in stucco dell’oratorio serpottiano, è evocata ripetutamente nelle catene paronomastiche e nella dimensione ecoica dell’inno incipitario che scompone e richiama ripetutamente il suo nome: tutti simulacra del sentimento amoroso concepito da Isidoro, espressione dell’ossessione del fraticello e dell’intangibilità di uno sfuggente oggetto del desiderio.[47] Per altro, nella rappresentazione laico-profana di Rosalia e nelle reduplicazioni della sua immagine, è facile scorgere la suggestione de Gli elisir del diavolo di Hoffmann.
Tra le statue che ritraggono Rosalia vi è l’allegoria serpottiana della Verità che, secondo lo statuto iconografico, è rappresentata come Nuda Veritas. La descrizione del teatro plastico settecentesco è una delle più note icone autoriali incastonate nel libro che nasconde, nella stessa rappresentazione degli stucchi rischiarati da un raggio di sole, l’ekphrasis di un dipinto di Clerici. Il raggio che penetra nell’aula, che colpisce una ninfa di cristallo e, rifrangendosi, illumina le statue, è lo stesso che si può scorgere in una tela del pittore milanese, La grande confessione palermitana: il chiarore diffuso dal raggio solare, consustanziale al «bianco puro»[48] dell’oratorio, rivela nel dipinto una natura luttuosa che lega le candide statue all’immagine funerea dei corpi imbalsamati delle catacombe dei Cappuccini di Palermo. Ecco che il testo consoliano, in una vertiginosa sovrapposizione, include in una descriptio un’altra ekphrasis. Come ha rilevato Maria Rizzarelli: «L’ordine delle somiglianze che nel Sorriso costituiva il principio gnoseologico della conversione ideologico-sociale del Mandralisca, diviene qui ordine delle apparenze, da fondamento conoscitivo si trasforma, attraverso l’esasperante trionfo della figura del doppio, in ordine dell’illusione con cui s’identifica l’arte».[49]
La rappresentazione dell’oratorio è il punto culminante del capitolo iniziale di Retablo. Se in questa prima parte del romanzo si incontrano alcuni grandi pittori e artisti (un rapido cenno è dedicato anche al dipinto palermitano di Caravaggio, la Natività), il secondo capitolo, Peregrinazione, è totalmente incentrato sulla figura di Clerici che, accompagnato da Isidoro, intraprende il suo viaggio e la sua esplorazione della Sicilia.

Anche Clerici viaggia per l’isola con l’intento di dimenticare la donna amata, Teresa Blasco, futura sposa di Cesare Beccaria e dunque futura nonna di Alessandro Manzoni.[50] Alla nobildonna milanese, il cui padre ha origine spagnola e la madre siciliana, il cavaliere dedica il suo diario di viaggio. Fin dalla Dedicatoria, indirizzata a Teresa, Clerici si dice intenzionato a illustrare e a narrare la patria materna della donna, rivelando così l’intenzione di avvalersi sia della parola che dell’immagine, di usare entrambi i codici per rappresentare la Sicilia.[51] Del resto, già in Oratorio, l’aristocratico viaggiatore è stato presentato da Isidoro in virtù della sua abilità di disegnatore: «Quel don Fabrizio che sbarcò in Palermo, con la fortuna mia, per viaggiare l’Isola, scoprire l’anticaglie e disegnar su pergamene con chine e acque tinte templi e colonne e statue di cittate ultrapassate».[52] Lo stesso cavaliere, ben presto, sente l’esigenza di porre sotto gli occhi di donna Teresa non solo le immagini del mondo classico, i monumenti antichi, ma anche le brutture della società contemporanea. Clerici si rivela, dunque, un viaggiatore assai lontano da compiacimenti arcadici e vagheggiamenti idilliaci, dall’eterno archetipo della pastorale teocritea e dalle sue riprese settecentesche. Le sue intenzioni e il suo sguardo disilluso preannunciano un motivo che diventerà dominante nei successivi romanzi consoliani, il contrasto tra la memoria del passato e un presente di rovina, immemore e degradato.
Il percorso di Clerici ricalca parzialmente quello del Grand Tour nella Sicilia occidentale: Palermo, la vicina Monreale, Alcamo, Segesta, Selinunte, Mozia e Trapani. Retablo rimodula dunque, attraverso una complessa trama intertestuale, temi e motivi propri dell’odeporica settecentesca, configurandosi come un Voyage pittoresque, un Conte philosophique e un romanzo picaresco. Lo sguardo di Clerici è quello straniante del pittore, aduso a scrutare le fisionomie, a indovinare l’animo di chi gli sta di fronte. La sua visione è arguta e disincantata, in altre parole è quella di uno smaliziato e inquieto viaggiatore novecentesco, anche se le illusioni, gli apparati effimeri, le rifrazioni, le quinte teatrali e i retabli ingannevoli appaiono ad ogni passo del suo viaggio, adatte a rappresentare le oltranze immaginative di pittori, scultori e architetti della Sicilia barocca o tardobarocca. Il trionfo della teatralità e la voglia di destare meraviglia trovano il culmine nella descrizione di Alcamo, la patria del Soldano Lodovico, il luogo dove si riunisce l’Accademia de’ Ciulli Ardenti che, con la sua poesia edulcorata e pretenziosa, non rende onore all’autore del Contrasto. È qui che, in occasione della festa del paese, appare il Retablo de las meravillas, un apparato aniconico e illusorio in cui ogni spettatore può proiettare e scorgere i suoi fantasmi.
Nell’ultimo capitolo di Retablo, Veritas, Rosalia racconta finalmente la sua verità: realmente innamorata di Isidoro, è divenuta una cantante che si appresta a debuttare in una rappresentazione della Vergine del Sole di Cimarosa. Ospite nel palazzo di un munifico marchese, è stata educata al bel canto da don Gennaro Affronti, un artista castrato che le ha fatto da «padre» e da «madre».[53] Rosalia si è dunque mantenuta fedele ad Isidoro, convinta che per preservare un amore sia necessaria la sua cristallizzazione. Per questo esorta l’amato a ritornare alla vita passata ed alla sicurezza claustrale.
Ogni aspetto della vita e dell’arte, in Retablo, si rivela illusorio: l’amore di Isidoro e Rosalia verrà preservato solo a costo di una monacazione spirituale; l’amore concepito da Clerici per donna Teresa Blasco non è ricambiato. Frequenti sono i dubbi, espressi dallo stesso Clerici, sulla possibilità di rappresentare quant’egli ha osservato nel suo viaggio: l’impotenza dell’arte è metaforizzata dalla condizione del castrato don Gennaro, ovvero dalla sua impotentia generandi. L’uso sapiente dei costrutti ecfrastici e delle rifrazioni che sembrano riproporsi ad infinitum allude all’intangibilità della realtà. Motivi che percorrono in modo insistito l’opera di Consolo e, dopo essersi affacciati in Retablo, passando per un testo capitale come Catarsi, giungono alle pagine intensamente patemiche dello Spasimo. Ma anche per viam negationis l’autore, col vertiginoso spessore palinsestico della sua opera, ha riaffermato la necessità dell’arte e della scrittura, del nesso intimo tra parola e immagine, del loro irrinunciabile valore tetico.
1 Cfr. M. Á. Cuevas, ‘Ut Pictura: El imaginario iconográfico en la obra de Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10, 2005, pp. 63-77.
2 G. Traina, Vincenzo Consolo, Fiesole (FI), Cadmo, 2001, p. 130.
3 La citazione è tratta da S. Puglisi, Soli andavamo per la rovina. Saggio sulla scrittura di Vincenzo Consolo, Acireale-Roma, Bonanno, 2008, p. 207.
4 Cfr. G. Genette, I titoli, in Id., Soglie. I dintorni del testo, Torino, Einaudi, 1989, pp. 55-101.
5 V. Consolo, Fuga dall’Etna, Roma, Donzelli, 1993.
6 Per le immagini di Fuga dall’Etna e dei suoi bozzetti cfr. F. Carapezza Guttuso (a cura di), Guttuso. Capolavori dai musei, Milano, Mondadori Electa, 2005, pp. 60-61.
7 V. Consolo, Retablo, Palermo, Sellerio, 1987, ora in Id., L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2015, p. 417. Tutte le successive citazioni saranno tratte da questa edizione.
8 Cfr. G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, Torino, Einaudi, 1991, pp. 630-631.
9 Per uno studio della fitta intertestualità de Lo Spasimo di Palermo mi permetto di rinviare a D. Stazzone, ‘Testi e intertesti in Vincenzo Consolo: Lo Spasimo di Palermo’, in F. Cattani, D. Meneghelli (a cura di), La rappresentazione allo specchio. Testo letterario e testo pittorico, premessa di S. Albertazzi, M. Cometa, M. Fusillo, Roma, Meltemi, 2008, pp. 185-201.
10 Adotto qui le definizioni di «icona autoriale» ed «ekphrasis nascosta» proposte in M. Á. Cuevas, ‘L’arte a parole. Intertesti figurativi nella scrittura di Vincenzo Consolo’, in R. Galvagno (a cura di), «Diverso è lo scrivere». Scrittura poetica dell’impegno in Vincenzo Consolo, introduzione di A. Di Grado, Avellino, Biblioteca di Sinestesie, 2015, pp. 17-37. Di notevole valore teorico è l’introduzione alla raccolta degli scritti per artisti di Consolo: M. Á. Cuevas, ‘L’arte a parole’, in V. Consolo, L’ora sospesa ed altri scritti per artisti, Valverde (CT), Le Farfalle, 2018, pp. 9-16.
11 M. Á. Cuevas, L’arte a parole, p. 29.
12 P. V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, Torino, Bollati Boringhieri, 2005, p. 38.
13 M. Á. Cuevas, L’arte a parole, p. 30.
14 Quanto al palinsesto consoliano cfr. D. O’ Connell, ‘Consolo narratore e scrittore palincestuoso’, Quaderns d’Italià, 13, 2008, pp. 161-185; D. O’ Connell, ‘Furor melancholicus: poetica pittorica nella narrativa di Vincenzo Consolo’, in D. Perrone, N. Tedesco (a cura di), Letteratura, musica e arti figurative tra Settecento e Novecento, Firenze, Franco Cesati, 2014, pp. 147-160.
15 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1976, ora in Id., L’opera completa, p. 127. Tutte le successive citazioni saranno tratte da questa edizione. Per una storia critico-genetica ed alcune valutazioni filologiche sul Sorriso cfr. N. Messina, ‘«Il sorriso dell’ignoto marinaio» di Vincenzo Consolo. Un approccio a III Morti sacrata’, in J. Eynaud (a cura di), Interferenze di sistemi linguistici e culturali nell’italiano, Atti del X Congresso AIPI (Università di Malta, La Valletta, 3-6 settembre 1992), Zabbar (Malta), Gutemberg Press, 1993, pp. 141-163; N. Messina, Per un’edizione critico-genetica dell’opera narrativa di Vincenzo Consolo «Il sorriso dell’ignoto marinaio», tesi di Dottorato, Universitad Complutense, Madrid, 2007, [accessed 17 February 2020]; D. O’ Connell, ‘“And he a face still forming”: Genesis Gestation and Variation in Vincenzo Consolo’s Il sorriso dell’ignoto marinaio’, Italian Studies, 1, 2008, pp. 119-140.
16 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, p. 143-144.
17 Sul rapporto tra Consolo e Sciascia cfr. C. Madrignani, ‘Dopo Sciascia’, La rivista dei libri, novembre 2001, pp. 26-29; M. Á. Cuevas, ‘Parole incrociate: Sciascia e Consolo’, in L. Trapassi, Leonardo Sciascia, un testimone del secolo XIX, Acireale-Roma, Bonnanno, 2012, pp. 195-206. Quanto alla funzione delle epigrafi nell’opera consoliana mi permetto di citare D. Stazzone, ‘Tra palinsesto e paratesto: le epigrafi di Consolo’, Quaderns d’Italià, 21, 2016, pp. 183-192.
18 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, p. 161.
19 Ivi, p. 219.
20 M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 2012, p. 135.
21 Si fa cenno alla nozione di «repertorio» elaborata da W. Iser, L’atto di lettura. Una teoria della risposta estetica, Bologna, il Mulino, 1987.
22 M. Cometa, La scrittura delle immagini,p. 116.
23 Ivi, p. 121. 24 Ivi, p. 140.
25 La Crocefissione, custodita al Koninklijk Museum voor Schone Kunstern di Anversa, è un olio su tavola realizzato da Antonello nel 1475, durante la sua permanenza a Venezia. Cfr. M. Lucco (a cura di), Antonello da Messina. L’opera completa, Cinisiello Balsamo (MI), Silvana Editoriale, 2006, pp. 216-221.
26 Cfr. M. Á. Cuevas, ‘Ancora su Antonello’, Testo, 59, 2010, pp. 117-124.
27 Cfr. R. Galvagno, ‘«Bella la verità». Figure della verità in alcuni testi di Vincenzo Consolo’, in Ead. (a cura di), «Diverso è lo scrivere»,pp. 39-64.
28 Cfr. S. Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura del «Sorriso dell’ignoto marinaio», Palermo, Sellerio, 2011, p. 44. Per l’iconografia di San Gerolamo cfr. H. Friedmann, A Bestiary for Saint Jerome. Animal Symbolism in European Religious Art, Washington D.C., Smithsonian Institution Press, 1980, pp. 291-293. Per l’iconografia di San Gerolamo nelle opere consoliane cfr. S. S. Nigro, ‘Gerolamo e Agrippino’, La Sicilia, 15 novembre 1988.
29 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 141-142.
30 Ivi, p. 135. 31 Ivi, p. 142.
32 Si pensi al don Eugenio Uzeda dei Vicerè di De Roberto o al don Tindaro del Marchese di Roccaverdina di Capuana.
33 V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, pp. 134-135.
34 Ivi, p. 142. 35 V. Consolo, Fuga dall’Etna, p. 45.
36 C. Segre, ‘La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo’, in Id., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi,1991, p. 83.
37 Cfr. V. Consolo, Conversazione a Siviglia, a cura di M. Á. Cuevas, Caltagirone (CT), Lettera da Qalat, 2016, pp. 45-46.
38 Si tratta di un dettaglio de La grande confessione palermitana, riprodotto nella prima copertina di V. Consolo, Retablo, Torino, Sellerio, 1987.
39 Il racconto della scoperta sciasciana del dipinto di Manetti è in F. Clerici, ‘L’eremo, l’abate e il diavolo’, in Id., Di profilo, a cura di M. Carapezza, Milano, Novecento, 1989, pp. 267-271.
40 Per alcune valutazioni complessive su Retablo cfr. N. Zago, ‘C’era una volta la Sicilia. Su «Retablo» e altre cose di Consolo…’, in Id., L’ombra del moderno, da Leopardi a Sciascia, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1992; G. Turchetta, ‘Il luogo della vita: una lettura di «Retablo»’, in M. Lanzillotta, G. Lo Castro, E. Porciani, C. Verbaro (a cura di), Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola, Pisa, 2014, ETS, pp. 647-656.
41 È evidente il simbolismo onomastico adottato da Consolo: il cavaliere Clerici, infatti, approdando a Palermo, salva Isidoro, lo trae dall’abisso in cui era sprofondato e gli permette di rinascere a nuova vita. Ma il nome del «pacchetto Aurora», nel continuo gioco di allusioni che caratterizza la scrittura consoliana, rinvia anche all’incrociatore russo che, nel dicembre 1908, portò soccorso alla popolazione di Messina dopo il terremoto che aveva raso al suolo la città siciliana e Reggio Calabria. L’Aurora, per altro, ebbe un ruolo di primo piano nella rivoluzione d’Ottobre, sparando il primo colpo d’arma da fuoco dal castello di prua, segnale dell’inizio della rivoluzione.
42 V. Consolo, Retablo, p. 371. 43 Ibidem.
44 Per l’iconografia della patrona palermitana Santa Rosalia cfr. M. Cometa, Descrizione e desiderio. I quadri viventi di E. T. A. Hoffmann, Roma, Meltemi, 2005.
45 V. Consolo, Retablo, p. 369.
46 Quanto alla finestra, alla sua funzione di tecnema della visione e al suo ruolo nelle descrizioni letterarie cfr. P. Hamon, Imagerie. Littérature et imageau XIX e siècle, Paris, Édition José Corti, 2001.
47 Cfr. il saggio di R. Galvagno, «Bella la verità», pp. 39-64.
48Ibidem.
49 M. Rizzarelli, ‘Un Retablo come uno specchio. Le voyage pittoresque del cavaliere Fabrizio Clerici’, in A. Ottieri (a cura di), Ai margini della letteratura. Le “scritture contaminate”, Sinestesie, IV, 2006, p. 92.
50 Per i rapporti tra Retablo e l’Illuminismo lombardo cfr. G. Albertocchi, ‘Dietro il Retablo. «Addio Teresa Blasco, addio marchesina Beccaria». Leggere Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10, 2005, pp. 95-111, ora in G. Albertocchi, «Non vedo l’ora di vederti». Legami, affetti, ritrosie nei carteggi di Porta, Grossi e Manzoni, Firenze, Clinamen, 2011, pp. 141-159.
51 Cfr. V. Consolo, Retablo, p. 379. 52 Ivi, p. 370. 53 Ivi, p. 473.
da Arabeschi n. 15