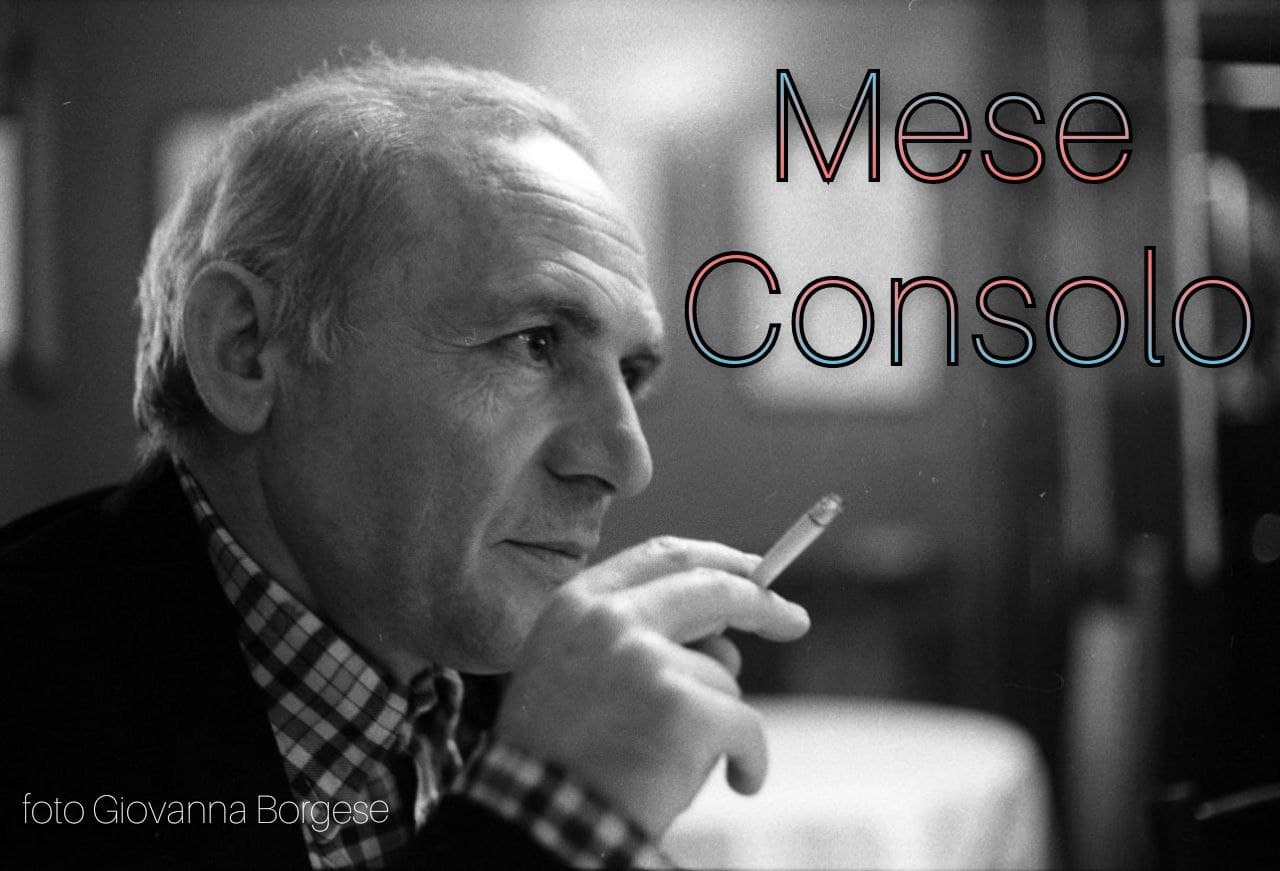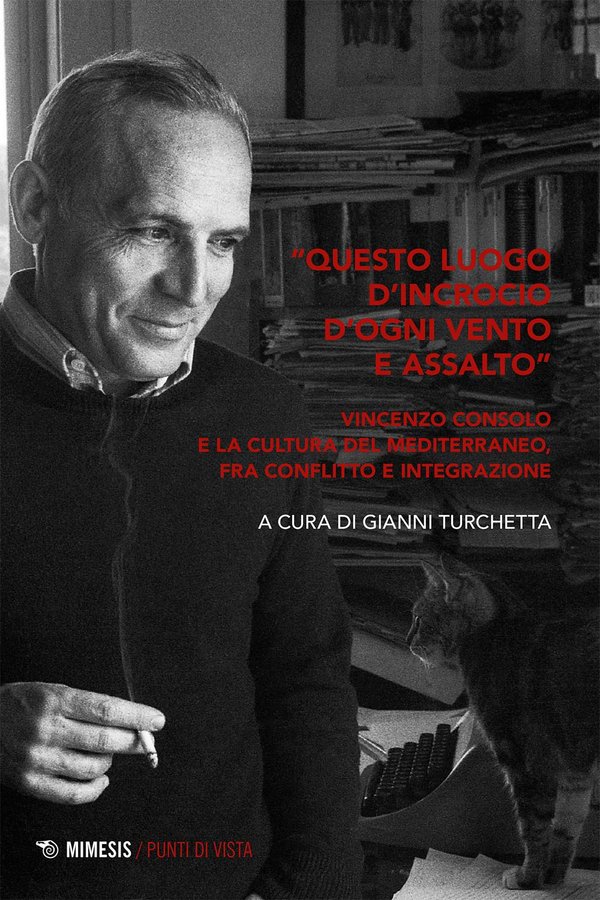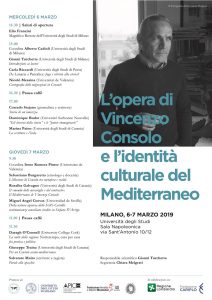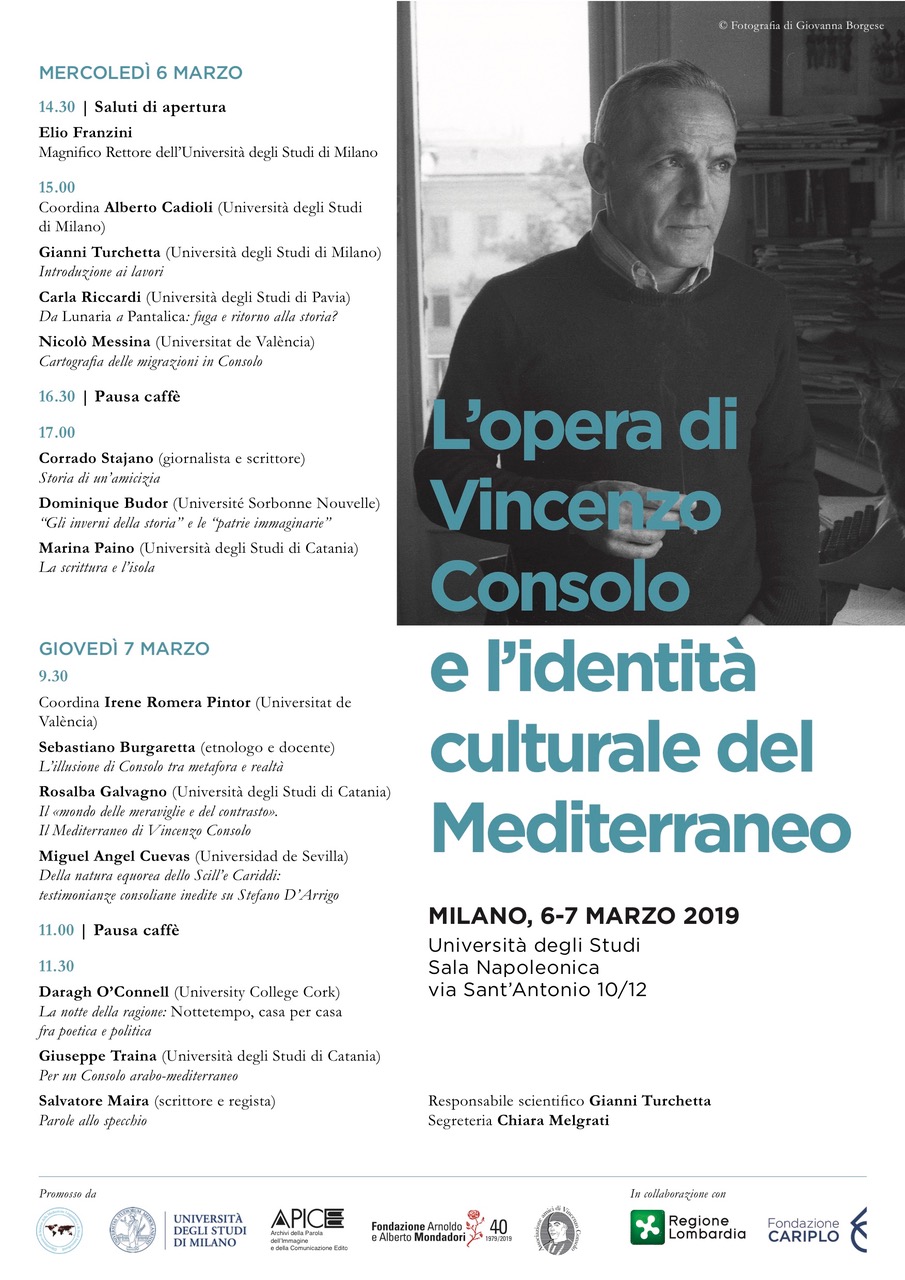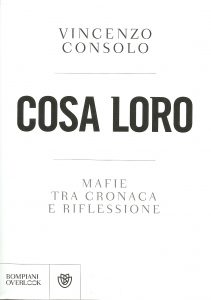Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
A 10 anni dalla scomparsa di Vincenzo Consolo, FAAM ricorderà lo scrittore con “Reading – Ricordi di Vincenzo Consolo”, a cura di Paolo Di Stefano e Giovanni Turchetta, in collaborazione con Associazione Amici di Vincenzo Consolo.
Mercoledì 26 gennaio alle ore 18:30 al Laboratorio Formentini verrà data voce ai ricordi di chi ha conosciuto l’autore, con i testi di Maria Attanasio, Maria Rosa Cutrufelli, Nino De Vita, Paolo Di Paolo, Ernesto Ferrero, Corrado Stajano e Nadia Terranova.
***
MARIA ATTANASIO
«Prima viene la vita»
Una fotografia, senza
pretese d’arte.
Puramente testimoniale di
uno dei tanti momenti di condiviso vissuto: presentazioni, incontri, lunghi
conversari di politica, letteratura, o degli eventi del giorno, di cui Vincenzo
era attentissimo e severo giudice.
Nel retro della foto, una
data: agosto 1993. Sullo sfondo di un’altura di pietre e sterpaglie, una
casamatta con due lunghe fessure orizzontali, da cui nel luglio del 1943 i
cannoni tedeschi cercavano di fermare lo sbarco alleato. In primo piano
Vincenzo e Melo; io tra loro.
Di fronte a noi – sotteso
all’immagine – il maldestro fotografo, Giovanni mio marito; e il profilo di
Gela in lontananza, la meta privilegiata dell’itinerario di quel giorno per
ritrovarne il passato e leggerne il presente. Ma del tutto smemorata -la città
di ciminiere e vocianti periferie- del suo costitutivo già stato: le
mastodontiche mura di Capo Soprano, i resti archeologici, il Museo.
A concludere la visita fu
una lunga sosta sulla tomba di Eschilo, che dal margine ovest della città si
affaccia sulla raffineria. Avvolta dai fumi di anidride solforosa e dai
malodori di catrame e benzene, la tomba del Grande Tragico apparve allo scrittore
come il simbolo “della perdita d’ogni memoria e senso, del gelo della mente
e dell’afasia” di una condizione umana, degradata e analfabeta nel consumo
mediaticodell’istante.
La fine di un’Atene civile “che
nessuno può liberare dall’oltraggio”, scriverà nel lamento-invettiva che
conclude la straniante e drammatica scrittura de L’olivo e
l’olivastro; l’amaro nostos di un contemporaneo Ulisse che,
ritornando nell’Itaca-Sicilia, si ritrova un’isola di kalashnikof e
omologazione, di tritolo e globalizzazione, senza scampo devastata dai proci.
Un
viaggio, durante il quale, per un breve tratto, gli sono stata compagna.
Tante volte era venuto -e
verrà- a Caltagirone, da solo o insieme a Caterina Pilenga, sua moglie.
Caterina è rimasta a Milano, mi disse invece, quando
nell’agosto del 1993 – durante la fase compositiva di quel libro – mi telefonò
per annunciarmi che sarebbe arrivato con suo fratello Melo: voleva rivisitare
Caltagirone e i paesi vicini. E io fargli da guida.
Nonostante
Vincenzo già conoscesse la medioevale topografia araba del centro storico della
mia città, tornò a interrogare chiese, conventi, scalinate, proletari carruggi
e nobili palazzi; i luoghi per lui non essendo pura definizione di spazi, ma
verticalità di tempi, storie, linguaggi, oscuramente vibranti dietro ogni casa,
ogni muro, ogni piazza.
Più forte di
ogni altra cosa fu però il malioso richiamo dell’antica civiltà del tornio e
dell’argilla; nelle botteghe dei vasai, nella scintillante bellezza di forme e
smalti dei loro manufatti, ritrovando l’essenza connotativa di ogni esistenza:
fusione di vivo presente e remoto vissuto.
E da
Caltagirone in tanti altri luoghi – non visibili nel testo ma esperienzialmente
costitutivi di esso – tra cui un piccolo villaggio rurale distante una ventina
di chilometri. Una laboriosa comunità contadina lo abita, in prevalenza
proprietari di piccoli fondi, che coltivano la terra in economia, o l’aiuto di
immigrati: tunisini e -in quegli anni di bombe umanitarie- anche albanesi. Non
era ancora arrivata in Occidente l’ondata subsahariana e medio-orientale, che
oggi invece ne è respinto ed errante nucleo.
Ritenendo che
non ci fosse nulla di interessante per il suo libro in fieri, cercai di
dissuaderlo. Inutilmente.
Andammo.
Vigneti,
serre, ortaggi, uliveti, e dignitose case a un piano con i catoi a pianoterra
aperti sulla strada, nel cui buioso dentro si intravedevano botti, attrezzi
agricoli, gente indaffarata. Da uno di essi uscì un uomo -il padre di un mio
alunno- che ci invitò ad entrare, offrendoci vino e frutta secca; insieme a
lui, Amedeo, in realtà l’italianizzato nome di Ahmed, un tunisino di pochissime
parole.
Seduti su
cassette che facevano da improvvisate sedie, iniziò un’indolente conversazione
su coltivazione e cicli produttivi di olio e vino, a cui Vincenzo, senza
prosopopea di superiorità intellettuale, con vivo interesse partecipava:
ascoltava, chiedeva, precisava, intervenendo con competenza su vigneti ad
alberello o a spalliera, su frantoi a freddo o a caldo.
Durante la
visita al Museo di Gela, mi aveva sbalordito la sua immediata individuazione di
conii e figurazioni della ricchissima raccolta numismatica, ma mi lasciò senza
parole il suo puntuale sapere di campagna e agricoltura; una sconfinata passione
conoscitiva, senza soluzione di continuità tra esperienza di vita e scrittura,
ne muoveva il passo e la parola, rispettosamente in ascolto di ogni fare umano,
e del linguaggio di quel fare!
Ad un certo
punto la conversazione sviò sulla scuola e sul figlio, che -disse il padre
alludendo alle sue difficoltà scolastiche in latino e greco- andava male perché
non aveva i p(i)ramenti (un termine dialettale per indicare l’invisibile
basamento su cui poggia una casa, che altrimenti crolla) convenendo entrambi,
Vincenzo e quell’uomo, sull’assoluta necessità dei p(i)ramenti, per
costruire case e saperi.
E la scrittura, aggiunse durante il
viaggio di ritorno, ripetendo, ilare e ammirato, quella parola: metafora e
senso della sua ricerca espressiva.
Risalendo dal fondo del già
scritto e del già vissuto, la metrica della memoria, in tutte le sue
operesi fa infatti visionaria poesia in forma di narrazione; sovversiva
scrittura della presenza per “dare ragione e nome” all’umano dolore; che
ne è sempre presupposto ed essenza: “Prima viene
la vita, – scrive in Retablo – quella umana,
sacra, inoffendibile, e quindi ogni altro: filosofia, scienza, arte, poesia,
bellezza.”
In ogni
tempo, in ogni spazio. Qui, adesso.
Continuo perciò a chiedermi
oggi -a distanza di dieci anni dalla sua morte- quale sarebbe la sua reazione
di fronte alla realpolitik di un’Europa, che finanzia spudorati sovranismi, per
difendere i confini e respingere i migranti in fuga da guerre, fame, dittature;
lasciandoli morire nel gelo della rotta balcanica, o annegare nel tentativo di
attraversare la Manica, o il Canale di Sicilia.
Solitamente
calmo nell’interloquire, Vincenzo però si accendeva di sdegno, esplodeva
davanti a un’ingiustizia sociale o all’indifferenza dell’obeso Occidente, concludendo
furente: “No. Tutta quest’ingiustizia non può durare.!
Hasta la
vista,
Vincenzo, poeta e profeta!
***
MARIA ROSA CUTRUFELLI
«Mai contro l’uomo»
“Siracusa, il tempio di
Apollo è allagato e le idrovore non possono intervenire. Potrebbero distruggere
i reperti.”
Il 30 ottobre scorso, quando
ho letto questa notizia sui giornali, ho immediatamente, inevitabilmente,
pensato a Vincenzo e al dolore che ne avrebbe avuto. Di colpo, mi è tornato in
mente il piccolo appartamento che aveva comprato a Ortigia. Piccolo, ma con un
grande terrazzo che si allungava proprio sul tempio dorico e le sue pietre
millenarie: una visione estraniante, che ti faceva precipitare in un punto
misterioso del tempo, là dove la storia incontra il mito. Era questa visione,
era quel terrazzo ad affascinare Vincenzo. Non gli importava che l’appartamento
fosse scomodo, con molte scale e pochi servizi. O che l’intero edificio fosse fatiscente.
Caterina, con il suo buonsenso nordico, se ne lamentava, ma lui non le dava
ascolto. Li ricordo così: lei pragmatica, adorante e critica nella stessa misura,
lui tutto preso dalla nostalgia per l’isola e dal “dovere di scrivere in
difesa dell’uomo, mai contro l’uomo” (come disse in una bella intervista
che gli fece Rosaria Guacci per il nostro bimestrale, Tuttestorie).
Molto uniti e solidali,
Caterina e Vincenzo si compensavano a vicenda. Lei ribelle, ma con un forte senso
pratico. Lui convinto che, per recuperare la speranza, bisognasse abbandonare
il codice razionalistico, cioè la Francia, e andare verso la Spagna, verso la
“dolce follia,
simbolica e metaforica”
di Don Chisciotte. Lei intransigente, lui mite. Ma se qualcuno peccava
d’indifferenza sociale, Vincenzo sapeva essere molto duro nei suoi confronti,
ed era lei, la ribelle pragmatica, a sgridarlo quando si mostrava troppo
rigido. Cosa che gli capitava abbastanza di frequente. Una volta l’ho visto
nascondere le mani dietro la schiena per non ricambiare il saluto di un
assessore, reo di non so più quale sopruso.
E Caterina, sottovoce:
“Smettila di fare il Pierino dispettoso!” La prima volta che l’ho
incontrato di persona, è stato a Torino, a un salone del libro. Avevo appena
pubblicato un romanzo ambientato in Sicilia, a Gela, la città del
petrolchimico, e Vincenzo volle conoscermi: tutto ciò che riguardava la Sicilia
lo riguardava personalmente. Era un uomo schivo e io, da parte mia, ero
intimidita dalla sua presenza: lui non poteva saperlo, ma lo consideravo il
‘mio’ maestro. Non solo per ammirazione verso la sua scrittura (questo non
basta, a mio parere, per fare di qualcuno un ‘maestro’). Ciò che mi
entusiasmava era la sua concezione della lingua, così innovativa,
straordinariamente moderna. Mi piaceva il suo interesse per le voci ‘altre’,
voci che possiedono ritmi e accenti diversi dai nostri, e che tuttavia si
mescolano alle nostre voci producendo un effetto che lui chiamava
‘mistilinguismo’.
Era più che un interesse, a
dire il vero: era una ricerca letteraria e, al tempo stesso, una presa di
posizione etica e politica. Che si concretizzava in un sostegno particolare a
certi libri e a certe scritture. Per esempio, quando al premio Vittorini arrivò
“Madre piccola”, il primo romanzo di Cristina Ali Farah, scrittrice
italiana di padre somalo, ricordo che disse a noi della giuria: “Ecco un
caso di mistilinguismo.” Ecco un romanzo degno della sua e della nostra
attenzione.
Vincenzo era sedotto dalla
commistione delle lingue, da quel loro sovrapporsi che produce scritture nuove.
Tanto più nuove in quanto arrivano da paesi dove scrivere non è mai un ‘atto
neutro’, perché la lingua stessa – lingua d’importazione, lingua nemica – ha
bisogno di essere re-inventata per poter diventare strumento di speranza.
Più volte Vincenzo Consolo
ha rivendicato la sua scelta, il suo situarsi “in una linea
sperimentalista in cui è forte l’implicazione del mistilinguismo”.
Implicazione evidente, sosteneva, fin dal suo primo libro, “La ferita
dell’aprile”. Era il respiro ampio, era lo sguardo che andava oltre,
superando confini e barriere, a dare senso morale alla sua narrazione, a unire
la ricerca formale all’impegno etico in letteratura. Un azzardo che mi lasciava
senza fiato.
Per farla breve, Vincenzo
Consolo era il ‘mio’ maestro e quel giorno, a Torino, ero paralizzata dalla
timidezza. Non rammento cosa gli dissi, come risposi alle sue domande, ma non
devo essergli dispiaciuta, considerando che da quel primo incontro è poi nata
una lunga amicizia.
Fu lui a volermi nella
giuria del premio Vittorini (di cui era presidente) e gliene sono ancora grata
per molti e svariati motivi. Ma soprattutto perché mi ha permesso di scoprire
cosa si prova a stare sopra un palco millenario. Infatti, in quegli anni ormai
lontani, il premio si teneva al teatro greco di Siracusa e la giuria, per
l’appunto, prendeva posto sul palcoscenico. Be’, vi assicuro che vedere il
panorama da lì, dal cuore del teatro, poter guardare la cavea da quella
prospettiva e risalire su con lo sguardo, su lungo i gradini a semicerchio, è
un’emozione indimenticabile. Invidio gli attori che possono godere di quello
spettacolo quando vogliono. Finita la cerimonia, spesso prendevamo la stessa
macchina per recarci in visita alle rispettive famiglie. Io mi fermavo a
Graniti, lui proseguiva per Sant’Agata di Militello. Durante il viaggio,
Vincenzo mi parlava di sua sorella, che aveva cresciuto lui e tutti gli altri
fratelli. Io gli parlavo di mia madre, fiorentina trapiantata in Sicilia.
Mi dava anche consigli,
naturalmente. Non è questo che fanno i maestri? Così quando, nel 2010, gli
comunicai che me ne andavo per un anno in Africa, in Senegal, si affrettò a
dirmi: “Scrivi un diario!” Un suggerimento che ho seguito solo in
parte, dato che provo un’avversione invincibile nei confronti dei diari (dei
‘miei’ diari, quelli degli altri mi piacciono, li leggo avidamente e guai se
non ci fossero!). Però, con quell’esortazione di Vincenzo che mi girava sempre
per la testa, quella volta ho cercato un compromesso. E dunque ho preso appunti
(talmente brevi, purtroppo, che a rileggerli oggi non capisco più a cosa si riferiscono)
e ho fatto foto e raccolto ritagli di giornale. Ma temo che Vincenzo non
intendesse questo… Comunque, al mio ritorno, lo trovai già malato. La
malattia non aveva spento la sua voglia di conoscere il mondo, era curioso come
sempre e dunque gli parlai dell’Africa e del mio lungo soggiorno a Dakar, città
ricca di cultura, di musica e di gioventù. In ogni caso, evitai accuratamente
l’argomento ‘diari’.
D’altronde le nostre
telefonate erano sempre più brevi e, per me, sempre più tormentose. Per fortuna
c’era Caterina, che, con la solita efficienza, gli organizzava la vita e gli
incontri con gli amici. Dopo, quando Vincenzo non ha più avuto bisogno del suo
aiuto per vivere, Caterina si è dedicata ai suoi scritti. Riordinava le carte,
cercava in ogni modo possibile di curare la sua memoria. Un giorno mi disse:
“Non m’importa di morire, ma non posso farlo finché le sue cose non sono a
posto”.
E così è stato.
***
NINO DE VITA
Questo racconto in versi dialettali di Nino
De Vita (avete il testo in fotocopia con traduzione) richiede una breve
premessa che lo stesso poeta di Marsala ci ha pregato di lettere:
Io e Vincenzo Consolo ci
siamo incontrati per la prima volta in una stanza dell’Ospedale “Sant’Antonio
Abate” di Trapani. Non ricordo di preciso in quale anno, di sicuro eravamo in
uno dei primissimi anni Settanta. Era estate. Lui si trovava in quei giorni in
vacanza a Pantelleria, lì si era sentito male (aveva contratto l’epatite) ed
era stato trasferito a Trapani. Una sua cara amica che lo accompagnava mi
aveva, su consiglio di Consolo, telefonato per avvisarmi e così io raggiunsi
quella mattina Vincenzo. C’era stato fino ad allora solo uno scambio epistolare
fra di noi. È tutto dentro il mio racconto in versi: non c’è di inventato, come
si suol dire, nemmeno una virgola. Da quel giorno (e fino a qualche mese prima
della sua scomparsa) io e Vincenzo non ci siamo più lasciati.
Trasu nno strurimentu
(Entro nel mio tormento)
I.
S’attrova sutta ô Munti, nno ’na timpa
– ed è rranni – ’u spitali
ri Sant’Antoniu Abbati.
Ri finistruna Trapani si gori
stinnigghiata, ch’allonga,
trasi, turciuta, rintra
ô mari.
Summu p’i scali, summu, allarmatizzu
pi stu ncontru, stu fattu
chi ntravinni a Vicenzu
Consulu. E comu fu,
com’èni chi successi.
A pperi summu, allentu,
cu ’a vuci ri sta fìmmina
chi chiamannu, vogghiardi,
mi fici sapituri.
Ora è mezziornu.
’A luci,
nne strati, quasi, annorva.
’U ventu manca e cc’è
scarmazzu.
I. É sotto il
monte, su un’altura/ – ed è grande – l’ospedale/ di Sant’Antonio Abate./ Dalle
vetrate Trapani si ammira/ distesa, che si allunga,/ penetra, a falce, dentro/
il mare.// Salgo le scale, salgo, intimorito/ per questo incontro, questo
fatto/ che è successo a Vincenzo/ Consolo. E come fu,/ com’è potuto accadere.//
A piedi salgo, a lento,/ con la voce di
questa donna/ che chiamando, di mattina presto,/ mi fece sapere.// Ora è
mezzogiorno./ La luce,/ nelle strade, quasi, acceca./ Il vento manca, stagna/
la calura.
II
É nno lettu, curcatu,
c’u cozzu nno chiumazzu
aisatu nna spaddera.
“Vicè” cci ricu, appena
m’apprisentu, nna porta,
e ’u canusciu. “Vicè…”
“Ninuzzu” rici “Ninu…”
E subbitaniu, aisannu
’u vrazzu “Arresta ddocu,
accura, ’un ti ncustari”.
Avi ’a facci ggiannuffa, comu ’u bbiancu
ri l’occhi, comu ’i manu.
“Vicè” cci fazzu “e cch’èni: nni ncuntramu
e ’unn’i putemu rari
’a manu!”.
Nno lettu allattu cc’èsti,
misu mpizzu, un bbonentu
mmicchiutu, allignamatu,
ch’assisti: s’arricogghi
tuttu, ciatìa, lampia
’i vavareddi.
’A fìmmina, chi mi
chiamau, èsti a tuccari
a mmia, additta, ’a viu
pigghiata ri cileri.
“Sta zzàfara m’a portu ri Milanu”
va cuntannu Vicenzu. “M’a sintia
sbissata sta pirsuna
mia…
’U tempu ri pusari
peri a Pantiddiria,
nzèmmula a idda” e cci
rriri nnamentri ch’a
talia “e sugnu cca…”
Ora talia a mmia.
Mi rici, rrisulenti:
“Sì propriu propriu ntìficu
comu t’avia nnall’occhi”.
“A to’ fiura ammeci eu l’hâ vistu
nne libbra, nne ggiurnala,
Vicenzu”.
E trovu appoiu
cu ’a spadda nna facciola
ra porta.
“Stu malannu” mi batti, cu ’a ncasciata
“parsi una puvirenzia:
nn’aviamu a canùsciri ô rritornu
ri l’ìsula e accurzamu”.
’A fìmmina è nnirvusa,
s’assistema i capiddi,
tira un’arricialata.
Rrutuliu cu Vicenzu
ri niatri, ra Sicilia,
l’amici chi cci avemu,
ri Sciascia, chi ora â gghiri
a truvari…
’U vecchiu nni talia,
senti, tistia, pari
ri sti cosi ntrissatu,
sta comu ’un alluccutu.
Trasi un nfirmeri, posa
nna culunnetta ’un sacciu
soccu, un agghiummareddu.
Sarrani chi ci sunnu
bbadduzzi ri pigghiari.
E sgangusu, nnamentri
chi nnesci: “Chi facemu,
chi faciti, ah, ’un scuffamu?”.
“Penzu ch’è avura, Ninu,
ri jiritinni” mi rici
Vicenzu.
“Chi torni a Cutusìu?”
“ ’A Cutusìu. Poi vegnu
a truvàriri, arrè,
ddumani.
’A juta a Rracarmutu,
â Nuci, ddà, nni Sciascia,
’a straportu”.
“No” iddu rici “ ’un strapurtalla, vacci,
’un ddàriti pinzeri.
Ri Sant’Ágata agghica me’ niputi
Rrinu…Vacci, tu vacci,
va ttròvalu a Nanà.
E sai soccu ti rico: ti priparu
una littra e cci ’a porti”.
Nesci ra bbuzza, misa
ô capizzu, un mazzettu
ri fogghi, ’a pinna, mentri
ch’a fìmmina, pigghiànnumi p’un ùvitu,
mi tira nno passettu
e mi rici, appagnata:
“Talìami nna facci,
nnall’occhi: chi ti paru
ggiannuffa? M’a pigghiai,
sta zzàfara â pigghiai!”
’Un sacciu chi cci ’a ddiri…
“ Ti ricu ch’è accussia”
idda accorna. “ ’A pigghiai,
mi l’ammiscau”.
E trimannu
’a testa s’accummogghia
l’occhi.
’A luci, fora, a ppicu,
misi comu una negghia
nne casi e puru a mmari.
Si viri sulu ’u curmu
ri Favugnana e Lèvanzu.
Marèttimu ’un si viri…
Penzu a sti jorna mei,
a mmia, sta sulità
chi ci haiu, a cu è chi persi,
trasu nno strurimentu…
“Ninu” sentu Vincenzo
chi mi chiama. E arrisagghiu,
tornu nnarrè. “Cci ’a scrissi”
rici appena chi spuntu
“è pronta”.
M’avvicinu.
Mi poiu pi pigghiari
’a bbusta e s’arritira
’u vrazzu.
“ ’U sai chi staiu pinzannu?”
mi rici, cu ’a timenza
“sta littra a Sciascia tu
è megghiu ch’un cci ’a porti.
Mi scantu chi maniannula,
chi nni sacciu, a viatri, a tutti rui
v’ammisca”.
II. É nel letto, disteso,/ con la nuca sul cuscino/ poggiato alla testiera./ “Vicè” gli dico, appena/ mi affaccio sulla porta/ e lo riconosco. “Vicè…”/ “Ninuzzo” dice “Nino…” / E di colpo, alzando / il braccio “Resta lì,/ attento, non ti accostare”./ Ha la faccia giallastra, come il bianco/ degli occhi, come le mani./ “Vicè” gli faccio “ e ch’è: ci incontriamo/ e non possiamo darci/ la mano!”/ Nel letto accanto al suo c’è,/ in punta, sul bordo, seduto, un uomo/ vecchio, smagrito,/ che ci ascolta: si stringe/ nelle spalle, sospira, batte/ le palpebre./ La donna, che mi/ chiamò per avvisarmi, è accanto/ a me, all’impiedi, la vedo/ turbata./ “Quest’epatite me la porto da Milano”/ racconta Vincenzo. “La sentivo/ spossata questa persona/ mia…/ Il tempo di posare/ piede a Pantelleria,/ assieme a lei” e le/ sorride intanto che la/ guarda “e sono qua…”/ Ora guarda me./ Mi dice, sorridente:/ “Sei proprio proprio come / ti immaginavo”./ “Il tuo volto invece io l’ho visto/ nei libri, sui giornali,/ Vincenzo”./ E trovo appoggio/ con la spalla allo stipite/ della porta./ “Questo malanno”/ ribatte, ironico/ “ è parso una provvidenza:/ dovevamo conoscerci al mio ritorno/ dall’isola e accorciammo”./ La donna è nervosa,/ si aggiusta i capelli,/ tira un sospiro lungo.// Parlo con Vincenzo/ di noi, della Sicilia,/ degli amici che abbiamo,/ di Sciascia, che devo andare/ a trovare…/ Il vecchio ci guarda,/ ascolta, fa sì con la testa, sembra/ di queste cose interessato,/ sta come un allocchito./ Entra un infermiere, poggia/ sul comodino non so/ cosa, un involto piccolo./ Forse ci sono dentro/ le pillole da prendere./ E canzonante, mentre/ che sta per uscire: “Che facciamo,/ cosa fate, ah, non smammiamo?”./ “Penso che è l’ora, Nino,/ di dovere andare” mi dice/ Vincenzo./ “Che torni a Cutusìo?”./ “A Cutusìo. Poi vengo/ a trovarti, di nuovo,/ domani./ L’andata a Racalmuto,/ alla Noce, da Sciascia,/ la sposto”./ “No” lui dice “non rinviarla, vacci,/ di me non preoccuparti./ Da Sant’Agata arriva mio nipote/ Rino… Vacci, tu vacci,/ vai a trovarlo a Leonardo./ E sai cosa ti dico: preparo/ una lettera e gliela porti”./ Esce dalla borsa, che tiene/ vicino al letto, un mazzetto/ di fogli, la penna, mentre/ la donna, prendendomi per un gomito,/ mi tira nel corridoio/ e mi dice, spaventata:/ “Guardami la faccia,/ gli occhi: che ti sembro/ gialla? L’ho presa,/ l’ho presa st’epatite!”/ Non so che cosa dirle…/ “Ti dico che è così”/ insiste. “L’ho presa,/ mi ha infettato”./ E scuotendo/ la testa si nasconde/ gli occhi./ La luce, fuori, a picco,/ ha steso come una nebbia/ sopra le case e a mare./ Si scorge solo la punta/ di Favignana e Levanzo./ Marettimo non si vede…/ Penso a questi giorni miei,/ a me, questa solitudine/ che vivo, a chi è che ho perso,/ entro nel mio tormento…/ “Nino” sento Vincenzo/ chiamare. E mi riscuoto,/ torno indietro. “Gliel’ho scritta”/ dice appena mi affaccio/ “è pronta”./ Mi avvicino./ Mi sporgo per prendere/ la busta e ritrae/ il braccio./ “Lo sai cosa sto pensando?”/ mi dice, pieno di temenza/ “questa lettera a Sciascia tu/ è meglio che non la porti./ Ho paura che toccandola,/ che so, a voi, a tutti e due/ vi infetti”.
***
PAOLO DI PAOLO
Un immenso giacimento
È una mattina di novembre, è il 2001. Vincenzo Consolo si
racconta agli studenti di un liceo non lontano da Roma. Io avevo diciott’anni:
provai a invitarlo; lui fu cortese in un modo che non mi aspettavo. Subito
paterno, curioso. Sono andato a ripescare la vecchia videocassetta in cui è
rimasta traccia delle sue parole, della sobrietà con cui le pronunciava. “Sono
uno dei pochi (o dei tanti?) che non predilige le memorie erotiche, gli schizzi
di sangue, gli intrighi internazionali. La lettura è un mondo infinito dal
quale trarre linfa vitale per l’immaginazione, per una continua ricerca di
verità e di conoscenza”. Ne Lo Spasimo di Palermo appare uno scrittore
di cui si dice che “aborriva il romanzo, questo genere scaduto, corrotto,
impraticabile” e che ha scelto “una diversa lingua, dissonante, in una furia
verbale ch’era finita in urlo, s’era dissolta nel silenzio”.
Non è un’opera facile, immediatamente accessibile la sua – con
quell’affollarsi sulla pagina di parole remote, preziose, sonore come note di
una musica distante –, e per gli studenti che lo ascoltavano provò a
semplificare, a descrivere la sua scelta letteraria con estrema chiarezza. Ho
provato a trascrivere parte del suo intervento, con maggiore fedeltà possibile,
perché credo somigli a un tentativo di autodefinizione preciso e appunto
trasparente. Disse tra l’altro:
«La tradizionale gerarchia mette in una posizione prevalente la
parte comunicativa. Io ho cercato di rompere questa gerarchia, strutturando le
frasi secondo un particolare ritmo, secondo un’autentica armonia sonora che
avesse una valenza di significante forte quanto quella di significato; e
attingendo all’immenso giacimento linguistico della mia terra, la Sicilia,
attraversata da tutte le grandi civiltà, dalla fenicia alla greca, a quella
romana, a quelle araba, francese e spagnola. Ho scavato in questo giacimento
come un archeologo, trovandomi per le mani una ricchezza impensabile, con lo
stesso stupore provato venendo qui stamattina e percorrendo un tratto di Appia
antica: con tutta la meraviglia e il rapimento di passare in un istante dalla
modernità a un passato remoto e viceversa. Ho innestato sulla lingua italiana i
reperti di altre lingue, anche scomparse, e non l’ho fatto per via di un gioco
formale. Per me è stato un bisogno, un’urgenza di allargare i significati della
parola, sottraendola alla convenzione linguistica, che ci spinge ad accettare e
fare nostro un solo significato. Ma le parole esistono davvero in una
dimensione più complessa, che comprende il loro suono, la radice da cui
nascono. Sono come biglie chiuse con un mistero dentro: bisogna aprirle».
Dietro alla gentilezza dello sguardo si notava come un allarme:
per una realtà politica, civile – non solo italiana – in cui gli era difficile
riconoscersi:
“Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato,
castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei
navigli, giambellino e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del
corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del
fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera
della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del
messaggio, video dell’idiozia e della volgarità” (ancora da Lo Spasimo di
Palermo).
Quando già allora parlava di “potere economico che diventa
potere politico” era profetico? No, era uno scrittore: capace di osservare, e
di aspettare. Come nelle parole con cui si chiude il romanzo Nottetempo,
casa per casa: “Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate
le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro.
Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore”.
Una delle scene più belle e commoventi dell’intera opera
narrativa di Consolo sta forse in un libro che, ancora più degli altri, si
sottrae alle definizioni, L’olivo e l’olivastro, sospeso tra
divagazione, saggio, racconto lirico. Ci appare a un tratto un Verga ormai
vecchio e distante da tutto, chiuso in un impenetrabile e risentito silenzio. È
investito da continue richieste di presenza a pubbliche onoranze e le rifiuta
una a una. Ma il primo giorno di settembre del 1920 – ottantesimo compleanno
dell’autore dei Malavoglia – a Catania è arrivato Luigi Pirandello. Che
osserva lo scrittore più anziano, si specchia in quel volto più vecchio del suo
di quasi trent’anni riconoscendolo padre, “superbo e ostinato come il padre
suo”, e in qualche modo sente di ricevere un’eredità.
Ma voglio lasciare ancora la parola a Consolo, che a sua volta
immagina e dà voce al sentire di Pirandello, in una giornata di un secolo fa:
«Pensò che, al di là dell’esterna ricorrenza, delle formali
onoranze, in quel tempo di lacerazioni, di violenza, di menzogna, in quel
tramonto, in quella notte della pietà e dell’intelligenza, il paese, il mondo,
avrebbe ancora e più ignorato, offeso la verità, la poesia dello scrittore.
Pensò che quel presente burrascoso e incerto, sordo alla ritrazione, alla
castità della parola, ebbro d’eloquio osceno, poteva essere rappresentato solo
col sorriso desolato, con l’umorismo straziante, con la parola che incalza e
che tortura, la rottura delle forme, delle strutture, la frantumazione delle
coscienze, con l’angoscioso smarrimento, il naufragio, la perdita dell’io.
Pensò che la sua Antonietta, la suor Agata della Capinera, la
povera madre, il fratello suicida di San Secondo, ogni pura fragile creatura
che s’allontana, che sparisce, non è che barlume persistente, segno di
un’estrema sanità nella malattia generale, nella follia del presente».
***
ERNESTO
FERRERO
«L’oscuro
segreto delle parole»
Nel
1963 Vincenzo Consolo pubblica da Mondadori il suo primo libro, La ferita
dell’aprile, un romanzo di formazione che racconta un’educazione cattolica.
Ha scelto per il titolo un verso di un amico fraterno, il poeta Basilio
Reale. L’aprile vuole simboleggiare la
stagione dell’adolescenza, quella scontentezza di sé che i romanzi di Cesare
Pavese, una delle letture fondative del giovane Consolo, hanno raccontato così
bene. Ma molte sono le ferite che l’esordiente si porta dietro, tutte
dissimulate e risolte nella scrittura.
È
nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, a metà strada tra Messina e Palermo,
da una famiglia che gestisce un commercio di olio e granaglie. È un bambino
gracile e biondiccio. Molti anni dopo, a Milano, in presenza della gran mole di
Riccardo Bacchelli dice a se stesso che lui, così piccolo, non potrà mai
diventare uno scrittore, gli manca il physique du rôle. Il padre
ripeteva scherzosamente che, diverso com’era dagli altri figli, era un
trovatello. Lo aveva ritrovato sulla vicina strada per San Fratello, antica
colonia d’origine lombarda, in cui si parlava un dialetto incomprensibile, che
per i siciliani della zona, raccontava Vincenzo, era diventato la cifra stessa
della diversità, dunque motivo di scherno, di dileggio. Lui invece si sentiva a
proprio agio, in quell’identità di sanfratellano. Lo faceva sentire in
battaglia contro ogni autorità costituita, contro il codice linguistico
dominante.
Cresce
in una casa senza libri, ma a scuola è bravissimo. Quando dopo la licenza
liceale si lascia scappare che vorrebbe fare lettere classiche, i suoi gli
dicono che per carità, quella è materia da femmine. Per compiacerli, si laurea
in Legge e si adatta persino a fare l’apprendista nello studio notarile di un
cognato, a Lipari. Poi insegna diritto in un istituto superiore, ma si sente
mancare l’aria.
È
afflitto da una timidezza patologica. Scrivere per lui è una ragione di vita,
ma si chiede se rifugiarsi nella letteratura non sia un “segno di babbìa”, di
sciocca ingenuità, un modo per evadere dalla realtà. Ama la sua terra, tra le
colline e il mare, con una adesione panica, e tuttavia avverte l’isola come una
gabbia. Si chiede se “uscendo da questo pozzo scuro di Sicilia, riuscirei a
sbloccare ogni cosa”. La ferita dell’aprile passa quasi inosservato,
apre una stagione di crisi e dubbi crescenti. Cerca e trova maestri, come
Leonardo Sciascia, avvolto nel fumo delle sue Chesterfield, e il poeta Lucio
Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, “il barone magico” che lo invita spesso
nella sua villa di Capo d’Orlando, dove lo gratifica di monologhi ammalianti.
Intanto matura una coscienza politica che resterà sempre vigile e risentita perché
offesa. Ha sperimentato le prepotenze mafiose, assistito alle lotte contadine e
alle repressioni poliziesche, è rimasto sconvolto dalla strage di Portella
della Ginestra.
Nel
1967 la grande occasione: vince un affollatissimo concorso in Rai. Viene
assunto come funzionario addetto ai programmi culturali e si trasferisce a
Milano. Non è un’esperienza felice. Non sopporta le regole troppo rigide, le
gabbie burocratiche, le imposizioni dall’alto. Ha duri scontri con la Direzione
centrale, sperimenta sulla sua pelle quello che oggi si chiama mobbing.
Lo
salva il giornalismo. Vittorio Nisticò lo invita a collaborare al battagliero
quotidiano palermitano che dirige, “L’Ora”, che ha già al suo attivo tante
battaglie civili, in primis contro la mafia trionfante di quegli anni. Nel 1975
si trasferisce a Palermo, fa il cronista con umiltà e dedizione, convinto che quello
sarà il suo vero mestiere. Intanto fermenta, lentamente e tortuosamente, il
progetto di romanzo che diventerà Il sorriso dell’ignoto marinaio: una
rilettura delle vicende risorgimentali in una Sicilia squassata da tentativi
rivoluzionari e rivolte contadine, molto lontana dall’agiografia tradizionale,
che si interroga sull’uso mistificatorio della Storia, scritta troppo spesso dalle
classi dominanti.
Ne
è protagonista Enrico Pirajno, barone di Mandralisca, liberale illuminato,
erudito, collezionista, appassionato studioso di scienze naturali, cultore di
chiocciole e molluschi, che ha reso pubbliche le sue raccolte trasformando la
sua casa di Cefalù in museo, quello stesso dove ancora oggi si conserva il
meraviglioso ritratto di ignoto di Antonello da Messina da lui acquistato a Lipari.
A
superare le incertezze di una stesura tanto travagliata è la moglie di Consolo,
Caterina, che di nascosto da lui porta al libraio-editore Gaetano Manusé i
primi due capitoli del romanzo, per una edizione d’arte arricchita da
un’acquaforte di Renato Guttuso. Corrado Stajano ne scrive entusiasta su “il
Giorno”: è più sottile e intenso del Gattopardo, è uno Sciascia poetico.
Da Einaudi ci precipitiamo a scrivere a Consolo che ci interessa molto.
A
questo punto l’uomo dei dubbi è obbligato a vincere le sue titubanze. In tre
mesi finisce il lavoro, di getto. Stajano ha visto giusto. Il sorriso
dell’ignoto marinaio si rivela un romanzo stupefacente, un poema in
prosa sostenuto da una scrittura potente, musicale, fortemente ritmata, che
fonde in una polifonia di voci un italiano “alto” e i dialetti, tradizione
colta e materiali popolari. Ne nasce una vertiginosa pluralità di lessici,
registri e toni, dove la parola è spinta verso un massimo di sonorità e
splendore. Consolo ha lo stesso vorace enciclopedismo del suo amato Gadda,
incrocia invenzione e documenti autentici, si abbandona alla vertigine della
lista. Gode nel nominare le cose, la natura di casa che conosce così bene. Così
avverrà negli altri suoi libri, come la malinconica favola teatrale Lunaria,
in cui la Luna cade su una contrada di una Palermo settecentesca, a
simboleggiare la fine di tante cose. O in un altro romanzo corale e musicale, Nottetempo,
casa per casa, Premio Strega 1992, in cui l’avvento del fascismo in Sicilia
è colto attraverso l’arrivo a Cefalù di una stravagante comunità di cultori di
riti esoterici, capeggiata da un moderno superuomo, l’inglese Aleister Crowley,
profeta di una religione satanica, tra sesso e droga.
L’uomo
che nel 1976 arriva nella redazione di Einaudi ha lo stesso mezzo sorriso
dell’ignoto di Antonello: “ironico, pungente e nello stesso tempo amaro, di uno
che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce del futuro; di uno
che si difende dal dolore della conoscenza e da un moto continuo di pietà”. Lo
scrittore che vuole dare voce agli oppressi e ai diseredati non ha nulla del
tribuno, non è uomo di invettive. Al contrario, racconta a bassa voce, senza
scatti o soprassalti, senza aiutarsi con i gesti, con una sorta di doloroso
stupore, tra orgoglio e lampi di sarcasmo, come se raccogliesse le conferme di
qualcosa che ha sempre saputo. Parla di sé solo per quello che può coincidere
con il “noi” di una collettività offesa e in cerca di riscatto. La sua
apparente mitezza nasconde la tensione di un continuo sospetto. Sta sempre
sulla difensiva, come i suoi contadini e i suoi pescatori. Bisogna quasi
insistere per cavargli qualche avara notizia sul suo privato. Non ama gli
aneddoti personali. Gli sembrano futili.
In
una delle sue ultime pagine, Vincenzo Consolo si dice figlio di una terra
flagellata, oltreché dalle violenze della Storia, da eruzioni di vulcani e
terremoti distruttivi. “E allora, – scrive – di fronte alle macerie, alla
polvere dell’esistenza e della storia, privi come siamo di speranze e conforti
di ordine metafisico, non resterebbe che lo sconforto, il pianto. Ma solamente
i poeti, ancora, posseggono l’oscuro segreto delle parole per dire, con la più
alta dignità e più alta bellezza, della grande avventura dell’esistere, della
vita; dei suoi dolori, delle malattie, della morte; dire delle sue
consolazioni; dell’amore, dell’arte, di un fiore (sia pure una ginestra), del
sorgere del sole, del tramonto della luna, della grazia di una donna”.
***
CORRADO STAJANO
Eterno migrante del ritorno
Questo ricordo dedicato da Corrado Stajano all’amico
Vincenzo uscì sul «Corriere della sera» il 22 gennaio 2012, il giorno dopo la
morte di Consolo.
Che dolore grande vederlo sdraiato su quel divano del soggiorno
di casa, con un plaid addosso, il volto sempre più segnato, la voce sempre più
flebile. Agitare il braccio smagrito e la mano, addio, addio. Chissà se quel
gesto era l’ultimo saluto, il segno amorevole della vita che si stava
allontanando.
Il vecchio sofferente era il ragazzetto che nel suo primo libro —
autobiografico — La ferita dell’aprile, sprizzava allegria beffarda, un grillo
saltellante dalla marina alla montagna siciliana, tra le piazze, i vicoletti, i
bagli, l’oratorio, in mezzo ai carusi, ai bastasi, ai preti, alle vocianti
donne di paese, alla baronessa secca e bianca, narrazione di un vivere che non
può finire mai?
Vincenzo Consolo è morto in corso Plebisciti a Milano, dove
abitava, dopo un travaglio di mesi. «Mi sto riprendendo», diceva
immancabilmente, e non si capiva se in quelle parole c’era soltanto la sua
antica ironia o anche un pizzico di speranza. Perché Vincenzo ha intensamente amato
la vita, anche nei momenti più difficili di dramma e sofferenza. E Caterina, sua
moglie, come quelle solide figure della mitologia greca che gli piaceva tanto,
gli ha sempre dato la forza e il coraggio di cui aveva bisogno.
È nato a Sant’Agata di Militello, nella piazza del paese, non
lontano dal mare, tra San Fratello e Capo d’Orlando. Da bambino, ricorda, era
piccolo e magro, «con un toracino d’uccello. Zigaga era il soprannome che mi
avevano appioppato i fratelli: zirlo, pìspola». La sua è una famiglia di commercianti,
la ditta vendeva olio, zucchero, lenticchie, fave, cereali. Suo padre, su un
camion Fiat 6211, consegnava la merce ai grossisti. Qualche volta il piccolo
Vincenzo lo accompagnava. Studi in paese, il liceo Valla a Barcellona Pozzo di
Gotto: dopo la maturità, è Milano ad attirarlo. La cultura industriale, in
quegli anni Cinquanta, gli sembra tutto ciò che c’è di nuovo. Elio Vittorini e Vittorio
Sereni stanno riscoprendo il rapporto tra letteratura e industria, Ottiero Ottieri
e Paolo Volponi lavorano in fabbrica, i nomi delle grandi aziende, la Pirelli, l’Alfa
Romeo, la Breda, affascinano, la città è ricca di energie intellettuali, vi
abitano Quasimodo, Montale, gli scrittori, gli scienziati, gli editori.
Consolo studia legge all’Università Cattolica, non per ragioni
religiose o ideologiche, semplicemente perché l’aveva preceduto un compaesano. Entra
nel convitto universitario di via Necchi, vicino a Sant’Ambrogio, capisce in
fretta. Ricorda padre Gemelli, il frate fondatore e rettore della Cattolica,
già vicino ai fascisti e avversario accanito del Modernismo e di tutto ciò che è
nuovo: aveva la testa grossa e gli occhi fulminanti.
Ricorda anche il cardinale Schuster, «etereo e magico come una
figura onirica, con il suo viso gotico e diafano ricamato di venuzze». Ricorda
soprattutto i poliziotti del suo paese, nella vicina caserma della Celere, e
gli zolfatari siciliani che al Centro orientamento immigrati venivano
equipaggiati di casco, lanterna e mantelline e fatti partire per le miniere del
Belgio dove molti di loro, a Marcinelle e altrove, troveranno la morte.
Vincenzo ha deciso di diventare scrittore.
Ma Milano non è il suo mondo, non ne possiede la lingua, per lui
essenziale, non ha memoria dell’immaginato mondo industriale. Come raccontarlo?
Torna in Sicilia, pensa di diventare uno scrittore di realtà viste e vissute,
di tipo sociologico. Ma non fa i conti con la sua natura fantastica da
archeologo delle parole. La ferita dell’aprile esce nel 1963 in una
bella collana, «Il Tornasole», diretta da Niccolò Gallo e da Vittorio Sereni.
Con i «Gettoni» di Vittorini è l’iniziativa editoriale più coraggiosa e aperta
al futuro. Vincenzo è affascinato dal mondo visionario del coltissimo Lucio
Piccolo, il barone di Calanovella, poeta scoperto da Montale, che viveva in una
villa di Capo d’Orlando come un uomo del Settecento. Nel salone della villa —
con il cimitero dei cani accanto — nel buio più assoluto recitava urlando le
sue poesie esoteriche, tra vasi Ming, statuette orientali, cassettoni Luigi
XVI, ritratti di viceré e di capitani dell’Inquisizione.
Ma è Leonardo Sciascia il vero maestro. È lui a far da
contrappeso al fantasioso mondo di Lucio Piccolo. Consolo ritrova con la sua
razionalità e i suoi saperi storici, critici, politici, quella strada civile
annusata nella prima avventura milanese. La Sicilia contadina così amata si è
nel frattempo disgregata, la mafia ha riconquistato un potere assoluto, il
candore dell’isola è stato macchiato dalla corruzione, dall’ossessione del
denaro, più sporco che pulito, dagli assassini. Il lavoro manca.
Quando decide di partire di nuovo, nel ’68, Milano è
incandescente, ricca di fervori. Dal ’63 al ’76 Consolo non pubblica nulla, sta
rimuginando, pensando, studiando. È convinto che la letteratura deve essere
nemica del potere. Vuole legare la Sicilia alle idee di progresso sociale e
civile della Milano di allora. Ma il linguaggio, come trovare il linguaggio
adatto che sente gorgogliare nella testa? Legge Gadda, ma il suo amore per la
metafora non lo accomuna allo scrittore dell’Adalgisa. È Manzoni,
piuttosto: trova paternità e sostegno «nel Manzoni dei Promessi sposi e
della Colonna infame, quello della necessità della metafora. (…) L’Italia
del Manzoni – scrive – sembra davvero eterna, inestinguibile».
Come spunta l’idea di un libro nella mente di uno scrittore? Il Ritratto
di ignoto di Antonello da Messina, del museo di Cefalù, fa da scintilla. Ma
sono il fallimento del Risorgimento, la speranza tradita dei contadini di avere
le terre dei feudatari, la povertà dei cavatori di pomice ammalati di silicosi
— storia e società — ad accumularsi informi nella testa di Vincenzo. Nel 1976, con
Il sorriso dell’ignoto marinaio, capolavoro di folgorante bellezza,
nasce, si può dire, Vincenzo Consolo, il Vicè dei compagni di giochi, uno dei
più grandi scrittori del Novecento, tradotto in quasi tutte le lingue del
mondo, conosciuto forse più in Europa che in Italia.
Vincenzo non era mai in pace, inquieto, sempre. Nel 1993 disse
pubblicamente che se alle elezioni di quell’anno avesse vinto a Milano la Lega
Nord, come poi accadde, se ne sarebbe andato dalla città per protesta contro la
barbarie della «padania» inesistente. Non partì, fu criticato, accusato di
esibizionismo, di presunzione. Un provocatore. La Sicilia nel sangue. Consolo
non ha di certo avuto bisogno di quella nota di diario che Goethe scrisse nel
suo Viaggio in Italia, il 13 aprile 1787: «L’Italia, senza la Sicilia,
non lascia alcuna immagine nell’anima: è qui la chiave di tutto».
Appena poteva, eterno migrante del ritorno, partiva. Non ha mai
tradito la sua isola. Andava per vedere un’altra volta quel che aveva nel
cuore. Non lo ritrovava. Ferito tornava al Nord, a Parigi, a Madrid. E poco
dopo riprendeva la strada dell’eterno viaggio, riandava in Sicilia. È morto
nella Milano della sua giovinezza. Nella grande stanza foderata dai libri degli
scrittori amati di laggiù. Alle pareti un dipinto con una smisurata macchia
arancione, il disegno di due ragazzi di Casarsa, di Pasolini, l’Ignoto
marinaio di Guttuso, incisioni secentesche, ritratti, carte geografiche
dell’isola stampate all’insù e all’ingiù. Tutto qui sa di Sicilia.
***
NADIA TERRANOVA
L’uomo dello Stretto
La prima volta che ho visto Vincenzo Consolo me lo sono andato a
cercare. Fu a Torino, al Salone del libro, però forse, siccome sono messinese
come lui, vi aspetterete che il nostro legame risalga a prima della mia età
adulta, alle mie origini.
Sarebbe bello oggi poter raccontare un’amicizia atavica, un
comune legame che viene da qualcosa di diverso dall’esser nati entrambi sulla
sponda più a sud dello Stretto, nella stessa provincia della Sicilia, la meno
narrata e tuttavia la più ricca di narrazioni, quella, per intenderci, che
compare per la prima volta nel dodicesimo canto dell’Odissea, quando Omero
canta di Scilla e Cariddi e della distruzione della nave di Ulisse per via
della loro furia. Mi piacerebbe dire che quella storia fu proprio lui a
raccontarmela, magari quando ero piccola, e che da lui venne la contezza di
potere, anzi dovere, raccontare quella lingua di mare che bagna città e paesi
per poi allargarsi e perdersi nel Mediterraneo. Perché, in effetti, è così che
è andata: non solo tutto questo io, messinese, l’ho imparato anche da Vincenzo
Consolo, ma è stato lui a sussurrarmi all’orecchio tutto ciò che serve per
scrivere, ovvero: guarda il mare e fallo, tu puoi. Ovviamente, non sa di averlo
detto, perché la sua voce mi è arrivata nel modo più nobile e giusto in cui
deve arrivare la voce di uno scrittore: attraverso i suoi libri.
Per primo fu un suo romanzo a dirmi della nostra Messina, che
soffre la ferita dell’identità perché i terremoti ne hanno distrutto la forza e
la potenza, soprattutto l’ultimo, quello
del 1908. Con una pagina mormorò a me, solo a me, che Messina, non esistendo
più, continuava a esistere.
“Città di luce e d’acqua, aerea e fuggente, riflessione e
inganno, fatamorgana e sogno, ricordo e nostalgia. Messina non esiste. Esistono
miti e leggende, Saturno, Orione, Cariddi, Mata e Grifone, Colapesce. Ma forse
vi fu una città con questo nome perché disegni e piante riportano la falce di
un porto con dentro velieri che si dondolano, e mura, colli scanditi da
torrenti e coronati da forti, e case palazzi chiese orti… “
Queste
parole di Vincenzo Consolo, tratte da L’olivo e l’olivastro, costituiscono la radice dei miei tre romanzi e del mio
libro Omero è stato qui, in cui ho raccolto le storie e le
leggende dello Stretto. Messina, ho pensato spesso, è viva solo per i
messinesi, per chi ci è nato e cresciuto. Oppure no: è viva solo per chi ne ha
letto, perché i luoghi esistono solo se c’è qualcuno che li sa raccontare, anzi
a volte penso che esistano solo dentro un racconto, dentro le parole che li
salvano e li traghettano da una storia all’altra.
Solo
dopo averne divorato i libri ho scoperto che, in realtà, un legame originario tra
me e Vincenzo Consolo esisteva, e riguardava in effetti Messina. La sorella di
mia madre, la poetessa Marietta Salvo, per qualche tempo aveva collaborato alle
pagine culturali dello storico giornale siciliano L’Ora. Solo dopo la pubblicazione del mio primo romanzo scoprii
che lo aveva intervistato: mi mostrò la doppia pagina dell’articolo e mi
raccontò delle loro conversazioni, degli scambi che avevano avuto, delle lunghe
conversazioni su poesia e letteratura.
Il
mio incontro dal vivo con lui, invece, avvenne in una città aliena a entrambi:
Torino. E forse solo nella capitale del libro potevano incontrarsi una
messinese che aveva scelto Roma e un messinese che aveva scelto Milano.
Erano i primi anni duemila e Vincenzo Consolo teneva un incontro al Lingotto, nei giorni del Salone. Io ero lì da lettrice, non avevo ancora pubblicato nulla se non dei racconti in qualche antologia e rivista, stavo lavorando al mio primo romanzo ma l’editoria mi incuteva timore, non sapevo se qualcuno mi avrebbe presa in considerazione e, nel frattempo, mi rifugiavo in ciò che non mi ha mai tradito: le pagine degli scrittori che amo. Insieme a un’amica che avevo contagiato con la mia “consolite”, la febbre dei suoi libri, aspettammo Vincenzo Consolo per poter avere con lui un contatto diretto poco prima dell’incontro. Lui si sorprese di trovare due lettrici entusiaste e così giovani, e allora mi sorpresi io: per me la letteratura è sempre stata androgina, senza età, senza tempo. Gli dicemmo che i suoi libri ci piacevano tantissimo anche se qualche volta erano difficili da trovare, e si incupì: ditelo al mio editore, rispose, e in quella sola frase, in quell’espressione di disappunto previdi quello che poi sarebbe toccato a me come a tutti gli scrittori, il difficile rapporto tra chi scrive e chi pubblica, una forma di poliamore fatta anche di incomprensioni e delusioni. Allora fu un lampo, ma adesso lo so bene, lo so per esperienza. Con la sua lingua magnifica, ricercata ed elegante, Vincenzo Consolo mi ha insegnato vocaboli e rime, musicalità della prosa e accuratezza storica, ma soprattutto mi ha insegnato due cose su cui ho imparato a piangere e sorridere, una altissima e una quotidiana: che lo Stretto è un luogo mitico da raccontare, e che gli editori sono sempre un po’ canaglie.
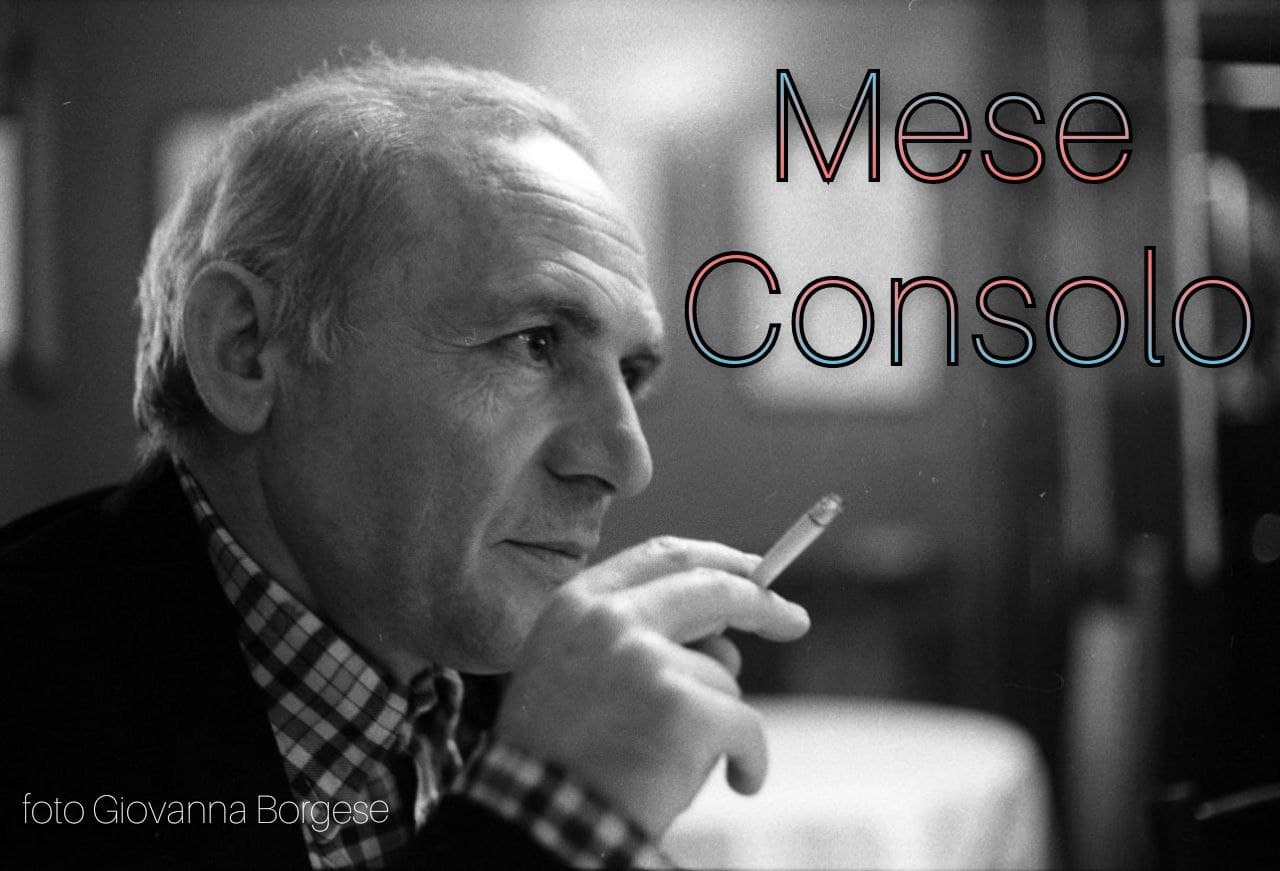
foto Giovanna Borgese