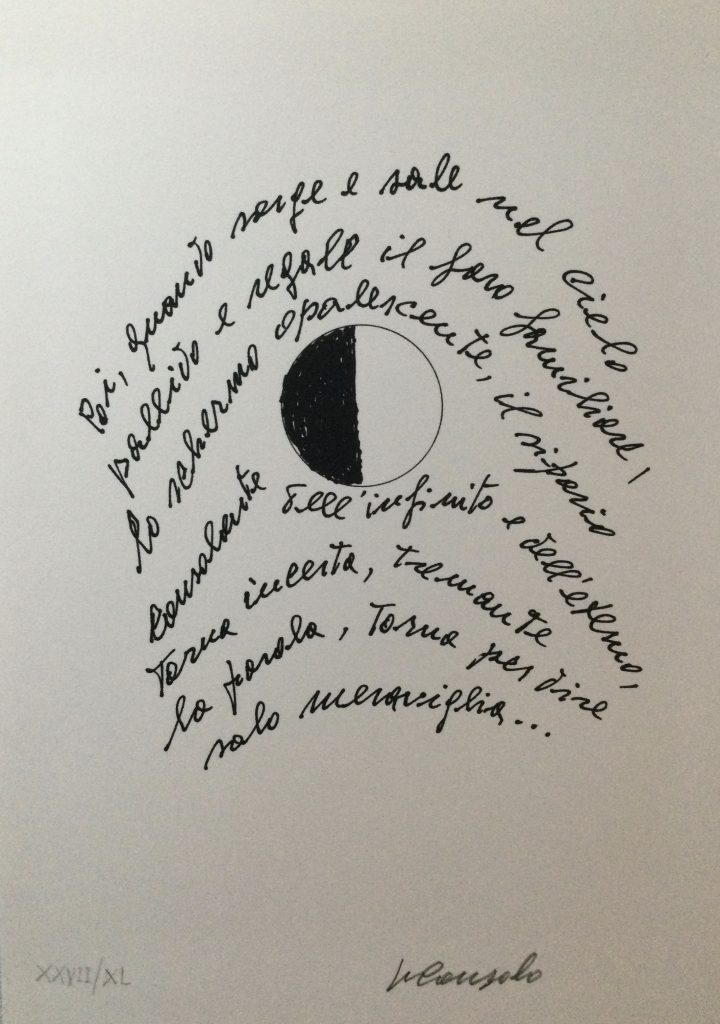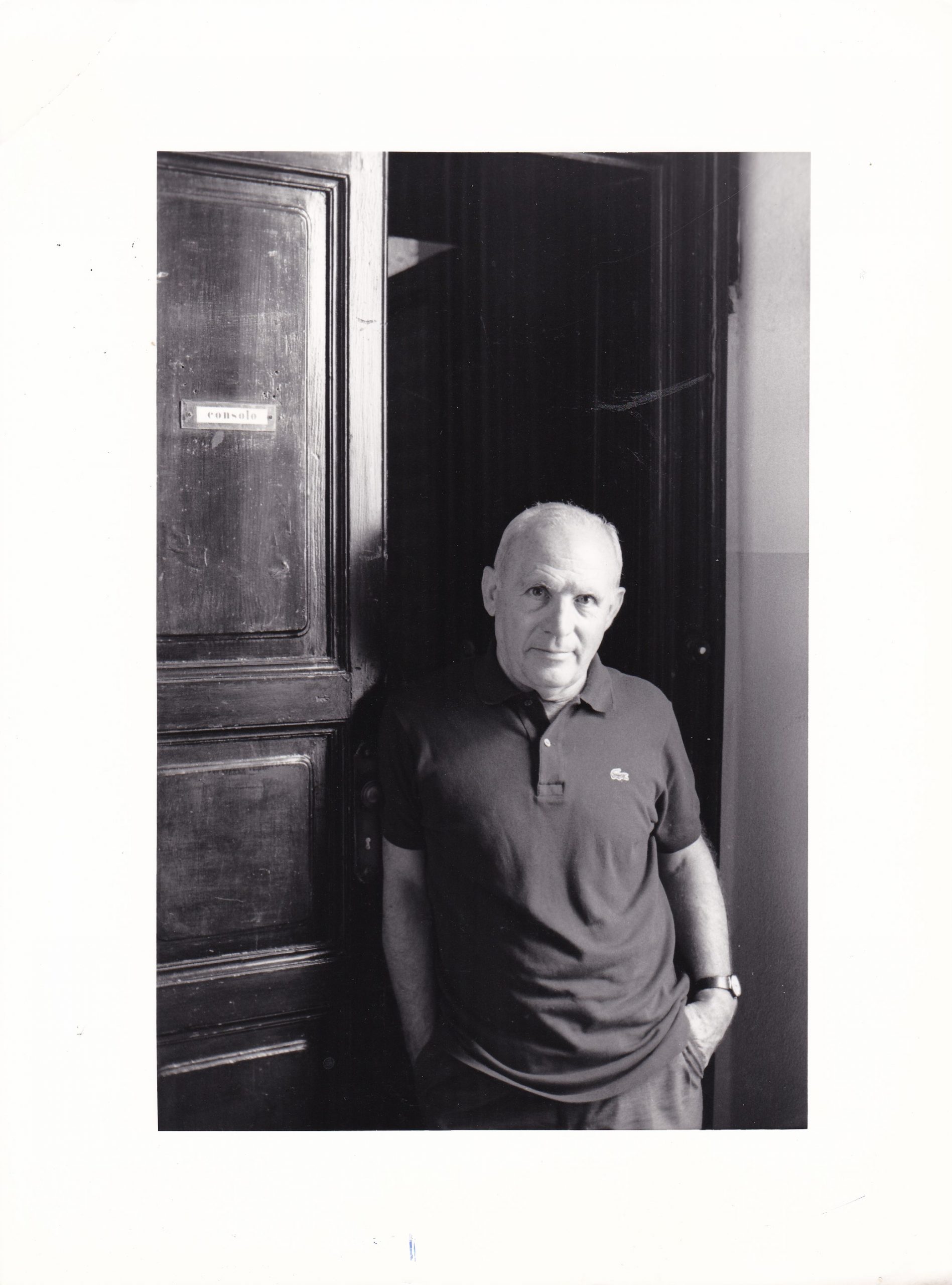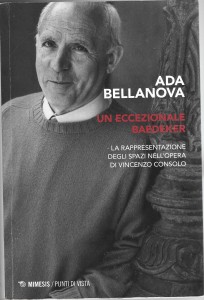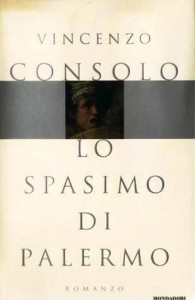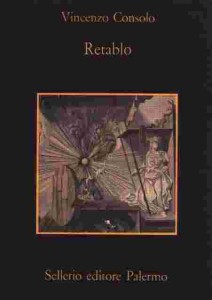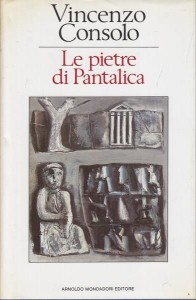Pubblicato il 10 gennaio 2025 da Comitato di Redazione
di Ada Bellanova
«Sembra retorico, ma non lo è: sono emozionato a vedere tutto questo. Quanta gente è passata di qui! […] Sento il contatto con chi è passato di qui». Mentre tocca i massi e i cocci delle rovine di Eloro, con queste parole Consolo si rivolge a Sebastiano Burgaretta per dirgli la sua commozione [1]. Ma simili se non identici devono essere stati i toni tutte le volte che l’autore ha percorso e ripercorso i sentieri tra le rovine della Sicilia, nell’abitudine che, inaugurata precocemente, nell’adolescenza, è poi diventata passione, quasi ossessione dell’intera vita, e ha generato itinerari letterari significativi contagiando la stessa scrittura, rendendola cioè profondamente ‘archeologica’, votata allo scavo, all’indagine delle profondità della storia.
L’emozione di Consolo davanti ai resti delle epoche più antiche è consapevolezza del loro valore. Da qui nascono le pagine dense di indignazione nei confronti dell’incuria contemporanea. Al lettore de L’olivo e l’olivastro non può non venire in mente l’amarezza dell’anonimo viaggiatore per i resti di Megara Hyblea e la necropoli di Thapsos sfregiati dal fumo delle ciminiere, soffocati dalla Lestrigonia infernale del polo industriale siracusano [2].
Non è il tempo la causa maggiore del deteriorarsi delle rovine del passato, piuttosto lo sono gli esseri umani. Proprio questo dichiara Consolo in un articolo poco citato del 2006 scritto per l’area archeologica di Morgantina [3]: se la formula iniziale, che dà anche il titolo al testo, «Che non consumi tu, Tempo vorace», la stessa che – riporta l’autore – gli incisori romantici utilizzavano come didascalia alle loro raffigurazioni del passato, avvisa della voracità dello scorrere degli anni, anzi, dei secoli, che guastano ogni cosa, l’analisi lucida che segue individua la ragione principale delle cattive condizioni in cui versano i siti archeologici nelle responsabilità umane, ovvero incuria e scavi clandestini, spesso con coinvolgimento mafioso.
Ciò che è accaduto con i reperti di Morgantina, ad esempio con la dea, asportata illecitamente, finita dopo una vendita all’asta addirittura al Museo Paul Getty e tornata in Italia dopo la condanna del ricettatore e i necessari accertamenti solo nel 2011, quindi dopo la pubblicazione del testo. D’altra parte, il sentire comune non è estraneo alla logica dei ‘tombaroli’, che interpreta i resti del passato solo in chiave utilitaristica, quale mezzo di un possibile profitto. Per questo con amaro sarcasmo, nell’antifrastico racconto eponimo di La mia isola è Las Vegas, Consolo sceglie come protagonista, e voce narrante, un detenuto per associazione mafiosa il quale, nella straniante confessione di attaccamento alla sua patria siciliana, auspica una maggiore resa delle rovine, ad esempio la vendita agli americani oppure a Berlusconi [4]. Così si tradisce e si corrompe ciò che è sacro.
L’incontro con le rovine è per l’autore necessità: lo scavo è ricerca del passato per riacquistarne consapevolezza in un presente omologante e perennemente in corsa che non tollera attenzione per la memoria e per gli esseri umani. Ciò rende i resti di antiche civiltà il rifugio ideale per molti personaggi consoliani, inquieti viaggiatori amareggiati o insoddisfatti dal presente. E proprio le rovine suscitano in loro riflessioni sulla fragilità dell’essere umano ma anche sul tempo e sull’infinito.
L’infinito e non solo: riflessioni sulle rovine in Retablo
Retablo è percorso da una vibrante passione per i resti del passato, che scaturisce dall’abitudine e dall’interesse dell’autore ma anche dall’adozione dello schema dell’odeporica settecentesca. Infatti, nelle memorie di viaggiatori stranieri, che, attratti dall’Italia e dal Mediterraneo, si mossero fra i resti antichi abbandonandosi al godimento malinconico di un paesaggio fatto di natura e ruderi e ‘scoprirono’ la religione laica delle rovine, l’isola ha un posto privilegiato, e in Italianische Reise di Goethe, in particolare, Consolo coglie la ricerca di una rinascita, un cammino a ritroso verso le radici della civiltà e della cultura che ha la sua necessaria conclusione proprio in Sicilia dove si svelano al viaggiatore del Nord, come in una iniziazione misterica, gli straordinari prodigi dei templi e dei marmi [5].
Clerici viaggia, in fuga da un amaro presente, nel passato, e scopre architetture antiche, statue e reperti d’ogni sorta che gli procurano uno straordinario piacere, a tratti addirittura un’estasi. I resti archeologici restituiscono lo splendore del passato di Segesta, Selinunte e Mozia, ma essi appartengono anche alla dimensione dell’immaginario per la prospettiva idealizzante con cui il viaggiatore li osserva: realtà passata e sogno si fondono nella caratterizzazione di un’alternativa al presente in cui rifugiarsi.
A rendere più viva l’esperienza del viaggio concorrono le frequenti descrizioni di antichità, pause ecfrastiche a cui si accompagna una ricca intertestualità fatta di riferimenti letterari, artistici e autocitazioni, e che permettono una più facile immedesimazione da parte del lettore in virtù del frequente corredo di suggestioni dell’esperienza sensibile. L’ambientazione settecentesca poi sposta la fruizione dei reperti in un altro tempo, togliendoli alle sale museali, ai percorsi espositivi attuali: templi, metope, statue emergono da un caos quasi armonioso, non toccato dalle chiassose comitive della contemporaneità, e sono sacri perché testimonianza di un passato ancora più antico.
Il racconto della tappa a Segesta è dominato dall’imponenza del tempio che appare a Clerici alto e solitario sul colle, circondato dal burrone [6], con un’immagine simile a quella reale che ancora oggi si presenta a chiunque guardi dal basso verso il sito archeologico, ripetuta nell’iconografia di guide e cartoline. La percezione visiva del paesaggio da parte del personaggio accoglie le suggestioni generate dalla stessa esperienza dell’autore e suscita un’immedesimazione e una partecipazione anche emotiva da parte del lettore, che, proiettatosi all’interno dello spazio narrato, lo percorre con il suo sguardo mentale, sulla base delle proprie esperienze, ed è portato a condividere lo stupore espresso dalla narrazione. Ma nella descrizione intervengono tratti onirici suscitati dalla prospettica classicheggiante di Clerici: il tempio è «come corona sul fronte d’un gran dio»; più avanti, diventa addirittura, nel disegno idealizzante del narratore, luogo arcadico, con pastorelle danzanti e musici [7]. La visione delle rovine è dunque un sogno perché chiama in causa, idealizzandola e vestendola di mito, l’antichità. Essa è però anche in grado di generare meditazioni sul tempo e sull’eternità.
La puntuale descrizione del tempio, corredata di informazioni molto precise, quasi tecniche, rompe lo slancio estatico [8] solo brevemente, per alludere probabilmente al testo di Goethe dove invece l’edificio è descritto con entusiasmo contenuto e osservazioni da profano, sigillate da «Un architetto potrebbe stabilirlo con esattezza» [9]. Ma non altezze, larghezze, volumi interessano davvero a Clerici: le osservazioni a proposito della posizione e a proposito dell’assenza di cella e copertura, della mancanza di scanalatura nelle colonne o scalpellatura nelle bugne dei lastroni si concludono con l’ipotesi suggestiva di un progetto ben preciso degli antichi che vollero il tempio, armonioso e imponente sul paesaggio pietroso, ma aperto verso il cielo, come porta o passaggio «verso l’ignoto, verso l’eternitate e l’infinito» [10].
Nelle memorie di viaggio del personaggio allora si insinuano impressioni che solo all’autore possono appartenere, o al referente novecentesco dell’itinerario, il pittore Clerici. Don Fabrizio di fronte al tempio medita sull’eternità, diventa Leopardi davanti alla siepe [11]. Seduto sullo stilobate tra le colonne da cui pende una ‘siepe’ di cappero, rovo, euforbia, egli ammira l’immensità dello spazio che è al di là e si ritrae nel passato, sprofonda nella vertigine dell’infinita sequenza di civiltà evocate dalle rovine, lontano da un presente tumultuoso e tragico. Come ne L’infinito leopardiano, a cui rinvia la sequenza di gerundi «E sedendo e mirando, e ascoltando», vista e udito sono tutti impegnati nel confrontare il presente sensibile (il cappero che oscilla al vento, le gazze e i corvi che stridono, il verso delle cicale, il fluire del fiume) con l’eterno. Clerici di fronte al tempio di Segesta è capace di andare oltre Goethe, di varcare il limite, naufragare nell’infinito [12].
La stessa cosa capita all’anonimo viaggiatore di L’olivo e l’olivastro, che ha maggiori evidenze autobiografiche. In fuga dai resti di un incendio doloso e dal chiasso dissacrante di alcune comitive che sciamano attorno al tempio, reso più imponente dal deserto di carbone e ceneri, ma ancor di più per staccarsi dalla corruzione e dal massacro della Palermo mafiosa, egli sale sul colle e poi, supino, in mezzo alle colonne, mentre medita sull’incompiutezza che rende l’edificio mirabile, quasi quello si fosse fatto da sé, si lascia rapire dall’osservazione del cielo stellato inquadrato nel recinto del tempio: «Rimango immobile e contemplo, sprofondo estatico nei palpiti, nei fuochi, nei bagliori, nei frammenti incandescenti che si staccano, precipitano filando, si spengono, finiscono nel più profondo nero» [13]. L’ipotesto leopardiano ritorna nella costruzione dell’emozionante naufragio di Clerici nel mare di rovine di Selinunte.
Nella smania di percorrere continuamente l’isola, la tappa si rivela per Consolo irrinunciabile, fin dall’adolescenza [14]. L’antica città è per lui estremamente affascinante: la sua fondazione ad opera dei migranti di Megara Iblea ha sapore epico, i suoi resti sono imponenti e misteriosi. Il racconto più suggestivo dell’incontro con le rovine è proprio in Retablo. L’avventura di Clerici ha il sapore di una scoperta: come un nuovo Fazello egli si trova di fronte a inattesi e abbondanti resti e la sua commozione mentre si immerge nel suggestivo labirinto di marmi e piante è contagiosa per il lettore.
La meraviglia di fronte ai resti dell’antica città avvolti dalla vegetazione è espressa attraverso fitte enumerazioni che costruiscono narrativamente il mare di rovine [15]. In questa distesa di marmi Clerici trova anche le metope, in particolare quella che ritrae Zeus e Era: a Consolo, che in più di un’occasione si è espresso sul valore di questi «libri di pietra» [16], non sfugge l’opportunità di collocarle lì, in un ipotetico e verosimile caos settecentesco, prima della catalogazione museale, a dimostrarne, nel racconto della seduzione esercitata sul viaggiatore, persino in una collocazione per così dire selvatica, nell’abbandono della vegetazione, la forza narrativa.
Di fronte alle rovine, il pensiero della fragilità di Selinunte diventa meditazione sulla sacralità dei resti e l’estasi contemplativa che ne consegue, come nel caso del tempio di Segesta, ha i tratti dell’ebbrezza leopardiana di fronte all’infinito. Lo smarrimento di Clerici si traduce in un naufragio dei sensi nel mare dei resti, naufragio a cui concorrono gli effetti sonori, cioè le voci immaginate di altre epoche – le morte stagioni – e visivi, ovvero i reperti che, affastellati, ammonticchiati, in un incredibile caos, sbucano nella vegetazione [17]: «Là un altro mar di pietra m’attendeva e mi ghermiva, una tempesta solida di basamenti, di tamburi, d’architravi, di capitelli, di templi, di are, di celle, di nicchie, d’agorà, di case, di botteghe, e io dentro, su onde e avvallamenti, su per le scale e sotto in ipogei, ebbro vi natava» [18].
A questa estasi segue la scoperta dell’area sacra dedicata a Demetra Malophoros che, come nel racconto autobiografico contenuto in Le pietre di Pantalica, ha i tratti di un percorso di iniziazione, quasi un incontro con l’Aldilà. Se la visita in compagnia di Ignazio Buttitta e Vincenzo Tusa del 1984 è un «procedere iniziatico o profanatorio» e le persone reali a un tratto vengono risucchiate nel pozzo di Ecate «nel mistero e nell’oscurità infinita del Tempo» [19], l’esperienza di Clerici, in un crescendo di particolari che evidenziano la consueta abbondanza archeologica e evocano il mistero del luogo, si chiude, proprio lì sulle rovine, davanti a un inatteso rito funebre dal sapore pagano, con tanto di epicedio, per una ragazza precocemente morta. Tra le nere donne che piangono e si lamentano con movenze da coro tragico, la «fanciulla d’impareggiabile bellezza che la luna nel cielo, nello splendore pieno, inargentava» allude a Murió la verdad, uno dei Desastres de la guerra diGoya, come sembrano confermare le parole del narratore: «Addio. Tu eri il pudore, la trepidazione, il sentimento, tu la verità [corsivo mio] del mondo. Ora non è che falsità, laidezza, brutalità e follia. Io un misero uomo, un nolente, un fuggitivo» [20].
L’apostrofe meditativa attribuisce al rito funebre e al corpo della ragazza un alto valore simbolico: diventa preghiera, lamento e compianto per un tempo che non esiste più, è pietas nei confronti delle realtà lontane, perdute di cui sono traccia tutti i resti osservati, le pietre calpestate o sfiorate, l’emozionante mare di resti di Selinunte, pietas tanto più necessaria di fronte all’incuria e alla superficialità contemporanee. Ma l’episodio è forse anche smemoramento, perdita di sé, in una sorta di contatto concesso con un altro tempo, un altro mondo, come sembra confermare il successivo «I’mi trovai disteso, e non so come» [21].
Ancora più misteriosa risulta, nel romanzo, Mozia, con gli abbondanti reperti archeologici affioranti dal terreno. E questo già nell’approdo, in cui, alla sorpresa di Clerici e Isidoro di fronte ai primi relitti che si affacciano dai fondali si accompagna una lunga nota dai toni meditativi, che è autocitazione da Paludi e naufragi, testo composto per la mostra di F. Mulas [22]. Agli occhi del viaggiatore Mozia emerge dal mare inondata di luce fenicia. Poi è «isola di spirti» [23] che genera spavento e attrazione in Isidoro mentre si rivela seminata di pignatte, ‘una grande trovatura’. Il suo tesoro sono le pietre, nocive e odiose, che i contadini dell’isola cercano di scansare per provare a coltivare la terra e che si rivelano al lettore rassegna di buona parte del patrimonio museale locale, in un procedimento ecfrastico originale che restituisce ancora una volta la natura delle antiche opere d’arte ipotizzandone la collocazione settecentesca, quindi lo stato d’abbandono e l’accumulo casuale.
Tra le pietre c’è anche la straordinaria statua dell’Efebo ed è proprio questa a suscitare le riflessioni del protagonista. Consolo vuole che i viaggiatori trovino l’opera per caso, nelle mani di alcuni contadini che non sanno che farsene e che anzi vogliono liberarsene, secondo lo stereotipo, comune nei resoconti di viaggi settecenteschi, del siciliano ospitale ma ignorante. Alla fine lavorazione che Clerici intravede nel marmo pur sotto le incrostature di terriccio fa da contraltare la fatica dei salinari, che appaiono neri sulla bianchezza dello Stagnone a lui che li contempla a distanza, commentata dall’osservazione del vecchio contadino dell’isola «Eh, la vita è dura, ma più per noi che la campiamo fidando solamente nelle braccia» [24]. Insomma la vita umana è decisamente un’altra cosa rispetto all’arte, ma lo stesso Clerici giungerà a questa conclusione, proprio partendo dallo strano destino della statua.
La lunga ecfrasi veicola l’immagine del Giovane di Mozia così come appare ai visitatori del Museo Whitaker e però il luogo è un altro. Dopo averlo fatto finire nelle mani di Clerici, che lo ha voluto caricare premurosamente sulla nave per portarselo via, l’autore vuole che l’Efebo ritorni all’oblio, nei flutti: durante il viaggio il marmo rompe i legami; un’onda più alta, sopraggiunta al levarsi dello scirocco, spinge la statua in mare. La reminiscenza di Morte per acqua di Eliot per dire il destino della «squisita fattura d’uomo, fiore d’estrema civiltà, estrema arte» sostanzia la riflessione sui limiti della letteratura e dell’arte: «tu, com’ogni arte, non vali la vita, un fiato del più volgare o incolto, più debole o sgraziato uomo» [25]. Attraverso le parole di Clerici Consolo sostiene così che la creazione artistica, pur pregevole, è poca cosa di fronte al valore della vita umana, che è – o dovrebbe essere – sacra e inoffendibile, la vita di tutti quelli che si sono spenti in mare, sciolti nelle ossa alla maniera dell’eliotiano Phlebas il fenicio [26].
Tra i cocci e l’infinito a Filosofiana
Sebbene l’apologo Filosofiana evidenzi la miseria e l’ignoranza dei personaggi e nell’amara conclusione che delude i sogni di tesori e ricchezze suscitati da una tomba antica racconti la tragedia dell’esistenza, anche al protagonista Vito Parlagreco capita di meditare sui resti antichi. Eppure i reperti in sé non gli interessano affatto, piuttosto vorrebbe toglierli di mezzo e coltivare una terra tutta sua, e, mentre si affatica a ‘spietrare’ sogna una casetta circondata da alberi e fiori. Ma la «distesa rossigna in groppa all’altopiano di cocci e di rantumi, pance culi manici di scifi, lemmi, di bombole e di giare» [27] e il pensiero delle favole sulla vicina Villa del Casale accompagnano la concretezza del suo pasto di pane e pecorino con inattese considerazioni sul destino degli esseri umani. Le riflessioni sono quelle del suo autore. «Ma che siamo noi, che siamo?» [28], si domanda. Egli accosta la vita degli uomini, la sua vita, a quella delle formiche: tanto affanno, tanto girare nel mondo che, in fondo, non è che un’aia. Piccola cosa, insomma, l’esistenza umana, di fronte all’eternità. Il tempo, riflette Vito, si porta via ogni cosa, lascia solo pochi segni «qualche fuso di pietra scanalata, qualche scritta sopra d’una lastra, qualche scena o figura come quelle dissepolte nella valle di Piazza» [29]. Per quanto liquidi i resti di antiche civiltà come capricci («certo la villa di un ricco capriccioso» a proposito della Villa del Casale e dei suoi mosaici; «Che capricci, che capricci si passavano gli antichi» a proposito dei cocci che emergono dalla terra) [30], egli vi riconosce il segno di un tempo lontanissimo: in questa vicinanza diventa un po’ filosofo, assaggia una forma di eternità. Prova subito a scacciare il pensiero come cosa da vecchi, per concentrarsi piuttosto su cose concrete, ma dalla terra non può evitare di passare «al cielo, al sole, alla luna, alle stelle», viene insomma risucchiato nella vertigine dell’infinito: «gli sembrava di scivolare dentro un pozzo senza fine» [31].
Agisce forse anche nella costruzione di questo personaggio la suggestione leopardiana de L’infinito. Vito, che guarda al di là del muro dove si è appoggiato per mangiare, è nella concretezza del suo mondo contadino ma i resti di epoche lontane affioranti lo trascinano verso altre dimensioni, i suoni a lui vicini come gli zoccoli della mula o il grido di qualche uccello scandiscono un silenzio immenso, enfatizzato dalla vista del pur immenso Etna all’orizzonte. La sensazione di scivolamento in un pozzo senza fine, interrotta tra l’altro dall’apparizione dello sfuggente Tanu o Tanatu quasi essere leggendario o addirittura liminare, proprio accanto alla tomba antica, allude inoltre a una forma di contatto con l’aldilà.
Anche se il racconto si sviluppa e si conclude con modi da farsa – Vito è trascinato dal cavatesori Gregorio Nanfara in un bizzarro rituale proprio sui resti, e i sogni di ricchezza e fama dell’uno e dell’altro vengono delusi dall’apparizione di un inutile mascherone comico – che sembrano sottolineare un’impossibile rigenerazione di valori e ideali antichi, le tracce liriche e meditative sono molto simili a quelle già incontrate in Retablo e esprimono la relazione di Consolo con le rovine.
«E tu, e noi chi siamo?»
Anche Petro, in Nottetempo, casa per casa, bisognoso di cancellare un presente di sofferenza, trova conforto nelle rovine. La contemplazione piena di stupore delle figure del tempio distrutto di Cefalù, al chiarore di una lanterna, innesca una lunga meditazione dai toni lirici che riprende con minime varianti e qualche espunzione L’ora sospesa, testo per il catalogo della mostra di Ruggero Savinio a Sciacca nell’estate del 1989 [32]. Già qui le rovine richiamano l’espressione «Che non consumi tu Tempo vorace» [33], ripetuta e poi troncata nel prorompere di commosse allusioni al mistero di una comunicazione, di una conoscenza non perfettamente attingibile. I riferimenti al «grembo tenero di Cuma, del Lilibeo» [34] rinviano al contatto con un sapere oracolare, possibile attraverso un’esperienza iniziatica che prevede una discesa, uno sprofondamento, come per l’appunto nell’apertura del passo «per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati» [35]. Ma il testo parla anche di oblio di sé e di assunzione del lete, al confine, il che conferisce all’incontro con le rovine tratti da viaggio nell’aldilà ancora più evidenti rispetto agli altri passi analizzati. Eppure l’accostamento al mistero permette solo la domanda esitante «E tu, e noi chi siamo?» [36].
Ecco allora cosa succede a questi personaggi di Consolo nel contatto con le pietre del passato: in fuga dal presente, vengono rapiti nel vortice del tempo – il tempo delle vite umane scomparse che hanno però lasciato traccia di sé, ma anche l’eterno, l’infinito – in una sorta di esperienza iniziatica che li avvicina a verità esistenziali per lasciarli poi esitanti, dubbiosi. Ma non è forse ciò che secondo Consolo succede anche nel processo della scrittura letteraria? La fuga verso realtà perdute rinvia per l’autore proprio al dovere di scrivere in maniera archeologica, ovvero discendendo ‘per gradi, per lenti processi a spazi inusitati’, tentando di rintracciare il mistero: iniziatico è lo sprofondamento, difficile, arduo il ridire. Eppure lo scrittore deve provare, ritrovando e risacralizzando parole perdute contro l’appiattimento della lingua d’uso quotidiana, recuperando frammenti, rovine, a ricostruire un mondo, anche in modo approssimativo. Perciò in La Sicilia passeggiata, a proposito di Selinunte, Consolo scrive che la tecnologia può sicuramente aiutare a sistemare le antiche pietre, a ricomporle, ma solo la fantasia,
«il sentimento di noi viaggiatori in luoghi del passato, può resuscitare quelle pietre […] dare significato e parola alle pietre, dare, al di là della loro maggiore o minore monumentalità o bellezza, al di là delle grandi imprese che le rovine evocano, il significato dell’umile vita degli abitanti, della trama dei loro affetti, dei loro gesti, dei loro bisogni, delle loro pene e delle loro gioie; può immaginare, ricostruire insomma, tra quelle antiche pietre, il grande miracolo dell’umano vivere quotidiano che ci ha preceduto che dà senso e illumina il presente nostro» [37]. Dialoghi Mediterranei, n. 71, gennaio 2027
Note[1] È Burgaretta a raccontarlo, attingendo a un suo diario personale, in Burgaretta S., Con Consolo per antiche pietre, in Galvagno R., L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo, Edizioni Milella, Lecce 2022: 272-273. [2] L’olivo e l’olivastro, in L’opera completa,a cura e con un saggio introduttivo di G. Turchetta e uno scritto di C. Segre, Mondadori, Milano 2015: 782-784. Ne ho parlato diffusamente in Bellanova A., Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano 2021: 237-241. [3] Consolo, Che non consumi tu tempo vorace, in Fontana F. (a cura di), Il tempo fissato. Pietre e colori a Morgantina, Edizioni Università Kore, Enna 2006: 11-13. [4] La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mondadori, Milano 2012: 217. [5] Viaggio in Sicilia, in Di qua dal faro, L’opera completa, cit.: 1219-1224. [6] Retablo, in L’opera completa, cit.: 412-213. [7] Ivi: 417. [8] Ivi: 413-414. [9] Goethe J. W., Viaggio in Sicilia, trad. e note a cura di P. Di Silvestro, Ediprint, Siracusa 1987: 76. [10] Retablo, cit.: 414. [11] Ivi: 414-415. [12] Viaggio in Sicilia, cit.: 1220. [13] L’olivo e l’olivastro, cit.: 856. [14] Malophoros, in Le pietre di Pantalica, L’opera completa, cit.: 577; La grande vacanza occidentale orientale, in La mia isola è Las Vegas, cit.:167-169. [15] Retablo, cit.: 433 e 436. [16] In particolarein In lettere d’oro il romanzo di Selinunte, in L’Ora, 13 marzo 1984; La Sicilia passeggiata, con fotografie di G. Leone, Nuova Eri, Torino, 1991: 94-101. [17] Retablo, cit.: 433-434. [18] Ivi: 435. [19] Malophoros, cit.: 581. [20] Ibidem. [21] Traina ravvisa nel passo uno smemoramento dai toni danteschi che induce a rileggere l’episodio di Selinunte come un vero viaggio iniziatico nell’aldilà. Traina G., Rilettura di Retablo, in Papa E. (a cura di), Atti delle giornate di studio in onore di Vincenzo Consolo, Manni, San Cesario di Lecce 2004: 122. [22] Retablo, cit.:442-443. Paludi e naufragi è ora raccolto in L’ora sospesa (L’ora sospesa e altri scritti per artisti, a cura di M.A. Cuevas, Le Farfalle, Valverde 2018: 33-36). [23] Retablo, cit.: 443-444. [24] Ivi: 449-450. [25] Ivi: 453. [26] Sul passo si veda Turchetta G., Per toccare la vita che ci scorre per davanti: Retablo e l’arte come nostalgia,in Microprovincia, 48, gennaio-dicembre 2010: 18; Id., Il luogo della vita: una lettura di Retablo, in Lo Castro G., Porciani E., Verbano C.(a cura di), Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola, Ets, Pisa 2014: 653: la statua viene gettata in mare a mò di zavorra a conferma del superiore valore della vita umana per Consolo; l’arte, dunque, può essere al comando della nostra esistenza se ci aiuta a vivere; quando entra in contrasto con la vita allora è il caso che soccomba. [27] Le pietre di Pantalica, in L’opera completa, cit.: 539. [28] Ivi: 541. [29] Ibidem. [30] Ivi: 541-542. [31] Ivi: 542. [32] Ruggero Savinio, catalogo della mostra a Sciacca, ex Convento di San Francesco, luglio-agosto 1989, Sellerio, Palermo 1989, ora nel volume omonimo (L’ora sospesa, cit.: 42-46). [33] Nottetempo, casa per casa, in L’opera completa, cit.: 687. [34] Ibidem. [35] Ivi: 686. [36] Ivi: 688. [37 La Sicilia passeggiata, cit.: 98. Riferimenti bibliografici
Testi di Vincenzo Consolo Consolo V., In lettere d’oro il romanzo di Selinunte, in L’Ora, 13 marzo 1984. Id., La Sicilia passeggiata, con fotografie di G. Leone, Nuova Eri, Torino, 1991. Id., Che non consumi tu tempo vorace, in F. Fontana (a cura di), Il tempo fissato. Pietre e colori a Morgantina, Edizioni Università Kore, Enna 2006: 11-13. Id., La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mondadori, Milano 2012. Id., L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di G. Turchetta e uno scritto di C. Segre, Mondadori, Milano 2015 (edizione di riferimento per Retablo, Le pietre di Pantalica, Nottetempo, casa per casa, L’olivo e l’olivastro, Di qua dal faro). Id., L’ora sospesa e altri scritti per artisti, a cura di M.A. Cuevas, Le Farfalle, Valverde 2018. Altri testi Bellanova A., Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis, Milano 2021: 237-241. Burgaretta S., Con Consolo per antiche pietre, in Galvagno R., L’oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo, Edizioni Milella, Lecce 2022: 272-273. Goethe J. W., Viaggio in Sicilia, trad. e note a cura di P. Di Silvestro, Ediprint, Siracusa 1987.Traina G., Rilettura di Retablo, in Papa E. (a cura di), Atti delle giornate di studio in onore di Vincenzo Consolo, Manni, San Cesario di Lecce 2004: 113-132. Turchetta G., Per toccare la vita che ci scorre per davanti: Retablo e l’arte come nostalgia,in Microprovincia, 48, gennaio-dicembre 2010: 13-19. Id., Il luogo della vita: una lettura di Retablo, in Lo Castro G., Porciani E., Verbano C.(a cura di), Visitare la letteratura. Studi per Nicola Merola, Ets, Pisa 2014: 647-655.
_____________________________________________________________









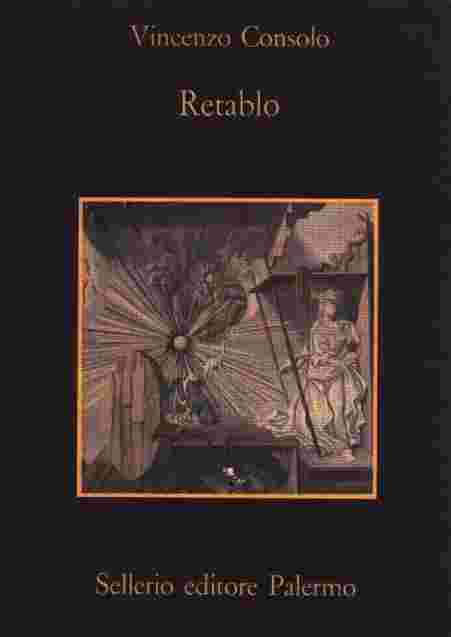
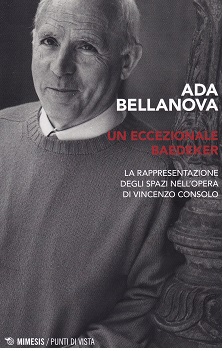 Ada Bellanova
Ada Bellanova