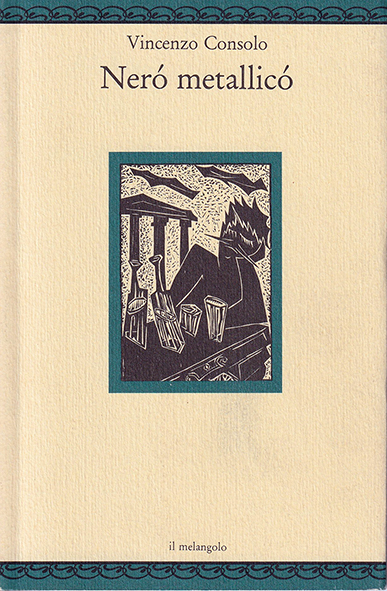*
Sciascia come Sherlock Holmes
nei sotterranei del potere di Cosa nostra
Mafia e letteratura… un binomio sofferto. Tanto più dal dopoguerra in poi, quando si ha un rinverdire del tema. A cominciare da uno scanzonato, fiabesco, sensuale Antonio Amiante, il cui mafioso è dotato di straordinario potere sessuale e quindi sociale. E si giunge, nel ’47, al caso più famoso (grazie anche a un film di Pietro Germi) di romanzo sulla mafia, a Piccola pretura di Giuseppe Guido Lo Schiavo in cui – quasi anticipazione dell’antagonistica coppia Bellodi – don Mariano Arena
dello sciasciano Giorno della civetta – il mafioso, don Turi Passalacqua, fermo nella concezione della giustizia presociale o asociale, rende omaggio alla giustizia statale rappresentata dal piccolo pretore. Nel 1960 viene pubblicato il bel dramma di Paolo Messina Il muro del silenzio, in cui, forse per la prima volta, la mafia è vista in tutta la sua valenza antisociale, s’inscena lo scontro tra il protagonista e il suo ambiente, la sua famiglia, chiusi nella vecchia cultura della rassegnazione e del silenzio. Accenniamo infine alla poesia di Ignazio Buttitta, civile, antimafiosa – raro caso di poesia popolare e vernacolare poggiante su una ideologia civile e progressiva – e al gattopardo di Lampedusa, in cui a sfondi, a situazioni mafiose si allude qua e là ed esplicitamente quindi si dice: “Vincenzino era uomo d’onore, uno di quegli imbecilli capaci di ogni strage.” Infine, lo scrittore che ha messo al centro di buona parte della sua vasta opera narrativa il tema della mafia, sentendo il fenomeno sociale come urgente e devastante, ricorrendo a uno trumento narrativo collaudato, al romanzo poliziesco, piegato a una funzione politica, civile. Tutta l’opera di Sciascia è di ispirazione e tema civile, ma nei romanzi polizieschi viene direttamente esplicata quella che possiamo chiamare l’epopea della piazza: un dibattito sui fatti sociali e politici, una serrata, filosofica, laica “conversazione in Sicilia”. In questa speculazione, in questa assillante, pubblica inquisizione Sciascia è figlio di Pirandello. Sennonché, il poliziesco di Sciascia è il rovesciamento del genere: ci sono il delitto, l’investigatore, ma non si arriva mai all’individuazione del colpevole, alla sua condanna; non si arriva mai alla soluzione del dramma, alla sutura dello squarcio nel corpo sociale.
Lo scrittore immaginava di calarsi nei sotterranei del potere e, illuminando, ecco che si aprivano al suo sguardo, si scoprivano nuove, occulte gallerie, insondabili, paurosi meandri. I suoi polizieschi non erano dunque che metafore della realtà politica italiana. Erano specchio e speculazione del e sul mistero, mafioso e criminale. Erano spesso racconti che anticipavano fatti che da lì a poco sarebbero accaduti nella realtà. Tra il ’61 e il ’74 Sciascia pubblica quattro romanzi polizieschi: Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Il contesto, Todo modo. I primi due, mafioso-politici, appartengono ancora all’epoca della mafia del feudo, della mafia rurale; i secondi due, politico-mafiosi, appartengono alla mafia urbana, alla società neocapitalistica. Attraverso i quattro racconti, si può vedere la storia dell’Italia di quegli anni, il processo di degenerazione del potere politico e degli organi dello Stato parallelamente all’evolversi e all’ingigantirsi della mafia, di questo cancro della società civile che sul corpo dello Stato sembra aver operato la sua metastasi. Il contesto – da cui Francesco Rosi ha tratto il film Cadaveri eccellenti – si svolge in un immaginario paese mediterraneo,
una sorta di Grecia che maledettamente somiglia all’Italia, in cui si sta attuando un golpe. Dei quattro polizieschi, il racconto di più alta tensione politica e letteraria ci sembra Todo modo. Nel quale Sciascia va al cuore del potere politico in Italia, al cuore del potere di un partito; alla matrice metafisica a cui il partito si ispira e da cui deriva il suo potere. Mai come in questo racconto la struttura poliziesca si è attagliata all’argomento, dialetticamente, come costruzione razionale contro la disgregazione della ragione, l’indagine contro lo sgomento, la memoria contro l’oblio, la cultura contro l’ignoranza, il logos, la parola contro l’inesprimibile, il silenzio. Ma è questo al contempo il poliziesco più misterioso di Sciascia, dove non è più possibile l’individuazione dell’assassino perché la ragione indagativa si arresta davanti al muro della metafisica: metafisica religiosa e metafisica del potere. Il mondo, il mondo civile, sembra dire lo scrittore, si è fatto
così tenebroso, così orrendamente e indecifrabilmente antisociale e criminale, così mafioso, che non è più possibile, stando sulla piazza, alla luce del sole, alcuna narrazione che possa rappresentarlo e interpretarlo. A meno che con mortale rischio morale, se non anche fisico, non si voglia scendere nei gidiani sotterranei, nei bui meandri del potere e di misteriose e criminose sette o logge segrete di balzachiani Dévorants. Diciamo qui che ciò che non fu più possibile al narratore, fu poi possibile, cioè calarsi nei sotterranei del potere, a un gruppo di giudici di nuova cultura e nuova coscienza civile e morale. Fu possibile a Chinnici, a Falcone, a Borsellino, a tanti altri, i quali pagarono con la vita questo loro azzardo. È il momento poi della solitudine dello scrittore, solitudine che è evidente negli ultimi suoi racconti polizieschi: Il cavaliere e la morte e Una storia semplice. Evidente, la solitudine, attraverso due citazioni iconografiche: di Dürer e di Klinger. Una famosa incisione del Dürer, Il cavaliere, la morte e il diavolo, fa da leitmotiv al racconto. Quel cavaliere, insidiato dalla Morte e dal Diavolo, solido dentro la sua armatura, sicuro in groppa al robusto cavallo procede solitario verso la turrita città in cima alla lontana collina, alla città ideale o d’utopia che mai raggiungerà. È disarcionato, cade dal cavallo il guerriero quando la società civile lo lascia solo nel cammino, perde tensione, volontà d’approssimarsi alla cittadella del diritto e della libertà. Il barbaro linguaggio del tritolo riprende a farsi sentire oggi, a esprimersi con la sua voce di paura e di morte in luoghi sacri alla nostra memoria storica, alla civiltà della lotta e del riscatto come Piana degli Albanesi, come Portella della Ginestra.
“Il Messaggero”, domenica 22 maggio 1994.
Pubblicato sul libro curato da Nicolò Messina
Cosa loro
Mafie tra cronaca e riflessione
Bompiani Editore
foto di Angelo Pitrone
Mese: Maggio 1994
Scilla e Cariddi
Vincenzo Consolo
Ora mi pare d’essere, ridotto qui tra Pace e Paradiso, come trapassato, in Con-templazione, statico e affisso a un’eterna luce, o vagante, privo di peso, memoria e intento, sopra cieli, lungo viali interminati e vani, scale, fra mezzo a chiese, palazzi di nuvole e di raggi. Mi pare (vecchiaia puttana!) ora che ho l’agio e il tempo di lasciarmi andare al vizio antico, antico quanto la mia vita, di distaccarmi dal reale vero e di sognare. Mi pare forse per questi bei nomi dei villaggi, per cui mi muovo tra la mia e la casa dei miei figli. Forse pel mio alzarmi presto, estate e inverno, sereno o brutto tempo, ancora notte, con le lune e le stelle, uscire, portarmi alla spiaggia, sedermi sopra un masso e aspettare l’alba, il sole che fuga infine l’ombre, i sogni, le illusioni, riscopre la verità del mondo, la terra, il mare, questo Stretto solcato d’ogni traghetto e nave, d’ogni barca e scafo, sfiorato d’ogni vento, uccello, fragoroso d’ogni rombo, sirena, urlo. Inciso nel suo azzurro, nel luglio, nell’agosto, dalle linee nere, dai ferri degli altissimi tralicci, alti quanto quei delle campate ch’oscillano sul mare, dal Faro a Scilla, che sono ormai l’antenne verticali e quelle orizzontali, ritte come spade sui musi delle prore, delle feluche odierne chiamate passerelle. Ferme, in attesa, clascuna alla sua posta, o erranti, rapide e rombanti, alla cattura del povero animale. Viene il momento allora, per i vocii e i frastuoni dei motori, sul mare (barbagliano parabrezza d’auto, di camion che lontano corrono lungo i tornanti della costa calabra, sopra Gallico, Catona; barbagliano vetri e lamiere dei grandi gabbiani, degli aerei aliscafi), sulla strada alle mie spalle, che corre, tra le case e il mare, giù verso Messina, il porto, fino a Gazzi, Mili, Galati, su verso Ganzirri, Rasocolmo, San Saba, viene il momento di rintanarmi. Mi metto allora a lavorare ai modelli in legno dello spada, azzurro e argento, tonno, alalonga, aguglie, ai modelli dei lontri veri, delle feluche antiche, a riparare reti e ritessere ricordi, miei, della mia vita, qui, sopra questo breve nastro di mare, quest’infinito oceano di fatti, d’avventure, o per il mondo. Sono nato (e chi lo sa più quando?) a Torre Faro, da rinomato padrone lanzatore, padre Stellario Alessi, terzo di cinque figli. I maschi, Nicola, Saro e io, di nome (solo di nome) Placido, ancora quasi lattanti, non lasciavamo in casa a nostra madre forchetta per mangiare, che legavamo in cima a una canna a mo’ di fiocina per infilzare polipi bollaci costardelle, ogni pesce che per ventura capitava a tiro del nostro occhio e braccio. Era l’istinto che ci portava verso il mestiere, come aveva portato nostro padre, suo padre indietro, ci portava verso il destino del mare, dello Stretto, del pesce spada, sopra feluche e lontri, ci portava a lance, palamidare, palangresi. Nicola morì soldato e Saro nel suo letto, di spagnola. E io non mi ricordo più quando salii sul lontro e lanciai l’arpione la prima volta. Ho solo negli occhi la vista della draffinera, di quelle preziose del ferraro mastro Nino, che s’inchioda nella pelle lucida, colore dell’acciaio, nel cuore della carne, del pesce che s’impenna, che s’inarca, alta la spada sopra il fior dell’acqua, e s’inabissa, sferzando forte con la luna della coda, rapido sparendo con tutto il filo della sàgola, il filo del sangue che disegna la sua strada. Strada che finisce nella morte. Ho negli occhi la ciurma che lo tira in barca, grande, pesante, inghiaccato alla coda, la bocca aperta, la spada in basso, come un cavaliere che ha perso la battaglia; negli occhi, l’occhio suo tondo e fisso, che guarda oltre oltre noi, il mare, oltre la vita. Ho nell’orecchio le voci di mio padre, i suoi comandi, le voci della ciurma: «Buittu, viva san Marcu binidittu!». Dopo la femmina, fu la volta del maschio, che s’aggirava, pesante e rassegnato, come in offerta, torno alla barca, a tiro del mio ferro. Da allora, ho negli occhi e nel ricordo una schiera infinita di pesci indraffinati, di spade a pezzi succhiate nel midollo, di teste, di pinne, di code resecate. Mio padre, vecchio e privo d’altri maschi, privo ormai di vista e resistenza, fu costretto a scender dall’antenna, ad ingaggiare, per la stagione che arrivava, uno di Calabria, dove sono gli antennieri più acuti dello Stretto, pur se i comandi, in vista dello spada, li fanno in lingua tutta loro. «Appà, maccà, palè, ti fò…» urlano. Il giovane, Pietro lanni, che sempre da caruso era stato guida sulle postazioni delle rocche alte di Scilla, di Palmi, di Ba-gnara, sposò poi Assunta, mia sorella, e se ne tornò al paese. Fu per il loro primo figlio, pel battesimo, ch’io conobbi quella che divenne poi la mia sposa. Figlia di padrone di barche, padre Séstito, era picciotta bella e assennata. Muta e travaglian-te. Ma non di fora, come le bagnarote libere e spartane che vanno a commerciare pesce, intrallazzare sale, avanti e indietro sempre sui traghetti, ma di casa, e al più sulla spiaggia, tra le barche dei suoi. Bruna, il fazzoletto in testa, gli occhi sfuggenti che spiavan di traverso, stretta alla vita, i fianchi dentro quel maremoto di pieghe della gonna, il busto che sbocciava in sopra ardito e snello: così m’apparve in prima a quella festa. Il matrimonio, con tutti gli accordi e i sacramenti, si fece nella chiesa bella del Carmelo, e il trattamento, nella casa capace della sposa. Fu quel giorno che mio padre, in presenza dei Séstito, pronunciò il testamento, disse che le barche, gli attrezzi per la pesca, tutto passava a me, ch’io sarei stato da quel giorno il padrone nuovo. Poco durò lo spasso per le nozze. Me la portai, Concetta, la mia sposa, nella casa nostra, lì vicino alla chiesa, davanti al monumento con l’angelo di marmo a cui la guerra tagliò di netto un’ala, in faccia alle barche nostre, al mare, alla rocca di Scilla dall’altra parte. Le feci conoscere Messina, il porto, con tutta la confusione dei bastimenti fermi, delle navi in movimento, dei ferribotti, la Madonna lì alla punta della falce, alta sopra la colonna, sopra il forte del Salvatore; il Duomo, dove restò incantata, a mezzogiorno, per il campanile e l’orologio, ch’è una delle meraviglie di questo nostro mondo: suonano le campane, canta il Gallo, rugge il Leone, la Colomba vola, passa il Giovane, il Vecchio, passa la Morte con la falce; sorge La chiesa di Montalto, passa l’Angelo, San Paolo, torna l’Ambasceria da Gerusalemme, la Madonna benedice… Me la portai per i viali, a Cristo Re, a Dinnammare, su fino a Camaro, a Ritiro, ai colli di San Rizzo. Ma lei, lei, sempre pronta, sottomessa, era però come restasse sempre straniata, come legata con la mente alla terra di là, oltre lo Stretto. E più mi dava figli (tre volte partorì in cinque anni) più sembrava crescere in lei il silenzio e lo scontento. C’era fra noi, che dire? come una distanza, uno stretto, una Scilla e Cariddi fra cui non si poteva navigare. Eppure, santissima Madonna!, la trattavo con ogni cura e affetto, l’adornavo di vesti, di ori; la portavo alla festa di Ganzirri, alla processione di San Nicola sul Pantano, alla trattoria di don Michele; e a Messina, alla festa dell’Assunta a Mezzagosto. Una volta tirai anch’io per voto (vo-to che si capisce quale fosse, d’avere finalmente quella donna, per cui potevo morire, indraffinato come un pescespada), tirai per la corda la gran Vara, scalzo, senza camicia, e lei accanto a me, sciolti i capelli, certo per un voto suo segreto che mai mi rivelò. Un luglio, ad apertura della pesca, per l’ammalarsi dell’antenniere mio, fu lei a suggerirmi, come per caso, quel nome d’un parente suo lontano, Polistena Rocco, rinomato fra Bagnara e Scilla. E arrivò quest’uomo snello, alto, d’una chioma riccia come quella del gigante Grifone sul cavallo. Tanto che là, in cima, stava per tutte l’ore senza un cappello, solo riparo quel suo casco nero di chiocciole o di cozze. Lo vidi e l’odiai. Non so perché. Forse per il suo portamento, il suo sorriso, la fama per cui ognuno rideva e mormorava, d’una sua dote fuori d’ordinario, la fama, scapolo com’era all’età sua, di grande ladro, d’amatore tenace e senza cuore. Mi parve che Concetta, al suo arrivare, mi parve che appena appena mutasse nell’umore, nel modo suo di fare; parlava più frequente, con me, coi figli, sorrideva finanche qualche volta. L’odiai. E quando alzavo il braccio per colpire il pesce, che lucido e dritto guizzava sotto l’acqua con la spada, mi sembrava di colpire, di piantare in quell’uomo la draffinera. E il mare lo vedevo tutto rosso, poi argento, poi blu, poi nero come la notte. Pel tempo che durò la sua presenza al Faro (due, tre estati, non ricordo), pur senza un segno, un fatto, un motivo ve-ro, cresceva sempre più la mia pazzia, l’ossessione dell’inganno. E sì che non eravamo più di primo pelo, né io né quello né Concetta. Durò fino a quell’anno in cui cominciò il grande mutamento, l’anno vale a dire in cui passarono in disuso remi, lontri, feluche, si mutarono le barche in pas-serelle. E ci vollero quindi, per i motori, l’antenne, tanti soldi. Decisi per questo (ma forse fu una scusa) di sbarcare, disarmare tutto, licenziar la ciurma, il calabrese. Per mantenere la famiglia m’imbarcai come marinaio, io padrone, sopra il Luigi Rizzo, il vaporetto che collegava Milazzo a Lipari, Vulcano… Fuori dal porto, costeggiando la penisola del Capo, oltre il Castello, davanti alla casa di quell’ammiraglio che nella Grande Guerra era stato eroe, assieme a un poeta, per una impresa ardita contro il nemico, il battello che portava il suo nome, lanciava il fischio di saluto. Allora qualcuno, una serva, un parente, rispondeva sventolando dal terrazzo un panno bianco. Il battello d’estate era sempre pieno di turisti: scoprii così il mondo. Mi feci, per cancellar l’amore per Concetta, gran traffichiere, facile predatore di straniere. D’inverno, nelle soste a Lipari sotto il Monastero, nelle soste forzate per il brutto tempo, m’intrecciai con una di là, ché sono, le donne di quell’isola, svelte, calamitose, seducenti. Tornavo al Faro, a casa, a ogni turno di riposo, tornavo per le feste. E lei, Concetta, era sempre chiusa nel suo mondo, sempre indifferente. In più ora sembrava solo presa dai figli, ch’erano ormai cresciuti e le davano maggior lavoro. Il colmo della sua freddezza nei confronti miei lo provai un’estate. Forse per sfida o forse nell’intento di smuoverla allo scontro, portai una straniera fino a Torre Faro, fino alla punta estrema del Peloro, all’incrocio dei mari, dove la rema forma i gorghi, quelli che la tedesca chiamava del mostro di Cariddi. Passammo davanti alla mia casa. Lei ci vide, da dietro la finestra, ed ebbe come un riso di sprezzo, di compatimento. Dopo quel fatto, decisi di sbarcare, di tornare al mio mestiere della pesca. Anch’io, come gli altri, misi da parte remi e lontri, comprai un motore per la mia feluca e cominciai a correre, a inseguire lo spada sullo Stretto. Avevo preso un’antenniere nuovo di Fiumara Guardia, e il mio braccio di vecchio lanzatore era tornato ad essere forte e preciso come nel passato. Fu in uno di questi erraggi, nell’inseguire il pesce dalla posta mia, che mi scontrai con una passerella che per abuso aveva catturato il pescespada. Lì, sull’antenna della feluca pirata, rividi allora dopo tanto tempo il calabrese. La questione della preda fu portata davanti al Consiglio, che sentenziò naturalmente a mio favore. Ma al Polistena, che seppi era il padrone della passerella, feci sapere che il giudizio per me, oltre il Consiglio, era nel riparar lo sfregio col duello: che si facesse trovare sulla spiaggia, proprio sotto il Faro. Fu li puntuale, come convenuto. Stavamo appressandoci, quando, a un passo l’uno dall’altro, cominciarono a fischiare sopra le nostre teste le palle dei fucili. Eravamo proprio sotto il campo del tiro al piattello. Ci buttammo per terra, la faccia contro la rena. E restammo così, impediti a muoverci, non so per quanto tempo. Ci spiavamo con la coda dell’occhio. Poi improvviso fu lui a ridere per primo, a ridere forte, e trascinò me nella risata, mentre i piatti in aria venivano dai colpi sbriciolati. Dopo, quando ci fu il silenzio, ed era quasi l’imbrunire, ci alzammo, ci guardammo in faccia. Fu lui, Rocco, a tendermi la mano. Non lo vidi più. Spari dalla mia vista e dalla mia vita. Anche perché spari in uno con Concetta tutto il rancore mio e la gelosia. Mi disse lei, là all’ospedale Margherita, affossata nel letto, gli occhi negli occhi, la mano serrata nella mia: «Ah, Placido, come si può passare una vita senza capire!» Da allora, quando mi lasciò la mia Concetta, sentii che cominciavo a farmi vecchio. Donai tutto, passerella e reti ai miei figli, lasciai il Faro e venni qui ad abitare in una nuova casa. Ora mi pare d’essere, ridotto qui tra Pace e Paradiso, come un trapassato… Ma vivo nei ricordi. E vivo finché ho gli occhi nella beata contemplazione dello Stretto, di questo breve mare, di questo oceano grande come la vita, come l’esistenza.
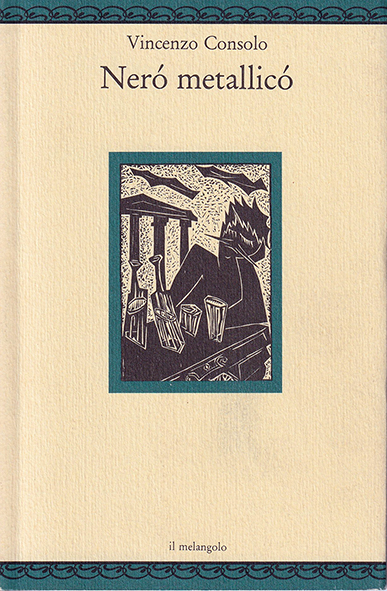


Nero’ Metallico’
Vincenzo Consolo
Nella discesa, l’aereo cominciò a scricchiolare, a ballonzolare. Vedevamo sotto di noi, sempre più vicino, il mare sferzato dalle raffiche di vento che schiumando s’infrangeva contro gli isolotti, contro la costa del Pireo. Ad Atene, trovammo subito la coincidenza per Salonicco Qui il vento s’era perso, era scemato, procedendo diritto verso oriente, il ciclone che aveva investito in quei primi giorni di marzo tutta l’Europa, andava forse a sciogliere le ultime sue forze verso le Cicladi. Era già sera quando prendemmo il taxi per raggiungere il centro di Salonicco. Guardavamo, andando lentamente in mezzo alle altre macchine, quella città moderna, piena di luci, di insegne, di manifesti pubblicitari, di quartieri appena costruiti come d’una città che è stata invasa da immigrati, che in poco tempo ha moltiplicato i suoi abitanti. E piena di traffico. Ci trovammo subito, in albergo – un moderno albergo su una piazza a emiciclo di fronte alla banchina del vasto porto — col nostro ospite, un simpatico professore napoletano. A tavola, in un ristorante del lungomare, raccontavo del mio precedente viaggio in Grecia, che risaliva a trent’anni prima, il “classico” viaggio-premio alla conclusione degli studi. Era stato, quello di allora, un viaggio nel Peloponneso, con soggiorno prima in una tendopoli (ah, disinvolta giovinezza!) di Kilini, in faccia alla foscoliana Zacinto, e quindi con giro in pullman che cominciava da Olimpia e, dopo varie tappe, finiva ad Atene. Avendo, come guida e mentore, oltre il fresco bagaglio di grecuccio, il libro di Cecchi Et in Arcadia ego. Quel libro, stampato da Hoepli nel ’36 e divenuto col tempo prezioso, con me e come me ritornava ora in Grecia dopo trent’anni, e divertita mia moglie lo esibiva a tavola, ben rilegato e giovanile d’aspetto, molto, ma molto più di me, ironizzava lei, che pur avendone quasi quanto quelli del libro, li dimostravo tutti, ma proprio tutti i miei anni, nella copertina malconcia della faccia, nel dorso incanutito della testa, nelle pagine ingiallite dell’anima, dello spirito… «Comunque», intervenne il professore, forse per salvarmi dalla crudeltà di mia moglie «quella Grecia lì di Cecchi qui non esiste. Qui siamo in un altro mondo: siamo in Macedonia». E gli chiesi allora che cosa avremmo potuto visitare, oltre il museo, le chiese e il resto, ben declinati nella nostra Guide bleu, e scartata, naturalmente, la famosa visita — per cui tutti venivano a far base qui a Salonicco — ai monasteri del Monte Athos, divenuti ormai, nel loro difficoltoso ed “esclusivo” accesso, fra i più ambiti e snobistici consumi turistici di oggi. «Un’antica città vicina all’Olimpo. Si chiama Dion» sentenziò il professore. Al museo, oltre la prevedibile statuaria greca e romana, oltre le stele, i busti, le teste, i sarcofagi, i mosaici, ciò di cui non avevo immaginato la bellezza era lo straordinario tesoro, scoperto pochi anni prima nella tomba di Filippo Il a Verghina. Mai avevo visto, in un museo archeologico, niente di tanto prezioso, di tanto dorato, di tanto sfavillante. Dall’urna funeraria del re macedone, del padre di Alessandro, alla corona di quercia, di mirto, alle placche della corazza, ai gambali, alle else delle spade, alle collane, agli anelli, alle medaglie, alle anfore, alle coppe, alle lanterne traforate… Non è facile vedere un’oreficeria antica così evoluta, così raffinata, con la quale solo quella della Firenze del Rinascimento credo possa reggere il confronto. E infatti, il pezzo più affascinante della raccolta, il famoso cratere di bronzo placcato d’oro di Derveni, nelle figure a tutto tondo che ornano la base della bocca, nelle placche delle anse, nei bassorilievi della pancia, faceva pensare al nostro Cellini. La scena che si dispiega sulla tonda superficie del vaso è quella di un corteo dionisiaco, con Menadi e Satiri, coperti da pelli di cerbiatto, il tirso in mano, che si affrontano, danzano, sotto un cielo di tralci di vite, di edera, di alloro. E c’è lui, il figlio di Zeus e di Semele, il dio dell’ebrezza e della liberazione, nudo al centro delle due ali del corteo, che accavalla e preme la sua coscia sul grembo di Arianna che gli siede accanto, turgida nel seno, colta nel gesto allusivo di togliere il velo dal capo. Il magnifico cratere di “Asteiunios, figlio di Anassagora di Larissa”, com’è inciso alla sua base, mi riportava indietro in un tempo remoto, il tempo della mia adolescenza quando, studente di ginnasio, mi portarono con la scolaresca a Siracusa per assistere alle tragedie greche. Quando vi- di, in quel vasto teatro, nel rosso infuocato del tramonto, Le Baccanti, con un giovane Gassman in bionda e riccioluta parrucca e in femminee vesti, come sempre quel dio si traveste, nella parte di Dioniso, e una Sarah Ferrati in quella di Agave, la figlia del tebano Cadmo, che sul Citerone, nel rito notturno, invasa dal dio, strazia il figlio Penteo e ne inalbera la testa, come trofeo, in cima al suo tirso. Nel Prologo della tragedia, Dioniso, narrando di sé, dice del cammino nel mondo della coltura della vite, della conoscenza del vi-no, della diffusione del suo culto, dei suoi riti, dalla terra dei Lidi e dei Frigi agli altipiani dei Persiani, all’aspra terra dei Medi, alla prospera Arabia, a tutta l’Asia che si stende lungo il mare, e giù fino alla regione degli Elleni. E il saggio Tiresia, in un dialogo col represso e repressivo Penteo, che nel potere e per il potere si nega a ogni sollecitazione dell’istinto, dice che due fra gli uomini sono le cose fondamentali: il secco frumento, dono della madre Demetra, e il liquido umore della vite, dono di Bacco. Il pane e il vino, dunque, simboli della carne e del sangue. Il sangue che di tempo in tempo deve scaldarsi, scorrere per le vene velocemente, dare impulso e movimento alle membra, risvegliare gli istinti sopiti, spingere alla foia, alla voracità, alla danza scomposta, all’entusiasmo, alla divinazione, alla spossatezza, al sonno e all’oblio. Senza il vino, la carne si spegne, si immobilizza, si fa catatonica; e l’uomo, pallido e freddo, varca la soglia della follia, della morte. Dioniso, il dio energico e guizzante, fanciullo cresciuto fra Ninfe, fra donne, apparendo agli uomini si femminilizza, e ai suoi riti, ai suoi cori partecipano donne, le donne che son vicine all’istinto, alla natura, alla verità della vita. Davanti all’albergo, trovammo l’indomani il tassista Ghiannis, serio e silenzioso, che ci portò a Dion, ai piedi dell’O-limpo. Era una giornata limpida, assolata, e le due vette del gran monte, del trono di Zeus, di fronte a noi, ammantate di ne. ve, brillavano come cristalli. Dion si stendeva sulla pianura deserta, ai margini d’un bosco di querce, di pioppi che avanzava su verso le pendici dell’Olimpo. Ci inoltrammo tra le sue rovine, tra le strade di larghi lastroni di pietra, il teatro, le ter-me, i templi affioranti con le sue statue da terreni acquitrinosi, il santuario di Iside, di Demetra, di Asclepio. E andammo poi alla grande villa dove, nella lussuosa sala da pranzo, il mosaico del pavimento raffigurava il trionfo di Dioniso e dove erano assise, in una trasognata atmosfera, le statue di quattro filosofi. In questa città era grande il culto del dio; qui, e sulle pendici dell’Olimpo, a Pieria, la patria delle Muse, che Euripide ricorda nella sua tra-gedia: “Lì sono le Grazie, / lì è il Desiderio, / lì è lecito alle Baccanti / celebrare il rito e l’orgia”. Finita la visita, trovammo Ghiannis seduto a una bettola con altre persone, giovani uomini del villaggio, rosso in viso, che gesticolava e parlava animato (lui che c’era sembrato così silenzioso, pacato), un bicchiere di vino davanti. Che vuota d’un fiato vedendoci e ci viene incontro sollecito, allegro. Un’altra persona sembrava. In quelle due o tre ore d’assenza, sembrava che il velo di uggia, scontento, che prima gli copriva la faccia, gli fosse caduto d’un tratto rivelandolo un uomo vivace, disposto allo scherzo, al dialogo. Parlava in un greco spedito, musicale ma privo per noi di senso. Lungo la strada, continuò a parlare, parlare, correndo veloce e volgendo indietro la testa, verso mia moglie. Che annuiva, annuiva, non sapendo che fare. A Salonicco, il professore ci attendeva davanti all’albergo e disse subito a Ghiannis di venirci a prendere da lì a un paio di ore per portarci in un villaggio fuori città, in una taberna sul mare. E il tassista si presentò puntuale, ancora più allegro di prima e spavaldamente tenendo in mano un bicchiere con dentro un liquido incolore. «Neró metallicó» disse sghignazzando e mettendosi al volante. Acqua minerale voleva farci credere che ci fosse in quel bicchiere. Che egli intanto aveva incastrato tra il sedile e la leva delle marce. Il professore ci rassicurò asserendo che i greci sono degli autisti provetti e anche pieni di “neró” guidano benissimo. Ghiannis, intanto, sorseggiava e par-lava, sempre rivolgendosi a mia moglie. Il professore, divertitissimo, traduceva. Diceva il tassista che quel giorno, festa delle donne, era contento perché la moglie era andata via con l’amante; che una sola volta durante l’anno le dava il permesso, e solo per un giorno: l’8 di marzo. E rideva, rideva. «Eh,» disse il professore «in questa regione le donne contano, e come. Anche Salonicco, Thessaloniki, porta un nome di donna, della sposa del suo fondatore». Mia moglie cominciò a protestare perché io non m’ero ricordato della festa, che la fine di Penteo meritavo. «Vuoi che ti dia il permesso d’andare sull’Olimpo, a Pieria, o sul Citerone, con la moglie di Ghiannis, con le altre Baccanti?» le dissi. In quella, si staccò qualcosa dal cruscotto della macchina, una vite o una chiave, che cadde proprio dentro il bicchiere con un rumore di metallo. «Neró metallicó» urlò mia moglie. Ghiannis, sghignazzando, prese il bicchiere e le offrì da bere.