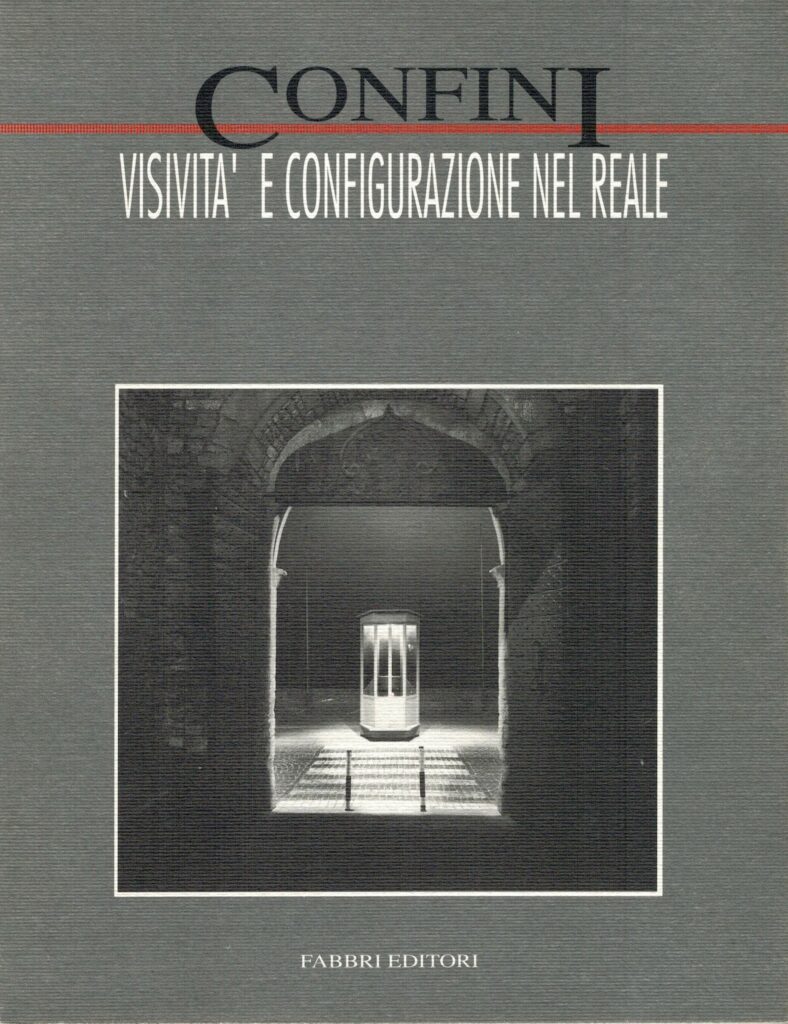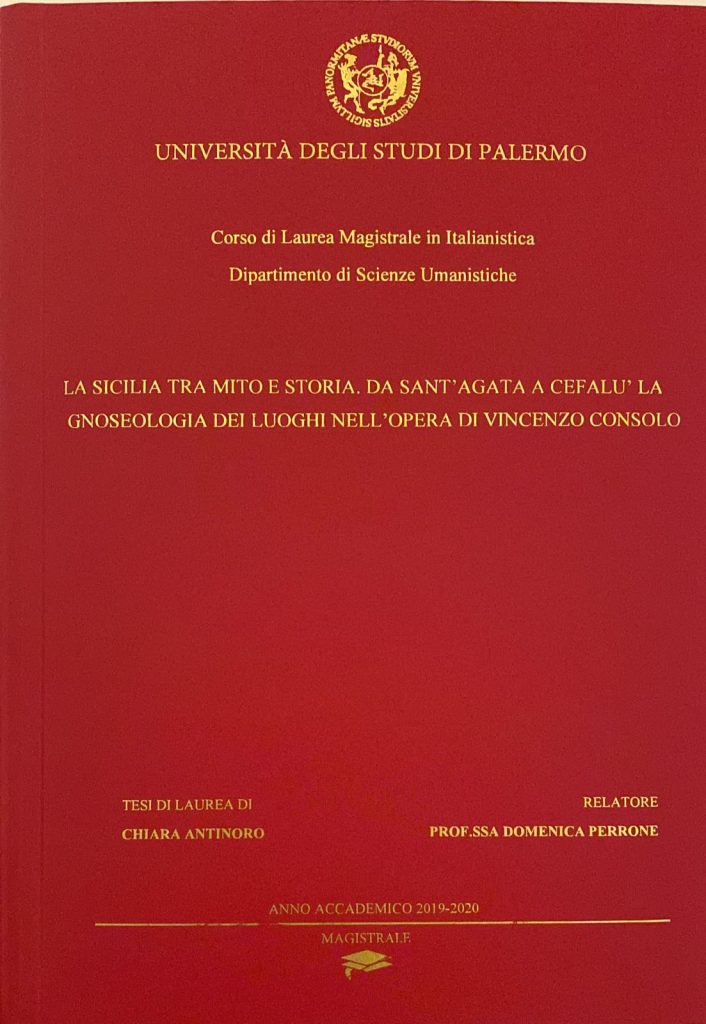
Tag: Madonie
L’ulivo e la giara
di Vincenzo Consolo
Nell’estate del 1882 Pirandello a compagnia del padre, compie un viaggio – il primo suo vero viaggio – da Palermo e Sant’Agata Militello, per una Sicilia, per una campagna, per un paesaggio tutt’affatto diversi da quelli che aveva dentro e che conosceva. Scopo di questo viaggio, da parte di Stefano Pirandello, è d’intraprendere, dopo il suo crollo economico a causa dello zolfo, il commercio degli agrumi. II signor Vincenzo Faraci di Sant’Agata, proprietario terriero e agente della compagnia di navigazione Florio-Rubattino, presso cui si reca, dovrebbe aiutarlo nella sua nuova impresa. La famiglia Pirandello, già dalla primavera dell’82, si era trasferita da Girgenti a Palermo, s’era allocata in una casa di via Porta di Castro, a ridosso delle mura del Palazzo Reale. Partono dunque, padre e figlio, per Sant’Agata, alle prime ore del mattino, su un treno che li porta fino a Termini Imerese. Da qui, per l’inesistenza ancora della strada ferrata fino a Messina, proseguiranno in diligenza.
Immaginiamo, in treno e in carrozza, la curiosità, l’attenzione, il rapimento del quindicenne Luigi di fronte a quel nuovo mondo che gli scorreva davanti agli occhi, agli echi che gli suscitavano i nomi dei paesi: Solunto, Himera, Cefalù, Halaesa, Calacte…
Al fitto e profondo verde degli agrumeti, e ai golfi, alle insenature, alle calette, al mare lungo la costa tirrenica; e alla cortina boscosa delle Madonie e dei Nebrodi che separavano questo rigoglio vegetale dalle sconfinate, aride lande dell’interno, della desolata nudità del latifondo e dei grigi e fumosi altipiani dello zolfo. E doveva accorgersi che man mano, dopo Termini, dopo Cefalù, il mondo colorato, vociante e brulicante del Palermitano andava a poco a poco stemperandosi – a spegnersi finanche nelle decorazioni dei carretti che, da chiassosi e spettacolari, si facevano monocromi, giallognoli o verdastri – a prendere gradualmente una misura più dimessa, ma forse più serena.
Sostano a Santo Stefano di Camastra. Un paese, questo, dopo la frana del 1682 che aveva distrutto il vecchio abitato in montagna, concepito e fatto ricostruire in basso-su un promontorio a mare, da Giuseppe Lanza duca di Camastra. L’impianto urbanistico disegnato dal duca ,un rombo inscritto in un quadrato – era ripreso aulicaunque dallo schema del Parco Versailles e della palermitana Villa Giulia. Un paese dunque non affastellato, casuale, di case sopra case, ma “pensato”, moderno, piano, ordinat: un paese “bello” secondo la qualificazione vittoriniana de Le cità del mondo. E’un paese anche di grande attività, di lavoro: la lavorazione dell’argila, di cui quasi tutti gli abitanti vivevano. A margini, lungo la statale, erano le purrere, le cave d’agilla, gli stazzuna, le fabbriche di laterizi, e le putii i robba r’acqua, le botteche delle ceramiche d’uso quotidiano (desumiamo queste notizie dalla monografia di Antonino Buttitta e Salvadore D’onofriono, La terra colorata) davanti alle qual erano gli spiazi dove la creta veniva ammucchiata e impastata ( dagli impastatura, a piedi nudi seguendo un preciso disegno, a ventaglio, a chiasciola, a spicchi d’arancio o a cerchi concentrici) e venivano esposti i manufatti ad asciugare o messi in mostra per la vendota dopo la cottura.
E davanti a queste botteghe, Luigino, fra i tanti oggetti, tante forme, quartari lémmi, bùmmuli, lumèri, fangotti, mafarati, avrà visto quella grande forma, alta, panciuta, ch’era la giarra.
La fabbricazione d’una giara era un lavoro delicatissimo, di grande precisione e di alta specializzazione dei “mastri”. Veniva eseguito in tempi successivi, al tornio. Sulla base precedentemente asciugata (u piezzu) venivano poi man mano innestate le fasce, su su fino alla parte più convessa della pancia e alla rastremazione delle spalle, del collo e della bocca. Veniva poi stagnata, invetriata con piombo ossidato, all’interno e fino al labbro, prima di essere infornata. In quella stagione, prossima alla raccolta delle olive e alla loro spremitura – le olive dei vasti oliveti della zona del Mistrettese, delle Caronie, di San Fratello – dovevano essercene già molte esposte davanti alle botteghe, di giare, nelle loro varie misure canoniche – da mezzo cantàru, venti litri, fino alle grandi capaci di quattrocento, cinquecento litri d’olio – un solenne corteo di badesse nell’ocra infuocata della luce del tramonto.
A Sant’Agata Luigi e il padre sono ospiti per alcuni giorni della famiglia Faraci, in contrada Muti, in una casina di campagna su una collinetta da dove si domina il piccolo paese col castello dei principi di Trabia al centro, le casupole dei pescatori lungo la spiaggia e quelle dei contadini verso l’alto. Luigi ritrovava qui il suo coetaneo e compagno di scuola, al “Vittorio Emanuele II” di Palermo, Carmelo, figlio di Vincenzo Faraci. Fra i due ragazzi si stabili una solida amicizia. E, ritornata la famiglia Pirandello a Girgenti nell’85, Luigi e Carmelo andranno a abitare insieme in un stanzetta d’affitto in via Mastro d’Acqua, E l’ultimo anno di liceo, Luigi allora ferocemente immerso nei suoi studi e nell’amore per la cugina Lina. Carmelo Faraci si dedicherà a questo suo compagno geniale e stravolto dalla passione d’amore fino ad accudirlo, a preoccuparsi di tute le necessità pratiche. Poi Carmelo, finito il liceo. avrà un triste futuro, si ammalerà di tisi e lascerà Palermo per andare a rifugiarsi in un bosco sopra Sant’Agata, a Mangalavite.
Luigi, da Porto Empedocle, dalla villa del Caos, nell’agosto dell’87, deluso dall’amore, dal lavoro tentato nelle zolfare del padre, in preda al pessimismo più nero, si ricorderà di questo suo mite e fedele amico e gli scriverà. Le cinque lettere che Pirandello invierà al Faraci sono state pubblicate dal professor Giovanni R. Bussino, di San Diego in California nel libro Alle fonti di Pirandello. Scrive in una di queste lettere:
“Tu sei malato di corpo (e io ti voglio intanto in via di guarigione) ed io sono malato di spirito e della mia malattia non si guarisce. Mi credono tutti pazzo, e prima – per maggiore tormento – i miei più cari; il mio vizio dei nervi si è bruscamente accentuato ed io non so trovar pace in nessun luogo: la mia vita mi si è fatta brutta bene… M’indusse a scriverti – non te lo nascondo – una dolcissima memoria del passato…”.
La memoria dolcissima d’una serena campagna: e di due forme, antichissime e significanti: l’ulivo e la giara.
La novella La giara è pubblicata il 20 ottobre 1909 sul “Corriere della Sera”.
Pirandello è chiuso, in questo periodo, in una doppia, tetra prigione: quella burocratica dell’insegnamento al Magistero, dov’era inquadrato nella categoria degli “incaricati” certamente contrassegnato da un mastronardiano “coefficiente”, e quella domestica, dove la gelosia paranoica della moglie gli tesseva intorno ogni giorno di più le sue terribili maglie. La novella La giara è la prima fuga nella memoria e nel ricordo, fuga dalla sua vita e dai fantasmi “pirandelliani” che lo assediavano.
‘A giarra, commedia in dialetto, è del 1916.
E’ tempo di guerra. Il figlio Stefano è prigioniero degli austriaci, la madre appena morta – quella madre che aveva incarnato il suo romantico patriottismo, che ora, nell’urto con la tragica realtà, si lacerava – gli ritornava a colloquio come personaggio, la moglie ormai dentro quella tenebra dove “nessuna voce può raggiungerla più” Si sa che al teatro regionale e dialettale Pirandello fu trascinato dall’amico Martoglio e dalla forza della “Compagnia comica di Angelo Musco, che in quegli anni mieteva successi per tutta la Penisola Successi, certo, di questi istintivi e irresistibili teatranti catanesi, dovuti anche al bisogno di distrazione e di riso da parte degli spettatori angosciati dalla guerra. Pirandello scriverà per quel teatro per ragioni materiali, economiche ma deve anche scrivere quel teatro per ragioni spirituali, in un bisogno crescente di luce e di respiro quanto più si sente precipitare nel pozzo della disperazione. Al momento più basso e più cupo della sua vita, corrisponderà il momento creativamente più luminoso e liberatorio che è Liolà.
Subito seguirà La giara, con la quale chiuderà questo ciclo. E a noi piace credere che nel concepire La giara gli sia tornato il ricordo di quel suo lontano viaggio nel Val Demone, della fertile campagna alle falde dei Nebrodi, delle giare intraviste a Santo Stefano. “Sissignore, della giara grande, per l’olio, arrivata ch’è poco da Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricano. Uh, bella: grossa così, alta a petto d’uomo, pare una badessa” dice ‘Mpari Pè, il garzone di don Lollò. L’uomo rimasto prigioniero dentro la giara è una delle trovate sceniche, visive e gestuali, più felici del teatro pirandelliano. Saracena è la giara – giarrat – e saraceno quel conciabrocche dentro, ladro (involontario) della roba altrui, su cui volentieri don Lollò, nella sua furia, butterebbe dell’olio bollente. Ma zi’ Dima è anche un folletto, un imprevedibile ginn, di quelli annidati dentro bottiglie o lampade – egli ha commercio col diavolo, e quella gobba e quella pece nera ne sono la prova – che con le sue argomentazioni da dentro la giara contrasta e distrugge di volta in volta le argomentazioni esterne, giuridiche, codificate, di don Lollò e del suo avvocato.
Ma La giara trapassa questa farsa saracena o questo mimo siceliota, sofroneo o senarcheo, trapassa ogni eclisse solare e storica, va più indietro verso un tempo remoto, verso significati più abissati, archetipici. La giara è allora l’involucro della nascita, l’utero, ed è insieme la tomba (i Siculi seppellivano i loro morti, in posizione fetale, dentro i giaroni). E zi’ Dima non perde, non muore, sapiente, dialettico e sarcastico, vince e rinasce nello splendore d’un plenilunio, nel tripudio dei contadini.
E quell’olio che la giara avrebbe dovuto contenere viene si dall’ulivo saraceno, ma viene anche dall’albero sacro ad Atena, dea della sapienza.
Se Liolà, della stagione della vendemmia, è mimo dionisiaco o fliacico (Phliax era un demone della natura, della fecondità), La giara è mimo apollineo e cavillico, della stagione dell’olio che dà sapore – sapere – e che dà luce. L’ulivo saraceno, un ulivo del Caos, immaginato, sognato, riapparirà in limine, nella notte che precede la morte, sul palcoscenico del palcoscenico, in un terzo atto mai scritto, a reggere un tendone – sudario contro cui si reciterà l’ultima favola. Apparirà quell’albero di forma tormentata, agonica, da cui l’anima anela a uscire, a consumarsi bruciando, come olio dentro una lampada: a ritornare, annullandosi, nella nudità, nella verità, nel flusso infinito.


UOMINI COME LUPI PAROLE COME SILENZI
Sono due biblioteche i primi antagonisti che si incontrano nel nuovo romanzo di Vincenzo Consolo (Nottetempo, casa per casa, Mondadori, pagg. 175): quella polverosa e non troppo frequentata del barone don Nenè Cicio, ospitata nel suo palazzotto patrizio di Cefalù, e quella del suo defunto zio don Michele, che don Nenè ha cominciato a chiamare Bastardo dopo l’ apertura del testamento. La prima, minuziosamente descritta neanche fosse la biblioteca di Des Esseintes, comprende le più improbabili opere di antiquaria siciliana accanto a “controversie storiche, teologiche, vite di santi, di missionari martiri, dissertazioni, apologie” e a vecchi trattati scientifici come la Flora palermitana, la Storia naturale delle Madonie, il Catalogo dei crostacei del Porto di Messina, e via dicendo; del tutto assente la letteratura, se non per il “segreto enfer” del barone, peraltro alquanto esiguo, visto che si limita ad accogliere le satire dialettali di Domenico Tempio e l’ opera venerata di Gabriele D’ Annunzio. Don Michele invece aveva libri in ogni stanza della sua grande casa, “di filosofia, di politica, di poesia”, e li raccontava a Petro Marano, figlio del suo mezzadro nominato erede universale: “‘ Vittor Ugo’ , diceva ‘ Vittor Ugo…’ e ‘ Gian Valgiàn, Cosetta…’ , ‘ Tolstòi’ e ‘ Natascia, Anna, Katiuscia…’ , e narrava, narrava le vicende, dell’ inverno, torno alla conca con la carbonella”. Più che due culture, sono due impronte antropologiche a fronteggiarsi: da una parte lo stanco e rituale ossequio alle tradizioni locali, radicato in una cinica accettazione dell’ esistente che nasconde solo volgarità intellettuale o edonismo d’ accatto; dall’ altra l’ esercizio ostinato e appassionato della fantasia, le fughe della mente verso altre realtà, e in un angolino la vis profetica di una pervicace fede nella palingenesi, con la minaccia incombente e inevitabile della follia. Il romanzo ruota per intero intorno allo scontro manicheo fra questi due modelli; e si ha l’ impressione che poco importi, in definitiva, l’ epoca storica in cui l’ intreccio è collocato (gli anni cruciali fra il ‘ 20 e il ‘ 22, le lotte contadine, l’ avvento del fascismo), di fronte a quell’ eterno conflitto che certo si cala di volta in volta in concrete incarnazioni istituzionali e sociali, ma che poi le trascende tutte in quanto resta un conflitto di “forme” pure, schemi astratti di rapporto col mondo. Voglio dire che la cantata sicilianissima e densa di umori da barocco popolare, quale Nottetempo, casa per casa può d’ acchito apparire, si rivela a ben guardare un’ articolata allegoria morale, una sorta di poema filosofico in cui l’ eco arcaica della physis presocratica (l’ unità e totalità delle cose e dell’ uomo. Il principio assoluto e comune della fisiologia e dell’ etica) fa da sottofondo ai lugubri rintocchi dell’ alienazione moderna, che quella totalità perduta riduce a pazzia, a deviazione mostruosa, a terrore. E don Nenè Cicio scimmiotta D’ Annunzio Il padre di Petro, ad esempio, è un “luponario”, un licantropo che urla alla luna e piange disperato sulla sua incomprensibile condizione (“Si spalancò la porta d’ una casa e un ululare profondo, come di dolore crudo e senza scampo, il dolore del tempo, squarciò il silenzio di tutta la campagna”); ed è pazza Lucia, sorella del giovane, che entra ed esce da una clinica psichiatrica, segregata e tormentata dai fantasmi ossessivi della sua malattia, eppure mai querula, anzi fiera e a suo modo orgogliosa. Sembrano, nell’ immaginario di Consolo, le propaggini esauste della schiatta dei puri e dei giusti, “piena della capacità d’ intendere e sostenere il vero, d’ essere nel cuore del reale, in armonia con esso”: la razza della speranza e della sintonia col mondo, della quale Petro, maestro di scuola generoso e progressista, è forse l’ ultimo erede sano. Dall’ altra parte, all’ altro polo del conflitto, non c’ è invece autentica follia: vi si incontrano al massimo il provinciale deréglement del barone Cicio, che scimmiotta un D’ Annunzio ridotto a magniloquente ed erotomane fantoccio, o le mistificazioni tra mistiche e sataniche di Aleister Crowley, uno sgangherato santone realmente esistito che trascina sul mare di Cefalù la sua esigua comunità di invasati sacerdoti dell’ amore di gruppo, alla quale aderisce con entusiasmo lo stesso don Nenè. E con questa comunità si incontra e scontra il personaggio più chiaramente allegorico del romanzo, il giovane pastore Janu, la cui carnale e prorompente innocenza è dapprima invano attratta dalla pazzia di Lucia, per poi rifluire nel grembo accogliente di un’ adepta di Crowley, e uscirne segnata per sempre da una malattia venerea che è anche e soprattutto inguaribile malattia morale. Petro, alla fine, fuggirà in Tunisia: per sottrarsi, lui amico di socialisti e anarchici, alle rappresaglie dei fascisti e degli sgherri di don Nené pronti a fargli pagare antichi e nuovi rancori sotto la protezione della camicia nera; ma anche per appartarsi in una lacuna franca, in un anfratto fuori dalla storia, dal quale poter affidare alla scrittura (ebbene sì, proprio all’ invenzione letteraria) le labili tracce di un Senso perduto, di una salvezza a venire da aspettare con pazienza e rassegnazione. I progetti palingenetici dell’ anarchico Schicchi, suo compagno di fuga, non lo toccano più di tanto: “Si ritrovò il libro dell’ anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore”. Manganelli e sangue e auto rombanti della Targa Florio Il romanzo così si conclude: per la schiatta dei giusti, dunque, l’ unica alternativa alla follia è la scrittura. Ma non sarà anche questa un’ illusione, una soccorrevole menzogna? “E’ mai sempre questa la scrittura”, si chiede Consolo qualche pagina prima, “è l’ informe incandescente che s’ informa… è canto, movimento, pàrodo e stàsimo per liberare pena gioia furia rimorso, mostrare nella forma acconcia, nella più bella la tempesta?… E’ menzogna l’ intelligibile, la forma, o verità ulteriore? Ma prima è l’ inespresso, l’ ermetico assoluto, il poema mai scritto, il verso mai detto… E’ la ritrazione, l’ afasia, l’ impetramento la poesia più vera, è il silenzio, o l’ urlo disumano. E allora l’ infinita acribia stilistica con la quale lo scrittore ha allestito il suo poema filosofico, quel martellare frequentissimo di endecasillabi che si affaccia da una prosa divenuta niente più che una sottile pellicola delegata ad amalgamare e dissimulare i versi, ci slarga improvvisamente davanti un’ ulteriore prospettiva: forse quella lingua musicale e misteriosa, attorta su termini rari e preziosi e poi improvvisamente sciolta con ritmi di sistole e diastole nel giro del parlato popolare, capace di attingere alla più alta tradizione letteraria italiana (“le mura e gli archi” di Leopardi, addirittura un inopinato Pascoli: “trapassa per le stanze un lume, palpita, s’ è spento”) come alla materia, vivente o arcaica che sia, del dialetto siciliano; forse quella lingua, dicevo, è ora una semplice efflorescenza del silenzio, ora il camuffamento di un “urlo disumano”. E la storia, i manganelli e il sangue, i nobili e i contadini, i mafiosi e gli anarchici, le automobili rombanti della Targa Florio e i periclitanti carretti dei venditori ambulanti, altro forse non sono se non puro materiale esornativo, attribuito, “forma intelligibile” e menzognera prestata dalla letteratura a una Sostanza oscura e inattingibile, assoluto Male o assoluto Bene, Totalità infranta ab origine, e mai più ricomposta. In tal modo lo stesso processo di civilizzazione, con gli scontri e le lotte all’ ultimo sangue fra i don Nenè e i Petro Marano, con la follia, gli entusiasmi e le ciniche sopraffazioni che lo scandiscono, diverrebbe un mero esorcismo, una sorta di rito – magari altrettanto insensato e sterile quanto quelli praticati da Crowley e seguaci – rivolto a scongiurare la minaccia di quell’ oscurità, e proprio per questo di essa in qualche modo partecipe, ugualmente minaccioso, ugualmente incomprensibile. E lo scrittore finirebbe comunque col farsene complice, nella necessità di sfuggire all’ aut aut tra urlo e silenzio, affastellando i suoi prodotti in biblioteche sempre più polverose e sempre più mute alla benché minima richiesta di aiuto loro rivolta: un aiuto per potersi ritrovare, magari per un attimo, “nel cuore del reale”. Non è un romanzo perfetto, Nottetempo, casa per casa: talvolta la tensione si allenta, il giro stilistico si assolutizza, diventa maniera; talaltra l’ invenzione simbolica si ingolfa per troppo combustibile, si fa confusa, pletorica. E tuttavia è un romanzo importante, quasi un evento nei tempi grami della nostra narrativa: vi si respira, vivaddio, l’ aria della grande letteratura, quella che suscita interrogativi, pensieri, disagi, che ti restituisce lo spessore, le contraddizioni, il senso nascosto di un’ epoca. Un’ aria tanto ricca di ossigeno culturale può far male, dar le vertigini a chi è abituato allo smog e alla stagnazione della quotidianità; ma è un rischio che va corso con entusiasmo, e ringraziando di tutto cuore chi per una volta è riuscito a farcelo correre.
di STEFANO GIOVANARDI
Paesaggi di luce
di Vincenzo Consolo
Non sappiamo se esiste o possa mai esistere una scienza che studia la luce in rapporto ai luoghi (topofotologia?). Speriamo che non esista, che non possa mai esistere. Perché vogliamo (noi che temiamo le razionalizzazioni, la distruzione delle fantasie, la loro riduzione in mappe, grafici, numeri: ah quella luna profanata, la sua caduta, il suo mito, la sua fantasia frantumata! Ah le sue misure, i nomi dei suoi “mari”. “. dei suoi monti, dei suoi crateri!) vogliamo che luoghi e luci – luoghi bruciati, smaterializzati dalla luce – rimangano pur sempre mari o cieli su cui navighi solo la poesia.
Luogo di luce, di incroci o giochi di luce è ad esempio quell’isola del Mediterraneo che si chiama Sicilia. Luce che si modula, cambia da capo a capo, da costa a costa, da montagna a montagna, da pianura a pianura. Abbiamo potuto constatare (o è stato un abbaglio?), percorrendo l’isola, che, oltrepassato il capo Gallo, improvvisamente la luce cambia, si fa diversa da quella del Tirreno; che aggirato il capo Peloro, a torre Faro, sopra il gorgo di Cariddi, diversa è la luce dello Jonio; e ancora diversa oltre gli Iblei, da Siracusa a Pachino, all’Isola delle Correnti; che luce sua è, diversa dalle luci dei mari e delle coste, quella della sconfinata landa desolata dell’interno, oltre la barriera delle Madonie e dei Nébrodi. E non è altra la luce rossastra, infuocata, fenicia o africana, di Mozia, del Lilibeo o Selinunte, da quella bianca e cristallina di Taormina, di Megara o di Ortigia, altra dalla luce nera di Catania e dell’Etna? La luce terrosa di Palermo da quella marina, acquorea di Messina? La luce delle Egadi da quella delle Eolie, delle Pelagie? Messina, la spirale del suo porto, lo iato, la fenditura dello Stretto…
Visto dalla platea di Paradiso, o dalle acque stagne di Ganziri, visto dai palchi dei colli di San Rizzo, dal Faro Superiore o Castanèa delle Furie, è un teatro unico, fantastico, una rappresentazione senza fine dove si spiegano velari, si squarciano, s’involano; dove rifrazioni di lastre immateriali, d’invisibili specchi sciabolano, s’incrociano, si spezzano; dove piovono, s’ammassano gravi cascami d’astri sfaldati; dove sorgono illusioni, sortilegi, fate morgane, allucinazioni; dove a volte il mondo crudamente e crudelmente si denuda, mostra tutta la sua desolazione, la sua angoscia (il dolore assoluto, senza scampo dello sfondo d’una qualche Crocefissione d’Antonello).
E allor mi pare d’essere, ridotto qui tra Pace e Paradiso, come trapassato, in Contemplazione, statico, e affisso a un’eterna luce o vagante, privo di peso, memoria e intento, sopra cieli, lungo viali interminabili e vani, scale, tra mezzo a cattedrali, regge di nuvole e di raggi. Mi pare quando che ho l’agio e il tempo di staccarmi d’ogni reale vero e di sognare. Mi pare forse per questi nomi belli di villaggi o pel mio levarmi presto, ancora notte, con le lune e le stelle, uscire, portarmi alla spiaggia, sedermi sopra un masso e aspettare l’alba, il sole che mi fuga infine l’ombre i sogni, le illusioni, riscopre la verità del mondo, la terra, il mare, lo Stretto solcato d’ogni traghetto e nave, d’ogni barca e scafo, sfiorato d’ogni vento, uccello, fragoroso d’ogni rombo, sirena, urlo.
E se dallo Stretto andiamo oltre il golfo, il capo di Milazzo, altro teatro, più vasto e più fantasioso vi si spiega: quello di Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi … Isole ora sfumate, lontane, fuggenti dietro cortine, velari, vapori, illusorie come Sirene; ora corpose, evidenti, reali, prossime e avanzanti sulle acque, con ali di meduse, pomici, alghe, fluttuanti come le Simplegadi. Andiamo verso il Tindari, i ricami delle rene, le acque morte, i giunchi velieri marciti sotto la sua rocca prominente. Questo il teatro che mi si parò davanti appena aperti gli occhi, questo il quadro, la memoria più antica e indelebile.
E cos’è allora la memoria d’un pittore nato sopra lo specchio di sommo sortilegio e sommo inganno, sopra l’occhio verde e tremendo di Gorgona, sopra la lastra versicolore, il vetro di Murano, sopra quel Mar Morto e quello Stige, quel cielo rovesciato, quel ceruleo abisso che è la Laguna, la natura più intima, la segreta sorgiva di quel mare che scorre e che si mesce allo Jonio, all’Egeo?
Nato in una città invisibile, Stambul e Samarcanda riflessa dentro l’acque, madrepora vagante, sargasso stralucente, mamona che si dona e che si nega?
Nato in Venezia e lì imprigionato, nella marea che sale, nel cielo che s’abbassa, nelle acque e nelle brume smemoranti, che celano splendori, miracoli, potenze, ogni beltà, ogni arte? Nella città che sorge all’orizzonte, oltre le soglie, s’erge nei cieli della Luna, di Venere, del Sole, nel cielo delle Stelle, nel centro dei cerchi luminosi?
Quali nei pleniluni sereni
Trivia ride tra le ninfe eterne
che dipingon lo ciel per tutti i seni,
vidi sopra migliaia di lucerne… (1)
E possibile ancora memorare, dire, riportare tanto abbaglio, tanta viva sorgente d’ogni luce, d’ogni trasparenza? Solo per allusioni, per astrazioni, per ritmi, per intermittenze, per pulsazioni, per fotoni, per piani e fasci di luce, per accenni d’infinito, per tagli, lame di giallo, bianco, per fuochi intensi, per vermigli, per modulazioni di cieli, e di acque, per azzurri profondissimi, per altre arti e per altre nostalgie, per inusitate visioni forse è possibile.
Possibile, meravigliosamente ardita e luminosa fu la parola d’un Poeta fra luci e visioni d’altro mondo che ad ogni altro avrebbe tolto il passo, il fiato.
Quali per vetri trasparenti e tersi,
o ver per acque nitide e tranquille,
non si profonde che i fondi sien persi,
tornan de’ nostri visi le postille,
debili sì, che perla in bianca fronte… (2)
(1) Dante,Paradiso, canto XXIII
(2) Dante, Paradiso, canto
Confini – Visività e configurazione nel reale.
1990 Fabbri Editore