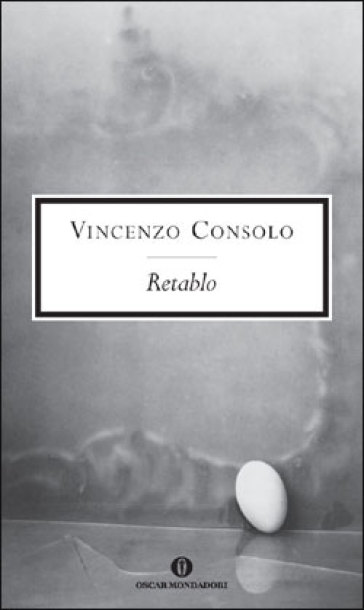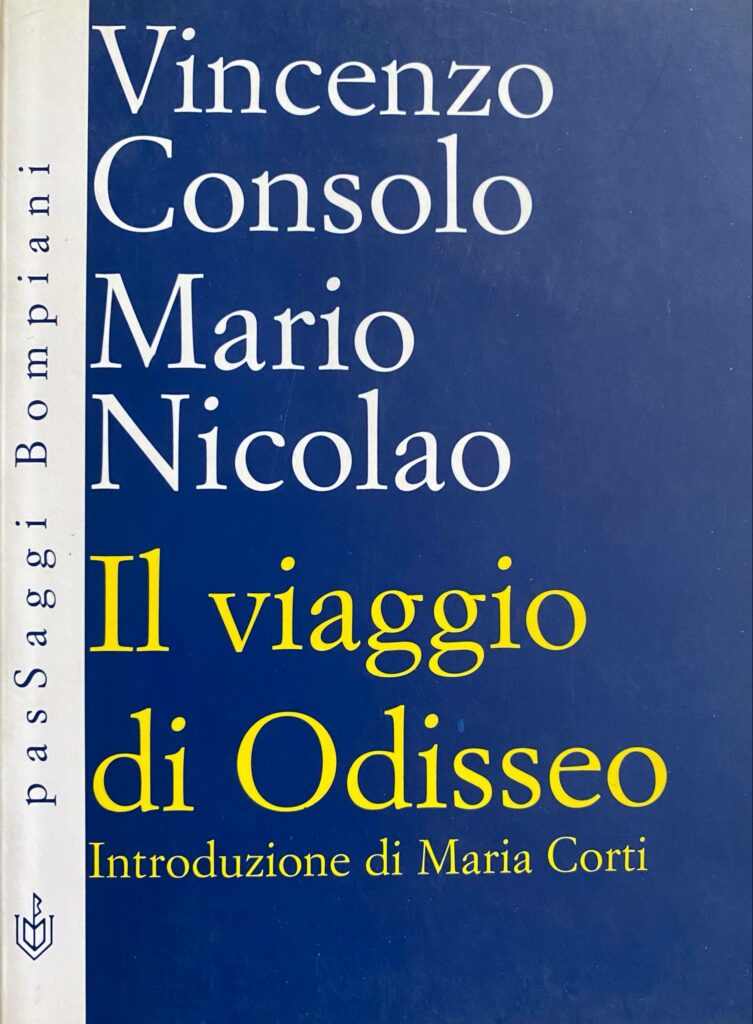Giuliana Adamo
In quel panorama saggistico così completo delle tendenze e delle
aporie dello spirito del XX secolo che è Uomo senza qualità,
Musil mette a fuoco la complessa, subdola, disperata problematica
in cui lotta l’uomo contemporaneo. Dibattuto sempre tra due
poli, l’uomo è condannato all’incertezza, ad una perenne insicurezza,
che investe, ovviamente, anche la Storia, ormai talmente deprivata
dell’ottimistica visione progressista di stampo positivista
da portare Musil ad affermare che <<per cause ignote l’evoluzione
raramente acquista di più di quanto non perde in deviamenti e
distruzioni» (p. 280)1.
Una visione realisticamente sconsolata di come stanno le cose
nel XX secolo, quindi, contro cui Kurndera, Brodskij, Calvino, Todorov
– tra i tanti – hanno ipotizzato una possibile via d’uscita.
Una sorta di salvezza estetica contro il male del mondo, e della
Storia: il male dell’indifferenza (contro cui si scagliava Gramsci
con tutta l’indignazione di cui era capace), del potere che tutto
eguaglia con la forza dell’ideologia, delle armi, del danaro. All’incertezza
paralizzante individuata da Musil si oppone la saggezza
dell’incertezza del romanzo, il rigore con cui la poesia oppone al
buio o alla luce accecante delle certezze ufficiali le tracce più tenui,
la differenza di minuscoli fatti o cose, come il topo bianco
d’avorio in Dora Markus di Montale.
La coscienza che emerge dalla letteratura – ovvero il fatto che
il reale è un fascio di possibilità – è ciò che viene opposto alle macchine
da guerra del potere. Di qui l’invito di Brodskij:
Eppure dobbiamo parlare; e non solo perché la letteratura, come i poveri, è
notoriamente portata a prendersi cura dei propri figli, ma più ancora per via di un’antica e forse infondata convinzione, secondo Ia quale se i padroni di questo
1 Robert Musil, L’uomo senza qualità, Torino, Einar-rdi,2 voll., 1996 e1997,
ol. I, p. 280
mondo avessero letto un po’ di più, sarebbero un po’ meno gravi il malgoverno e le sofferenze che spingono milioni di persone a mettersi in viaggio. Poiché non sono molte le cose in cui riporre le nostre speranze di un mondo migliore, poiché tutto il resto sembra condannato a fallire in un modo o nell’altro, dobbiamo pur sempre ritenere che la letteratura, sia l’unica forma di assicurazione morale di cui una società può disporre; che essa sia I’antidoto permanente alla legge della jungla; che essa offra l’argomento migliore contro qualsiasi soluzione di massa che agisca sugli uomini con la delicatezza di una ruspa […] Dobbiamo parlare perchè dobbiamo dire e ripetere che la letteratura è una maestra di finesse umana, la più grande di tutte, sicuramente migliore di qualsiasi dottrina; dire e ripetere che, ostacolando l’esistenza naturale della letteratura e l’attitudine della gente a imparare le lezioni della letteratura, una società riduce il proprio potenziale, rallenta il ritmo della propria evoluzione e in definitiva, forse, mette in pericolo il suo stesso tessuto. Se questo significa che dobbiamo parlare cli noi, tanto meglio: non già per noi stessi, ma forse per la letteratura 2. La realtà estetica è, così, chiamata a ridefinire la realtà etica dell’uomo. Ed è proprio in questo senso, allora, che l’affermazione di Dostoevskij – «la bellezza salverà il mondo>> – va presa alla lettera. Consolo sapeva tutto questo. Sempre impegnato sia nel suo lavoro giornalistico sia in quello letterario, sapeva bene – sapeva sempre più – che (come aveva intuito Musil) non abbiamo punto d’appoggio, che danziamo tutti sull’orlo dell’abisso. Sapeva che il mondo con i suoi orrori – (guerre, fame, ingiustizie, razzismo, violenza, disperazione dei tanti, arroganza dei potenti) da lui inesaustivamente denunciati fino all’ultimo – deborda da tutte le parti. E, dunque, avvertiva (insierne a Kundera, Brodskij, Calvino Torodov’, Pasolini, etc.) che per un intellettuale è necessario opporsi con tutti i mezzi possibili, essere contro a tutto questo. Ma per fare diga all’orrore del mondo e di chi lo governa, ci vuole un impegno permanente, una capacità di sdegno sempre all’erta, un’arte – la scrittura – che abbia un metodo inesorabile che permetta di costruire un ponte sull’abisso sottostante. Ecco, quindi, delinearsi le componenti necessarie al suo scrivere storico-metaforico, sostanziato anche dalla sua frequentazione con i lavori del Gruppo 47, particolarmente con l'<<etica della memoria>> di Enzensberger a cui Consolo fa eco con la propria <<metrica della memoria>3:
2 Iosif Brodskil, Dail’esilio, Milano, Adelphi, 1988, p. 54.
3 Per il debito contratto con il Gruppo 47, in particolare con l’Enzesberger di Letteratura come storiografia, cfr. quanto dice Consolo in Fuga dall’Etna, La Sicilia e Milano, la memoria e la storiografia (Roma, Donzelli, 1993), alle pp. 33,48-49.
1) Demistificazione dell’idea ottocentesco-progressista della storia (quella, per capirci, del Manzoni e non solo)4.
2) Necessità di dare voce a chi non l’ha mai potuta avere.
3) Passione e impegno civili ad oltranza che portano a una coincidenza tra vita e scrittura.
4) Uso raffinato e ironico della grande sapienza storica, letteraria e linguistica che riguarda ogni sua scelta di stile e di lingua d’espressione determinandone la plurivocità.5
Consolo – rifacendosi alle parole di Sciascia nel racconto La
sesta giornata – si ascrive a quella schiera di poeti che non capiscono
come <<un testo possa splendere di verità e mancare di poesia>>
e che intendono, invece, scrivere <<parole che vogliono farsi
azione>> 6, rappresentando profondamente la storia e lo spirito del
proprio tempo, partendo sempre da una precisa appartenenza e
specificità storico-geografica perché, come ricorda Maria Attanasio
– poetessa e scrittrice calatina che ha in Sciascia e Consolo due
suoi maestri – ogni narrazione storica è sempre ad alto tasso autobiografico
e non potrebbe essere altrimenti. Come in Sciascia, così in Consolo, parola e azione sono due facce della stessa medaglia.
Scrittura e impegno etico e civile sono indissolubili l’una dall’altro.
E se Sciascia afferma che solo nella storia la sua scrittura del
mondo trova legittimazione e senso, Consolo ha sempre ripetuto:
«Mi interessava il mondo storico sociale, non mi interessavano i
problemi personali o le indagini psicologiche” Mi interessava raccontare
la storia, la Sicilia>>. Detestava, inoltre, come sanno tutti quelli che lo hanno conosciuto, il romanzo giallo (fatta eccezione per i gialli civili di Sciascia ben lontani dal cosiddetto romanzo giallo con tanto di fine risolutiva) e l’autobiografismo (amava ripetere che proprio non si sapeva più che farsene dei troppi Proust di provincia …).
Scrive, quindi, di storia e sulla storia, cercando – non senza valenze
utopistiche – soluzioni non volte a cancellare la storiografia ufficiale. ma tali da affiancarle quella potenziale, mai scritta, mai 4
A questo proposito si veda il saggio di Renato Nisticò, Cochlìas legere. Letteraturae realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo, in «Filologia antica e rnoderna >>, 4, 1992,pp 179.22).
‘ Per gli aspetti linguistico-stilistici e per il concetto di plurivocità, è d’obbligo il lavoro di Cesare Segre, La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, in intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del novecento, Torino, Einaudi, 199i, pp. 71-86.
” Leonardo Sciascia, La sesta giornata, in «Officina>>,7,1956, pp.29L-298, p.297 . 7 Traggo questo concetto dai miei appunti presi durante una conversazione privata con Maria Attanasio. Di Maria Attanasio si veda Struttura-azione di poesia e narrativa nella scrittura di Vincenzo Consolo, in <<Quaderns d’ltalia, 10, 2005, pp. 19-30. tramandata, non riconosciuta, comunque e sempre passata sotto silenzio. Con sfida, nel Sorriso dell’ignoto marinaio (editio princeps 1976) delega nelle appendici i cosiddetti documenti ufficiali mentre costruisce i capitoli del libro su elementi verisimili, che ufficiali non hanno mai potuto essere. La storia, infatti, la scrivono sempre i vincitori mai i vinti, ed è proprio ai vinti – nel suo tentativo di riscattarli dall’immobile fatalismo a cui li aveva condannati Verga ed eternati Tomasi di Lampedusa – che Consolo dà la parola. Scrive di storia con forza e convinzione per cercare di fare breccia sulla crosta di parzialità, falsità, assolutismo di cui è fatta la storiografia ufficiale. Dietro quella crosta costruita sull’illusione del cammino progressivo della storia si nasconde la storia di chi non ha avuto i mezzi e gli strumenti per narrarla dal proprio punto di vista. Con il suo sguardo Consolo vuole andare aldilà di
questa crosta cercando di rintracciare il nostro destino, cercando – forse – al di là di tante pretese certezze – qualcosa che giustifichi laicamente, come ebbe a dire il suo amato Leopardi, la <<nostra vita mortale». A proposito di Leopardi, Consolo in impietrata lava – uno degli ultimi testi da lui pubblicati e che è profondamente autobiografico – ricorda che è la poesia a salvare il poeta: <<E nel deserto della natura e della storia, unica consolazione si trova nell’odorata ginestra”, nella “social catena”, ne “l’onesto e il retto conversar cittadino”, nella “giustizia e nella pietade”>>, ribadendo che l’unica consolazione possibile va cercata <<nella religione della tradizione e della famiglia, nell’attaccamento tenace come quello delI’ ostrica allo scoglio, al paese natio>>. Il che illumina sia le ragioni di Leopardi che quelle di Consolo. Sempre nello stesso saggio, a proposito di Verga – che deluso, a Milano, a partire dal 1874 scrive sulla Sicilia in una maniera fino a quel momento a lui stesso sconosciuta (Consolo parla traslatamente di se stesso, del suo essere diventato scrittore di storia di Sicilia dopo avere lasciato l’isola nativa alla volta della città del Grande Nord dello Sviluppo Economico) – in seguito alla caduta di tutte le illusioni che questo esilio aveva comportato e alla necessità, attraverso la scrittura, di cercare di fare i conti con la storica collettività umana (di cui la Sicilia è emblema) per coglierne, al di là delle macerie di cui è disseminata, alcuni tra i suoi aspetti più vividi: Vincenzo Consolo, Impietrata luna, la matrigna natura in Leopardi e Verga, in «RISL», ed. Insula, 6. 20i0, pp.253A: p.28.
«Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove. Una voglia, una smania che non mi lascia stare fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca.>>
Queste parole, tratte dal racconto Comiso dalle Pietre di Pantalica, sono una dichiarazione di poetica. Rivelano il fondamento lacerante delia sua impostazione ontologica e letteraria: la memoria dall’esilio, l’evocazione da lontano della Sicilia. La vocazione di Consolo è precoce, dettata sia dalla posizione geografica (Sant’Agata di Militello sul versante tirrenico della Sicilia), sia dalla dichiarata volontà di schivare ogni mediterraneità, scegliendo subito l’impegno l’indagine della realtà, avevano fatto
Levi, Silone, soprattutto Vittorini e Sciascia. Dopo l’università Cattolica, Milano divenne la mia città.10
Emblematico di quanto appena detto è il brano finale del racconto La casa di lcaro:
E ora che sei migrato per sempre, caro Uccello, io rispondo a quella tua richiesta di fare tutto il possibile… E il possibile è questo, di ricordarti, dagli spazi chiusi di questa nostra frigida vita, con affetto e con rimpianto, dolce e feroce, cantore e predatore di memorie, di reliquie d’un mondo trapassato di fatica e dolore, vero, umano, per iI quale non nutrivi nostalgia, ma desiderio, apparenza di riscatto.11.
Il primo libro, La ferita dell’aprile (1963), rispecchia quegli anni di impegno, giustifica la propensione verso la storia che è stata decisiva per la sua vita letteraria. E con il romanzo del 1976, Il sorriso dell’ignoto marinaio – con cui si apre la Trilogia – che il quarantatreenne scrittore fa affiorare sua critica corrosiva e irridente alla storia ufficiale proponendone una possibile alternativa: quella di una lettura polifonica dei fatti e degli eventi che accolga anche la voce di coloro a cui è sempre stato negato averne una. La sua storia è sempre stata quella degli esclusi, dei reietti. Quella, in termini gramsciani, dei subalterni. Non quella silenziosa e ras-
Vincenzo Consolo, incipit di Comiso, in Le pietre di Pantalica f 19BBl, Milano, Mondadori, 2001, pp. ll5-181, p, 175.ro Citazione dall’articolo di Alessandra Bonaccorsi, Vincenzo Consolo: un intellettuale immerso nella Storia, nella rivista on line «Sicilia&Donna>>, wvw,siciliaedonna.it, 29 gennaio 2012. 1r La casa di lcaro, in Le pietre di Pantalica, cit., pp. 119-127: p. 127 .
segnata dei protagonisti gattopardeschi, né quella trionfante dei vincitori, dei nobili, dei mafiosi: quella di Vincenzo Consolo è una storia ” altra” – di sofferenti e di sofferenze – contro la Storia di sempre, quella che viene ripetuta da “baroni, proprietari e allitterati con ognuno che viene qua a comandare, per avere grazia e giovamenti e soprattutto per fottere i villani” 12.
Il Sorriso è il risultato di una speranza storica, della fiducia ancora riposta nella lotta di classe quale unico possibile strumento valido per cambiare il corso della Storia. Dopo il Sorriso si assiste progressivamente ad una metamorfosi, un cambio – in Consolo – che si manifesta attraverso il rintuzzamento di quella fiducia e di quel sorriso in Nottetempo, casa per casa (1992), fino al loro desolato spegnersi nell’afasia terminale dello Spasimo (1998). Nel Sorriso, Consolo si dedica alla non facile impresa di rappresentare il drammatico dilemma espresso da Marx nella Sacra famiglia: La classe possidente e la classe del proletariato rappresentano la stessa auto-estraneazione umana. Ma la prima classe si sente completamente a suo agio in questa auto-estraneazione, sa che essa costituisce la sua propria potenza ed ha in essa la parvenza di un’esistenza umana; la seconda, in tale estraneazione, si sente invece annientata, vede in essa la sua impotenza e comprende in essa la realtà di una – la sua – esistenza non umana. Per usare un’espressione di Hegel, essa è, nell’ abiezione, la ribellione contro questa abiezione, ribellione a cui essa è necessariamente spinta dalla contraddizione tra la sua natura umana con la situazione della sua vita, che è la negazione aperta, decisa, assoluta di questa natura. 13
C’è una pagina, all’ inizio del capitolo sesto del Sorriso – Lettera di Enrico Pirajno all’avvocato Giovanni Interdonato come preambolo a la memoria sui fatti d’ Alcara Li Fusi – che a questo proposito
mi pare esemplare. Ricordo velocemente (giusto per contestualizzare
pagina prescelta) che il romanzo – il cui ordito storico è costituito dalle vicende siciliane negli ultimi anni del dominio
borbonico e, in particolare, dai tentativi di rivoluzione liberale e dalle rivolte contadine susseguitesi fino a poco dopo lo sbarco di
12 A. Bonaccorsi, Vincenzo Consolo: un intellettuale immerso nella Storia, cit. La Bonaccorsi a sua volta cita un passo di Consolo dalle Pietre di Pantalica.13 Friedrich Engels – Karl Marx, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik.Gergen Bruno Bauer and Corsorten [1845], La Sacra famiglia ovvero Critica della critica critica. Contro Bruno Bauer e soci, traduzione e cura di Aldo Zanardo, Roma, Editori Riuniti,1967, p.97..
Garibaldi – culmina nella rivolta di Alcàra Li Fusi contro i feudatari
del luogo nel maggio 1860. Vi assiste casualmente il protagonista
del libro, il nobile Enrico Pirajno barone di Mandralisca – personaggio storico realmente esistito (1809- 1864) a cui si deve Il Museo Mandralisca di Cefalù, dove è conservato il Ritratto di Ignoto di Antonello da Messina a cui rimanda il titolo del romanzo di Consolo – erudito, archeologo, numismatico e famoso naturalista appassionato di malacologia nonché collezionista d’arte. deputato alla Camera dei Comuni nel 1848 e, dopo l’Unità, nel Primo
Parlamento del Regno d’Italia. Uomo di idee liberali ma lontano
fino a quel momento dall’’azione politica, non può esimersi, date le circostanze di cui è stato testimone, da due decisive riflessioni: I) la considerazione che la Storia è <<una scrittura continua di privilegiati>> 14 e che esiste, quindi, una storia dei vincitori e una dei vinti, scritta la prima mai scritta la seconda e II) che in questa drammatica dicotomia, perenne e a prima vista irresolubile, consiste la tragedia della Storia. Nell’atto di stendere una relazione sui fatti appena accaduti, e di stenderla come avrebbe fatto <<uno di quei quei rivoltosi protagonisti moschettati [fucilati] in Patti» 15 o << uno zappatore analfabeta come Peppe Sirna inteso Papa>>16, intuendo e avendo come già chiaramente presente tale versione in irriducibile opposizione a quella fatta di <<arringhe, memorie, scritte su gazzette e libelli che pendono dalla parte contraria agli imputati>> 17, appartenenti alla voce ufficiale della storia, confessa e ammette l’impossibilità dell’impresa:
No, no. Ché per quanto l’ intenzione e il cuore sian disposti, troppi vizi ci nutriamo dentro, magagne, per nascita, cultura e per il censo,18. E di conseguenza questo “scarto di voce e di persona” (ovvero, per dirla con Marx, questo immedesimarsi nella classe del proletariato) gli appare un’azione scorretta, una cosa che non si fa, un’impostura.19
14 II sorriso dell’ ignoto marinaio (1976), Torino, Einaudi. 1999, p. 97. 15 15Ibid.
16 ibid.
17 ibid
18 ibid.
19 Ugo Dotti, Storia e memoria: Vincenzo Consolo,,<Marxismo oggi>>, sul sito on line www.marxismoggi.it, pp. 1-8, p. 1.
Ed allora, nella sua lettera all’avvocato <<illuminato>> Giovanni Interdonato (altra figura storica del romanzo, nominato nel 1865
Senatore del Regno d’Italia) che fa da preambolo alla memoria su
fatti di Alcàra Li Fusi, scrive:
Ed è impostura mai sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro e passion di casta. Osserverete: ci son le istruzioni. Le dichiarazioni agli atti le testimonianze.,. E bene: chi verga quelle scritte, chi piega quelle voci e le raggela dentro i codici. le leggi della lingua? Uno scriba, un trascrittore, un cancelliere, Quando [invece] un immaginario meccanico istrumento tornerebbe al caso, che fermasse què discorsi al naturale, siccome il dagherrotipo fissa di noi le sembianze. Se pure, siffatta operazione sarebbe ancora ingiusta. Poi che noi non possediam la chiave, il cifrario atto a’ interpretare que’ discorsi. E cade acconcio in questo luogo riferire com’io ebbi la ventura di sentire un carcerato, al castello dei Granza Maniforti, nel paese di Sant’Agata, dire le ragioni nella parlata sua sanfratellana, lingua bellissima, romanza, o mediolatina, rimasta intatta per un millennio sano, incomprensibile a me, a tutti, comecché dotati d’un moderno codice volgare. S’aggiunga ch’oltre alla lingua, teniamo noi la chiave, il cifrario dell’essere, del sentire e risentire di tutta questa gente? Teniamo per sicuro il nostro codice, del nostro modo d’essere e parlare ch’abbiamo eletto a imperio a tutti quanti: il codice del dritto di proprietà e di possesso, il codice politico dell’acclamata libertà e unità d’Italia, il codice dell’eroismo come quello del condottiero Garibaldi [.,.], il codice della poesia e della scienza, il codice della giustizia o quello d’un utopia sublime e lontanissima .,. E dunque noi diciamo, Rivoluzione, diciam Libertà, Egualità, Democrazia, riempiamo d’esse fogli, gazzette, libri. lapidi, pandette, costituzioni, noi, che que’ valori abbiamo già conquisi e posseduti [.,.] E gli altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione, questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle parole modo nostro? 20 La ricerca di una possibile veridicità dei fatti storici da parte di coloro che hanno potere di scrittura viene meno. E allora? Che resta da fare? Ben lontano dalla fatalistica accettazione dello status quo in cui sono condannati a mal convivere per sempre i <<galantuomini> e la <<povera gente>> che popolano 1a novella Libertà di Verga – relativa alla feroce rivolta di Bronte e a1la ancor più violenta repressione di Nino Bixio il 4 agosto 1860 -, Consolo è altamente conscio della natura umana delle due classi antagoniste. In lui, con Dotti. sono evidenti sia il riconoscimento di quanto sia stata giusta la cruda ribellione contadina, ma anche l’inattesa affermazione che la classe dei possidenti, mancando dei necessari “codici” interpretativi, 20 Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit. pp. 97 -98. dovrebbe comunque astenersi dal giudicare un evento che ha in realtà appalesato l’ignominia umana della storia stessa. 21 E qui soccorre la proposta, dal sapore utopistico, di Consolo espressa, in quegli anni ancora soffusi di speranza, attraverso il
suo barone di un secolo prima con un attacco di frase, che echeggia
il <<“Verrà un giorno.,. “>> che Padre Cristoforo rivolge a Don Rodrigo nel VI capitolo dei Promessi sposi.:22 Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno interamente riempiti dalle cose. 23 Si vagheggia di un futuro in cui il linguaggio, invece di essere l’ornamento retorico di una violenta ipocrisia storica, riconquisti urla precisa adesione al senso concreto delle cose e possa dare corpo alle voci fino ad allora silenziate e mute, rese abili finalmente a svelare l’autentico senso delia storia, con le sue infamie morali, politiche ed economiche. Una certa qualche speranza nel futuro,
che poi sparirà dall’ opera di Consolo, si rintraccia nel fatto che quell’auspicato cambiamento trovi uno spiraglio per riproporsi non più nell’Occidente (dove la fiducia nella lotta di classe è spenta. divenuta fredda cenere), bensì in un più profondo e vitale Sud del mondo. C’è un racconto del 1985, raccolto ora in La mia isola è Las Vegas col titolo Porta Venezia, in cui Consolo parla del luogo da lui più amato a Milano, la zona, multietnica di Porta Venezia, dove a proposito della cospicua popolazione africana e asiatica che ci vive, leggiamo nell’incipit: <<“Incidono lo spazio” mi dicevo.
“Sono una perentoria affermazione dell’esistenza”>>. E ancora, poco più avanti nel testo:
Erano, i marciapiedi di corso Buenos Aires, in questo tardo pomeriggio di
sabato, tutta un’ondata di mediterraneità, di meridionalità, dentro cui m’immergevo e crogiolavo, con una sensazione di distensione. di riconciliazione. Io che non non sono nato in questa nordica metropoli, io trapiantato qui, come tanti, da un Sud dove la storia s’è conclusa, o come questi africani, da una terra d’esistenza (o negazione d’esistenza) dove la storia è appena o non è ancora cominciata; io che
21 Ugo dotti, Storia e memoria: Vincenzo Consolo, cit., p.2. 22 Alessandro Manzoni, I promessi sposi [1840-1842], Milano, Garzanti,l9B3,p.75. 23 Il sorriso dell’ignoto marinaio cit., p. 98.
24 Vincenzo Consolo, Porta Venezia, ora in mia isola è Las Vegas, (postumo) voluto da Consolo e a cura di Nicolò Messina, Milano, Mondadori, 2012,pp,111-116, Il racconto era uscito per la prima volta nel luglio 1985 ne<Il moderno» col titolo una sera mediterranea
sono di tante razze e che non appartengo a nessuna razza, frutto dell’estenuazione bizantina, del dissolvimento ebraico, della ritrattazione araba, del seppellimento etiope, io, da una svariata commistione nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie. Mi crogiolavo e distendevo dento questa umanità come sulla spiaggia al primo, tiepido sole del mattino 25.
Nel 1985 la speranza riguardo alla Storia trapelava ancora. Non a caso, sempre nel 1985, Consolo può scrivere quel cunto di settecentesca ironia che è Lunaria che, insieme a Retablo (1987), costituisce un intermezzo, un momento di pausa e di riflessione riguardante (sempre da leggersi in chiave di metafora) il secolo dei lumi, con le sue contraddizioni, la sua guerra tra buio e ragione, seguendo i protagonisti nel loro progressivo rendersi conto dei perché del proprio vivere e del mondo, alla luce di una ragione difficilmente conquistata, se e quando conquistabile. E questo costituisce l’impegno di tutti i personaggi degli scritti di Consolo e, con loro, del loro autore che in essi rivive e tramite essi cerca di dare espressione all’uomo che si sforza di annientare la propria componente animalesca per diventare umano. Messaggio questo ben esemplificato nel titolo di un libro, tra i suoi più belli, che è L ‘olivo e l’olivastro (1994): l’umano e il bestiale, il coltivato e il selvatico: dicotomia di omerica, ulissica memoria. Con il passare del tempo e con quel che accade nell’oggi dello scrittore, sensibilissimo a rilevare i cambiamenti e i sismi della società (gli anni Novanta vedono la cancellazione di un’intera generazione politica, Tangentopoli, l’inchiesta Mani pulite, l’ascesa politica di Berlusconi e della Lega Nord in un ritorno al fascismo più becero), speranza e fiducia vacillano e cominciano a venir meno, soppiantate da rabbia, sdegno, impotenza senza scampo tranne – forse e sempre più in bilico – quello estetico da affidare nonostante tutto e contro qualsiasi tentazione di afasia e silenzio, alla scrittura. La Trilogia è come un’appassionata partitura in cui i tre movimenti – adagio, sostenuto, grave – sono ben distinti e si susseguono in un crescendo vorticoso (come l’immagine della chiocciola cara a Consolo) che svela, con sempre più sdegnato dolore, gli inganni, le crudezze, le insensatezze della storia: dalla
cosiddetta Unità nel Sorriso nel 1976 (in realtà miope piemontizzazione della penisola), alle sopraffazioni e angherie del fascismo in Nottetempo (1992), ai crimini di uno Stato connivente con la Mafia nello Spasimo (1998)”
25 lvi, pp. 112-113.
Il 1992 è l’anno di Nottetempo. In questo romanzo Consolo, come suo solito, parla dell’oggi raccontando dell’ieri. Qui si tratta di un momento clou della storia siciliana e italiana nei primi anni Venti, quelli che hanno segnato l’avvento del fascismo e la notte della ragione. In un romanzo corale, attraverso l’evocazione di tanti destini individuali, lo scrittore coglie un’intera civiltà ormai sull’orlo dell’abisso, In questo libro Consolo tenta di realizzare quell’arduo proposito a cui accennavo poco fa dell’uomo che lotta per fare prevalere la sua umanità sull’animalità. Qualcuno ha suggerito che Nottetempo è un <<poema diviso in dodici canti>. In questi dodici canti il narratore svolge il tema di un uomo, Petro Marano che, atrocemente colpito da un’ignota offesa, si sforza facendo conto solo su se stesso per sottrarsi alla propria sventura, alla sua continua pena: la follia animalesca del padre (<<luponario>>, licantropo), la disgrazia mentale della sorella, la confusione babelica che corrompe anche il linguaggio e che <<stracangiava le parole, il senso loro 26>> onde <<il pane si faceva pena, la pasta peste, il miele fiele, la pace pece, il senno sonno…>>27. Il tutto ad
echeggiare i tempi (passati e presenti) di perdita della ragione, buio dell’ignoranza, irrazionalità (v. il personaggio modellato su quello storico di Aleister Crorvley (1875 -1947), mago profeta e satanista di origine britannica), sopraffazioni, crimini e misfatti” Nel libro si cerca, con fatica e allentata speranza, di fare leva sulla ragione per vincere quello che ragione non è, quella <<bestia dentro l’uomo che si scatena e insorge, trascina nel marasma. La bestia trionfante di quel tremendo tempo, della storia, che partorisce orrori, sofferenze>>28. Alla fine del libro Consolo, con scoperta autoreferenzialità, riprende lo speranzoso proposito del Sorriso (quello veicolato dalla frase <<verrà un giorno in cui i nomi saranno riempiti dalle cose>>) e ne affida la (potenziale) realizzazione al disgraziato protagonista del libro che nella chiusa si smarca dalla nefasta influenza dell’’anarchia violenta e idealista di Paolo Schicchi, fugge in Tunisia, e cerca ragione nella scrittura: ultimo stadio prima dell’afasia e del silenzio. Ecco le parole conclusive di Nottetempo: Cominciava il giorno, il primo per Petro in Tunisia. Si rinnovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che
26 Nottetempo casa per cassa (1992), Milano, Mondadori,2000, p, 140,
27 Ibid. 23 Nottetempo casa per casa, cit., p. 170.
ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore.29 Pietro Marano, qui esplicitamente chiamato a ‘riempire i nomi con cose nuove’, porta a compimento la prima parte del suo compito (quella precedente la scrittura) nel momento in cui arriva a comprendere che l’unica salvezza possibile risiede nella fuga. Una fuga che è anche resurrezione: emigrazione a Tunisi, come un qualsiasi emigrante alla ricerca di <<lavoro, casa, di rispetto>>30. Ed è rispetto la parola chiave. Rispetto per se stesso, per gli altri, per gli uomini di senno che superano il sonno a cui i più sono costretti. Il risvegliarsi dal quel sonno non è stato facile, non allietato da nessun enfatico ‘sol dell’avvenire’. Il risveglio coincide con il distacco necessario autobiograficamente a chi scrive (a Dante in esilio, a Verga e Consolo a Milano) – avvenuto nottetempo, casa per casa – da un passato dolorosamente ma consapevolmente respinto, da una memoria a cui si dovrà tornare un giorno (con la scrittura) per calcolarne il peso e coglierne il significato. La speranza in una possibile polifonia della storia e sulla storia, vaga nel Sorriso, assai attenuata in Nottetempo, è fugata nello Spasimo (1998). Il libro è stato scritto in seguito all’offensiva della Mafia contro lo Stato culminata nelle stragi che videro nel 1992 la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (alla cui esecuzione il narratore fa menzione alla fine del libro). Si tratta del testo più sofferto della Trilogia, e non a caso. È infatti quello che tratta di fatti contemporanei all’autore, ragione per cui gli viene a mancare a mancare – data la gravità dell’argomento trattato – il distacco. È il meno lineare dei libri di Consolo nell’ossessivo affollarsi di passato e presente, nella contrapposizione di storia e memoria, nel vano bisogno di conforto che il ricordo potrebbe offrire e che suscita, invece, un bruciante sentimento di patimento, di sofferenza, di spasimo appunto. Il sostantivo del titolo (oltre al dipinto di Raffaello e alla chiesa eponima palermitana a cui si riferisce), è allusivo allo strazio che da Palermo e dalia Sicilia si allarga e investe il mondo intero. Consolo fa scorrere il suo sguardo sempre più ferito e indifeso sulla società attuale in cui, sotto mentite e apparentemente benevole spoglie, domina sempre, e non solo subliminalmente, la violenza fascista avvallata dalla follia del libero mercato del capitalismo più selvaggio, che ha inondato il mondo con la sua spietata corruzione. Dopo la guerra, l’Italia del dopo-
2e Ivi, p. 171.3 lvi, p. 170.
guerra, quella del futuro… Ma, si chiede il narratore, cosa hanno fatto di effettivo le due generazioni che si sono succedute dal secondo dopoguerra? Quella del padre (protagonista del libro, scrittore) Gioacchino Martinez e quella del figlio Mauro? La prima s’è rinchiusa nell’inerte escapismo dell'<azzardo letterario>>31; la seconda mossa da quella che riteneva una «lucida ragione32>> si è data all’inconcludente violenza della lotta armata e del terrorismo. Ma è così che si costruisce una <<nuova società, una civile,
giusta convivenza>>33? Questa amara confessione, sottesa a tutte le ingarbugliate pagine del racconto, emerge finalmente nel capitolo conclusivo. Ma in quell’ultimo, XI capitolo, la catartica confessione
scritta del protagonista e indirizzata all’estraniato figlio, proprio quando sembra lasciare trapelare che, nonostante tutto e tutti, il lume della ragione possa forse ancora riaccendersi e mandare qualche favilla, viene bruscamente interrotta da una telefonata allarmata che impone al protagonista di scappare e, di lì a poco, esplode sotto casa sua la bomba che distrugge la vita del giudice (senza nome ma è Borsellino) e della sua scorta.
Se la lettera, in quanto scrittura, era ancora a sole poche righe dalla chiusa del libro l’unico salvagente possibile rimasto per aggrapparvicisi e cercare di non affogare, dopo l’esplosione rimane solo il silenzio. Storia e memoria sono morte. E con esse muoiono parola e scrittura e, quindi anche l’un tempo vagheggiata altra possibilità polifonica di scrivere la storia. Restano il silenzio e una cantilena popolare muta, un rituale senza più speranza che irride forse apotropaicamente, qualsiasi salvezza, dovuta alla ragione e all’umanità. Su queste ha prevalso l’animalità, l’olivastro ha estirpato l’olivo:
Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono. Implorò muto. O gran mano di Diu, ca tantu pisi, cala, manu di Diu, fatti palisi! 34
Dopo due millenni di civiltà <<post Cristum natum i popolani si vedono ancora costretti a invocare l’appalesarsi della giustizia divina>>35: più sconsolata e sconsolante di così questa fine non poteva essere.
31 Lo Spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, 1998, p.126.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Lo Spasimo di Palermo cit., p, 131
35 Ugo Dotti, Storia e memoria; Vincenzo Consolo, cit., p. 4,
La data di pubblicazione del libro, 1998, la dice lunga sull’atmosfera che si respirava in Italia se anche un giornalista-scrittore – lontano letterariamente da Consolo ma a lui vicino in quanto a impegno civile – come Enrico Deaglio, nel 1992, in uno dei suoi racconti quasi veri ambientato in Sicilia, Il figlio della professoressa Colomba, descrive il progressivo eclissarsi della forza innovativa che un suo personaggio eccentrico e solitario, l’anglo-americano Michael Stetson Morse, aveva deciso di devolvere al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione del paese siculo scelto come sua patria adottiva. Ecco cosa gli fa dire il narratore ricorrendo, come farà anche Consolo alla fine dello Spasimo, all’espediente della lettera, indirizzata al fratello Richard e che sarà letta pubblicamente, senza essere ascoltata dai presenti, al proprio funerale dopo essere stato assassinato dalla Mafia:
[.,.] Come ben sai, la mia opera qui si è trasformata in un grande fallimento; ho tentato di promuovere un’istruzione e un’assistenza sanitaria moderna, ma mi sono dovuto arrendere; ancora adesso non riesco a capire perché: ci deve essere qualcosa di importante in questo posto che mi sfugge, perché ancora adesso sono convinto che basterebbe poco per trasformarlo in un paradiso. [.,.l Quando arrivai qui, deciso a starci fino alla fine della mia vita, ebbi un colloquio con il prete. [.,.] Mi ammonì che il Male, qui al sud. è talmente straripante e ostinato che pervade tutto e che uno come me non l’avrebbe mai potuto capire. [.,.] Qui ho visto tanta violenza, quotidiana, dura. Sono quindi stato spinto à indignarmi. Ma, con il passare degli anni e con il progressivo esaurimento dei miei tentativi, ho imparato a controllare la mia indignazione, cercando di concentrarla sugli aspetti più importanti, per scaricare su un punto solo la massima energia. Ma il solo risultato è che anch’io ho smesso di indignarmi. [.,.] Per questo, caro Richard, mi dedico ora alle piccole cose. Conchiglie, pesci, fossili. La spiaggia qui, dove mi reco ogni mattina, è sabbiosa e lunga tre miglia. [.,.] E’ un paesaggio spettacolare, credimi. […] il luogo è intatto e deserto, ma sui giornali ho ietto [.,.] che proprio qui è in progetto un grande insediamento turistico, con alberghi e un piccolo aeroporto. Se qualcuno riuscisse a impedirlo! Se se ne potesse parlare sui giornali! Ti allego un po’ di documentazione che ho raccolto”. Questo brano è intriso dei tristi loci communes di cui traboccano, da sempre ormai, le vicende giudiziarie italiane circa il potere mafioso: speculazione edilizia, appalti truccati, corruzione, spietato controllo e abuso del territorio, eliminazione fisica e vituperante del nemico. Colpisce, ed è per questo che l’ho riportato, che Deaglio faccia compiere al suo personaggio un percorso inverso a quello riservato da Consolo al protagonista del sorriso: dall’impegno alla collezione di conchiglie.
16 Enrico Deaglio, Il figlio della professoressa Colomba [1992], Palermo, Sellerio, 1996,pp. 105-108.
Nessuna speranza, per nessun autore italiano impegnato, esiste più negli anni Novanta subito prima e dopo la morte, nel1992, dr Falcone e Borsellino e delle loro scorte. Caterina, giovane eroina fuggita dalla Sicilia. parlando a Roma Dei loro paese natio al cugino Gerlando, che si appresta a divenire killer d’ultima generazione al fine di eliminare i colleghi di vecchia generazione, gli dice: La cosa tremenda è che non sarebbe finita mai. E così, improvvisamente. mi è sembrata la nostra Rocca di Loto. Un inferno perché tutti fanno sempre le stesse cose, dicono le stesse frasi. E si proteggono, l’un l’altro, perché questo inferno continui, perché non cambi mai, perché nessuno dall’esterno venga a turbarlo. Anche ora, che tutti si ammazzano .,. Sì, si ammazzano per qualche interesse. però non per cambiare qualcosa, ma per continuare ad essere così come sono sempre stati.37 Con una manovra paradossale, ma realistica, nel suo libro – che tratta di una generazione siciliana che, persino nel ribellismo giovanile, non ha alternative all’uso dei metodi mafiosi -, Deaglio annoda il fatalismo di Verga e di Tomasi di Lampedusa con la desolazione a cui per la sua strada è giunto Consolo, emblematizzandolo in un paese siciliano dove la modernizzazione passa stravolgendo tutto e non cambiando nulla. Nel 2002, in Catarsi, Consolo scrive parole che tornano retroattivamente all’explicit dello Spasimo e le affida ad Empedocle: Se le parole si fanno prive di verità, di dignità e di storia, prive di fuoco e di suono, se ci manca il contorto loro, non c’è che l’afasia. Non c’è che il buio della mente, la notte della vita 38 ,.. Avviandomi a concludere, mi pare si possa cogliere, nell’ultimo Consolo, un’ulteriore passo. Dalla dissoluzione di qualsiasi speranza storica sancita dallo Spasimo – che mette la parola fine al suo dialogo illuminato e razionale sulla Storia intrapreso anche sulla scia di Sciascia e con Sciascia -, all’abbracciare sempre più sfiduciato le ragioni di un male di vivere più universale, cosmico, a forte reminiscenza leopardiana e pirandelliana, meno storico (quantomeno non solo storico) che, però, lascia spazio al recupero
37 Ivi, pp. 95-96.
38 Vincenzo Consolo, Catarsi, in Oratorio, San Cesarino di Lecce, Manni,2002,p.25.
Dell’ importanza, malgrado tutto, dell’azione individuale affidata alla parola <<“scritta e pronunciata”>> 39. Sempre nel Prologo della sua opera teatrale tragica Catarsi (in cui, ricordo, è messo in scena il suicidio sull’Etna di un moderno Empedocle di Agrigento), Consolo, dice che la <<tragedia è la meno convenzionale, / la meno compromessa delle arti 40>> e che «[a]l di là è la musica. E al di là è il silenzio>>41. E, altrove – ne La Metrica della memoria 42, riflessione critica sulla sua stessa scrittura – ricorda di avere voluto scrivere questi versi incipitari di Catarsi Perché la tragedia, in forma teatrale o narrativa, in versi o in prosa, rappresenta l’esito ultimo di quella che posso chiamare la mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Espressione, in Catarsi, in forma teatrale o poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite della pronunciabilità, tenda al suono, al silenzio.43 E questo si rinserra con la chiusa sul silenzio già esperita e sofferta dal narratore dello Spasimo (1998): generi diversi, esiti analoghi. Col silenzio Consolo si era già scontrato nel suo libro del 1994 L’olivo e I’ olivastro, il cui incipit non a caso recita: <<Ora non può Narrate 44>> e in cui vengono negate la finzione letteraria e l’invenzione del racconto” E, a proposito dell’Olivo e l’olivastro, ne La metrica della memoria, Consolo allude al narratore, all’ ànghelos che vede interrotto il dialogo con i suoi destinatari, scomparso lo <<spirito socratico>> 45, perché ormai la cavea è vuota, deserta. Sulla scena è rimasto solo il coro che in tono alto, Lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi 46.
39 Vincenzo Consolo, citazione da Affabulazione di Pier Paolo Pasolini, nel Prologo di Catarsi, cit., p. 13.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Vincenzo Consolo, Per una metrica della memoria, ora la La parola scritta e pronunciata.
Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, prefazione di Giulio Ferroni, San Cesario di Lecce, Manni,2006, (con un CD con la lettura di Consolo di brani tratti da varie sue opere), pp. 177 -189. Per la storia esterna del saggio di Consolo si rimanda alla mia nota con asterisco a fine dell’appena nominato libro, p. 188.
43 lvi, p. 178.
44 Vincenzo Consolo, L’olivo e l’olivastro 1994), Milano, Mondadori, 2000, p. 9.
45 Vincenzo, Consolo, Per una metrica della memoria, cit., p. 187.
46 Ibid.
Sempre più netto è il passaggio operato da Consolo, fin dai suoi esordi letterari, da scrittura della comunicazione a scrittura dell’espressione. L’unica, ormai, secondo lui, in cui possa scriversi un romanzo: Nelle mie narrazioni c’è sempre l’interruzione del racconto e il cambio della scrittura, il suo alzarci di tono, svolgersi in forma ritmica, lirico-poetica.47 Se l’atteggiamento nei confronti di parola e silenzio è andato peggiorando – culminando nella disperata chiusa dello Spasimo, che è un romanzo, nell’ultimo Consolo riemerge la speranza nella catarsi, nel potere consolatorio della parola, ma in un genere letterario diverso, quello teatrale di greca memoria con tanto di anghelos e coro. Eccolo, quindi, in Catarsi, affidare la deuteragonista di Empedocle, Pausania, la rivendicazione del ruolo del narratore: Io sono l’anghelos, il messaggero necessario, colui che narra, che riferisce in tono basso la tragedia. che dice l’indicibile, che rappresenta l’irrappresentabile. Io sono il coro, l’eco sonora del crudo, del muto evento, colui che piange, si lamenta in geometrica cadenza, come vuole il rito, Poiché solo nel rito, come quello teatrale, nelle frasi. nelle movenze stabilite è possibile dire del dolore, della colpa, è possibile che avvenga la catarsi.48 E, ancora, restituisce alla parola la sua funzione super partes et super omnes et omnia, oltre la Storia. È Empedocle a parlare: Chi è presso alla morte si fa profeta. Io vi dico: la sua poesia eretica, blasfema, com’è la poesia vera, in questo tempo uniforme e tondo come una sfera spenta, la sua esplosione, la sua voce di vento e acqua, di terra e fuoco, valicherà me, voi, la storia, dopo millenni illuminerà la terra come la luce d’una remota stella. Ultimo ma non meno importante, Consolo, oltre all’impegno letterario, ha da sempre portato avanti, con coerenza e coraggio quello dell’impegno giornalistico (tra i pochi in Italia, in un passato recente, a schierarsi pubblicamente contro l’ex governatore della regione Sicilia Totò Cuffaro, che ha passato anni in galera per associazione mafiosa) ” La sua ultima accorata difesa della forma teatrale tragica, lo porta a realizzare un testo composito e inatteso: l’atto unico intitolato Pio La Torre, orgoglio di Sicilia (2009), scritto su incarico del Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, col pre-
47 Ivi, p, 187.
48 Catarsi, cit., p. 43.
49 lvi, p. 39.
ciso intento di destinarlo alle scuole. Il testo composito, dicevo, è a cavallo tra storiografia e teatro. Infatti, è in parte un obiettivo resoconto storico di alcuni dei fatti più significativi della storia siciliana a partire dal secondo dopoguerra (dalla lotta contro il feudo all’ industrializzazione, al boom economico, attraversando le successive fasi della migrazione dei siciliani e dei meridionali e il continuo conflitto con la Mafia, strumento di potere connivente con lo Stato). I resoconti storici sono affidati a tre voci narranti che offrono mirabilmente <<una drammatica sintesi della vita politica e sociale dell’Italia dal primo dopoguerra>>, come recita la nota introduttiva vergata da Vito Lo Monaco. Ma è anche un dialogo mimetico tra i personaggi coinvolti da cui emerge – con discrezione e grande efficacia – il loro vissuto, il loro credo, i loro valori pagati con il prezzo delle loro stesse vite. La storia del grande sindacalista comunista, successore del precedentemente assassinato Placido Rizzotto, che sarà assassinato a sua volta dalla Mafia insieme al suo amico-autista Rosario Di Salvo il 10 aprile 1982, si profila sullo sfondo della Storia d’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Si ratta di uno scritto in cui Consolo con penna leggera e obiettivamente implacabile delinea, e fa rivivere, il travaglio e l’evoluzione del nostro Paese verso la modernità. Credo che un testo come questo, sia la fertile eredità lasciata da Consolo ai più giovani: un modello di scrittura della Storia – obiettivo, espresso con lingua e stile efficacemente comunicativi, che tenga conto del punto di vista delle vittime e di chi gli sopravvive. Un linguaggio diretto, lontano da quello dell’’espressione letteraria. Ecco perché questo suo ultimo tentativo di comunicare la storia potrebbe germogliare al contrario di quello letterario. Quest’ultimo è uno stile: individuale, unico ed irripetibile per definizione; l’altro suggerisce un metodo. Gli stili sono, e devono restare, inimitabili; i metodi si imparano e si applicano. Concludo lasciando la parola a Consolo, a futura memoria:
50 Vito Lo Monaco, nota editoriale a Vincenzo Consolo, Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia, Palermo, Centro di Studi ed iniziative Culturali PioLaTorre,2009,pp.4 – 5,p.4.
L’atto unico è stato donato da Vincenzo Consolo al Centro Studi affinché fosse usato come strumento di memoria e di educazione civica.
Io sono stato onorato, al di là di ogni retorica, quando il Centro Pio La Torre mi ha incaricato di scrivere quest’atto unico, destinato alle scuole, [e di essere qui,] oggi, in questa sede così importante qual è il carcere dei Pagliarelli. Ecco io dico che la storia di Pio La Torre è la storia di tanti altri che sono la nobiltà di Sicilia. Io non credo ai signori gattopardi. Mi ha molto irritato da sempre la frase di Lampedusa <<Noi fummo i leoni, i gattopardi e dopo di noi vennero le iene e gli sciacalletti. Questi signori che abitavano nei loro palazzi, questi feudatari, sapevano benissimo chi erano le iene e gli sciacalletti. Erano i gabellotti, i soprastanti. Erano quelli che sfruttavano il lavoro dei braccianti e dei contadini, dove è nata La Mafia, e che poi portavano i profitti nei palazzi dei signori nobili palermitani. Io credo che la vera nobiltà di Sicilia sia, appunto, rappresentata da quei braccianti, da quei contadini, da quei sindacalisti come Pio La Torre. Figura di grande nobiltà è quella di Francesca Serio, la madre di Turiddu Carnevale, di cui ci parla Carlo Levi ne Le parole sono pietre. E si potrebbero fare tantissimi altri nomi, una lista enorme di persone che hanno sacrificato la vita per ii riscatto della loro dignità, per avere riconosciuti i loro diritti. E poi, oltre i braccianti, i contadini, i sindacalisti, sono stati anche i magistrati e le forze dell’ordine ad avere sacrificato la vita per il riscatto di questa nostra terra. Io ho avuto l’onore di conoscere alcuni di questi magistrati. Ho conosciuto Falcone. Ho conosciuto Gian Giacomo Ciacco Montaldo. E pensare alle loro figure… veramente quella è la vera nobiltà di Sicilia: i braccianti. i sindacalisti, i contadini, i magistrati e le forze dell’ordine che hanno pagato con la vita per il riscatto di questa nostra terra.51
51 Trascrizione mia dell’intervento orale tenuto da Vincenzo Consolo in occasione della rappresentazione del suo atto unico Pia La Torre, orgoglio di Sicilia, avvenuta sabato 17 aprile 2010 al teatro della casa circondariale Pagliarelli a Palermo. (v. on line: www.piolatorre.it /video). Mia la responsabilità dell’interpunzione e della paragrafatura.
da Strumenti critici/ a. XXXI, n. 2, maggio – agosto 2016
Questa è una foto del 2007, in occasione della (terza!) venuta in Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, per un incontro aperto al pubblico, dello scrittore Vincenzo Consolo. E la nostra Alunna, Giuliana Adamo, era con lui e Cesare Segre, a presentare la raccolta di saggi, da lei curata per Manni Editori, dedicata allo scrittore.