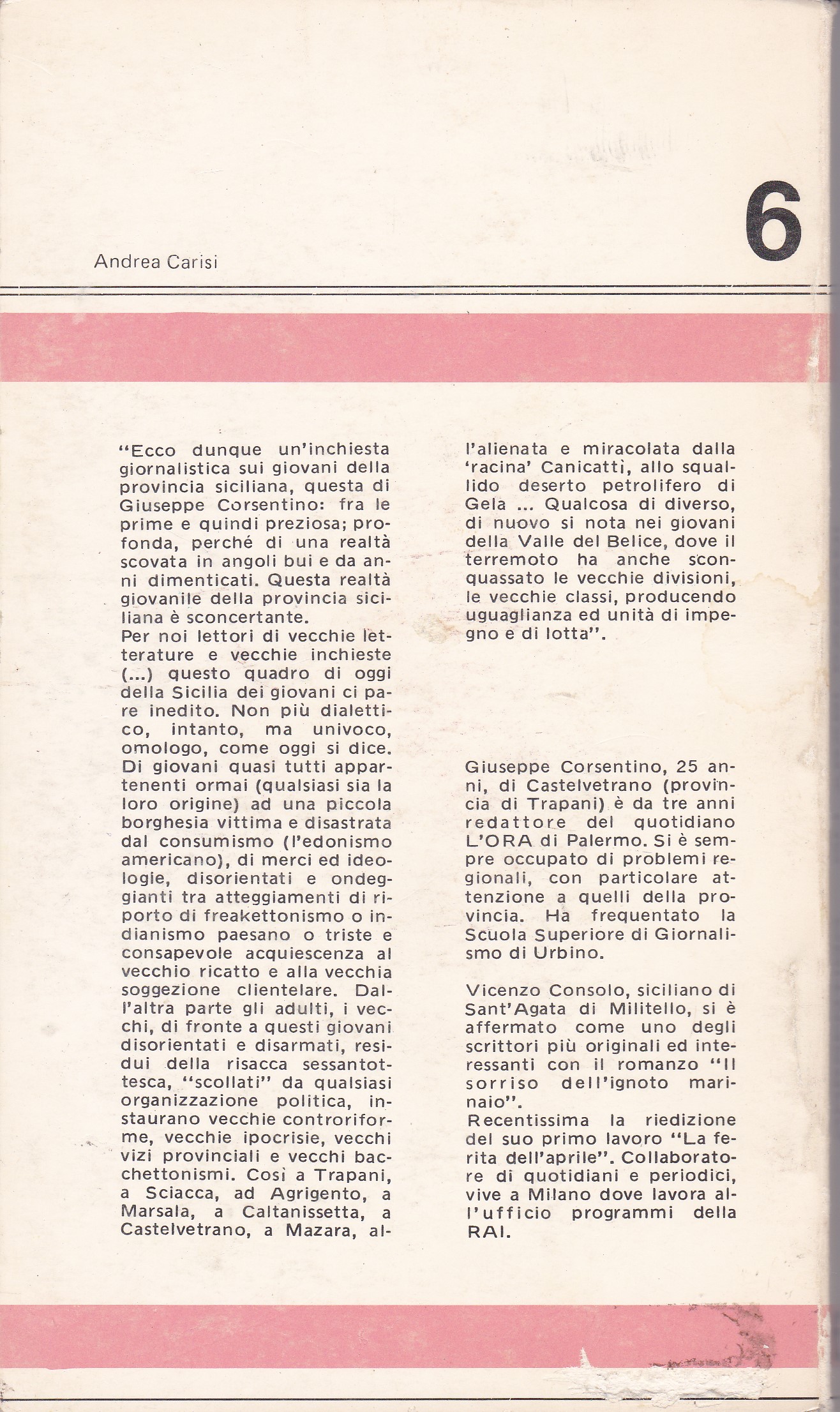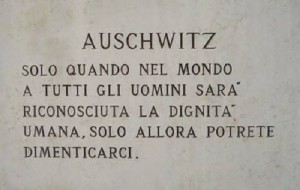Il grande scrittore era curiosissimo di conoscere luoghi feste usanze linguaggi e personaggi della sua terra così amata. Per andarlo a trovare nella sua casa in città, lasciai in un giorno di luglio il mio mare ai piedi dei verdissimi Nébrodi. Poi di corsa in littorina tra stazioncine solitarie nella vallata di un torrente quasi asciutto dal nome enfatico di Fiumetorto.
Nell’isola interna del latifondo e delle zolfare Io, smarrito, fino alla Caltanissetta di Sciascia.
Avevo mandato a Leonardo Sciascia il mio primo racconto. (…) Mi rispose con la civile sollecitudine di cui sono capaci le persone attente e disponibili verso gli altri. Aggiungendo nella lettera questa postilla vergata a mano: «Mi piacerebbe sapere quali sono i luoghi del Suo racconto: per documentarmi su quelle particolarità storico-linguistiche che insorgono nel libro, e che hanno, a mio parere, peculiare carattere». I luoghi del racconto, i luoghi dei racconti: c’era allora, in quei primi anni Sessanta, usciti da molto dalla guerra, ma da poco dalle penurie del dopoguerra, c’era come un bisogno vitale da parte degli scrittori, almeno in Sicilia, di conoscere e riconoscere i luoghi, i paesi, di incontrarsi, di conoscersi (…). E Sciascia era curiosissimo di conoscere luoghi, paesi, feste, usanze, linguaggi, persone, personaggi di quella sua Sicilia tanto amata e per la quale poi negli anni fini per disperarsi. (…) Ma è certo che i luoghi più interessanti del racconto, tracciato fino a quel momento da Le parrocchie di Regalpetra, Gli zii di Sicilia, Il consiglio d’Egitto e Il giorno della civetta, erano quelli di Sciascia, e luogo di attrazione, di convergenza fu allora Caltanissetta, dove a quel tempo lo scrittore abitava (…). Partii un giorno di luglio dal mio paese sul mare ai piedi dei verdissimi Nébrodi. A Termini Imerese, cambiato treno, m’inoltrai in un giallo aspro, desertico paesaggio che abbagliava e smarriva. Era quella la Sicilia interna del latifondo e dello zolfo che gli abitanti della costa settentrionale, al di qua della barriera appenninica, usi ad andare a Palermo, a Messina, a varcare lo Stretto, spesso ignoravano. La littorina correva dentro la vallata di un torrente quasi asciutto dall’enfatico nome di Fiumetorto e si fermava davanti a caselli, a stazioncine solitarie che servivano paesi nascosti dietro gole di monti: Sciara (il paese di Le parole sono pietre di Levi, dell’euripidea madre di Salvatore Carnevale), Montemaggiore, Roccapalumba, Valledolmo, Marianopoli, Xirbi.. .. Toponimi di lirismo vittoriano, ma avrebbe potuto essere, una di esse, la stazione dentro cui viene consumato il duplice omicidio di Una storia semplice, l’ultimo racconto di Sciascia. Perché qui, in questa vastità, in questo vuoto, nella finzione del racconto, nella realtà, si può scoprire la violenza corpo squarciato del picciotto o del giudice inerme, la catena del servaggio, della pena d’una condizione disumana, nei calcheroni, nei tralicci arrugginiti della zolfara morta, la solitudine del bandito, del ribelle braccato nella bocca d’una grotta, il senso di desolazione e di morte nel grumo roccioso d’un crinale sopra cui volteggiano corvi, nel chiarchiaro de Il giorno della civetta o di Occhio di capra: «E il cuoco disse ai suoi piccoli / al chiarchiaro ci rivedremo tutti. Per dire dell’appuntamento che tutti abbiamo con la morte». Caltanissetta (…). A proteggerla (…) era in alto una gran statua del Cristo Redentore. E in via del Redentore era la casa dello scrittore. (.) Il mondo intorno si faceva sempre più ingiusto, violento, bugiardo, perdeva intelligenza, sentimento, umani-tà: si imbarbariva. E con questo dolore di pietra se ne andò al chiarchiaro, alla morte (…)

Tag: Primo Levi
Rosalba Galvagno Ada Bellanova Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo Milano-Udine Mimesis 2021
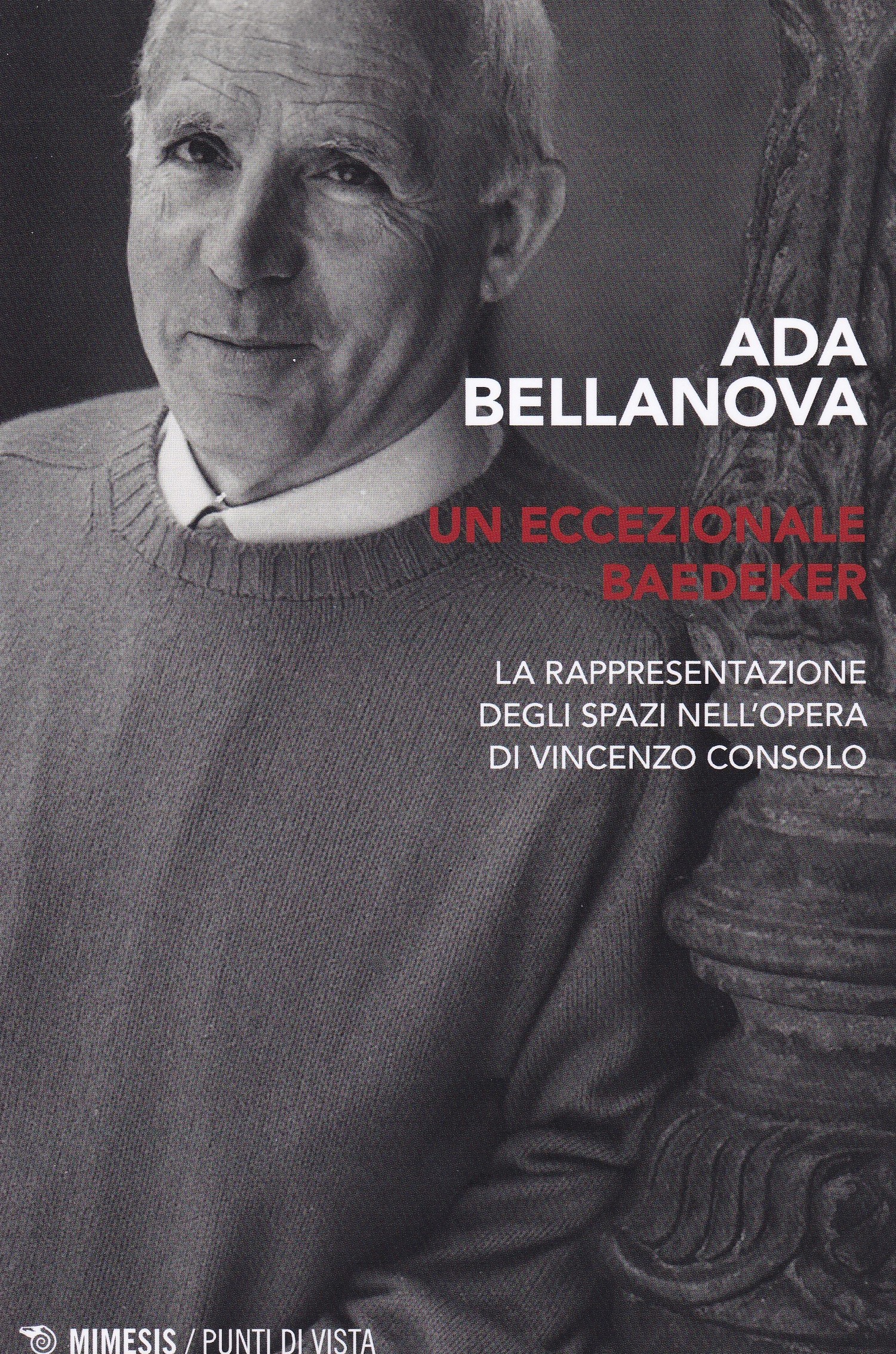
La giovane studiosa Ada Bellanova ha recentemente pubblicato una poderosa monografia su Vincenzo Consolo per i tipi della casa editrice Mimesis nella collana diretta da Gianni Turchetta: Punti di vista. Testi e studi di letteratura italiana contemporanea. (Un eccezionale Baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo, Mimesis/Punti di vista, Milano-Udine 2021). Il volume comprende, oltre all’Introduzione (Un eccezionale Baedeker. Cartografare lo spazio), quattro parti (I. Strumenti per percorrere i luoghi; II. Un percorso tra luoghi simbolo; III Ecologie consoliane; IV Mediterraneo) ciascuna suddivisa a sua volta in un numero diverso di capitoli, nei quali l’autrice distribuisce con grande perizia e intelligenza i testi consoliani presi in esame, da quelli giornalistici (molti non ancora raccolti in volume) e saggistici, a quelli di finzione. Ora, la prospettiva dalla quale la studiosa legge e organizza la testualità consoliana è quella già enunciata nel sottotitolo del suo lavoro: La rappresentazione degli spazi nell’opera di Vincenzo Consolo. Alla prospettiva ‘spaziale’ è dedicata infatti la prima parte del libro, che si può considerare a tutti gli effetti una introduzione teorica e comparata alla sua «perlustrazione» dei luoghi consoliani, che fa il punto sullo spatial turn e il geographical turn, sugli approcci teorici cioè (Braudel, Turchi, Piatti, Westphal, Scaffai, Iacoli, Iovino, Montandon ecc., la lista sarebbe lunga) utili a indagare gli spazi geografici, paesaggistici, territoriali, umani, insieme alle topografie di suoni e di luci presenti nei testi di Consolo. Naturalmente l’autrice mette in guardia il lettore dalla corrispondenza esatta tra realtà e ambientazione letteraria, et pour cause, la geografia reale è sempre determinata dallo sguardo di chi la scopre o la osserva, a maggior ragione dallo sguardo di uno scrittore o di un artista. Rivolto a questa delicata questione e ai numerosi contributi teorici sul rapporto tra ‘geografia e letteratura’ (geocritica, geopoetica, geotematica ed ecocritica), è il capitolo intitolato Come percorrere i luoghi di Consolo: «I luoghi che l’universo letterario di Consolo ci invita a scoprire sono già molto ‘detti’, possiedono cioè una propria intrinseca ricchezza in termini di rappresentazione letteraria e artistica, oppure sono stati e sono ancora al centro del dibattito storico e filosofico: hanno già una propria identità frutto dell’interazione tra immaginario e reale» (34). Fermo restando comunque che per Consolo la geografia letteraria si intreccia alle istanze di una geografia intima, sicché spesse volte l’autrice fa riferimento ad una «soggettività autoriale», e anche a una «soggettività pensosa» (p. 136). Un altro maestro di luoghi per Consolo è stato senza dubbio l’autore del Cristo si è fermato a Eboli: «Con Levi Consolo vede davvero i luoghi» (p. 51) E così come viene sottolineato questo particolare legame ‘spaziale’ con Carlo Levi, altrettanto accade per Verga del quale Consolo accoglie non solo, come è noto, la rivoluzione linguistica e stilistica, ma anche l’attenzione al mondo degli umili efficacemente rilevata dalla studiosa. Ora, l’approccio ‘geografico’ fa emergere strati della scrittura dell’agatese finora solo sfiorati dalla critica e che Bellanova approfondisce o porta alla luce per la prima volta. Mi riferisco in particolare a certa stratificazione ‘classica’ della geografia consoliana (come ad esempio la geografia euripidea e omerica), meravigliosamente ‘scoperta’ e analizzata dall’autrice: «Rilevanti mi sono parsi inoltre i riferimenti ad alcuni storici greci o a Virgilio. Per lo più si tratta di rimandi che riscostruiscono, tra oblio 42|43 XI (2021) ISSN 2039-7917 268 storia e mito, il passato lontano della Sicilia e del Mediterraneo, testimonianza dunque, utile a comprendere toponomastica o reperti archeologici. Ma a volte non si tratta solo di questo. Quando Consolo allude all’Arcadia – luogo letterario teocriteo, oltre che virgiliano, e segnato dalla rilettura del classicismo settecentesco –, richiamando l’immagine dello spazio consacrato al contatto armonico tra esseri umani e natura, muove in realtà una critica nei confronti del mondo contemporaneo che invece deve fare i conti con una relazione distorta tra uomo e ambiente. Se gli Iblei si rivestono ai suoi occhi di caratteri arcadici, se Pantalica è il luogo della rinascita possibile, ciò non avviene soltanto perché anche in questo caso è in gioco una tradizione, ma perché l’autore, attraverso l’associazione con l’immagine classica, definisce le caratteristiche di uno spazio e lo salva dalla generale resa alla contemporaneità, trasformandolo in un modello di permanenza della biodiversità non tanto o non solo naturalistica ma soprattutto culturale» (p. 312). I rimandi classici, così essenziali e profondi nell’opera di Consolo, acquistano dunque nello studio di Bellanova una precisa collocazione spaziale e temporale in una necessaria e logica relazione col presente, relazione che non è solo di nostalgia o di sterile indignazione, ma di critica e di reazione nei confronti dei disastri della modernità. Questo ci è sembrato, tra gli altri, il contributo inedito di questo ‘eccezionale baedeker’ che, a partire dai luoghi reali, immaginari e simbolici della geografia consoliana, ne mette in luce non soltanto la tragica antitesi (bellezza/orrore, antico/moderno, armonia/violenza, potere/umiltà ecc.), che dalla Sicilia di Consolo si può estendere oggi all’intero pianeta, ma anche una via possibile di resistenza al disastro. La passione per l’antico di Consolo serve questa causa di sopravvivenza. Come esempio emblematico di questo singolare procedimento per forti e quasi fatidici contrasti, sempre legato alla geografia dei luoghi e dei tempi storici, si legga, fra gli altri, il notevole capitolo Palermo bellissima e disfatta (pp. 155-176). L’approccio geocritico del saggio mette in luce, ne Il sorriso dell’ignoto marinaio ad esempio, un’altra dimensione spaziale e storica estremamente interessante, e cioè il particolare sguardo dello scrittore sul cosiddetto Risorgimento siciliano, narrato non a partire dalla grande Storia ma dalla piccola storia, quella, all’occorrenza, di un paesino come Alcara Li Fusi: «In più Consolo è affascinato dal fatto che la vicenda di Alcara si sia svolta proprio sui Nebrodi, a poca distanza dal suo paese: da questo dettaglio, dalla valorizzazione di un luogo e di un evento trascurati, parte per un suo processo di rilettura del Risorgimento» (p. 21, corsivi miei). O ancora, più avanti: «Ma la scelta di un episodio trascurato dalla storiografia, avvenuto in un territorio marginale, assente dalle mappe ufficiali, dalle geografie di sbarchi e battaglie celebri, è il risultato di una sorta di pratica “archeologica” che porta alla superficie del testo le rovine nascoste del tempo. […]. Dal rifiuto della storia come scrittura dei privilegiati Consolo giunge alla scelta di narrare una storia al margine e dal margine, ovvero quella di chi ha potuto solo lasciare tracce di carbone sulle pareti a spirale del carcere» (p. 116, corsivi miei). Altrettanto per la valorizzazione di alcuni luoghi poco o affatto frequentati dai viaggiatori nell’isola: «Un vero e proprio criterio cartografico è ravvisabile nell’organizzazione di Retablo, del 1987. È in particolare la sezione centrale ad offrire spunti di riflessione in merito. […]. L’opera offre un ritratto della Sicilia occidentale, da Palermo a Trapani, passando attraverso luoghi di grande fascino, come Segesta, Selinunte, Mozia, e svela angoli altrimenti poco noti, come le terme segestane» (p. 21). Il lavoro di Ada Bellanova è talmente denso e ricco di percorsi che non posso che rinviare alla lettura integrale del suo istruttivo baedeker nato, come ella stessa ricorda all’inizio e alla fine del suo saggio, proprio da un viaggio in Sicilia: «Quando, alcuni anni fa, sono andata nella Sicilia occidentale per la prima volta, Retablo è stato il mio eccezionale baedeker. […]. L’intero mio percorso ha beneficiato della suggestione incantata di Retablo. La visita alle rovine di Segesta e Selinunte, l’incontro con l’enigmatico efebo di Mozia mi hanno molto emozionato. Mi si dirà che è naturale, che si tratta di luoghi estremamente affascinanti, senza tempo e insieme testimonianza di un altro tempo, opera della mano dell’uomo, ma anche spazio della natura. Eppure io credo che le pagine di Consolo abbiano avuto un ruolo determinate nel farmeli apprezzare» (p. 11). Condivido oblio 42|43 XI (2021) ISSN 2039-7917 269 pienamente quest’ultima affermazione dell’autrice, permettendomi solo una semplice chiosa a conferma: la scrittura di Consolo ha il pregio non solo di mappare i luoghi della sua isola (e anche della sua Milano!), ma soprattutto di evocarne l’aura, bella o orrida che sia. E per questo i suoi testi possono costituire un prezioso baedeker per quei lettori-viaggiatori che non si sottraggono al fascinum della scoperta.
Da Oblio 42|43 XI (2021)
ISSN 2039-7917
La metrica della memoria

foto: Giovanna Borgese Palermo 1975
La metrica della memoria
Un velo d’illusione, di pietà,
come ogni sipario di teatro,
come ogni schermo; ogni sudario
copre la realtà, il dolore,
copre la volontà.
La tragedia é la meno convenzionale,
la meno compromessa delle arti,
la parola poetica e teatrale,
la parola in gloria raddoppiata,
la parola scritta e pronunciata. (1)
Al di là é la musica. E al di là é il silenzio.
Il silenzio tra uno strepito e l’altro
del vento, tra un boato e l’altro
del vulcano. Al di là é il gesto.
O il grigio scoramento,
il crepuscolo, il brivido del freddo,
l’ala del pipistrello; é il dolore nero,
senza scampo, l’abisso smisurato;
é l’arresto oppositivo, l’impietrimento.
Così agli estremi si congiungono
gli estremi: le forze naturali
e il volere umano,
il deserto di ceneri, di lave
e la parola che squarcia ogni velame,
valica la siepe, risuona
oltre la storia, oltre l’orizzonte.
In questo viaggio estremo d’un Empedocle
vorremmo ci accompagnasse l’Empedoklès
malinconico e ribelle d’Agrigento,
ci accompagnasse Hölderlin, Leopardi.
Per la nostra inanità, impotenza,
per la dura sordità del mondo,
la sua ottusa indifferenza,
come alle nove figlie di Giove
e di Memoria, alle Muse trapassate,
chiediamo aiuto a tanti, a molti,
poiché crediamo che nonostante
noi, voi, il rito sia necessario,
necessaria più che mai la catarsi.
(Catarsi, p.13-14, […])
Questi versi, strofe o frasi, sono tratte dal Prologo della mia opera teatrale intitolata Catarsi, in cui é messo in scena il suicidio sull’ Etna di un moderno Empedocle.
Ho voluto iniziare con questi versi perché la tragedia, in forma teatrale o narrativa, in versi o in prosa, rappresenta l’esito ultimo di quella che posso chiamare la mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica. Espressione, in Catarsi, in forma teatrale o poetica, in cui si ipotizza che la scrittura, la parola, tramite il gesto estremo del personaggio, si ponga al limite della pronunciabilità, tenda al suono, al silenzio.
[…] Empedocle:
La tragedia comincia nel fuoco più alto (2)
In questa nuda e pura, terrifica natura,
in questa scena mirabile e smarrente,
ogni parola, accento é misera convenzione,
rito, finzione, rappresentazione teatrale.
Un testo, questo, dal linguaggio di voluta comunicabilità,privo di innesti dialettali, lontano dal pastiche espressionistico praticato nelle mie opere narrative, intenzionalmente alto, in qualche modo declamatorio, puntellato da rimandi impliciti e da esplicite citazioni di testi classici: da Hölderlin, naturalmente, ai frammenti di Perì Phùseos e di Katharmoì di Empedocle.
Per spiegare questo esito, devo partire dall’ esordio, dalla mia scelta di campo letterario, dalla prima impostazione stilistica. E il discorso cade fatalmente sulla scrittura, sulla lingua.
La lingua italiana, sin dalla sua nascita, sappiamo, é stata, come dice Roland Barthes, “molto parlata”, nel senso che molto si é scritto su di essa. A partire dal suo grande creatore, da Dante, con il De vulgari eloquentia. Il quale, oltre ad essere un saggio di poetica personale, é il primo trattato di linguistica italiana. “Chiamiamo lingua volgare” dice “quella lingua che i bambini imparano ad usare da chi li circonda quando cominciano ad articolare i suoni […] Abbiamo poi un’altra lingua di secondo grado, che i Romani chiamarono ‘grammatica’ (lingua letteraria regolata)”. E afferma, con un bell’ossimoro: “Harum quoque duarum nobilior est vulgaris” (Di queste due lingue la più nobile é la volgare). Da Dante dunque a Lodovico Castelvetro, ad Annibal Caro, e giù fino a Leopardi, a Manzoni, a De Amicis, fino a Pasolini. Molti scrittori insomma hanno parlato di questo strumento, della lingua che erano costretti ad usare.
Mi voglio soffermare su Leopardi, sulle riflessioni che il poeta fa sulla società, sulla letteratura e sulla lingua italiana in quel gran mare che é lo Zibaldone. Leopardi confronta la lingua italiana con la lingua francese, stabilisce un continuo parallelo fra le due lingue, così apparentemente prossime e insieme così lontane. Lontane al punto, afferma tra gli altri Luca Serianni (3), che per un adolescente italiano la lingua di Dante o del Novellino è ancora in gran parte comprensibile, mentre per il suo coetaneo francese La Chanson de Roland é un testo straniero, da affrontare con tanto di vocabolario.
Ma torniamo al nostro Leopardi. Il francese, egli dice, tende all’ unicità, mentre l’italiano é un complesso di lingue piuttosto che una lingua sola, potendo essa variare secondo i vari soggetti e stili e caratteri degli scrittori, per cui diversi stili sembrano quasi diverse lingue; il francese invece, sin dall’epoca di Luigi XIV, si é geometrizzato, é diventato lingua unica. E cita, Leopardi, Fénelon, il quale definisce la lingua francese una “processione di collegiali”.Diciamo qui tra parentesi che alla frase di Fénelon deve aver pensato Ernest Renan nell’affermare: “Il francese non sarà mai una lingua dell’assurdo: e neanche sarà mai una lingua reazionaria. Non si riesce a immaginare una vera e propria reazione che abbia per strumento il francese”. Ma a Renan ribatte Roland Barthes: “L’errore di Renan non era errore strutturale ma storico; egli credeva che il francese, plasmato dalla ragione, conducesse necessariamente all’espressione di una ragione politica la quale nel suo spirito non poteva che essere democratica”. E concludeva: “La lingua non é né reazionaria né progressista: essa é semplicemente fascista; il fascismo infatti, non é impedire di dire, ma obbligare a dire”. Non capisco questo radicalismo linguistico di Barthes, espresso nella lezione inaugurale al Collège de France, ma chiudendo la lunga parentesi, ritorno ancora a Leopardi, alla sua idea del francese geometrizzato. E non posso non esclamare:”Beati i francesi con la loro lingua unica, geometrica e cartesiana! Che é segno, quella lingua, dell’esistenza e della compiutezza di una società civile (“Oggi so che alla Francia mi lega soltanto l’amore per la lingua francese” scriveva Jean Genet durante il suo vagabondare per l’Europa) (4). Il complesso di lingue che é (o che é stato, fino agli anni Sessanta, fino all’analisi della trasformazione di questa lingua che ne fa Pasolini), l’italiano é di segno opposto: segno vale a dire dell’assenza o incompiutezza di una società civile italiana.
Lo Zibaldone, dicevo. Leopardi afferma che la lingua italiana, il toscano vale a dire, raggiunge la sua massima eleganza nel Cinquecento. Finisce questa eleganza, questa centralità toscana, con la Controriforma, con l’esplosione di quel leibniziano cataclisma armonico, di quell’ anarchia equilibrata che va sotto il nome di Barocco. Per Croce però il Barocco non nasce dalla Controriforma, ma da una concomitante decadenza, dall’ affievolirsi di quell’ entusiasmo morale, di quello spirito del Rinascimento che aveva illuminato l’Europa. Era stata Firenze dunque centro di quella lingua attica, di quell’italiano platonico, di quella scrittura borghese, laica, elegante dei poeti, dei filosofi, degli scienziati a cui ogni scrittore, da ogni corte o convento, da ogni accademia o piazza, da ogni centro o periferia aspirava. Ma questa lingua dell’Ariosto e del Tasso, del Machiavelli e del Guicciardini, nel tempo si irrigidisce, si fa aulica, perde contatto col suo fondo popolare, si geometrizza, perde in estensione. Leopardi ammira la perfezione stilistica raggiunta dagli scrittori del nostro Secolo d’Oro, ma predilige l’immensità, la varietà, la vertiginosa libertà espressiva di uno scrittore secentesco, barocco, del gesuita Daniello Bartoli, l’autore della Istoria della Compagnia di Gesù. Dice: “Il padre Daniello Bartoli é il Dante della prosa italiana. Il suo stile, in ciò che spetta alla lingua, é tutto risalti e rilievi”. Risalti e rilievi come quelli del Resegone, che Manzoni ironizza ironizzando il Seicento, il tempo della disgregazione, del marasma sociale. Ironizza prima esplicitamente trascrivendo nell’introduzione del suo grande romanzo il “dilavato e graffiato autografo” dell’anonimo secentista, inzeppato “d’idiotismi lombardi”, di “declamazioni ampollose”, di “solecismi pedestri” e seminato qua e là da qualche eleganza spagnola. (L’espediente del documento dell’anonimo secentesco pensiamo derivi al Manzoni da Cervantes, dal Don Chisciotte, dal sedicente manoscritto dell’arabo Cide Hamete Berengeli). E ironizza ancora nascostamente parodiando nell’incipit, in “Quel ramo del lago di Como”, un brano del Bartoli riguardante l’India, la regione del Gange, riportando così il disordine lombardo all’ordine, alla geometria fiorentina. Che era per Manzoni l’aspirazione all’ordine, all’armonia sociale, a un illuministico, cristiano Paese, di cui la lingua, comune e comunicativa, doveva essere espressione. Utopia mai realizzatasi, si sa. E dunque la moderna storia letteraria italiana, con le rivoluzioni linguistiche degli Scapigliati, di Verga e dei Veristi, con il preziosismo decadente di D’Annunzio, con la esplosione polifonica del “barocco” Gadda e degli altri sperimentalisti, da una parte, con lo sviluppo della “complessa” semplicità leopardiana dei rondisti e degli ermetici, con l’asciutta, scabra lingua di Montale, dall’altra, é la storia del convivere e dell’alternarsi della lingua rinascimentale e illuministica e della linea barocca e sperimentale. É la storia di speranza e di fiducia degli scrittori in una società civile; la storia di sfiducia nella società, di distacco da essa, di malinconia, di disperazione.
Da tali altezze scendendo al mio caso, a quel che ho potuto o saputo fare, posso dire questo. Ho mosso i miei primi passi in campo letterario (e questo risale al 1963) nel momento in cui si concludeva in Italia la stagione del Neorealismo e stava per affacciarsi all’ orizzonte quel movimento avanguardistico che va sotto il nome di Gruppo ‘63. Il quale, come tutte le avanguardie, opponendosi alle linee letterarie che erano in quel momento praticate, dalla neo-realistica, alla illuministica e razionalistica, alla sperimentalistica, programmava l’azzeramento d’ogni linguaggio che proveniva dalla tradizione e proponeva un nuovo, artificiale linguaggio di difficile praticabilità. L’operazione non era nuova, naturalmente, era già stata fatta dal Futurismo, dal suo fondatore Marinetti, il quale aveva dettato il decalogo della nuova scrittura.
1) Bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso, come nascono.
2) Si deve usare il verbo all’ infinito.
3) Si deve abolire l’aggettivo.
4) Si deve abolire l’avverbio…Etc…Etc…
Questa ideologia linguistica o stilistica marinettiana riproponeva uno dei teorici del Gruppo ’63, affermando che bisognava praticare il “disordine sintattico e semantico come rispecchiamento del disordine della società”. Credo che si fosse nel campo della indecifrabilità, della pseudo-afasia, speculare alla indecifrabilità linguistica e alla pseudo-afasia del potere.
Dicevo che ho mosso i primi passi in quel clima letterario e insieme in quel clima politico in cui un partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana, dal ’48 ininterrottamente al potere, aveva cambiato profondamente l’assetto sociale e culturale del nostro Paese, aveva cambiato la nostra lingua.
Pasolini (sulla rivista Rinascita – dicembre ’64 – quindi in Empirismo eretico) aveva pubblicato il saggio dal titolo Nuove questioni linguistiche in cui sosteneva che, con il neo-capitalismo, l’asse linguistico italiano s’era spostato dal centro meridione, da una realtà burocratica e contadino-dialettale, al centro settentrione, a una realtà piccolo-borghese aziendale e tecnologica. E analizzava un brano del discorso di un uomo politico emblematico, Aldo Moro (ucciso a Roma nel ’78, come sappiamo, da quei piccolo-borghesi criminali, mascherati da rivoluzionari, che sono stati i componenti delle Brigate Rosse), discorso pronunciato nel momento significativo dell’inaugurazione dell’Autostrada del Sole, autostrada che univa per la prima volta l’Italia dal Piemonte alla Sicilia. Diceva Moro: “ La produttività degli investimenti del piano autostradale dipende dunque dal loro coordinamento in una programmazione delle infrastrutture di trasporto, che tenda a risolvere gli squilibri, ad eliminare le strozzature, a ridurre gli sperperi della concorrenza fra diversi mezzi di trasporto, a dare vita insomma ad un sistema integrato su scala nazionale”. E Pasolini concludeva dunque nel suo saggio: “Perciò in qualche modo, con qualche titubanza, e non senza emozione, mi sento autorizzato ad annunciare che è nato l’italiano come lingua nazionale” (si noti in questa frase l’amara ironia pasoliniana). Non era certo, questo italiano per la prima volta nazionale, uguale al francese unico e geometrizzato di cui parlava Leopardi, ma una sorta di sotto o extra-lingua, una astorica, rigida, incolore koinè.Sono passati più di quarant’anni dal 1964 e lascio immaginare la situazione linguistica italiana di oggi, dell’italiano strumentale e di quello letterario.
Esordivo in quel tempo, insieme a Luigi Meneghello, Lucio Mastronardi, Stefano D’Arrigo con La ferita dell’aprile, titolo di eco eliotiana. Un racconto in una prima persona mai più ripresa, una sorta di Telemachia o romanzo di formazione. Mi ponevo con esso subito, un po’ istintivamente e un po’ consapevolmente, sul crinale della sperimentazione, mettendo in campo una scrittura fortemente segnata dall’ impasto linguistico, dal recupero non solo degli stilemi e del glossario popolari e dialettali, ma anche, dato l’argomento, di un gergo adolescenziale. Gergo quanto mai parodistico, sarcastico, quanto mai oppositivo a un ipotetico codice linguistico nazionale, a una lingua paterna, comunicabile. E organizzavo insieme la scrittura su una scansione metrica, su un ritmo, con il gioco delle rime e delle assonanze. Prendeva così il racconto, nella sua ritrazione linguistica, nella sua inarticolazione sintattica, nella sua cadenza, la forma in qualche modo di un poemetto narrativo. C’era certo, dietro il libro, la lezione di Gadda e di Pasolini, c’era l’ineludibile matrice verghiana, ma c’era l’evidente polemica sociale, la diffidenza nei confronti del contesto storico, della sua lingua.
Tredici anni sono trascorsi tra il primo e il secondo libro. Un tempo lungo che poteva anche significare dimissione dalla pratica letteraria. Un tempo che ha coinciso – mi si permetta di dirlo – con la mia vicenda personale, con il mio trasferimento, nel ’68, dalla Sicilia a Milano. In questa città provai spaesamento per la nuova realtà, urbana e industriale, in cui mi trovai immerso, realtà di cui mi mancava memoria e linguaggio; per l’acceso clima politico, per i duri conflitti sociali di quegli anni. Fu un tempo quello di studio e di riflessione su quella realtà e sul dibattito politico e culturale che allora si svolgeva. Frutto di tutto questo fu la pubblicazione, nel 1976, del romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio.
Un romanzo storico-metaforico, ambientato in Sicilia intorno al 1860, che voleva chiaramente rappresentare il grande rinnovamento, l’utopia politica e sociale che nel Sessantotto si vagheggiava in Italia e altrove, che nel nostro Paese doveva frantumarsi a causa dei suoi esiti tragici, disastrosi. L’ambientazione storica e il ripartire dal luogo della mia memoria mi permetteva di raggiungere maggiore consapevolezza della mia scelta di campo letterario, scelta contenutistica e stilistica. La sperimentazione linguistica, per l’adozione della terza persona, si svolgeva ora sul piano dell’ironia e del discorso indiretto libero. L’esito era quindi la “plurivocità” ben individuata da Cesare Segre. In cui era incluso il linguaggio alto del protagonista, un erudito dell’800, e la lingua dei contadini, la cui estremità era rappresentata da un antico dialetto, il gallo-italico o mediolatino, che si parlava in Sicilia in isole linguistiche dell’azione del romanzo. La sperimentazione, nel romanzo, era anche sul piano della struttura. I cui jati, le cui fratture erano riempite da inserti storiografici, da documenti, la cui funzione era quella di connettere i vari lacerti narrativi. Mi veniva questo dalle sollecitazioni del Gruppo ’47 di Enzerberger, per le sue teorie di Letteratura come storiografia. Anche qui c’é la messa in crisi del genere romanzo, c’é ancora la polemica della scrittura narrativa nei confronti della società. Società di cui fa parte la cosiddetta industria culturale che mercifica e distrugge il romanzo.
Nei miei successivi romanzi perseguo e approfondisco sempre di più la sperimentazione linguistica. In essi c’é la messa in crisi del genere romanzo, e c’é ancora, come dicevo sopra, la polemica nei confronti della società. Società in cui, con la rivoluzione tecnologica, con l’invasione dei mezzi di comunicazione di massa, l’autore non riesce più a individuare il lettore. Italo Calvino, scrittore quanto mai razionalista o illuminista, estremamente comunicativo, al pari di Moravia, di Bassani, di Primo Levi, di Sciascia, e di altri di quella generazione, Calvino, nel contesto di una inchiesta, alla domanda, a quale tipo di lettore egli pensasse scrivendo, rispondeva: “A un lettore che la sa più lunga di me”. Non credo che Calvino, in questo nostro presente, potrebbe ancora rispondere in quel modo, oggi in cui non è immaginabile un lettore più o meno letterariamente avveduto, più o meno
colto dell’autore.
Viene quindi la pubblicazione di
Lunaria (1985), un racconto, una favola dialogata, che fatalmente prende forma
teatrale.La favola, ambientata in un vago Settecento, alla corte di un viceré spagnolo di Sicilia, si ispirava a un frammento lirico di Leopardi, Lo spavento notturno,e ad una prosa di Lucio Piccolo, L’esequie della luna. La metafora della caduta della luna significava la caduta della poesia, della cultura nel nostro contesto. L’epoca e il tema favolistico, mi facevano approdare a soluzioni di apparente puro significante, come questa:
Lena lennicula
Lemma lavicula,
làmula,
lèmura,
màmula.
Létula,
màlia,
Mah.
Della stessa epoca e dello stesso clima quai favolistico è anche Retablo. E’ un viaggio nella Sicilia classica, una metafora della ricerca al di là della ideologia, della completa dimensione umana, della perduta eredità umanistica. Per i rimandi, le citazioni eplicite e no, per la struttura, il risultato del racconto è di un ipertesto letterario o di un palinsesto.
Nottetempo, casa per casa è ancora una narrazione scandita come un poema. Dico narrazione nel modo in cui è stata definita da Walter Benjamin. Il quale in Angelus Novus, nel saggio su Nicola Leskov, fa una netta distinzione tra romanzo e narrazione.
La storia di Nottetempo, casa per casa é ambientata negli anni Venti, nel momento del fascismo in Italia. Vi si parla della follia privata, individuale, dolorosa, innocente, e della follia pubblica, la follia della società, della storia. Personaggio simbolico é il satanista Aleister Crowley, che incarna il decadentismo estremo della cultura europea di quegli anni, di nuove metafisiche, di misticismi di segno nero o bianco. Il protagonista del racconto, Petro Marano, è un piccolo intellettuale socialista, é costretto all’esilio, a rifugiarsi in Tunisia. Il racconto termina con questa frase: “Pensò che ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore.”
Il libro successivo L’olivo e l’olivastro, inizia con questa frase: “Ora non può narrare. Quanto preme e travaglia arresta il tempo, il labbro, spinge contro il muro alto, nel cerchio breve, scioglie il lamento, il pianto”. Qui è negata la finzione letteraria, l’invenzione del racconto. Il libro è un viaggio nella realtà contingente e nella memoria. E’ il ritorno di un Ulisse a Itaca, dove non trova che distruzione, violenza, barbarie.
Ma devo ora tornare all’inizio di questa conversazione. Tornare alla tragedia Catarsi, in cui , l’antagonista di Empedocle, Pausania, così recita:
– Io sono il messaggero, l’anghelos, sono
il vostro medium, colui a cui è affidato
il dovere del racconto, colui che conosce
i nessi, la sintassi, le ambiguità,
le astuzie della prosa, del linguaggio….
Cambia tono, diviene recitativo, enfatico.
PAUSANIA – E un mattino d’agosto lasciammo la dimora alta e luminosa, lasciammo i templi, le piazze, le arnie e le vigne, abbandonammo la patria nostra, la superba Agrigento che s’alza sopra il fiume…Spogli ed esposti, solitari, per boschi e per deserti giungemmo all’oriente, all’altro mare di quest’isola vasta, alla montagna immensa, presso la scaturigine del fuoco, del fragore, della minaccia…
Empedocle lo interrompe con un ghigno sarcastico.
EMPEDOCLE – Che menzogna, che recita, che insopportabile linguaggio! E’ proprio il degno figlio di questo orrendo tempo, di questo abominevole contesto, di questo falso teatro compromesso, di quest’era soddisfatta, di questa società compatta, priva di tradimento, d’eresia, priva di poesia. Figlio di questo mondo degli avvisi, del messaggio tondo, dei segni fitti del vuoto…Dietro il velo grasso delle sue parole di melassa, io potrei scoprire l’oscena ricchezza della mia città, la sua violenza, la sua volgarità, gli intrighi, gli abusi, i misfatti, le stragi d’innocenza, d’onore, di memoria, la morte quotidiana imbellettata come le parole morte di questo misero ragazzo, di questo triste opportunista…
Ecco, ne L’olivo e l’olivastro l’ánghelos, il narratore, non appare più sulla scena poiché ormai la cavea è vuota, deserta. Sulla scena è rimasto solo il coro che in tono lirico, in una lingua non più comunicabile, commenta e lamenta la tragedia senza soluzione, la colpa, il dolore senza catarsi. Avviene qui la ritrazione invece che l’irruzione dello spirito socratico, quello che Nietzsche, ne La nascita della tragedia vede nel passaggio dall’antica tragedia di Eschilo e di Sofocle alla moderna tragedia di Euripide. Lo spirito socratico è il ragionamento, la filosofia, è la riflessione che l’autore del romanzo fa sulla vicenda che sta narrando: è quindi, come quello dell’ánghelos o messaggero con lo spettatore, il dialogo con il lettore. La ritrazione, la scomparsa dello spirito socratico é l’interruzione del dialogo con il lettore; é lo spostamento della scrittura dalla comunicazione all’espressione.
Nelle mie narrazioni c’é sempre l’interruzione del racconto e il cambio della scrittura, il suo alzarsi di tono, svolgersi in forma ritmica, lirico-poetica. Sono questi per me le parti corali o i cantica latini.
Eric Auerbach, nel suo saggio sul Don Chisciotte, contenuto in Mimesis, scrive: “Cervantes (…) é (anche) un continuatore della grande tradizione epico-retorica, per la quale anche la prosa é un’arte, retta da proprie leggi. Non appena si tratti di grandi sentimenti e di passioni o anche di grandi avvenimenti, compare questo alto stile con tutti i suoi artifici”.
I grandi avvenimenti di cui parla Auerbach (e i sentimenti che essi provocano) con sistono per me, in questo nostro tempo, in questo nostro contesto occidentale, nella cancellazione della memoria,e quindi della continua minaccia della cancellzione della letteratura, soprattutto di quella forma letteraria dialogante che é il romanzo. Il quale credo che oggi possa trovare una sua salvezza o plausibilità in una forma monologante, in una forma poetica.
Poesia che é memoria, e soprattutto memoria letteraria.
Questo ho cercato di fare nello Spasimo di Palermo, terzo tempo, con il Sorriso dell’ignoto marinaio e Nottetempo,casa per casa, di una trilogia. “Ostinata narrazione poetica, in cui il raccontare é in ogni momento ricerca di senso, un interrogazione sul valore della realtà e dell’esistenza…” (Giulio Ferroni)
Nello Spasimo vi si narra ancora di un viaggio di ritorno, di un nòstos in un’Itaca dove non é che smarrimento, violenza e dolore, “..una landa ingrata, / dove si trovano strage e livore” dice Empedocle nel Poema lustrale.
Questa é la nostra Itaca d’oggi, la matrigna terra della giustizia negata, della memoria cancellata, dell’intelligenza offuscata, della bellezza e della poesia oltraggiate, delle passioni incenerite.
Vincenzo Consolo
- Pasolini P.P. Affabulazione – 1966 – prefazione di G.D. Bonino TO Einaudi 1992
- Hölderlin F. Sul tragico –1795-1804 – prefazione R.Bodei Mi Feltrinelli 1994
3) Serianni L. Viaggiatori, musicisti, poeti, MI Garzanti 2002
4) Genet J., Diario del ladro, Il Saggiatore 2002
versione definitiva al 18.2.2009
L’ulissismo intellettuale in Vincenzo Consolo
Giuseppe Traina 1
Per provare a ragionare sull’ulissismo intellettuale in Vincenzo Consolo bisogna tener conto sia dei debiti di Consolo con l’Odissea come testo, sia della varia commistione fra il nostro scrittore e il protagonista dell’Odissea come personaggio che vive oltre il poema e diventa antonomastico. Si tratta di rapporti diretti, che Consolo ha esplicitato, per esempio quando ha definito l’Odissea un «grande archetipo» (Consolo 2015: 1241). Ma si tratta anche di elementi riconducibili a una nozione più ampia di ulissismo intellettuale da intendere come avventura della conoscenza oltre i confini disciplinari, temporali e geografici, di cui magari Consolo non ha lasciato tracce esplicite ma che si possono ugualmente riscontrare, pensando soprattutto alle feconde ambiguità di Ulisse, personaggio moderno non tanto perché astuto ma perché problematico portatore dell’ambivalente potere della parola2.
Consolo ha tematizzato l’ulissismo prima di tutto nel viaggio narrato in Retablo e poi in tre elementi basilari: la costruzione della trilogia composta da Il sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo Spasimo di Palermo, che evidenzia rimarchevoli elementi ulissiaci in comune, come l’azzardo e lo scacco che condannano alla morte, all’erranza o all’afasia; la concezione a dittico di L’olivo e l’olivastro e Lo Spasimo di Palermo, fondata sul tema del nostos;
- la pubblicazione di testi laterali ma ai quali Consolo mi sembra desse una certa importanza, come Il viaggio di Odisseo e soprattutto Fuga dall’Etna3. 1 Giuseppe Traina, Università di Catania.
2 La bibliografia su Ulisse è impossibile da riassumere in una noterella: cfr. almeno Boitani 20122. 3 Cfr. Consolo 1993 e Consolo, Nicolao 1999. Sull’ulissismo esplicito in Consolo esiste un bel saggio di Massimo Lollini nel quale quest’aspetto mi pare sia affrontato in modo quasi esaustivo. Riassumo i punti principali del discorso di Lollini: I. Ulisse è eroe del Mediterraneo, ma la civilizzazione del Mediterraneo ha rivelato in sé tanto il volto della violenza quanto quello della cultura e dell’intelligenza: sicché Consolo, in tale direzione, ipervalorizza l’emblema omerico dell’olivo e dell’olivastro, ripetendolo in più luoghi e facendone il perno del suo libro più inclassificabile; II. «il viaggio di Odisseo diventa la metafora che consente a Consolo di ritrovare nel mito e nella letteratura un senso drammatico e complesso dell’esistenza personale e collettiva, non più legato ad alcuna ideologia di progresso della civiltà mediterranea» (Lollini 2005: 25); III. Ulisse è anche immagine dell’esilio «inappagato per l’infinito che lo pervade e lo proietta in una dimensione di alterità»: da questa alterità deriva il lavoro dello scrittore, un lavoro di scavo nel linguaggio alla ricerca di «una parvenza di umano» (Lollini 2005: 25); IV. odissiaco è il viaggio in mare come esperienza di tipo sia storicamente determinato (economico), sia come avventura intellettuale, nel senso codificato da Dante nel XXVI canto dell’Inferno; V. il racconto omerico è diventato fondativo di un mito perché ha unito i tre elementi basilari della civilizzazione mediterranea: il viaggio, il mare, la guerra; VI. odissiaca è la centralità della catabasi come luogo del riconoscimento del dolore, della paura di morire; VII. la profezia di Tiresia ha messo al centro del destino di Ulisse l’erranza, l’esilio come «riconoscimento dell’alterità intrinseca nella condizione dell’Ulisse moderno», che Consolo studia «in una prospettiva di lunga durata» (Lollini 2005: 29): talché discendono dall’inquietudine ulissiaca non solo i suoi protagonisti più immediatamente riconoscibili in questa condizione, ma perfino i satanisti di Aleister Crowley e il barone Cicio di Nottetempo, casa per casa; VIII. data l’importanza del precedente rappresentato dall’Iliade, poema della guerra, in Consolo l’Odissea diventa «un viaggio penitenziale, un nostos di espiazione» (Lollini 2005: 30) del sopravvissuto rispetto agli orrori della guerra, un po’ come in Primo Levi. Dunque la meta del nostos non è la patria, ma l’esilio stesso, anche perché non si può avere nostalgia di una patria distrutta dalla tecnologia, come dimostra L’olivo e l’olivastro; IX. Consolo è condannato all’erranza nei due poli opposti del disgusto: Milano e la Sicilia. L’erranza non è una scelta ma una condizione dolorosa dell’Ulisse moderno; X. unica alternativa per Ulisse è il naufragio. Ovvero, nei termini consoliani, il naufragio del romanzo, l’afasia. Che è poi effetto L’ulissismo intellettuale in Vincenzo Consolo 101 della dimensione etica che distingue Consolo dal mero approccio solipsistico al presente (la disperazione); XI. se l’Ulisse omerico ha messo in discussione il suo nome e la sua identità, chiamandosi Nessuno, l’Ulisse moderno riconosce la mancanza di identità come un valore perché apre all’ibridazione culturale (che è un vero e proprio topos del Consolo saggista tra gli anni Ottanta e Duemila, dunque con ampio e preveggente anticipo su temi che poi diventeranno vulgata culturale, almeno per buona parte della sinistra intellettuale italiana). Fin qui Lollini. A integrazione della sua analisi si può ulteriormente sottolineare che la dimensione tragica (ma anche di pietas4) del discorso di Consolo, soprattutto dell’ultimo Consolo vieppiù odissiaco, non è soltanto riconducibile alla formazione classica, con netta preferenza per la cultura greca su quella latina, ma si innerva anche di contributi che sul piano strettamente letterario si rivolgono soprattutto alla cultura araba (con naturale predilezione per i poeti arabi di Sicilia) e dei paesi sudamericani o, in genere, delle culture postcoloniali. Mentre sul piano non letterario è sempre viva in Consolo l’attenzione alla cultura popolare siciliana. E qui si potrebbe innestare una riflessione su quello che Consolo considera popolare, perché mi pare che ci sia in lui, come c’è nella migliore tradizione letteraria siciliana, un netto rifiuto delle forme più arcaiche e arretrate della cultura popolare5 mentre c’è un interesse sempre vivo (e atipico, per un letterato italiano) nei confronti del popolo che vuole emanciparsi attraverso l’acculturazione (l’olivo) e anche verso la cultura tecnico-scientifica purché nella sua versione pre-tecnologica: si pensi alla botanica e all’arboricoltura che si affaccia in Retablo e di cui si fa vessillifero soprattutto lo zio/padre putativo di Chino Martinez nello Spasimo di Palermo. Queste aperture si sostanziano di una conoscenza perfino erudita di tutta una pubblicistica scientifica, soprattutto di ambito pre-novecentesco e siciliano; e anche queste aperture rientrano, a mio avviso, nella prospettiva ulissiaca in quanto si collegano alla dicotomia tra olivo e olivastro e anche in quanto considerano la techne non meccanizzata come una forma tra le più alte dell’intelletto umano e di una misura umana del vivere: si ricordi il grande emblema del letto nuziale costruito da Ulisse ricavandolo da un unico blocco di legno d’ulivo. Ci sono però alcuni micro-elementi che rinviano a singoli punti della presenza odissiaca in Consolo e che non mi pare siano stati messi in evidenza a sufficienza. Per esempio, vorrei ricordare che, ben prima di Retablo, emerge il tema del viaggio, non massicciamente nella Ferita dell’aprile ma più chiaramente nel Sorriso dell’ignoto marinaio, e comunque sempre in posizione incipitaria:
4 Cfr. Turchetta 2015: LXVIII-LXXIV. 5 Leggiamo in Ratumemi: «“Contra la forza nun cci vali la raggiuni” concluse il primo. E: “E basta, vah! Finiamola con ‘sti proverbi vani degli antichi!”» (Consolo 2015: 534). «Dei primi due anni che passai a viaggiare mi rimane la strada arrotolata come un nastro, che posso svolgere» (Consolo 2015: 5)6 – ma è bene ricordare che nel primo romanzo il viaggio non si compie via mare: né questo di cui parla all’inizio, che gli serve a raggiungere la scuola, né quello in camion col padre: quest’ultimo, però, occupa un importante spazio nella Bildung dell’io narrante, sia perché lo lega al padre (figura positiva, alla stregua del vero padre di Consolo e a lui abbastanza somigliante, peraltro) sia perché gli permette di abbozzare un episodio nel bosco che rimanda all’importante racconto I linguaggi del bosco (che si legge nella seconda sezione delle Pietre di Pantalica). Anche il Sorriso dell’ignoto marinaio comincia all’insegna del viaggio con un clamoroso periodo nominale e proprio con le parole: «Viaggio in mare di Enrico Pirajno barone di Mandralisca da Lipari a Cefalù con la tavoletta del ritratto d’Antonello […]» (Consolo 2015: 127). A proposito di viaggi, forse si potrebbe ricondurre al modello dell’Odissea anche la struttura del viaggio ‘a stazioni’7 molto presente nella narrativa consoliana: spesso si tratta di tappe previste, ma talvolta è il contrario e i personaggi si fermano a causa di rapine, fughe o accidenti vari; questa struttura è tipica della tavola centrale di Retablo e ovviamente anche dell’Olivo e l’olivastro (ma non è assente neppure nello Spasimo di Palermo) e appare in singoli momenti di altri testi, come nel caso dei due viaggi col padre a cui accennavo prima, o in Le vele apparivano a Mozia (Consolo 2012: 124-127), che racconta il viaggio a cui fu ispirato Retablo, o ancora in un racconto come La grande vacanza orientale occidentale (Consolo 2012: 163-169), che ci dà modo di risalire con molta chiarezza alla vocazione del giovane Consolo a viaggiare per la Sicilia e a leggerne l’identità all’insegna della grecità. Vocazione alla quale si giustapporrà, senza scacciarla, l’altra e successiva vocazione a valorizzare l’età dell’oro della Sicilia araba, «unico e irripetibile esempio di equilibrio ateniese» (Consolo 2015: 1215). Non vanno sottovalutati anche taluni micro-aspetti ricondotti esplicitamente dall’autore a Omero: per esempio, quasi alla fine del quinto capitolo della Ferita dell’aprile, Filippo Mùstica si spoglia, salta in groppa al mulo ed entra in acqua per fare il bagno con l’animale. È una sequenza che ci verrebbe facile definire panica8 ma che invece Consolo attribuisce a tutt’altra ispirazione, perché il ragazzo «tirò avanti come un condottiero, di quelli delle storie d’Omero» (Consolo 2015: 54). Dell’Iliade, insomma. Ancora: all’inizio del capitolo X della Ferita dell’aprile, troviamo un intrigante paragone tra il mare e i campi coltivati: 6 Per inciso, un nastro arrotolato è abbastanza simile, come forma, a una chiocciola e ci pare quasi un’anticipazione del simbolo fondativo del Sorriso dell’ignoto marinaio. 7 E chissà che Consolo, attento lettore di Benjamin e di Enzensberger, non avesse letto anche Mittner e riflettuto sul modello dello Stationendrama o che l’abbia ripreso direttamente da Conversazione in Sicilia. 8 Forse anche dannunziana, se si potesse azzardare – e io lo farei – anche quest’aggettivo per definire certi aspetti della prosa consoliana. Le reti stese sopra la spiaggia parevano campi di terra grassa, orti concimati, tra la rena grigia. Il cielo scivolava fitto di qua dalle colline e sopra il mare verde e come scosso da un brivido si levava un tetto, spesso, che finiva lontano verso l’orizzonte, dov’era chiaro, lucente, come una lista di sole fra le stecche della gelosia: mare e cielo erano due piani paralleli, all’infinito. (Consolo 2015: 97). Può essere utile ricordare, sempre nella logica dell’interesse di Consolo per le specificità della coltivazione agricola, quei punti, presenti in altre opere, in cui il nostro autore si sofferma sulla fertilità della terra: per esempio la terra grassa che si nasconde sotto la lumaca nel Sorriso dell’ignoto marinaio o quel bellissimo passo di Filosofiana in cui Vito Parlagreco comincia a zappare un campo pieno di quelli che noi chiameremmo reperti archeologici e che per lui non sono inutili cocci senza valore (come, invece, lo sono per gli abitanti di Mozia che guardano il cavaliere Clerici come un matto quando vuol pagare loro la statua dell’Efebo) ma «capricci» (Consolo 2015: 542) degli antichi, che però lo distraggono dall’occupazione primaria, cioè la coltivazione di quel gramo spicchio di terra. Perché, nonostante l’apparenza di inutile petraia, sotto questo strato di antichi cocci, Vito trova «una terra nera e grassa, terra di verginità immacolata» (Consolo 2015: 540). Se volessimo un po’ estremizzare, potremmo perfino dire che non solo la natura è sotto la natura (la terra sotto la chiocciola), ma anche che sotto la cultura (che può anche essere percepita come sovrastruttura) c’è la natura, nella sua forma colturale ma anche, appunto, culturale: insomma, ci sono due forme dell’olivo ma non l’olivastro. La bipartizione tra olivo e olivastro non è stata sempre così netta e dominante in Consolo: starei per dire ‘fortunatamente’, dato che a me sembra perfino un po’ eccessiva nella sua formulazione così oppositiva. Si legge nella Ferita dell’aprile, in un passo in cui circola aria non soltanto siciliana ma anche greca, omerica: così rugoso e scuro, così contorto, il carrubo l’avevo sempre pensato venuto dall’oscurità del tempo, che affondasse le radici al centro della terra: e il tronco mi pareva di tufo e i frutti di carbone. L’ulivo come il carrubo, la vite e l’asino e le capre, le lancelle di mosto e gli scifi di quagliata, certi vecchi accoccati ma saldi, mi parevano cose antichissime e immortali. (Consolo 2015: 111). La conclusione della Ferita dell’aprile recita: «Così girai tanti anni per i paesi, all’isole, sulle montagne, alle marine, dal comune d’Alì fino a Messina» (Consolo 2015: 121). In pochissime parole, c’è quasi una panoramica, prima, sull’intero ‘mondo’ che il giovane siciliano impiegato del Dazio può immaginare e accogliere in una definizione vaga quanto vasta; poi, c’è la precisazione, che riduce tutto al vero ‘mondo conosciuto’, una porzione nemmeno troppo grande della provincia di Messina, che non è certo la più piccola tra le province siciliane: un allargamento della prospettiva geografica senza una chiara visione di quello che concretamente attende l’io narrante. Sarà certo ben più ampia la rinnovata prospettiva esistenziale del viaggiatore Petro Marano approdato in Tunisia alla conclusione di Nottetempo, casa per casa; ma ricordiamo che l’io narrante della Ferita dell’aprile prima viaggiava soltanto sui monti più vicini a casa e invece alla fine si slancia, con il nuovo lavoro che è frutto della sua educazione scolastica, alla conquista di un territorio sia montuoso che marittimo (l’autore lo specifica, volutamente). Dal canto suo, Petro non è ancora il viaggiatore che sperimenta la disperazione radicale dell’Olivo e l’olivastro e dello Spasimo di Palermo9, tant’è che rifiuta l’esilio in versione anarchica del compagno di viaggio Schicchi e si considera, costruttivamente, «solo come un emigrante, in cerca di lavoro, casa, di rispetto. Solo ad aspettare con pazienza che passasse la bufera» (Consolo 2015: 755). Come ha ricordato Lollini, uno degli elementi basilari del viaggio di Ulisse è la catabasi: sorvolando sulla sensazione che per Consolo il vero viaggio all’inferno sia l’imbattersi nella sofferenza degli uomini nel mondo, nelle sue varie forme – una tra le più rilevanti è senz’altro la follia –, può essere interessante rilevare, a ulteriore conferma del ruolo tutto particolare giocato da Retablo nella storia letteraria del suo autore10, la continua alternanza metaforica tra inferno in terra e paradiso in terra. Quando Isidoro comincia a lavorare come facchino alla Cala dice: «Ero nell’inferno» (Consolo 2015: 373); quando, di ritorno dal viaggio, si aggira in cerca di Rosalia: «Mi parvi preso da’ turchi, da’ corsari, rapito in un sogno angustiante. Girai per vichi, per strade, per piazze, del Borgo, della Kalsa». Poi, dopo questo nuovo tuffo all’inferno, ascende al paradiso nell’oratorio di San Lorenzo: «Entrai, mi parve d’entrare in paradiso» (Consolo 2015: 375). E poi di nuovo in giro, «senza posa sulla strada, pazzo, forsennato» (Consolo 2015: 376). Si ritrova nell’intero romanzo, però, l’idea che tutta la realtà siciliana sia un’alternanza di inferno e paradiso: ancora Isidoro, durante il bagno termale a Segesta, «“Ma qui è il paradiso!” sclamò Isidoro, più sempre in beatitudine o in ebetudine vagante» (Consolo 2015: 402). Allusioni all’inferno ci sono invece nel rivolgersi di Clerici alla Beccaria: «nulladimeno, pur sulla soglia di questa forte terra, nel primo cerchio di questo vortice di luce, sull’ingresso di questo laberinto degli olezzi, nell’incamminamento di questa galleria de’ singolari tratti e d’occhi ardenti» (Consolo 2015: 403). La narrazione del viaggio da parte di Clerici è trasognata: «E a mano a mano io mi trovai a passare dal sogno e dall’incanto al risveglio più lucido, alla visione più netta delle cose, ne la luce di giugno più vere e crude, ch’invade l’animo mio d’incertezza e d’ansia pel futuro, finito questo tempo sospeso e irreale del viaggio» (Consolo 2015: 380-381); anche per lui, i facchini arrembanti tra la folla della Cala si presentano come invadenti e infernali, tanto più dopo la visione dei corpi degli impiccati e dei torturati. Ne deriva l’elezione di Isidoro come unica persona umile e istruita, che si distingue nel branco. In realtà Clerici, anche se porta con sé l’Odissea11, si presenta come un viaggiatore fin troppo diverso dall’Ulisse omerico. Ricordiamo la sua motivazione al viaggio: 9 Molto interessante l’interpretazione di Daragh O’ Connell, che distingue tra la «disfatta» del personaggio e la «disperazione» dell’autore: cfr. O’ Connell 2008: 174. 10 Cfr. Traina 2001 e Traina 2014. 11 Cfr. Consolo 2015: 406. volli sottrarmi alla tempesta insana d’ogni sentimento percorrendo a ritroso, per gli antichi sentieri della storia, questo tempo umano del conato, del movimento cieco e incontrollato, fino al punto oscuro iniziale per cui si passa nell’immota eternitate da cui veniamo, nel tempo senza soli e senza lune, giorni e stagioni, natività e morte, del vuoto e del silenzio, nell’immensa stasi, la somma e infinita quiete metafisica, nel modo come spiega il Campanella (Consolo 2015: 383). Egli sembra proprio l’antitesi del viaggiatore, soprattutto del viaggiatore per mare; gli basta lo sballottamento d’un sentiero disagevole ed ecco il paragone enfatico: «E la lettica è come il maremoto, un guscio di barchetta sopra creste e avvalli delle onde, e i naviganti sbattuti e tormentati a dritta e a manca» (Consolo 2015: 385). Poi però impara dell’altro: Poi domani, vicende sempre nuove, nuove avventure, ignote, che è l’essenza stessa della vita, che dentro i due certi punti, l’avvio e la sua fine, ricomincia l’avventura ogni mattina. E ancor di più l’essenza della vita dentro nel viaggio, per cui viaggio si fa dentro il viaggio, ignoto nell’ignoto. Così ora capisco coloro che viaggiano, capisco gli eterni erranti, i nomadi, i gitani: vivono ancor di più dei sedentari, dilatano il tempo, ingannano la morte (Consolo 2015: 440). D’altronde non c’è differenza tra sogno, viaggio e scrittura di viaggio, per il cavaliere Clerici: Mai sempre tuttavia il viaggio, come distacco, come lontananza dalla realtà che ci appartiene, è un sognare. E sognare è vieppiù lo scrivere, lo scriver memorando del passato come sospensione del presente, del viver quotidiano. E un sognare infine, in suprema forma, è lo scriver d’un viaggio, e d’un viaggio nella terra
del passato. Come questo diario di viaggio che io per voi vado scrivendo, mia signora» (Consolo 2015: 413). Infine, la prosecuzione del viaggio, verso la Spagna, forse il Nuovo Mondo, sembra dettata, di botto, soltanto dalla notizia del matrimonio di donna Teresa, non da altri motivi più consoni a un vero viaggiatore. In Retablo troviamo altri episodi o motivi riconducibili all’Odissea. L’ospitalità di Soldano Lodovico potrebbe ricordare quella di Alcinoo; anche l’impressione che Clerici suscita al suo apparire – «e mi sentii, così chiaro di pelo, chiaro di pelle e panni, così alto e scarno, un’apparizione inusitata, un palo o baccalaro come bersaglio di tutte quell’occhiate dritte e acute della corte, oblique e gravi della loggia» (Consolo 2015: 388) – ricorda un po’ l’apparizione di Ulisse a Nausicaa, dopo che si è lavato ma anche dopo che «Atena, la figlia di Zeus, lo fece / più grande e più robusto a vedersi»12. Ci sono dei paragoni espliciti: immergersi nei Bagni Segestani provoca Una dimenticanza di sé, degli altri, di passioni e crucci, come i compagni d’Ulisse che nella terra dei Lotofagi mangiando il fior dolcissimo obliarono il ritorno o chi assunse il farmaco triste o altri doni accettò della magica Circe, o chi si perse ascoltando una volta il canto stregato di Sirene, come mi persi anch’io nel vacuo 12 Omero 2010: 407 (libro VI, vv. 229-230). smemorante, nel vago vorticare, nella felicità senza sorgente e nome» (Consolo 2015: 402). Mentre nella palude di Mozia «annega la memoria: vana sembra la ricerca, la prova d’un racconto»: qui però la posta è più alta, è in gioco la possibilità stessa di narrare, come sfida di conoscenza all’ignoto: «Ma se appena ci volgiamo, castigo di sale, siamo spinti ancora, per lo scarto d’un riquadro, più dentro alla cascata, più presso alla montagna: e troveremo un varco, un passaggio, e cosa ci attende dietro quel sipario?» (Consolo 2015: 442). Nella storia dell’interpretazione del personaggio Ulisse molti si sono soffermati sul fatto che Ulisse è tanto personaggio narrato quanto personaggio narratore di sé, dunque, in qualche modo, controfigura archetipica del narratore, dello scrittore13.
Altri segni odissiaci in Retablo possono esserci anche per opposizione: Curàtolo Nino, «quell’uomo, alto e vigoroso, vestito delle pelli dei montoni» (Consolo 2015: 407), è un anti-Polifemo: ed è talmente anti-Polifemo da essere maestro d’inganni, quando suggerisce a Clerici di fingersi medico risanatore del mal di denti del brigante. Si ricordi il ritornare, come basso continuo nell’opera di Consolo, di Morte per acqua di T. S. Eliot: una sorta di monito periodico, che riguarda il conflitto natura-cultura, oriente-occidente, terra-mare, poesia-commercio. Una specie di inceppo della fantasia, forse un incubo, forse il grande incubo di un greco abitatore di isole14. Ma sul motivo dell’isola bisognerebbe rileggere con attenzione almeno lo Spasimo di Palermo, dove si trovano diverse declinazioni, anche metaforiche, di tale tema: dagli «anni di serena gioia» in cui Chino e Lucia vivono «davanti al grandioso mare, all’isola che appare e che dispare all’orizzonte» (Consolo 2015: 928) giù giù fino all’isola, «che egli in cuore malediva, matrice d’ogni male, estremo lembo, perenne scivolio, annientamento», e infine a Enna, «isola sopra l’altipiano» (Consolo 2015: 931). Lollini giustamente ha ricordato che il viaggio per mare è anche temuto dalla cultura greca, perché implica il rischio della morte per acqua senza seppellimento: in Retablo abbiamo una versione felicemente capovolta di questo timore nell’episodio dell’inabissamento della statua dell’Efebo di Mozia. Dunque, il viaggio non promana soltanto il fascino intellettuale della sfida ai propri limiti (come in Dante), ma anche autentica paura. Tali ambivalenze riguardano anche il rapporto con la Natura di alcuni personaggi di Consolo: si pensi al tema del licantropismo che domina Nottetempo, casa per casa, o in Filosofiana al ‘notturno’ leopardiano di Vito Parlagreco, il quale, per la verità, s’interroga soprattutto sulla labilità della storia, ma poi – nel confronto con il pastorello mutangolo e con la lepre morta – viene profondamente inquietato dal tema funebre. Da lì a una riflessione sulla scrittura, il passo è breve: 13 Ma, a tal proposito, si legga la finissima analisi di O’ Connell, fondata sul confronto tra un passo dello Spasimo di Palermo e il suo avantesto Consolo 1995. Cfr. O’ Connell 2008: 174-179. 14 Cfr. Curi 2005: 77-84. Solo che sogno o favola poco è diverso. Non è sogno tutto quanto si racconta, s’inventa o si riporta, per voce, per scrittura o in altro modo, d’una vicenda d’ieri, di oggi o di domani, d’una vicenda possibile o fantastica? È sempre sogno l’impresa del narrare, uno staccarsi dalla vera vita e vivere in un’altra. Sogno o forse anche una follia, perché dalla follia è proprio la vita che si stacca e che procede accanto, come ombra, fantàsima, illusione, all’altra che noi diciamo la reale. O della morte? (Consolo 2015: 545-546) A proposito della grande metafora ulissiaca dell’erranza, va detto che Consolo la riserva, sì, a diversi suoi protagonisti ma, prima che essa trovi gli accenti tragici e non riconciliati dello Spasimo di Palermo (romanzo in cui sono in gioco davvero tante cose, forse troppe), la metafora dell’erranza mi pare che assuma tinte anche alquanto ambivalenti. Per esempio, se riflettiamo sulla componente autobiografica del tema dell’erranza o dell’esilio, si consideri che Consolo ha narrato in tante occasioni e dietro diversi schermi, finzionali o no, il suo arrivo a Milano, da studente universitario, e la scoperta che esisteva a Milano, non lontano dall’Università Cattolica dove studiava, una sorta di luogo concentrazionario di accoglienza e smistamento per gli emigranti meridionali. Molto onestamente, Consolo non ha mancato di sottolineare come, rispetto al destino animalesco degli emigrati poveri, la sua condizione di studente emigrante fosse piuttosto diversa: non un privilegiato, ma neppure un disperato, ammassato in transito verso altre destinazioni. Ma sul tema dell’esilio abbiamo due ulteriori approfondimenti della prospettiva di Consolo: come abbiamo già visto, nell’Olivo e l’olivastro l’esilio è l’autoesilio, conseguenza del disgusto per l’invivibilità della Sicilia; nello Spasimo di Palermo il discorso da un lato si allarga alla tragedia civile della Sicilia infettata dalla mafia, dall’altro si restringe – ma quanto si restringe in profondità! Mi verrebbe da dire che si verticalizza verso il basso, nel romanzo del marabutto, della tragedia del nascondiglio ipogeo – a una prospettiva individuale, come dimostrano le parole conclusive del primo capitolo: «L’esilio è nella perdita, l’assenza, in noi l’oblio, la cieca indifferenza» (Consolo 2015: 890). In uno scrittore come Consolo, l’influsso omerico non può mancare anche nelle scelte stilistiche. È sufficiente procedere un po’ a casaccio, quasi ad apertura di libro, per trovare qualche esempio. Attingo alle Pietre di Pantalica per un riconoscibilissimo calco omerico come «E Filippo Siciliano […] così parlò» (Consolo 2015: 520), che dà slancio epico a un personaggio di cui Consolo è stato amico e di cui ammirava la coerenza nella lotta per i diritti dei contadini; ma attingo allo stesso libro anche per un modulo spiccatamente narrativo (e che al nostro orecchio suona omerico) che è l’abbrivio epico al passato remoto, spesso seguito da complemento di luogo. Un solo esempio, tra i tanti possibili: «Mossero per via Bivona e Castelvecchio, su per la mulattiera» (Consolo 2015: 515). Weinrich ci ha insegnato che, se il passato remoto è il tempo grammaticale della storia, dell’epos, della guerra, delle vittorie e delle sconfitte, l’imperfetto durativo è il tempo dell’eterna e immutabile ciclicità; attingo da Malophòros: «S’adagiava, tutta l’area sacra, circondata da mura, sul fianco della collina» (Consolo 2015: 580); e, ancor più, alla fine del racconto: A poco a poco non sentii più le parole di Tusa, guardavo Angelina e Ignazio, questi due giovani vecchi di ottant’anni passati, […]. Persone reali, qui con me, su questa collina di Malophòros, in questo radioso mattino del primo giorno dell’anno, che pure a poco a poco svanivano, venivano prese in un vortice, precipitavano con me nel pozzo di Ecate, incontro alle divinità sotterranee, nel mistero e nell’oscurità infinita del Tempo. (Consolo 2015: 581) Nell’economia delle Pietre di Pantalica, Malophòros è il racconto della quiete illusoria, delle accoglienze oneste e liete, dell’immersione nel mondo umano e civile di Selinunte ma anche in quello ctonio della Malophòros appunto: insomma, uno tra i racconti più sereni e rasserenanti che Consolo abbia scritto. Ma come dimenticare che questa quiete è continuamente insidiata dall’agitazione motoria di Ignazio, dell’inarrestabile Buttitta? E come non dire che al suo un po’ eccezionale ritmo piano, alla sua quiete, quantitativamente Consolo preferisce l’agitazione dromomaniaca dei suoi protagonisti? Non solo il cavaliere Clerici, ma anche l’io saggistico di certe pagine delle Pietre di Pantalica (penso soprattutto a Comiso), l’io narrante dell’Olivo e l’olivastro, e soprattutto il povero Chino Martinez dello Spasimo di Palermo. In questi testi è tutto un andare e venire da un punto a un altro della Sicilia, o tra Milano, Parigi e la Sicilia, secondo tragitti – non sono sempre logici sul piano topografico ma dettati da un istinto che è soprattutto non dominabile istinto di fuga – che trovano il loro modulo espressivo preferito nel sintagma «Via da…» che ricorre tante di quelle volte che quasi non fa macchia nel testo; mentre non si può dimenticare, se non altro per l’inciampo semantico costituito dalla voce di origine dialettale e rara, quella sequenza di Retablo di identico significato ma che inizia con «Arrasso, arrasso, mia nobile signora, arrasso dalla Milano attiva» e si conclude circolarmente con «Arrasso dalla mia terra e dal mio tempo, via, via, lontan!» (Consolo 2015: 433), dove il cavaliere Clerici sembra recuperare in extremis con l’avverbio tronco la sua milanesità linguistica pesantemente revocata in gioco dall’uso del meridionalissimo ‘arrasso’15. A questo punto, una piccola divagazione, sempre di segno odissiaco: proprio mentre si trova, e sappiamo che non è un caso, a Selinunte il cavaliere Clerici rifiuta la prospettiva del nostos a Milano, si dichiara felicemente prigioniero (anche dal punto di vista linguistico) della Sicilia che attraversa da ulisside. Bene, il rifiuto della Milano «attiva, mercatora» a me fa pensare non soltanto alle note prese di posizione antiborghesi di Consolo ma anche a un sottotesto che mi rifiuto di credere Consolo non conoscesse: ossia all’Ulisse di Tennyson, che poteva aver letto nella classica traduzione di Giovanni Pascoli, al rifiuto del nostos compiuto, del continuare a regnare su un’Itaca in cui gli abitanti sono in preda alla logica solo economica, alla necessità per questo Ulisse nauseato 15 Lessema il cui uso risale, in Consolo, già alla Ferita dell’aprile: cfr. O’ Connell 2008: 182, nota 59. di ripartire verso l’ignoto e di affidare lo scettro a Telemaco (di lui più adatto a intendersi con i regnicoli imborghesiti). Mentre non sarà senza significato che nello Spasimo di Palermo sia il figlio a sperimentare la condizione dell’esilio: come dire che a Itaca non c’è più posto nemmeno per Telemaco, mentre a Ulisse-Chino Martinez è riservato non l’esilio in un luogo (Parigi) dove, di fatto, Mauro si è rifatta una vita, ma l’erranza. Un paio di considerazioni finali. Non ho ancora menzionato il rapporto tra i viaggi dei personaggi alter ego di Consolo e il viaggio di Goethe in Sicilia, perché la mia intenzione era quella di utilizzare il meno possibile le pagine saggistiche e concentrarmi sul Consolo narratore. Però il saggio raccolto in Di qua dal faro mi dà l’agio di ricordare che, mentre Consolo sottolinea il fatto che Goethe ha dimostrato, in Sicilia, di volere sfuggire al rischio di «varcare la soglia dell’ignoto» (Consolo 2015: 1220), Consolo, nei suoi romanzi, ha dimostrato di volere affrontare l’ignoto, i suoi fantasmi, il mondo ctonio che li contiene anche se non li placa, ma l’ha fatto utilizzando tutte le mistificazioni letterarie possibili: i mascheramenti, gli spostamenti, i veli e i filtri che gli venivano offerti dal gioco, appunto letterario, di specchi, reduplicazioni, metafore, simboli, rimescolamenti di carte e raddoppiamenti di alter ego. Tutte armi più che legittime del suo armamentario mentale che forse non è barocco soltanto in Retablo o in Lunaria: si pensi al fatto che il romanziere delle scritte del Sorriso dell’ignoto marinaio ha inserito una scritta anche nel testamentario Spasimo di Palermo, ed è, non a caso, l’iscrizione incisa sull’arco dell’ingresso alla grotta dei Beati Paoli, che recita «per arte e per inganno» (Consolo 2015: 910). Se le armi del raddoppiamento e del nascondimento sono per l’autore più che legittime, anche il lettore è legittimato a tentare di smascherarle. E a chiedersi, per esempio, se il marabutto dello Spasimo di Palermo non sia anche un aleph, ovvero – come mi pare che il testo suggerisca – l’illuminazione su una verità sconcertante, appresa da «un libro raro, da sempre sognato, sul quale aveva oltremodo fantasticato, topographia e historia general de argel» (Consolo 2015: 954). A interrogarsi su «i sensi vari del nome marabutto» (Consolo 2015: 955): non solo un luogo-incubo il cui ricordo rinnova lo strazio di Lucia e di Chino, ma anche un uomo, prete della moschea o maestro del Corano, eremita santo o sacro pazzo: si ricordi che nella pagina proemiale in corsivo leggiamo un «T’assista l’eremita» (Consolo 2015: 877), dunque un auspicio che così viene a cadere; e si pensi, sia pure per un attimo e senza trarne illazione alcuna, alla follia di frate Agrippino o al male catubbo del luponario. D’altra parte, lo sappiamo bene dal proemio, Chino Martinez è un’ennesima nuova versione del multiforme mito di Ulisse: è un Ulisse che arriva, sì, a Itaca ma trova la reggia vuota, senza la Penelope impazzita e morta, dunque non sa a chi svelare «il segreto che sta nelle radici» e, preda di questa tragedia, ha bisogno della calma per «ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza». Il nome, il punto: l’aleph, insomma. E siamo legittimati a chiederci, infine, perché nello Spasimo di Palermo Consolo fa morire Chino Martinez insieme a Borsellino e non insieme a Falcone. Domanda stupida? Non so, io me la sono posta solo adesso, ripensando al fatto che, nell’immaginario collettivo degli anni atroci che abbiamo vissuto – noi da spettatori, altri un po’ meno –, il giudice Falcone aveva una ‘presenza’ simbolica e un carisma superiori a quelli di Borsellino. E allora, perché non lui ma Borsellino? Mi sono dato tre risposte, di ordine assai diverso: la prima, che spalmo sul piano della realtà, è che, se già la strage di Capaci era stata vissuta dall’opinione pubblica come un’enormità, l’omicidio di Borsellino, così immediatamente successivo, fu vissuto ancora peggio, come l’emblema di una misura ormai colma; la seconda risposta è che sarebbe apparsa una ben misera casualità il fatto che Chino Martinez sfrecciasse sull’autostrada contemporaneamente alla macchina di Falcone (però questa risposta funziona sul piano della coerenza narrativa e della verosimiglianza romanzesca, a dimostrazione del fatto che, anche in un’opera-limite come lo Spasimo di Palermo, Consolo doveva pur fare i conti con le regole e le tradizioni del romanzo, che invece non mancava mai di definire come un genere ormai defunto); la terza risposta non si colloca su un piano, ma s’inabissa nei sottoscala del profondo, o dell’inconscio, e riguarda il fatto che, mentre Falcone muore insieme alla moglie, Borsellino invece
muore davanti agli occhi della madre. Della quale Chino aveva in precedenza immaginato la pena, l’ansia e, nella sua immaginazione, aveva pensato a come
anche Lucia, se fosse sopravvissuta alla follia, avrebbe atteso con ansia e con pena il ritorno di Mauro. L’ansia e la pena, se si vuole, di Penelope. E già che siamo a questa trafila metaforica femminile, vale la pena di ricordare il bellissimo inizio del decimo capitolo, quando Chino stenta a ricordare i tratti del volto di Lucia, che pare poi trascolorare in Euridice («il volgere le spalle, l’andarsene man mano, lontana nel sacro regno, oscuro») ma anche, poco dopo, nella potentissima immagine omerica dell’impossibile abbraccio di Ulisse all’ombra della madre: «La piena assenza. Lui mùtilo, smarrito, perso nell’inconsistenza, nel protendere le braccia, stringere a sé un’ombra» (Consolo 2015: 958). La madre, dunque, arcana immagine – omerica e perenne – collegata alla morte.
Bibliografia
Boitani P., 20122, L’ombra di Ulisse. Figure di un mito, Bologna, il Mulino.
Consolo V., 1993, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, a
cura di Renato Nisticò, Roma, Donzelli.
Consolo V., 1995, I barboni, in: Sgubin: Opere 1988-1995, Milano, Electa.
Consolo V., 2012, La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina, Milano,
Mondadori.
Consolo V., 2015, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni
Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani».
Consolo V., Nicolao M., 1999, Il viaggio di Odisseo, Milano, Bompiani.
L’ulissismo intellettuale in Vincenzo Consolo 111
Curi U., 2005, «Uno, nessuno, molti: ritratto di Odisseo», Letture Classensi,
n° 32-34, 2005, p. 77-84.
Lollini M., 2005, «Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo,
moderno Odisseo»¸ Italica, LXXXII, n° 1, 2005, p. 24-43.
O’Connell D., 2008, «Consolo narratore e scrittore palincestuoso», Quaderns
d’Italià, 13, p. 161-184.
Omero, 2010, Odissea, traduzione di Vincenzo Di Benedetto, Milano, Rizzoli.
Traina G., 2001, Vincenzo Consolo, Fiesole, Cadmo.
Traina G., 2014, Siciliani ultimi? Tre studi su Sciascia, Bufalino, Consolo. E oltre,
Modena, Mucchi.
Turchetta G., 2015, «Da un luogo bellissimo e tremendo», in: Consolo V., L’opera
completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno
scritto di Cesare Segre, Milano, Mondadori, «I Meridiani», p. XXIII-LXXIV
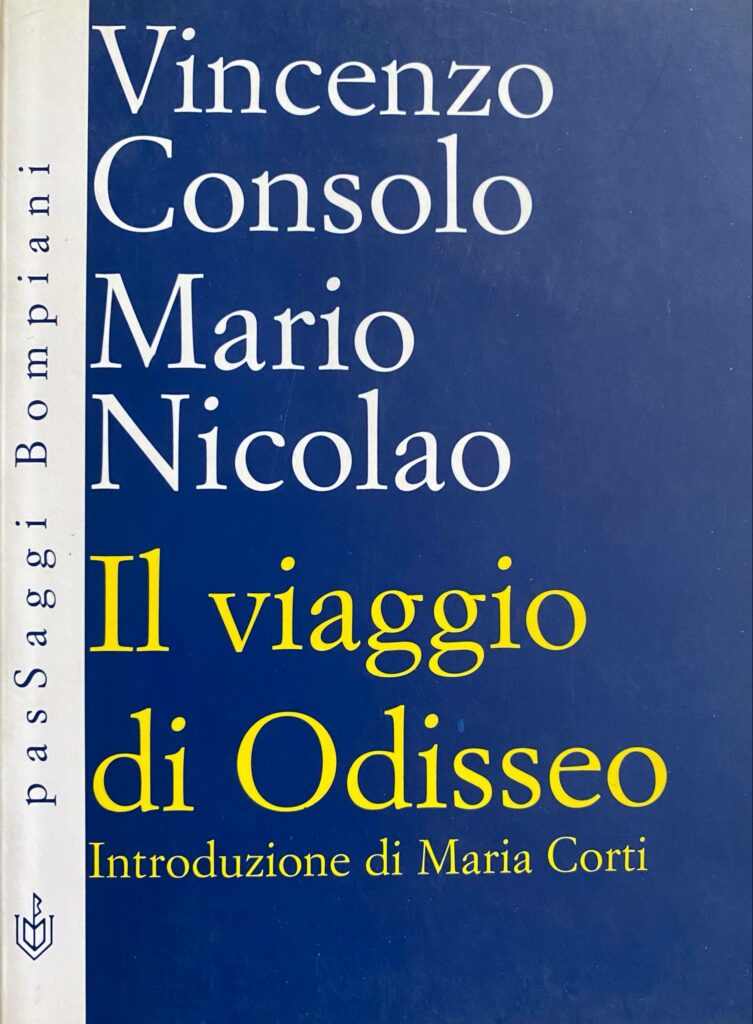
reCHERches
Culture et histoire dans l’espace roman
21 | 2018
Studi per Vincenzo Consolo.
Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo

Intrecci mediterranei.
La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo
di Massimo Lollini
Cosa in comune quest’isola di culto, questo giardino, i suoi astanti, cosa l’ affabile algerino, tu coi cristiani di Bosnia, Sarajevo, i mercenari d’ogni Africa, i trafficanti d’armamenti, i boia d’ogni scarica e veleno, i Mafiosi del potere? Nel bronzo, si, e la crepa, il varco in ogni sacro testo, ogni decalogo, codice latino o d’altra lingua, dentro te, ognuno in questo tempo feroce e allucinato. (Lo spasimo di Palermo 41-42) Il mare, l’infinito e la guerra Concludendo un’importante riflessione sull’eredita mediterranea nella cultura europealo storico Georges Duby osservava un ventennio fa che “da circa un secolo il Mediterraneo offre a chi lo scruta, agli avamposti della speranza, un volto di violenza” (Duby 282). In realta questo volto violento richiama alla memoria storica la “parte piu tenebrosa” dell’eredita del classicismo greco-romano presente fin nelle origini della civilta mediterranea. Nella ricostruzione dei momenti fondamentali di questa civilta lo stesso Fernand Braudel ha sottolineato il carattere decisivo dei “conflitti tra civilta” da quelli brevi (Maratona, Lepanto) a quelli lunghi, come le tre guerre puniche o le crociate. Secondo Braudel questi conflitti mettono bene in evidenza “quali urti sordi, violenti e reiterati si scambino quegli animali possenti che sono le civilta”; e come le civilta siano “intrise di guerra e di odio, una immensa zona d’ombra che le divora quasi per meta” (Braudel, “La Storia” 110-11). Tuttavia le civilta non sono solo questo odio fabbricato e nutrito per l’altro. Esse rappresentano anche l'”eredita dell’intelligenza” l’accumulo dei beni culturali, sacrificio. Questi due elementi, quello “distruttivo” e quello “costruttivo,” appaiono strettamente intrecciati e appare quanto mai arduo e problematico il tentativo di separarli quasi fossero realta distinte ed autonome, come talora sembra proporre lo storico Braudel. La ricerca sul ruolo del Mediterraneo nella formazione dell’immaginario letterario europeo deve cogliere questo aspetto, se non vuole assecondare la marea montante di parole che puntano a derealizzare l’esistente e a costruire un mondo puramente ideologico che finisce per cancellare ogni consapevolezza della realta in cui si vive. Il saggio prende avvio da una riflessione sul nesso che si stabilisce nella cultura greca da una parte trail mare e l’orientamento verso l’infinito, e dall’altra trail mare e la guerra. Le due nozioni, quella di una ricerca intellettuale infinita e quella della guerra come esito inevitabile dell’attraversamento del mare, trovano un modello esemplare nella figura dell’Ulisse omerico, che i greci hanno lasciato in eredita alle letterature europee dall’antichita fino ai nostri giorni. L’esperienza della guerra di Troia ha segnato Ulisse in maniera profonda, rendendolo capace di un senso di pietas per il dolore proprio e altrui inconcepibile nel contesto dell’Iliade che rimane il “poema della forza” come ha scritto Simone Weil. L’episodio di Odisseo nella reggia feacia che piange sentendo il canto di Demodoco (da lui stesso richiesto) dove si racconta l’inganno del cavallo di Troia, e senza dubbio rivelativo di un profondo mutamento dell’eroe nel passaggio dal primo al secondo poema omerico (Odissea, libro VIII). Ma e la catabasi raccontata nel canto XI che rende manifesto in maniera inequivocabile il cambiamento rispetto al codice dell’eroismo al centro dell’Iliade. L’episodio piu potente rimane l’incontro con l’anima di Achille che preferirebbe essere un servo di una padrone povero piuttosto che essere morto. Emerge qui con forza la novita piu profonda dell’Odissea, il riconoscimento del dolore della propria morte e la scoperta della privazione dell’identita che essa comporta. La discesa di Odisseo nell’Ade rimane centrale nell’economia del racconto omerico cosi come si articola nei due poemi. Odisseo desidera ardentemente incontrare non solo Tiresia per conoscere il proprio destino, ma anche le anime di molti defunti per interrogarle sulle modalith e il senso della morte. In essi Odisseo trova una sapienza che e estranea ai vivi, la consapevolezza profonda del dolore che pervade la vitae il limite invalicabile rappresentato dalla morte. Altri momenti significativi del viaggio di Odisseo nell’Ade sono l’incontro con l’anima del compagno Elpenore e quello con la madre piangente. L’anima di Elpenore e la prima che si fa incontro ad Odisseo e lo implora di seppellire e compiangere il suo corpo rimasto in casa di Circe senza sepoltura. La dimensione del compianto e del lamento funebre per la morte dell’altro e al centro anche dell’incontro con l’ombra della madre. Il figlio vivo si trova qui unito alia madre morta nel comune desiderio di dare espressione al proprio dolore e al proprio pianto. Il viaggio nell’Ade e il lamento funebre sono importanti per Odisseo e la cultura greca e mediterranea almeno nella stessa misura del viaggio in mare. (4) Il viaggio in mare rappresenta cio che si teme piu profondamente, l’esposizione al pericolo infinito e incondizionato, la paura di una morte negli abissi marini senza sepoltura umana. Il viaggio nell’Ade e la sepoltura rappresentano la riconciliazione con gli esseri umani e divini, il conforto rappresentato dal lamento funebre che aiuta a vivere e a dare un senso sia pure straziante alla morte. Ma anche se tu tornassi se le distanze si accorciassero e la guida fiammeggiasse nel tuo sembiante tragico o nel tuo terrore intimo, sempre per me tu saresti la storia della partenza per sempre tu saresti in una terra senza promessa in una terra senza ritorno. Anche se tu tornassi, Ulisse. (Adonis Poesie) Questi versi, letti insieme a quelli di un’altra poesia di Adonis, L’erranza, bastano da soli a far comprendere come la condizione dell’esilio e dell’erranza siano una condizione irreversibile nella cultura mediterranea moderna sia nel mondo cristiano che in quello arabo. I versi di Adonis sono veramente significativi, soprattutto se letti insieme alle sue dichiarazioni di poetica (5): L’erranza, l’erranza L’erranza ci salva e guida i nostri passi L’erranza e chiarezza E il resto e solamente maschera L’erranza ci lega a tutto quello che e altro Ai nostri sogni imprime il volo dei mari E l’erranza e attesa. (Adonis Poesie) Nel verso “L’erranza ci lega a tutto quello che e altro” e contenuto il senso profondo della condizione dell’Odisseo moderno cosi come si manifesta nella tradizione mediterranea araba e cristiana, con molti punti in contatto con analoghe concezioni ebraiche che pure non si riferiscono al mito di Ulisse ma a quello di Abramo. Si tratta di una condizione di continuo esilio che rifiuta ogni certezza in nome di un apprezzamento intrinseco di tutto cio che e altro. Pur comprendendola Dante condanna la ricerca intellettuale di Ulisse dal momento che non e illuminata dalla luce divina. Per questo il viaggio di Ulisse rimane un “folle volo” che mantiene comunque qualcosa in comune con qualunque aspirazione alla conoscenza autentica e creativa, come sapeva bene Dante e come sanno gli scrittori moderni e contemporanei che sono venuti dopo di lui. Vincenzo Consolo dedica un capitolo de L’olivo e l’olivastro (1994) alla riscrittura del viaggio di Odisseo che viene presentato come metafora dell’esperienza del viaggio dello scrittore siciliano attraverso la sua isola e, piu in generale, come figura dell’uomo moderno e dello sradicamento esistenziale e storico provocato dalla civilta tecnologica da lui creata. Dopo la risoluzione del conflitto Ulisse si trova di nuovo immerso nella vastita del mare. Il suo viaggio questa volta procede in verticale e si presenta come “una discesa negli abissi, nelle ignote dimore, dove, a grado a grado, tutto diventa orrifico, subdolo, distruttivo” (19). Il viaggio di Odisseo nasce dall’orrore della guerra e dal senso di colpa per le morti e le distruzioni, e il viaggio di un sopravissuto. (9) E un viaggio dal mare verso la terra, da Oriente ad Occidente, “dall’esistenza alla storia, dalla natura alla cultura” (124) un viaggio al termine del quale non c’e la patria agognata, ma la condizione perenne dell’esilio. L’Itaca che trova l’Ulisse moderno non esiste pit perche e sottoposta ad una continua distruzione, del tutto simile a quella che esperimenta durante la guerra. Per questo, scrive Consolo, Ulisse comprende che Itaca coincide con Troia ed e costretto a ripartire, condannato ad una condizione di erranza. Nessun viaggio penitenziale o liberatorio appare possibile allo scrittore siciliano. Itaca la citta del mito non esiste pit; le citth della memoria e della letteratura appaiono sempre piu lontane. Siamo Iontani dal modello rappresentato da Conversazione in Sicilia di Vittorini che pure ha ispirato gli ultimi due romanzi di Consolo. Il romanzo di Vittorini poteva ancora contare sulla “conversazione” come mezzo per una rigenerazione spirituale e morale. Il ritorno di Silvestro in Sicilia serve proprio a questo e si nutre di un potente linguaggio lirico e simbolico che aiuta il protagonista a ritornare ormai deciso e maturo nella Milano del lavoro, dell’industria e della lotta politica per la costruzione di una nuova Itaca. La critica della cultura per Consolo non si nutre piu di alcuna utopia, mentre la posizione privilegiata della coscienza che valuta e giudica l’ordine delle cose appare sempre piu pervasa da domande inquietanti. Il paesaggio che ci descrive Consolo ha perduto la dimensione lirica e simbolica assumendo una sostanza allegorica in cui non si intravede una via di riscatto. E un paesaggio di rovine quello a cui approda l’Odisseo moderno. Un paesaggio in cui l’immagine di Itaca appare sbiadita al punto da scomparire. L’unica alternativa per lui sembra essere quella, gia indicata da Dante, del naufragio definitivo come conseguenza del “folle volo” di Ulisse. Si tratta di un’immagine drammatica, che Primo Levi ha fatto sua a conclusione del capitolo “Il canto di Ulisse” che non a caso ha un ruolo centrale in Se questo e un uomo. Per Consolo, come per Primo Levi (e Italo Calvino), la posizione etica delia scrittura consiste sempre piu in questa volonta di testimonianza che pone questioni fondamentali sul destino della civilta europea, e si esprime in domande radicali che coinvolgono il gesto stesso della scrittura, intesa come strumento fondamentale della cultura, della tecnologia e del sapere occidentale. Occorre allora chiedersi se la nozione di “esilio” su cui Consolo stesso ha insistito, sia la piu adeguata e dar conto dello spessore della sua ricerca intellettuale. Ritorneremo su questa importante questione nell’ultima parte del saggio. Le domande dello scriba menzogna l’intelligibile, la forma, o verita ulteriore? (Nottetempo 164) E questa la situazione in cui si muove anche il protagonista de Lo spasimo di Palermo (1998), Gioacchino Martinez, scrittore in crisi che si trova sempre piu perplesso e sgomento di fronte al gesto della scrittura: Aveva tentato infinite volte la scrittura, lettere memorie resoconti, ma l’orrore nasceva puntuale per quell’ordine assurdo, quel raggelare la ferita, quella codificazione miserevole dell’assenza prima e poi assoluta, dell’improvviso vuoto, dello sgomento fisso. (53) Questi ragionamenti sulla scrittura, piuttosto che ridursi a puro gesto autoriflessivo e solipsistico, rappresentano la linfa profonda che collega la riflessione di Consolo nella trilogia romanzesca rappresentata dal Sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo. Come accade in Primo Levi, Italo Calvino e nei maggiori scrittori del Novecento, Consolo inserisce nell’orizzonte della scrittura letteraria la presenza di un soggetto filosofico che riflette sulla propria attivita, nel tentativo di comprenderne l’orizzonte e il senso. Accade cosi chela domanda sulla possibilita del racconto e della scrittura e la parallela aspirazione a dare una testimonianza vera dei processi storici possono trovare espressione non tanto nella dissoluzione della forma e della soggettivith, ma nel “vuoto della forma” e nella decisione in base alia quale il soggetto filosofico trova nella contingenza della propria vita il proprio modo di abitare la verith (Lollini). Non posso dire di ricordare esattamente come e quando il mio greco scaturi dal nulla. In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra: il mondo intorno a noi sembrava tornato al Caos primigenio, e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava in moil ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi. (I: 226; mia l’enfasi) In maniera significativa la stessa metafora ritorna alia fine, nell’ultima pagina del libro in cui si spiega perche il viaggio di ritorno non e stato ne poteva essere un viaggio liberatorio: … non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. E un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un’ angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade o si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone e l’angoscia si fa piu intensa e piu precisa. Tutto e ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o l’inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. (I: 395; mia l’enfasi) Alla fine del lungo e avventuroso cammino che, come buona parte della narrativa di viaggio ha come modello appunto l’Odissea di Omero, Levi deve constatare di non essere riuscito ad allontanarsi dal Campo e che anche nella sua Itaca la memoria del Lager ritorna ossessiva e implacabile: Testimonianza e alterita Non riconosci la terra da cui eri partito. Chi sia, domandano, il reduce avvolto nella nebbia, nascosto dietro la vizza maschera del viso, privo di doni, di bottino. (Lo spasimo di Palermo 101) Le vicende storiche piu recenti, dalla guerra nella ex-Jugoslavia agli attuali conflitti in Afghanistan e Iraq, non fanno che confermare le tendenze remote della storia Europea nell’era della globalizzazione. L’attraversamento del mare finisce per dar luogo anche oggi al conflitto armato e alla fondazione di un ordine mondiale fondato sulla forza e sul mancato riconoscimento dei valori positivi insiti nella diversith culturale. E significativo che l’operazione bellica che ha portato all’ulteriore distruzione dell’Afghanistan gia stremato dalla poverta e dalla guerra pluridecennale sia stata chiamata “Giustizia infinita.” In quell’ aggettivo e da riconoscere un orientamento antico della civilta occidentale nata sulle sponde del mare greco. Ancora una volta il mare non appare un luogo di incontro e di comunicazione, ma di conflitto e di conquista che oggi assumono dimensioni planetarie. L’era attuale e stata preparata dalle rivoluzioni scientifiche e spaziali del diciassettesimo secolo. Sul piano scientifico, come ha scritto Koire si e passati dal mondo cosmico e chiuso della scienza antica aristotelica e tomistico-medievale all’universo infinito della scienza moderna, introdotta dal canocchiale di Galileo. La metafora geometrica e spaziale serve a introdurre la grande rivoluzione della concezione della spazio di cui ha parlato Carl Schmitt che vede in questo secolo e nelle scoperte geografiche che lo hanno preparato l’affermarsi di una dimensione “oceanica” della storia universale, con un’enorme dilatazione dello spazio, fattosi infinito e “vuoto.” Schmitt parla del passaggio dal nomos della terra fondato sulla condizione continentale europea e caratterizzato dal carattere locale dei conflitti al nomos del mare, in cui predomina l’infinito, dell’incondizionato, il movimento e la volonta di potenza, la guerra totale e lo spirito della tecnica senza piu limiti. Il mare di cui parla Schmitt non e piu il Mediterraneo, ma l’Oceano che e il vero protagonista della rivoluzione spaziale moderna e serve per comprendere la dimensione mediterranea in un orizzonte piu vasto e attuale. Schmitt vedeva nella condizione insulare dell’Inghilterra (e a suo modo degli Staff Uniti) il simbolo di questa rivoluzione spaziale alle origini della modernita (Schmitt). Sono fenomeni ancora in corso che si manifestano nei conflitti sempre piu numerosi e incontrollati. Consolo-Odisseo moderno continua i suoi viaggi nel Mediterraneo per portare testimonianza di questi processi violenti in toni che a tratti si fanno apocalittici e profetici. In questa prospettiva si collocano gli scritti giornalistici usciti negli ultimi anni sul Corriere della sera o l’Espresso. Tra questi ultimi spiccano “Viaggio a Sarajevo” e “Viaggio in Israele/Palestina del PIE.” Nel primo testo Consolo racconta di un viaggio fatto con altri scrittori italiani per testimoniare la guerra sanguinosa della ex Jugoslavia. (12) Ritroviamo qui il paesaggio di rovine e distruzione che hanno colpito soprattutto Sarajevo, una citta un tempo civile e fiorente nella tolleranza religiosa ed etnica. La testimonianza di Consolo insiste sulle atrocita commesse da uomini ormai privi di ragione e ridotti a natura, tanto che l’immagine di Sarajevo devastata dalla violenza umana a suoi occhi assomiglia alle immagini di Assisi colpita da un terribile terremoto nei giorni in cui egli si trovava a Sarajevo. n questo ambito di scritti tra testimonianza e profezia occorre ricordare anche il “Memoriale di Basilio Archita” (Consolo, Le pietre di Pantalica 183-91), un breve racconto-saggio dove lo scrittore testimonia di un’altra tragedia che insanguina il Mediterraneo nei nostri giorni. Si tratta del racconto della morte violenta di un gruppo di africani che imbarcatisi clandestinamente su una nave greca sono poi gettati in mare e divorati dai pescecani. La tragedia dei clandestini che muoiono nel tentativo disperato di attraversare il mare per sfuggire ad un destino di fame e poverta non aveva ancora assunto le dimensioni attuali quando Consolo scrive questo testo. Le sue parole assumono qui un ruolo veramente profetico nel mostrare il livello di degenerazione raggiunto dalla civilta greca e mediterranea. I versi del poeta greco Kavafis recitati dal vicecomandante della nave greca non fanno che confermare la decadenza di una cultura priva di un senso di responsabilita o di una visione etica e civile della convivenza umana. Si tratta di una cultura ormai incapace di riconoscere se stessa. La voce narrante del racconto, e quella di Basilio Archita un giovane sfruttato a bordo della nave greca che pure esprime un elementare senso di solidarieta con le vittime. Tuttavia egli non e affatto consapevole dell’origine greca del suo nome e trova un senso di identita unicamente nell’abbigliamento offerto dal consumismo di massa. In questa situazione per tanti aspetti distruttiva risulta veramente preoccupante il venir meno di un vigile senso critico nella cultura contemporaneo come si vede nell’accettazione sempre piu passiva dei fenomeni distruttivi in corso, e nel consenso diffuso che hanno incontrato in occidente le parole d’ordine di guerra dopo gli eventi del terribile il settembre 2001. Minoranze sempre piu esigue si oppongono con la forza della ragione a questo stato di cose dove la violenza del terrorismo e quella degli stati belligeranti non sembra aver piu limiti. Questa situazione ci aiuta oggi a capire il senso profondo delle opere di scrittori come Levi e Consolo che hanno denunciato il carattere pervasivo della maledizione tecnologica e del contagio della violenza distruttiva che domina la storia dell’Occidente. Proprio in questa testimonianza consiste l’attualith e la forza del loro messaggio non tanto nell’adesione al pensiero dell’erranza e dell’esilio che pure e presente nei loro scritti. NOTE (1) Della Weil the considera la guerra come “il principale motore della vita sociale” (Quaderni 1: 189), si veda il fondamentale saggio “L’Iliade poema della forza” (Weil 10-41). Cfr. anche la raccolta di saggi Sulla guerra. Hannah Arendt indica l’esistenza di un rapporto strutturale tra polemos e polis. Sostiene the la violenza e la guerra di per se non sono politiche ma fondano tuttavia la politica. Si veda la raccolta di saggi Arendt tradotia in italiano con il titolo Politica e menzogna (Milano: SugarCo, 1985). Su tutta la questione si veda Esposito. (2) Su questo aspetto si veda Boitani che intende Ulisse come “figura” o umbra nel senso di Auerbach. (3) Su questo punio, si veda Gentiloni. Put criticando l’impostazione schematica di Levinas Gentiloni sottolinea le differenze tra Ulisse e Abramo e indica nel cerchio la metafora della cultura greca e nella freccia quella della cultura ebraica, la logica contro il suo superamento (121). (4) Ernesto de Martino ha mostrato l’esistenza di una modalita mediterranea del lamento funebre a partite da uno studio sul pianio rituale delle donne lucane. Cfr. De Martino. La prima edizione del saggio e del 1958. (5) Adonis sostiene the la modernita non e specifica di un paese o di un popolo. Il suo aspetto universale consiste nello sviluppo scientifico che non si puo evitare. Adonis sostiene una visione creativa della modernita e conclude: .” .. the questions ‘What is knowledge?’, ‘What is truth?’, ‘What is poetry?’ remain open, … knowledge is never complete and truth is a continuing search” (Adonis, An Introduction to Arab Poetics 101). Cacciari, Massimo. Geo-Filosofia dell’Europa. Milano: Adelphi, 1994. Consolo, Vincenzo. Le pietre di Pantalica. Milano: Mondadori, 1988. –. Nottetempo, casa per casa. Milano: Mondadori, 1992. –. L’olivo e l’olivastro. Torino: Einaudi, 1994. –. Lo spasimo di Palermo. Milano: Mondadori, 1998. –. Di qua dal faro. Milano: Mondadori, 1999. –. Il sorriso dell’ignoto marinaio. 1976. Torino: Einaudi, 2000. Consolo, Vincenzo, e Franco Cassano. Rappresentare il Mediterraneo. Lo sguardo Italiano. Messina: Mesogea, 2000. Consolo, Vincenzo, e Mario Nicolao. Il viaggio di Odisseo. Milano: Bompiani, 1999. De Crescenzo, Assunta. “Paesaggio e mito Mediterraneo Nell’opera di Luigi Pirandello.” Il mare ciclope. Per un’identita Mediterranea. III Concerto Spettacolo. Atti del Convegno di Napoli 24 Aprile 1999. Ed. Assuta De Crescenzo e Aristide La Rocca. Napoli: Liguori, 2003. De Martino, Ernesto. Morte e pianto rituale nel mondo antico. Torino: Einaudi, 1958. Duby, Georges. “L’eredita.'” Il Mediterraneo: lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni. Ed. Fernand Braudel. 1985. Milano: Bompiani, 2003. 267-82. Esposito, Roberto. L’origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil? Roma: Donzelli, 1996. Gentiloni, Filippo. “Il viaggio fra mito e religione: Abramo Contro Ulisse.” Il viaggio. Ed. Di Giovanni Gasparini. Roma: Edizioni Lavoro, 2000. 117-32. Koyre, Alexandre. Dal mondo chiuso all’universo infinito. Milano: Feltrinelli, 1988. Levi, Primo. Opere. Ed. Marco Belpoliti. 2 vols. Torino: Einaudi, 1997. Levinas, E. “La signification et le sens.” Revue de Metaphysique et de Morale 2 (1964): 125-56. Lollini, Massimo. Il vuoto della forma. Scrittura, testimonianza e verita. Genova: Marietti 1820, 2001. Mondolfo, Rodolfo. L’infinito nel pensiero dell’antichita classica. Firenze: La Nuova Italia, 1956. Montanari, Franco. “I1 viaggio come motivo mitico. Odisseo, il ritorno al passato e un pensiero a Edipo.” Da Ulisse a Ulisse: il viaggio come mito letterario. Atti Del Convegno Internazionale Imperia, 5-6 Ottobre 2000. Ed. Giorgetta Revelli. Pisa: Istituti editoriali e poligrafici intemazionali, 2001. 37-48. Propp Ja, Vladimir. Morfologia della fiaba–le radici storiche dei racconti di magia. Roma: Newton Compton, 2003. Schmitt, Carl. Terra e mare. Milano: Giuffre, 1986. Shay, Jonayhan. Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character. New York: Atheneum Macmillan, 1994. Spinazzola, Vittorio. Itaca, addio. Vittorini, Pavese, Meneghello, Satta: il romanzo del ritorno. Milano: Il Saggiatore, 2001. Weil, Simone. “L’iliade poema della forza.” La Grecia e le intuizioni precristiane. Roma: Borla, 1984. –. Quaderni. A cura di Giancarlo Gaeta. Vol. 1. Milano: Adelphi, 1982. –. Sulla guerra. Scritti 1933-1943. Milano: Pratiche, 1998. MASSIMO LOLLINI University of Oregon Bibliography for: “Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo” Massimo Lollini “Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno
Odisseo”.
Italica. FindArticles.com. 21 Feb, 2012.
“AMOR SACRO”CRONACA DI UN ROMANZO MAI NATO
di Sergio Buonadonna
Dopo dieci anni di silenzio Vincenzo Consolo torna al romanzo. Considerato l’erede di Vittorini e Sciascia, ma dai più accostato a Gadda per la sua scrittura espressiva, il grande narratore siciliano (78 anni, più di quaranta vissuti a Milano, “il luogo dell’emigrazione come fu per Verga”) si ripropone con una metafora storico-sociale e una scrittura palinsestica (cioè scrittura su altre scritture) come nella sua famosa trilogia: “Il sorriso dell’ignoto marinaio” tema il Risorgimento, “Nottetempo casa per casa” (il fascismo), “Lo Spasimo di Palermo” (la contemporaneità fino alle stragi Falcone e Borsellino). Al grande ritorno sta accudendo da anni, ne è segno la fitta libreria d’epoca accumulata accanto al suo tavolo da lavoro che domina l’ampio studio carico di volumi, quadri e disegni tra cui quelli a lui carissimi di Guttuso e Pasolini. Racconta Consolo: “Il titolo di questo romanzo storico, lo dico con molto pudore, è Amor Sacro, è un processo d’Inquisizione di cui ho trovato i documenti all’Archivio di Madrid: una storia che si svolge in Sicilia. La vicenda riguarda un monaco e quindi Amor sacro direi che è appropriato. Ma non voglio aggiungere altro ché sarebbe impudico. Il secolo è la fine del Seicento, tempo, luogo e stagione di furori e misteri. Tuttavia non dico come Arbasino: sapesse signora mia la mia vita è un romanzo. I miei libri sono sempre storico-metaforici. Spero”. Si parla del passato per dire del presente? “Sans doute, come dicono i francesi. Senza dubbio”. Sicché – pubblicato questo libro tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 – dovremmo vedere finalmente il Meridiano che raccoglierà la tua opera?“ Tutta l’opera completa, questo è l’accordo con Mondadori anche se devo chiarire che ho atteso a lungo perché il mio contratto iniziale era con Arnoldo Mondadori. Berlusconi è arrivato dopo e come si sa io non ho molto piacere di lavorare per il cavaliere. Ma rispetterò i patti. Nel Meridiano ci saranno anche i miei scritti giovanili. Giorni fa è venuto a trovarmi un professore dell’Università di Gerona, bravissimo, che sta curando tutti i miei racconti. Il primo risale al 1952”.È giusto definire un tuo libro romanzo o narrazione? Ne “Lo Spasimo di Palermo” appare infatti il tuo manifesto letterario quando avverti: ‘il romanzo è un genere scaduto, corrotto, impraticabile…’“Quando negli anni Sessanta ho cominciato a scrivere il mio primo libro, ho visto cos’era accaduto nel nostro Paese soprattutto dal punto di vista linguistico, ma anche in campo letterario, politico, civile. C’era stata una forte mutazione, l’esodo dei contadini del sud, la ricerca di una lingua altra che non fosse quell’italiano che – come dice Leopardi – aveva l’infinito in sé. La lingua italiana l’aveva perso, s’era orizzontalizzata perciò il mio scrupolo è stato reperire dei preziosi giacimenti linguistici che ci sono in Sicilia, dove sono passate tante civilizzazioni, recuperare vocaboli immettendoli nel codice italiano. In Sicilia questi giacimenti linguistici significano greco, latino, spagnolo, arabo, tante parole che riportavo in superficie. Un giorno un dialettologo dell’Università di Catania mi chiese dove hai preso la parola “calasía” perché nei vocabolari siciliani non c’è? Gli risposi: viene dal greco kalós che vuol dire bello. Nella mia zona tra le province di Messina e Palermo, che è greco-bizantina si dice che calasía, che bellezza”. Insisto. Che cosa distingue il romanzo dalla narrazione? “È la distinzione che fa Walter Benjamin. Nella tragedia greca c’era l’anghelos, il messaggero che arrivava in scena, si rivolgeva al pubblico della cavea e narrava quello che era successo altrove in un altro momento. Oggi io dico che la cavea è vuota, non ci sono più i lettori. Quindi non sai a chi rivolgerti e perciò l’anghelos non appare in scena. Sono i lettori che scelgono l’autore”. Tu in Sicilia avevi scelto Lucio Piccolo e Sciascia. Come si collocano nella tua formazione? “Per me Piccolo e Sciascia erano due riferimenti fondamentali. Quando ho pubblicato “La ferita dell’aprile” l’ho mandato con una missiva a Leonardo Sciascia e lui mi ha risposto con una bellissima lettera invitandomi ad andarlo a trovare a Caltanissetta. È nato un rapporto di amicizia, quando ci incontravamo le nostre conversazioni sulla Sicilia erano davvero intense e avvincenti. Dall’altra parte c’era Lucio Piccolo, che era di Capo d’Orlando, stava nella villa in campagna con il fratello Casimiro, un esoterico, e la sorella Giovanna una botanica, Lucio poeta era cugino di Tomasi di Lampedusa col quale aveva un antagonismo incredibile. Quando andavo da Piccolo lui mi diceva salutami il caro Sciascia e quando andavo da Sciascia, Leonardo mi diceva salutami Piccolo. Poi ho fatto in modo di farli incontrare. Piccolo, che stava quasi sempre chiuso nella sua magione, quando arrivavano ospiti dava il meglio di sé. Era di una cultura infinita. Anni dopo Sciascia dichiarò che i due personaggi che più l’avevano colpito nella sua vita erano stati Borges e Lucio Piccolo. Poi è esploso il fenomeno del Gattopardo. In un’altra circostanza ho saputo che in un alberghetto di campagna vicino al mio paese c’era Salvatore Quasimodo con un’amica che presentava come figlia, sono andato a scovarlo e ho fatto in modo di accompagnarlo per fargli conoscere Lucio Piccolo, ma siccome questi era stato scoperto da Montale, acerrimo nemico di Quasimodo, allora il Nobel, uscendo dalla villa, mi fa: questo piccolo poeta”. Al nord stringi invece intensi rapporti con Pasolini e Calvino. Che cosa succede nella cultura italiana perché oggi sia così difficile trovare dei riferimenti che segnano veramente il tempo e la cultura? “Non voglio essere profeta di sventure ma credo che la letteratura italiana ormai sia al grado zero. Mi arrivano parecchi libri di esordienti. Leggo le prime pagine e rimango allibito dalla banalità della scrittura, delle storie, tutti che guardano il proprio ombelico, la propria infanzia, il papino, la mammina, le vicende personali, familiari, sessuali, non c’è uno sguardo nella storia nostra. La società è assente e ci si chiede ma ‘sta letteratura dov’è andata a finire? Negli anni Sessanta, dopo un’infelice esperienza alla Rai, che mi aveva cacciato perché mi ero rifiutato di mandare in onda un’autointervista su Cavour dell’allora direttore generale Italo De Feo (suocero di Emilio Fede), grazie a Calvino sono stato per più di dieci anni consulente della casa editrice Einaudi. Quando arrivavano i dattiloscritti, io dovevo essere il primo a leggerli, fare la relazione scritta e leggerla alla riunione del famoso mercoledì. Se io approvavo il libro, passava a Calvino. Quindi se lui l’approvava passava a Natalia Ginzburg per il giudizio conclusivo. Oggi basta andare alla televisione a sculettare o a fare il cantante, si scrive il romanzo e subito diventa best-seller. Questa è la letteratura italiana attuale”. La letteratura può far paura perché non è dominabile? “Senz’altro. La letteratura vera non è dominabile, se poi invece aspetti l’applauso e il successo sei dominabilissimo. Fai la volontà del padrone”. La Sicilia è sempre il cuore delle tue storie anche quando racconti il male di vivere, in certo modo l’inutilità di stare in Sicilia. “Diceva Verga che non ci si può mai allontanare dai luoghi della propria memoria. Lui l’ha fatto per parecchio tempo, i cosiddetti romanzi mondani quand’era a Milano, poi c’è stata la famosa conversione quando comincia il ciclo del verismo, ma anche Pirandello ha scritto che noi siamo i primi anni della nostra vita, cioè che quei segni sono incancellabili”. La distanza ti ha consentito una messa a fuoco migliore della realtà siciliana?“ Anche questo diceva Verga, e Capuana scriveva che la lontananza serviva a vedere più obiettivamente il luogo in cui si era nati e vissuti, il luogo della memoria”. E l’infinito presente del nostro tempo che cosa ci sta rubando? “Sia la memoria del passato che la visione di quel che può essere l’immediato futuro. Viviamo in questo infinito presente”. 
La sintassi del regime
LA SINTASSI DEL REGIME
di Vincenzo Consolo
«L’ idea di questa gente era di distruggere tutto quanto di fine e di delicato vi era stato in una tradizione poetica di più di sei secoli, deridendo la democrazia, applicavano alla letteratura i metodi più violenti della demagogia. Se ci fossero stati degli usignoli a cantare nei boschetti immortali del Petrarca e del Leopardi, essi li avrebbero fatti tacere uccidendoli». «Questa gente», «essi», gli uccisori degli usignoli, chi sono? Sono i Futuristi, i seguaci di quel movimento letterario d’avanguardia «inventato» da Tommaso Filippo Marinetti. E il brano sopra riportato è tratto da Golia – Marcia del fascismo di Giuseppe Antonio Borgese. Autore di saggi e di romanzi, fra cui il celebre Rubè, Borgese nel 1931 va esule, per antifascismo, negli Stati Uniti, dove scrive appunto Golioath in inglese. In questo saggio, lo scrittore analizza la situazione sociale e il clima culturale degli anni Venti in Italia per cui è nato il Fascismo, per cui è assurto al potere, imponendo la sua dittatura, un omuncolo, un piccolo borghese di nome Mussolini. Con la crisi economica succeduta alla prima guerra mondiale, con i conflitti sociali, gli scontri tra capitale e lavoro, con la crisi delle ideologie, con l’insorgere di nuove metafisiche, misticismi di segno nero e bianco, si coniugava il decadentismo culturale, l’estetismo languido ed estenuato di Gabriele D’Annunzio. Ma il prezioso drappo bizantino del languore e dell’estenuazione nascondeva l’aggressività, la ferocia, la voluttà della guerra, del sangue e della morte. D’Annunzio forniva a Mussolini e alla piccola borghesia italiana la terminologia barbarica e guerresca del fascismo. «Ehia, ehia, alalà!» era l’urlo delle masse ottuse e ignoranti. Parallelamente e specularmente al dannunzianesimo sorgeva il Futurismo di Marinetti. Questo italiano avventuriero della cultura, da Alessandria d’Egitto approdava a Parigi, dove pubblicava sul Figaro, nel 1909, il primo Manifesto del Futurismo e quindi, l’anno dopo, il Manifesto della letteratura futurista. Nei due Manifesti, Marinetti teorizzava la distruzione della lingua logico-comunicativa, scardinava lessico, grammatica e sintassi riducendo la scrittura a fragoroso balbettio monosillabico, esaltava il dinamismo, i miti della violenza e della guerra (Guerra sola igiene del mondo scrisse), il mito del Fascismo e della dittatura. Questo nefasto personaggio finì i suoi giorni, insieme a Mussolini, nell’estremo rifugio della Repubblica nazi-fascista di Salò. Giuseppe Antonio Borgese, più degli storici, ha dimostrato che il primo sintomo – come la febbre nelle infezioni del corpo umano – dell’insorgere del fascismo, del totalitarismo, è la modificazione della lingua, lingua che, dal fascismo divenuto potere dittatoriale, viene ulteriormente modificata. Così è stato in Italia. Il Fascismo nacque sulle modificazioni linguistiche di D’Annunzio e di Marinetti e, divenuto regime dittatoriale, si preoccupò subito di modificare la lingua italiana interrompendo l’incontro tra lingua colta e lingua popolare o dialettale, reprimendo o prosciugando i due affluenti che avevano arricchito il fiume della lingua italiana fin dalla sua sorgente, dalla sua nascita. Il regime fascista creò così una lingua media piccolo borghese e burocratica da una parte, eroica e ridondante dall’altra. Mussolini impose, col nero di catrame e a caratteri cubitali, sui muri degli edifici pubblici e privati di tutto il Paese, una sua antologia di vuoti motti dannunziani, di slogan guerreschi e retorici. Questo è avvenuto in Italia con il Fascismo. E lo stesso in Germania con il Nazismo, come ci ha insegnato il filosofo ebreo tedesco Viktor Klemperer. Da professore a Dresda ridotto a manovale, continuò a scrivere il suo giornale di linguistica, stese il suo libro sulla Lingua Tertii Imperii, la trucida lingua delle iene naziste. Thomas Mann, che ebreo non era né filologo, abbandonando nel ’34 la Germania per esiliarsi negli Usa, forse per difendersi, oltre che dal Nazismo, dalla modificazione della lingua tedesca e quindi del romanzo, quindi della letteratura, si immergeva, nel viaggio in mare attraverso l’Atlantico, nella lettura del grande archetipo del romanzo europeo, nel Don Chisciotte di Cervantes. Nel libro Una traversata con Don Chisciotte , Mann ci fa scoprire i barbagli di gemme nascoste, i rimandi a testi di autori classici, di Apuleio, di Achilleus Tatios, nel capolavoro cervantino. Ed elogia la lingua del traduttore del Don Chisciotte, lingua che non è certo quella modificata dal Terzo Riech. «Non saprei esprimere fino a qual punto mi entusiasmi la versione di Ludwing Tieck col suo linguaggio sereno, ricco e prezioso dell’età classico-romantica, questo tedesco nel suo stadio più felice». Infelice doveva essere invece lo stadio della lingua spagnola, la lingua di Cervantes, quando nel ’36, all’inizio della Guerra Civile, i falangisti irrompevano all’università di Salamanca e ululavano al rettore, a don Miguel de Unamuno, in una feroce lingua, «Viva la muerte!» E lui don Miguel, rispondeva, «Sento un grido necroforo e insensato», lui, che aveva sciolto un inno alla sua lingua, «…lengua en que a Cervantes / Djòs le diò el evangelio del Quijote». E vorremmo ancora dire, se ne avessimo cognizione, delle modificazioni del russo di Puskin e di Tolstoj in Urss, dei linguisti sovietici, a cui Stalin, che era Stalin, oppose un suo breve saggio. Vorremmo ancora dire di altre modificazioni linguistiche che hanno preluso all’avvento dei totalitarismi, i quali poi continuano a modificare la lingua, modificazioni che hanno annunciato l’età delle catastrofi, il Novecento appena trascorso, il Secolo breve, come l’ha chiamato Eric Hobsbawm. Catastrofi. Sono sì quelle racchiuse tra le due Sarajevo, come scrive Adriano Sofri, l’intellettuale innocente recluso da sei anni in una prigione italiana, ma che vanno ancora oltre la seconda Sarajevo, oltrepassano il Novecento, arrivano a questo nostro terzo Millennio. In questo presente in cui ormai tutte le nostre lingue sono state modificate, in cui sono insorte nuove metafisiche, nuovi misticismi, come negli anni Venti, l’instaurarsi di nuovi totalitarismi. E, prima d’ogni altro, il totalitarismo dei mezzi di comunicazione di massa, che ha il potere di seppellire, nel nostro mondo globalizzato, le parole della verità, di imporci ogni giorno l’impostura, la menzogna. E nel fango della menzogna viene seppellita la libertà di pensiero, la libertà di espressione. Viene seppellita la poesia, viene seppellita la civiltà. Totalitarismo, quello dei media, che è feroce, aggressivo, bellicoso. E mette in campo, come simulacro, come ieri metteva in campo la diversità della razza, la categoria metafisica del Male: questo indica come Nemico, questo urla di voler distruggere con le armi. Ma dietro lo spirituale simulacro, sappiamo – riusciamo ancora a sapere -, che vi è la materialità delle fonti energetiche, l’oleosa, sporca concretezza dell’oro nero, del petrolio. Dietro o sotto le bombe vi sono invece le vite umane, vi sono i corpi fragili degli innocenti. «La guerra, la guerra!» urlata dagli uomini di voce dura, è stata da sempre una barbarie, uno scandalo. Scandalo è stata l’antica guerra narrata da Omero. Ed Efesto, narra il poeta, fabbrica le armi di Achille e scolpisce sullo scudo le scene di guerra, in cui «Lotta e Tumulto era fra loro e la Chera di morte, / che afferrava ora un vivo ferito, ora un illeso / o un morto tirava pei piedi in mezzo alla mischia, / veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano». E poi, nel secondo poema, ci fa capire che quello decennale del più umano degli eroi greci, di Odisseo, non è che un viaggio, un nòstos di espiazione della colpa, di rimorso per i morti e per la distruzione di Ilio. «Sei ancora quello della pietra e della fionda / uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, / con le ali maligne, le meridiane di morte, / l’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, / alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, / con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio…» Così scriveva Salvatore Quasimodo nel ’47, nel ricordo ancora vivo degli orrori, delle distruzioni, degli stermini della guerra, della notte più fitta d’Europa, del mondo. Dopo i campi di sterminio e Hiroshima, un’altra guerra esplodeva in Corea, ancora stermini si compivano. E Picasso, nel tratto e nella monocromia di Guernica, nella memoria de I disastri della guerra di Goya, dipingeva i grandi cartoni del Massacro in Corea e de La guerra e la pace . E dopo fu il Vietnam, la Bosnia, l’Iraq, la Serbia, la Palestina, l’Afgnanistan… E ancora le bombe sono state puntate contro Saddam Hussein, il raìs di Bagdad, contro il popolo iracheno. Ma bisognerebbe ricordare all’altro raìs, a Bush junior, al presidente monosillabico del paese più potente del mondo, che il tiranno è un uomo senza speranza, che nel suo futuro non ci sono che le Idi di marzo, sul suo cammino i pugnali di Cassio e Bruto e l’ignominia della storia. Bisognerebbe ricordare a Bush II che se qualcuno dall’esterno lo colpisce, il tiranno si rafforza, che l’assalto esterno fa riporre il pugnale ai congiurati, ricordare che, nella sua nera disperazione, nel buio della sua mente, il tiranno vuole soltanto che insieme a lui finisca, si dissolva il mondo intero. «Sono stanco che il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del Mondo…» fa dire a Macbeth Italo Calvino nel suo Il castello dei destini incrociati.
13 gennaio 2004 L’Unità edizione Nazionale (pagina 23) nella sezione “Cultura“
Saggio introduttivo per il libro “Gli Arabi paesani, inchiesta sui giovani di oggi.
“Per la nostra Sicilia invoco una vera solidarietà regionale, una concordia sacra, una pace feconda e operosa. Giustizia per la Sicilia! Tregua di Dio per la Sicilia!” declamava alla prima seduta dell’Assemblea regionale il presidente (per anzianità) Francesco Paolo Lo Presti. A Palermo, nel pomeriggio di domenica 25 maggio 1947. Nel- la sala detta d’Ercole per gli affreschi alle pareti d’un Velasquez che raccontano le fatiche del semidio enfio di coraggio e di muscoli di quel palazzo che era stato sede di emiri, di re e viceré, i novanta deputati erano disposti secondo gli schieramenti politici: a sinistra i comunisti e i socialisti del Blocco del popolo, i saragattiani e i repubblicani, al centro democristiani e separatisti; a destra monarchici, liberali e qualunquisti. Tra di essi, i protagonisti della infuocata battaglia politica che aveva preceduto le elezioni del 20 aprile: Li Causi, Colajanni, Finocchiaro Aprile, Alessi, Aldisio, Alliata… E in prima fila, al centro, tra le autorità, quel cardinale Ernesto Ruffini che implorerà “di cuore sul nuovo Parlamento siciliano l’abbondanza delle celesti benedizioni». (Una travolgente abbondanza di voti, di potere e di vantaggi s’abbatterà di lì a poco solo su quel gruppo democristiano che col cardinal Ruffini intreccerà unita d’ intenti e di voleri), Cosa voleva dire quella implorata “concordia sacra” “tregua di Dio” del presidente Lo Presti? Era che sala d’ Ercole, tra gli scranni, un profondo fossato era aperto, tra la sinistra e il resto degli schieramenti, un fossato entro cui scorreva la paura del centro e della destra per i seicentomila voti ottenuti dal Blocco del popolo. Paura che alcuni avevano cercato di fugare armando la mano d’un bandito, Giuliano, contro gli inermi lavoratori festeggianti il I° maggio a Portella delle Ginestre. «N’ammazzarono tanti in uno spiazzo (c’erano madri e cerano bambini), come pecore chiuse nel recinto, sprangata la portella. Girarono come pazzi in cerca di riparo ma li buttò riversi sulle pietre una rosa maligna/nel petto e nella tempia: negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lava, di deserto. La pezza s’inzuppò e rosso sopra rosso è un’illusione, ancora un’illusione. Disse una vecchia, ferma, i piedi larghi piantati sul terreno: – Femmine, che sono ‘sti lamenti e queste grida con la schiuma in bocca? Non è la fine: sparagnate il fiato e la vestina per quella manica di morti che verranno appresso!” Ora il sangue delle undici vittime e dei feriti di Portella rigava quel fossato, ancora a demarcare, ancora a dividere le due Sicilie di sempre: quella proletaria dei contadini e dei braccianti e l’altra dei principi, dei sedara, dei gabelloti, dei campieri, dei mandanti e dei sicari. Sono, questi ultimi, i siciliani che si sentono eredi della storia illustre dell’Isola, che ne difendono l’antica civiltà e l’onore, sono questi che si riconosceranno nei “perfetti dei? del Gattopardo: d’un olimpo disumano, violento e sopraffattore, mafioso e “democristiano”. E mettiamo democristiano tra virgolette volendo dire che, messa da parte la componente popolare e sociale di quel partito, prevalendo l’altra, quella borghese delle clientele e delle cosche, niente ci sembra più siciliano del partito democristiano (come niente è stato in origine più padano, più lombardo del fascismo agrario e cattolico), di pratica politica cioè intesa in senso familiare e tribale, in senso mafioso e clientelare. Trent’anni sono passati da quel 25 maggio del ’47. Cosa è successo da allora lo sappiamo. Quella Sicilia di là dal fossato, la Sicilia che, dopo ottant’anni di unità sabauda, per non parlare di prima, dopo i vent’anni di fascismo con gli ultimi quattro anni di guerra, accesasi per l’ultima volta nella speranza di una nuova storia, di fare essa la nuova storia dell’Isola, è costretta a emigrare, a spargersi per l’Italia e l’Europa. E non erano, questi siciliani dell’emigrazione, solo contadini e braccianti, erano anche intellettuali. Restava nell’Isola, sequestrata dal potere, stretta nella morsa della promessa del favore e del ricatto, quella classe intermedia che riempiva uffici, riceveva assistenza, sovvenzioni, emolumenti. E in quei contadini e in quegli intellettuali emigrati, oltre la rabbia, era sempre dentro la speranza che nell’Isola prima o dopo qualcosa potesse cambiare, che prima o dopo fosse possibile il ritorno. Anche uno scrittore come Vittorini, che sempre respinse l’idea-sentimento di una patria-Sicilia, creandosi una dimensione ideologico-poetica di Sicilia-Lombardia, anche il Vittorini delle “‘tensioni” europee, nutrì per un momento la speranza di un cambia- mento. Si era intorno al ’50, e lo scrittore degli astratti furori di Conversazione, del notturno viaggio nel dolore e nella rassegnazione, tornato in Sicilia, assiste al grande movimento per la scoperta del petrolio: erano gli anni di Gela e di Mattei. Rapportò, o innestò, questa speranza dell’Isola a quella del Nord per l’industria “umana” e olivettiana, la speranza della nascita di una nuova società. Scrisse allora Le città del mondo, libro diurno e di grande movimento, di personaggi in lingua dalle rassegnazione dalle stasi di camionisti per le strade, di contadini a cavallo convergenti in una valle per una grande assemblea) Hai, quando la poesia si fa illusione e utopia, quando la storia taglia il filo che l’aggancia alla realtà. Nel maggio di quest’anno si è celebrato il trentennale dell’Autonomia siciliana. In quella sala d’Ercole del palazzo dei Normanni, accanto a Pancrazio De Pasquale, il primo, dopo trent’anni, presidente comunista del ‘Assemblea, cerano Andreotti, Ingrao e Murmura (quest’ultimo in rappresentanza di Fanfani). Ha parlato De Pasquale, ha risposto Andreotti, e da una parte c’era la richiesta di attuazione completa dello statuto e dall’altra la promessa, data la convinzione che è proprio dal rilancio della autonomia locale che può e deve scaturire a livello civile, culturale, umano il primo elemento di ricomposizione della società? e data la speranza che “dal Meridione e dalla Sicilia potrebbe emergere oggi, invertendo l’itinerario del secolo scorso, la riaggregazione a più alto livello dell’attuale società nazionale tanto turbata”. Il clima di ricorrenza e di celebrazione, chiaro, permette di eludere le analisi, i processi e le imputazioni, ché allora ci sarebbe stato davvero da sghignazzare, se non da gridare, alle parole di un presidente del Consiglio di quel partito della maggioranza che da trent’anni detiene il potere nel Paese, responsabile quindi delle condizioni di oggi della Sicilia, del Meridione, che appunta le speranze nelle autonomie locali di una ricomposizione- a livello, civile, culturale, umano della nostra società disgregata, di un nuovo risorgimento nazionale che parta dal Sud. E solo quest’ironia allora ci permettiamo menti avvertiti come siamo in fatto di risorgi i chi è che lascia oggi Pisacane per Cavour e i Savoia? Chi baratta la rivoluzione per il risorgimento, chi sono oggi questi nuovi Garibaldi del Sud? Intanto, quel fossato apertosi tra i banchi di sala d’Ercole, quello rigato di sangue, di cui si parlava all’inizio di questo scritto, è stato riempito. Il I° maggio di quest’anno s’è anche commemorata per la prima volta all’Assemblea regionale la strage di Portella delle Ginestre. Un’altra commemorazione a Piana degli Albanesi, sul luogo della strage, l’hanno fatta i sindacati unitari. Ma domenica 5 giugno a Palermo, mentre Pajetta commemorava da una parte Girolamo Li Causi, il grande capitano delle lotte del ’47, dall’altra parte il Centro Siciliano di documentazione svolgeva un convegno di studi sul tema: 1947- 1977. Portella delle Ginestre: una strage per il centrismo”: una controcelebrazione del trentennale? E in questo nostro paese di telegrammi ufficiali, di lacrime di coccodrillo, di corone di fiori di commemorazioni, di controcelebrazioni ce n’è gran bisogno: bisogno di analisi, di processi e di imputazioni. Cosa sappiamo, intanto, della Sicilia, del Meridione, dopo questi trenta anni di malgoverno, cosa sappiamo delle condizioni in cui sono state lasciate queste terre “di rapina”? Abbiamo avuto notizie solo di altre stragi, di sindacalisti ammazzati, di sciagure naturali che scoperchiavano altre e millenarie sciagure storiche, di mafia, di rapine, di corruzioni, di speculazioni, di intrighi e di compromissioni della classe dirigente: vasta è la letteratura a riguardo, e spesso romanzata fino al folklore, fino all’amenità, fino a perdere forza di verità, forza di denunzia. Ma dei siciliani che nell’Isola sono rimasti, dei loro mutamenti sociali e politici in questi anni poco sappiamo. La letteratura, a riguardo, crediamo che sia inesistente Ci sovviene soltanto qualche meritoria inchiesta giornalistica, come quella per esempio di Mario Farinella raccolta in volume sotto il titolo di “Profonda Sicilia”, una ricognizione per l’Isola sul finire degli anni ’60. E dei giovani meridionali, dei giovani siciliani di questa fine degli anni settanta, cosa sappiamo? Di questi, di cui non si può dire ormai che siano una generazione, ma una classe (una situazione esistenziale che è immediatamente storica Ed è allora, per questo che loro, i ragazzi, hanno sentito il bisogno di rivendiate, tra le altre cose, il principio che il personale è politico?): per l’emarginazione. il cui li abbiamo spinti, noi, i loro padri, per il deserto di valori in cui li costringiamo a vivere; por le varie crisi che gli abbiamo apparecchiato; per la distruzione di speranze, per le lande senza orizzonti in cui li abbiamo relegati, spogli di cultura e identità. Fino a poco tempo fa, dire giovani, dire siciliani, calabresi o lucani, appariva subito una definizione astratta se non qualunquistica, priva com’era di una distinzione di classe. Dire oggi giovani o giovani siciliani non è più sospettabile. Anzi. In questi, nei giovani siciliani, o giovani calabresi o giovani pugliesi, c’è già una doppia connotazione storica: in quanto giovani e in quanto meridionali. Di una storia che non è più uguale a quella delle generazioni precedenti. Tra queste ultime (del subito dopo- guerra, degli anni cinquanta o sessanta, del sessantotto o del dopo sessantotto) e le generazioni di questa fine degli anni settanta, sembra che dei terremoti siano avvenuti, a scavare abissi, voragini, a creare profondi mutamenti. A decifrare i quali non servono più i metri conosciuti e praticati sin qui. Quali nuovi metri allora si usano? Le sofisticate e asettiche analisi di laboratorio su campionature o cavie che gli scienziati, antropologi e sociologi, praticano con quel distacco e quella iattante autorevolezza che a noi – col rischio di apparire corrivi o vecchi umanisti superati – tanno nascere il dubbio di verità o deduzioni sospette perchè nate da quella scientificità “‘pura che è già ‘”socialdemocratica”; quando non risultano, queste analisi nel chiuso del laboratorio, immediatamente superate dallo svolgersi e radicalmente rivolgersi della realtà esterna. E allora preferiamo la vecchia, esposta. non-scientifica, non-rigorosa, ma “calda” e reale inchiesta giornalistica. E preferiamo anche la pratica di una realtà umana come quella giovanile (e spero che i lettori di questo scritto non siano portati a facili e offensive alla loro stessa intelligenza – battute cosiddette di spirito) di un poeta come Pasolini che lo portava a dolorose constatazioni, a inquietanti profezie. Ecco dunque un’inchiesta giornalistica sui giovani della provincia siciliana, questa di Giuseppe Corsentino: fra le prime e quindi preziosa; profonda, perchè di una realtà scovata in angolo bui e da anni dimenticati. Questa realtà giovanile della provincia siciliana è sconcertante. Per noi, lettori di vecchie letterature e vecchie inchieste sulla Sicilia, dove le classi separate davano un quadro dialetti- co e storicistico (gli zolfatari e i padroni di miniere, i contadini occupanti le terre incolte e i baroni e campieri, le speculazioni edilizie e le stragi a scoppi di tritolo e colpi di lupara, i cortili di Palermo e gli sprechi messi in luce da Dolci, le parole che erano pietre delle madri dei sindacalisti uccisi dalla mafia riportate da Levi, la fame dei bambini e i bottoni nella loro minestra, i salinari e il potere che si ricostituiva nel dopoguerra come ce li ha fatti vedere lo Sciascia de “Le parrocchie di Regalpetra”…), questo quadro di oggi della Sicilia dei giovani ci appare inedito (come inedito deve essere il quadro della realtà giovanile del resto delle regioni meridionali) non più dialettico, intanto, ma univoco, omologo, come oggi si dice. Di giovani quasi tutti appartenenti ormai (qualsiasi sia la loro origine) a una piccola borghesia vittima e disastrata dal consumismo (l’edonismo americano), di merci e di ideologie, disorientati e ondeggianti tra atteggiamenti di riporto di freakettonismo o indianismo paesano o triste e consapevole acquiescenza al vecchio ricatto e alla vecchia soggezione clientelare. Dall’altra parte, gli adulti, i vecchi, di fronte a questi giovani disorientati e disarmati, residui della risacca sessantottesca, “‘scollati” da qualsiasi organizzazione politica, instaurano vecchie controriforme, vecchie ipocrisie, vecchi vizii provinciali e bacchettonismi. Così è a Trapani a Sciacca, ad Agrigento, a Mazara, a Caltanissetta, a Castelvetrano, alienata e miracolata racina Canicattì, allo squallido deserto periferico di Gela… Qualcosa di diverso, di muovo, si nota noi giovani della Valle del Belice, dove il terremoto ha anche sconquassato le vecchie divisioni, le vecchie classi producendo, a prezzo di tanto dolore, uguaglianza e unità di impegno e di lotta. Siamo partiti da lontano: dalla Sicilia del 47. Questa è la Sicilia di oggi. Ma è anche il Meridione di oggi. Di questo Meridione che si è voluto cacciare dalle campagne e dai paesi, lo si è portato nelle fabbriche del Nord in nome della dea industria, che lo si è eletto a terra di conquista per i consumi, che si è spogliato di cultura e di identità. Oggi che quella divinità industriale dai piedi di argilla è crollata, c’è il marasma e lo smarrimento, nei giovani, soprattutto, i più fragili e vulnerabili. Per essi, la unica novità è la recente legge per l’avviamento al lavoro, e quale? In essi, intanto, c’ è il desiderio di un ritorno alla campagna: ci sono le rioccupazioni delle terre come negli anni ’50, si formano le comuni agricole, le cooperative. E questo significa che c’è nei giovani, oltre a una volontà di una vita diversa, anche il bisogno della ricerca di una cultura più “umana” di una identità più vera e più solida. Il governo, le forze economiche nazionali e non, terranno conto di questo loro bisogno?
VINCENZO CONSOLO Milano, 26 agosto 1977