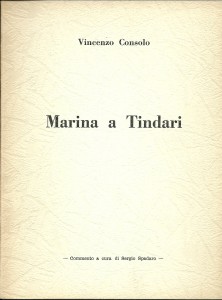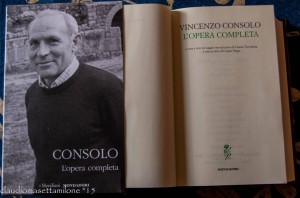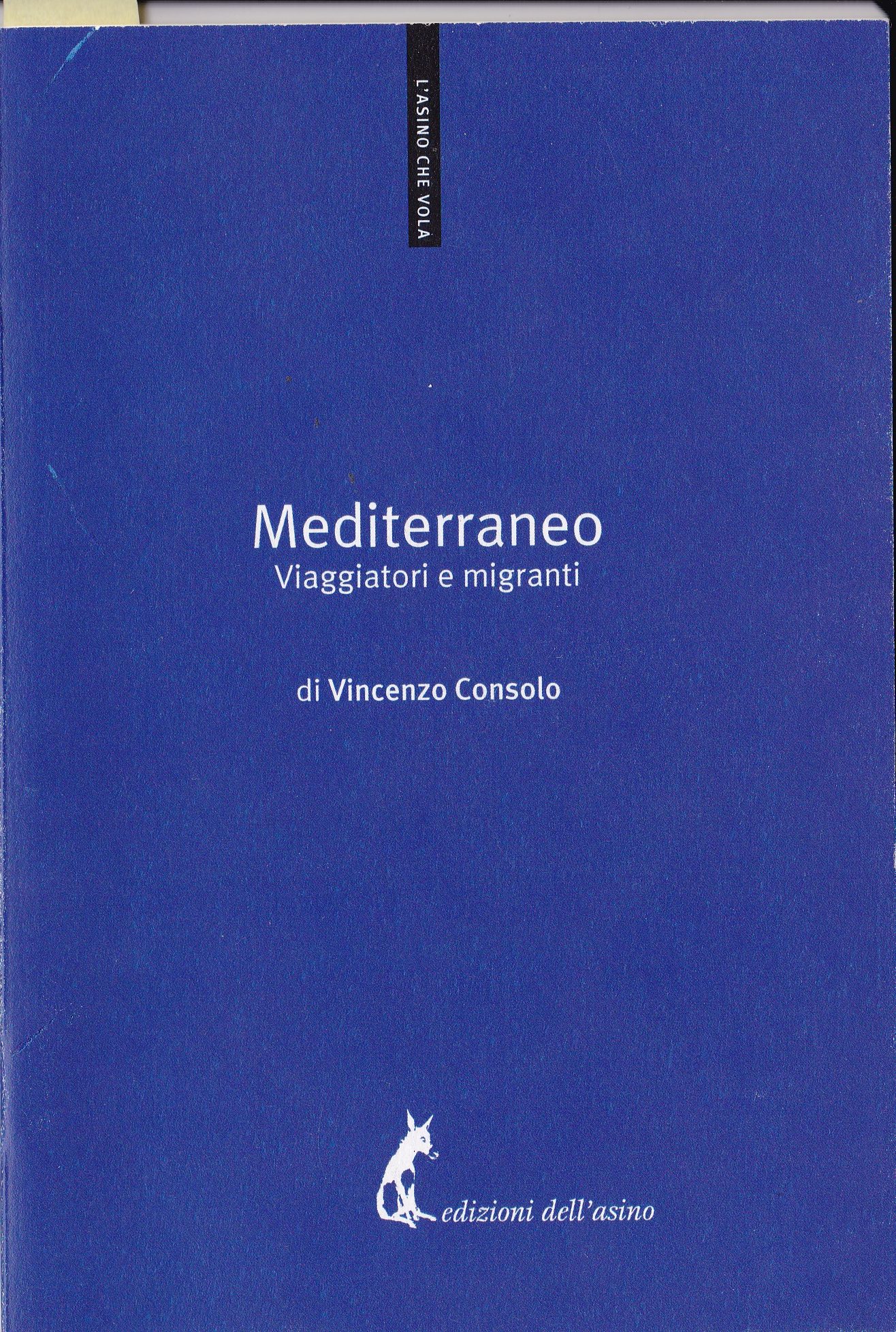Carmine Battaglia
Un filo d’erba al margine del feudo
Via del Sole scende stretta tra il muro laterale del Palazzo e una ringhiera di ferro sul dirupo. Era in ombra a quell’ora. Il sole batteva invece sulle pietre di via Murorotto e sul portale d’arenaria ricamata del Palazzo. La ringhiera di ferro di via del Sole era quella d’un terrazzo sospeso, navigante.
Il vecchio con lo scialle sporse nel vuoto il braccio e con l’indice a corno percorreva la linea ondulata che disegnavano nel cielo terso i monti tutti attorno, dalle spalle del paese fino al mare.
– Motta – diceva fermando il dito su un punto biancastro lungo la costa dei monti. E poi – Pettineo, Castelluzzo, Mistretta, San Mauro… – Posò lo sguardo sul mare, ripiegò il braccio, si tirò sulla spalla lo scialle scozzese che gli era scivolato. Stesi io il braccio nel vuoto oltre la ringhiera e indicai il mare. – Quelle macchie azzurre sono isole, Alicudi, Filicudi, Salina… Più in là c’è Napoli, il Continente, Roma…
– Roma – ripeté il vecchio. Volse le spalle al mare e continuò a indicare le montagne, ora con un breve cenno del capo: – Cozzo San Pietro, Cozzo Favara, Fulla, Foieri…
L’ulivo, fitto ai piedi dei monti, diradava, spariva verso l’alto. Poi vi erano costole nude, scapole, e qua e là ciuffi di sugheri, di castagni.
Il vecchio sedette sulla panchina di pietra e, la faccia tra due sbarre della ringhiera, appuntò gli occhi sullo spiazzo erboso sotto il dirupo. Ragazzi vi giocavano, tra pecore al pascolo, piccoli, appiattiti sul prato, silenziosi. Uccelli con larghe ali planavano sulla valle. La strada a serpentina, grigia di fango rappreso, partiva dalle prime case del paese, passava tra alberi d’eucalipto e d’acacia, circondava il prato, accostava una vasca d’acqua stagnante e finiva in un cancello di lamiera arrugginita. Il sole di questo primo pomeriggio era tutto ammassato nella tenera valle, suscitava tremuli vapori.
Al di là del cancello, dentro, il cerchio del muro, nel tabuto fresco di vernice, era Carmelo Battaglia, il sindacalista di Tusa ammazzato su una trazzera, una mattina di marzo, con due colpi a lupara, e messo in ginocchioni, con la faccia per terra. La valle declinava dolce fino alla balza d’Alesa (le sue mura massicce, l’agorà, i cocci d’anfora e le colonne spezzate affioranti tra gli ulivi, la bianca Demetra dal velo incollato sul ventre abbondante). In fondo, Tusa Marina, col suo castello sull’acqua smagliante e triangoli di vele sui merli.
Nel ventitrè ammazzarono il padre Battaglia, con colpi a lupara, su una trazzera, e gli riempirono la bocca di pietre e di fango. Il vecchio s’era tirato fin sulla nuca e gli orecchi lo scialle scozzese, aveva chiuso gli occhi e reclinato il mento sul petto.
Il piano della Piazza era tagliato a rettangoli e trapezi di luce. La torre medievale, al centro, massiccia, quadrata, aveva due facce illuminate. Uccelli neri, con lieve fruscio, facevano la spola tra la Matrice e la torre. Via Pier delle Vigne si perdeva tra vecchie case. Via Matteotti, dall’ogiva dell’antica porta, scendeva ripida e larga verso le case nuove. Un vecchio cantava nella piazza, seduto al sole davanti alla porta della società Agricola. Un altro vecchio stava immobile dall’altra parte; e altri tre dentro, nel vano interrato della società, immobili attorno a un piccolo tavolo su cui batteva il sole. Il vecchio sulla porta cantava con gli occhi in cielo e un sorriso sulle labbra. Cantava: – Al natio fulgente sol / qual destino ti furò –; e poi daccapo: – Qual destino ti furò / al natio fulgente sol –; sempre avanti e indietro su quelle parole.
Un’automobile nera venne giù da via Alesina, attraversò la Piazza e scese per via Matteotti. Vi era dentro un ufficiale dei Carabinieri con le stelle d’argento sulle spalle e altri signori col cappello. Il vecchio interruppe il suo canto e poi riprese.
Via Alesina era tutta in ombra, stretta e lunga, tra alte case, dalla Piazza fino al Belvedere. I vicoli verticali erano assolati. Cespi di bàlico fiorito, viola e giallo, spuntavano dalle crepe delle case e ficodindia da sopra i tetti. Da un balcone del vicolo penzolava la testa d’un asino, pensosa nel sole. Il municipio e la cooperativa Risveglio Alesino. Sul portone del municipio era scolpito lo stemma della città: un grosso cane muscoloso sopra una torre, le zampe posteriori contratte, sul punto d’avventarsi, i denti scoperti (1860: «In più luoghi, come a Bronte, a Tusa e altrove, i Consigli municipali, costituiti dai Governatori distrettuali, erano composti di elementi della grossa borghesia o dell’aristocrazia di proprietari terrieri, avversi alle rivendicazioni contadine e ai fautori e capi del movimento per la divisione delle terre demaniali»).
Una giovane bellissima, dietro i vetri d’una piccola finestra, ricamava. Divenne viva, aprì la finestra, si sporse, allungò il braccio bianco e fece segno che dovevo ancora andare avanti e poi salire per il vicolo.
Bussai e venne ad aprire una donna in nero. Mi fece strada per uno stretto corridoio celeste che sbucava in una grande stanza celeste. È il celeste, abbagliante per le mosche, latte di calce mischiato con l’azolo. Sei donne tutte nere erano attorno alla ruota della conca: la figlia, la moglie, due sorelle e altre due parenti di Carmelo. Parlava la giovane figlia, il fazzoletto nero annodato sotto il mento e ancora il velo nero che le scendeva per le spalle, gestiva con le sue mani guantate di nero. La madre, accanto, non parlava perché muta, muta e paralitica. Solo gli occhi aveva vivi.
– Sì, fece il soldato e, finita la guerra, venne a piedi da Trieste. Passò lo Stretto su una barca e, a Messina, prima che attraccassero, si buttò in acqua per toccare prima la Sicilia, ma non sapeva nuotare. Il pescatore calabrese lo dovette afferrare per i capelli per salvarlo. Rideva molto quando raccontava questo. Diceva che allora, a vent’anni, era sventato come un caruso.
– Sempre l’ha avuta questa idea socialista, ma di più quando tornò dalla guerra. Diceva che i contadini, i bovari sono sempre state malebestie. Sempre a limosinare un palmo di terra o un po’ d’erba al limite del feudo. Ma non parlava molto in casa, aveva le parole giuste, contate. Questa di mia madre era una pena forte che portava in cuore: venti anni che è allogo, un male di nervi.
– Partiva alle quattro, alle cinque, secondo la stagione, col mulo, per il feudo. A volte si restava là e si portava un poco di pasta e una boatta di salsina. Questa volta doveva restarci per due giorni.
– Sì, voglio che si scopra al più presto l’assassino. Voglio conoscerlo. Voglio vedere in faccia questo che insulta i morti, che li mette in ginocchioni.
– No, neanche i vivi s’insultano. Ma di più i morti, specie se in vita sono stati sempre latini, diritti, cavalieri.
La madre mugolò e cominciò a piangere. La figlia le prese le mani, se le portò sulle gambe e, tenendovi sopra le sue, si mise a cullargliele.
La stanza era piena di penombra. C’era solo la luce rossa di un lumino davanti alla fotografia di Carmelo vestito da soldato, sopra il comò. Le donne stavano tutte chiuse nei loro scialli e mute. Una prese la paletta di rame e rimestò la brace nella conca.
– Nessun desiderio, nessun progetto. L’unica sua idea era quella di aggiustare questa casa».
Il sole era tramontato e, all’uscita del paese, sopra un muretto della strada, erano seduti un prete grosso e un prete magro. Quello magro, scuro, era venuto da Cesarò per predicare il quaresimale. Quello grosso, chiaro, era del paese.
– Un uomo buono, benvoluto da tutti. Parlava poco ma spartano. No, in chiesa mai. Ci andavo io a casa sua, una volta al mese, per confessare e comunicare la moglie. Poveretta, mi scriveva i peccati su un foglio di carta.
Passavano i contadini per la strada, tornavano a gruppi dal lavoro, gli uomini sul mulo e le donne a piedi. – Vossia benedica – salutavano.
– Benedetto – rispondeva il prete.
– Tra loro, si ammazzano, tra loro bovari.
– Benedetto.
Le montagne là di fronte erano diventate viola, di un viola tenero sfumato.
Questi Nebrodi, alti di fronte al mare, sono di una bellezza impareggiabile. Ora, con le prime ombre della sera, si udivano per la campagna ringhiare e abbaiare i primi cani: quei cani orbi, bastardi, che si avventano feroci non appena li sfiora l’odore della carne d’un cristiano.
[i] «L’Ora», 16 aprile 1966, p. 6. Stesso testo, col titolo: Per un po’ d’erba al limite del feudo, in L. Sciascia e S. Guglielmino (a cura di), Narratori di Sicilia, Milano: Mursia, 1967, pp. 429-434. Il testo del 1966 è ripreso tal quale – sotto forma di «Prima appendice del curatore», con fonte: L’Ora, 16 aprile 1966 (p. 6), autore: Vincenzo Consolo, occhiello e titolo: Tra cronaca e racconto un giorno a Tusa. Un filo d’erba ai margini del feudo, sottotitoletti redazionali inframmezzati: Il tabuto fresco di vernice, Sei donne tutte nere – in Mario Ovazza, Il caso Battaglia. Pascoli e mafia sui Nebrodi, a cura di Fernando Ciaramitaro, Palermo: Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre, 2008, pp. 124-126 [cfr. il precedente M. Ovazza, La mafia dei Nebrodi. Il caso Battaglia, a cura di Maurizio Rizza, Palermo: La Zisa, 1993].