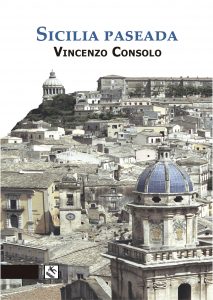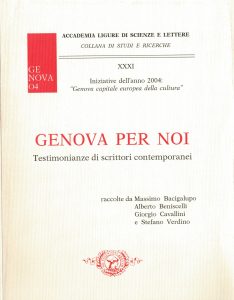Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati (dimenticammo l’ora, il punto del passaggio, la consistenza, la figura d’ogni altro; dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete: al confine bevemmo il nostro lete). Ora, in questa luce nuova – privazione d’essa o luce stessa rovesciata, frantumo d’una lastra, rovinìo di superficie. Sfondo infinito, abissitade – in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. O ignote forme, presenze vaghe, febbrili assenze, noi aneliamo verso dimore perse, la fonte ove si bagna il passero, la quaglia, l’antica età sepolta, immemorabile.
E in questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichìo di quell’oro, è possibile ancora la scansione, l’ordine, il racconto? È possibile dire dei segni, dei colori, dei bui e dei lucori, dei grumi e degli strati, delle apparenze deboli, delle forme che oscillano all’ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono?
E tuttavia per frasi monche, parole inadeguate, per accenni, allusioni, sfasature e afonie tentiamo di riferire di questo sogno, di questa emozione[1].
Questa lunga citazione è l’incipit dello scritto che dà anche il titolo al libro L’ora sospesa, di Vincenzo Consolo, raccolta di articoli, brevi saggi, presentazioni di mostre curata con una sapiente scelta di testi, peraltro approvata e postillata negli ultimi suoi mesi di vita dallo scrittore di Sant’Agata Militello, dal critico e italianista spagnolo Miguel Ángel Cuevas. Questi ha arricchito il volume con un accurato apparato di note informative e critiche che colgono ed evidenziano il ruolo non secondario dei testi compresi nel volume, edito dalle edizioni Le Farfalle del poeta e raffinato editore Angelo Scandurra. Ho voluto riportarla, perché mi pare evidente che in essa risieda la cifra chiara, ineludibile non solo di questo libro ma anche dell’intero cammino letterario dello scrittore e narratore-poeta che è Consolo. Non si tratta, come potrebbe suggerire la tipologia specifica degli scritti, soltanto del tempo sospeso, dell’attimo necessario a catturare un’emozione, una sensazione da fermare con lo scatto della macchina fotografica o da dilatare col pennello su una tela. In essa è contenuta la metafora della ricerca continua che, fra tappe e soste, parola e afasia, luce e lutto, illusione e disinganno, lo scrittore e narratore ha svolto in ambito letterario con una rara e sofferta identificazione tra pagina e vita. Tutta l’avventura letteraria di Vincenzo Consolo è stata un’ora, un tempo perennemente sospeso tra dissonante assenza di luce e musicale illuminazione apportata da un ánghelos portatore di vita. A ragione l’incipit è chiuso dalle seguenti parole: Viene e sovrasta un nunzio lampante, una lama bianca, un angelo abbagliante. Da quale empireo scende, da quali paradisi? O risale prepotente da quali abissi? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai miracoli; si dichiara vessillo, simbolo e preambolo d’ogni altro spettro[2].
Si direbbe che la scrittura di Consolo sia ispirata, che scenda dall’alto grazie alla mediazione di un ánghelos, che ne agevola il kairós, il momento di grazia, atto a celebrare funzione e fasti della parola, sempre emergente dalla memoria, con la cadenza e il ritmo di uno spartito musicale che trasfigura in arte e poesia autentica i fantasmi e le tragedie della storia umana. In questo libro, occasionalmente dedicato alle arti figurative, è racchiusa una sorta di mini laboratorio della scrittura tutta di Consolo. Come dimostra l’apparato delle note curate da Cuevas, l’ora, il tempo creativo per lo scrittore messinese è sempre sospeso, perché questi torna continuamente a rivedere, a integrare, a rimodellare i suoi scritti, per rifunzionalizzarli a momenti diversi, a tappe creative nuove. È una perenne sospensione del processo creativo, tesa a cogliere e, possibilmente, a fissare, come fa l’artista delle arti figurative, il momento di grazia, la giusta dimensione, il kairós di luce che attinga alla sfera dell’armonia e della poesia. La scrittura di Consolo è in movimento continuo, e non a caso la metafora che supporta e caratterizza quasi tutti i suoi romanzi è data dal viaggio, così come un viaggio è stato il peregrinare dell’autore per il mondo e l’andirivieni tra la Sicilia e il continente, un viaggiare esistenziale assurto a cifra letteraria fondamentale della sua opera. Un andare e venire quasi compulsivo, sulle cui ragioni egli stesso si interrogava: Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostare in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove.
Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto sia questo una sorta d’addio, un volerla vedere e toccare prima che uno dei due sparisca[3].
Questo continuo movimento nella vita e nell’opera di Consolo tiene tutto in sospensione, l’animo e il pensiero dell’uomo nonché l’opera del narratore e scrittore. Tutti gli incipit dei testi compresi in questo libro postumo fanno capo al principio e alla realtà del movimento, con una sorta di corrispondenza incoercibile e perciò significativa: Manovre di notte, ronzare di motori, cigolii di maglie. Manovre di notte. (Per Pippo Spinoccia); Sì, che bisogna scappare, nascondersi. (Nottetempo, casa per casa); …T’avvolge improvvisa voluta di brezza di mare di monte… (Guida alla città pomposa); Ora avanziamo per pianure acquitrinose, fra balze, rigagnoli…Avanti è la luce. Una frigida luce di riverbero, d’un’alba immota, d’una stagione ignota. (Paludi e naufragi); Soli andavamo dentro la boscaglia, dentro il verde più cupo più profondo. (L’immensa luce); Quindi per gradi, per lenti processi discendiamo in spazi inusitati (dimenticammo l’ora, il punto del passaggio…) …Ora in questa luce nuova…in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risediamo. (L’ora sospesa); E vado, vado nel tempo mio del rapimento e dell’incanto, vado alla ricerca del luogo della quiete, dell’incominciamento mio dentro la notte… (Il libro celeste).
L’illusione incessante di vedere una Sicilia diversa, nuova; da qui il viaggiare continuo per tutti gli angoli dell’isola come necessario rituale di vita e come metafora, sia nelle opere maggiori e nei romanzi col linguaggio alto della poesia, sia in quelle cosiddette minori col linguaggio della comunicazione ma pur sempre curato e musicalmente calibrato. Questa illusione perenne di Consolo che viaggiava era in continua elaborazione, in eterno fieri e induceva lo scrittore a parlare delle città e dei luoghi della Sicilia viste e amate, quando erano da amare, come vittoriniane città del mondo. E ciò con la chiara consapevolezza della differenza che passa tra lo scrivere e il narrare, perché si narra, io credo, riportando, nell’operazione del narrare, la propria memoria esistenziale e la propria memoria culturale… Lo scrivere invece, al contrario del narrare, può fare a meno della memoria, è un’operazione che attinge al pensiero, alla logica[4].
Il libro si occupa di opere pittoriche, anche se l’autore parla, come egli stesso precisa, da non addetto ai lavori… per consonanza[5] artistica. E infatti, anche trattando di opere figurative, l’animo del poeta e del narratore viene immancabilmente fuori, a cantare con lo stesso trasporto e la stessa armonia di sempre. Emblematico, a tale riguardo, è il frammento lirico Blu, vera sintesi di quanto qui si vuole evidenziare, per cui appare quanto mai opportuna la scelta di averlo messo a chiusura del libro, quasi come cifra finale e firma autenticante: Per isole di calce, passaggi di carminio, per sprazzi gialli e sfumature verdi, ai bordi, sul ciglio d’un ignoto mondo, del più profondo azzurro, ci muoviamo. Sfioriamo un mare immenso, un immenso cielo, uno smisurato spazio… Ci prende e ci trascina questo fiume imperioso nella Venezia e Samarcanda del racconto, della favola, nell’oriente di splendori, nella Bisanzio al culmine del fasto e della grazia…Tracima ora dagli argini, scorre per invisibili passaggi, colma ogni vuoto, abisso, s’addensa a strati, spegne ogni luce, riflesso, culmina nella notte del mondo, nel blu più cupo. Nell’assoluto nero. Compiamo questo viaggio dentro le quinte mobili e fugaci, dentro l’illusione, l’inganno, la malìa dei colori, fra l’apparenza della pittura. Dentro l’avventura dell’azzurro, del colore dell’origine, dell’infinito spazio e dell’eterno, del
dolce color d’oriental zaffiro[6].
È prosa questa, è poesia, è pittura modellata con la parola, o forse è tutto questo insieme? Certamente si registra qui una chiara consonanza fra i vari generi artistico-creativi. E certamente è poesia pura, in sintesi straordinaria la stessa cui ci ha educato in tanti altri suoi scritti Consolo, poesia, cioè, che gronda del sangue umano versato lungo i sentieri terribili della storia ma che vive anche della speranza e della luce della redenzione e della libertà. Poesia pura che sembra fare da antifona ai versi della successiva La palma celeste, scritto nel quale la festa di colori cangianti e il ritmo spezzato del gioco della memoria sembrano sintetizzare una sorta di metafora del cammino della vita tra natura e cultura.
Non è, del resto, un caso che Consolo abbia amato l’arte e la figura di Antonello da Messina, sino a farne un fermo punto di riferimento della sua ricerca artistico-letteraria, al punto da divenirne una sorta di alter ego empatico e consonante. La grandezza di Antonello ha le stesse radici dalle quali sarebbe germogliata anche quella di Consolo. Sembra, infatti, che lo scrittore stia parlando anche di sé stesso, quando, riferendosi ad Antonello, afferma che tanta grandezza, tanta profondità e tali vertici non si spiegano se non con una preziosa, spessa, enorme sedimentazione di memoria. Ma di memoria illuminata, capita dopo il confronto con altre realtà, dopo aver messo la giusta distanza tra sé e tanto bagaglio, giusto equilibrio tra caos e ordine, sentimento e ragione, colore e geometria[7]. Come poi avrebbe fatto anche Consolo, Antonello dovette andare via da Messina e dalla Sicilia, per potere trovare la via della sua creatività artistica: Il suo andare a Napoli, a vent’anni, l’ha salvato, gli ha salvato la ragione e il prezioso talento di pittore. Nella bottega di Colantonio gli si sono dispiegati nuovi orizzonti, ha visto nove cose, sentito nuovi linguaggi. E il suo vedere e il suo sentire altre realtà dovevano essere una continua verifica, un’illuminazione, una razionalizzazione, un controllo della realtà che si portava dentro, nella sua memoria: la realtà di Messina…e lascia il mare per la terra, l’esistenza per la storia. La Sicilia e Messina possono così tornare attivamente, espressivamente, in tutta la loro “oggettiva” bellezza e passione[8]. L’andare di Consolo ventenne a Milano, a respirare l’aria dell’ambiente vittoriniano salvò il talento dello scrittore messinese, come la Napoli di Colantonio aveva salvato quello di Antonello, perché anche lo scrittore di Sant’Agata Militello potè guardare “oggettivamente” la Sicilia e farne oggetto di appassionato canto memoriale senza i limiti esistenziali talora insiti nel provincialismo, specialmente quando questo è acritico. E, come per Antonello il tornare a Messina ormai, saldo com’è, non comporta alcun rischio[9], così per Consolo la distanza interiore stabilita era garanzia di salvezza definitiva, anche se la sirena dello Stretto richiamava sempre in patria[10] anche lui come il pittore. Ma ormai non c’era rischio d’involuzione così per l’uno come per l’altro. Tra i due grandi messinesi si configurano i termini di un parallelo cammino, anzi viaggio, di vita tra sogno e nostalgia, tra l’isola e il mondo, Messina e la Sicilia, da un lato, la storia con la sua logica, dall’altro. Solamente così, al prezzo dell’esposizione e dell’alghios del ritorno, il palcoscenico del teatro siciliano, sempre amato tra illusione e disinganno, potè trasfigurarsi nel paradigma di un più vasto teatro, facendo sciascianamente assurgere, con le opere dei due grandi messinesi, la Sicilia a metaforico teatro del mondo; il che la dice lunga sugli orizzonti culturali, artistici, politici e fondamentalmente umani dei due corregionali, la cui lontana e pur vicina somiglianza, forse non a caso – nella vita di Consolo poco era lasciato al caso — è resa iconograficamente visibile in alcune immagini fotografiche di lui che, con un pizzico di autoironia – velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà[11] —, si è fatto riprendere come l’uomo del Ritratto d’ignoto marinaio conservato al Museo Mandralisca di Cefalù o è stato ritratto, sempre con le stesse caratteristiche, dall’amico pittore Bruno Caruso, il quale ha disegnato anche, con le caratteristiche e il copricapo dell’ignoto marinaio lo stesso Antonello che varca lo Stretto di Messina[12]. E non è Consolo stesso a confermare, in quell’Autoritratto, forma di poesia visiva, significativamente messo a clausola del libro, con l’immagine dell’uovo e del limone la parentela con i volti geometrici ma intelligenti e pensosi di Antonello? Come a dire che tout se tient.
[1] V. Consolo, L’ora sospesa, Le Farfalle, Valverde 2018, p. 42.
[2] Ibidem.
[3] V. Consolo, Le pietre di Pantalica, Mondadori, Milano 1990 p. 179.
[4] V. Consolo, L’ora sospesa, cit., p. 70.
[5] Ivi, pp. 68, 69.
[6] Ivi, pp. 121-122.
[7] Ivi, p. 103.
[8] Ivi, p. 108.
[9] Ivi, p. 109.
[10] Ibidem.
[11] Ivi, p. 117.
[12] Cfr. E. Bilardello, Bruno Caruso, Flaccovio, Palermo 1986, p. 159.