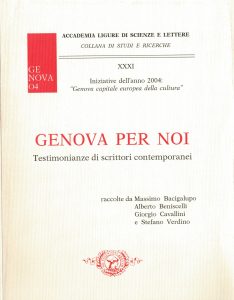*
Chimica industriale! – esclamarono tutti insieme. Tutti, vale a dire mio padre e i tre zii, soci della ditta commerciale fondata da mio nonno: compravano, loro, l’olio che si produceva nella zona, nei frantoi dei proprietari terrieri dei paesi dei Nèbrodi, riempivano cisterne e cisterne di vagoni ferroviari e spedivano agli industriali Costa di Genova, i quali imbottigliavano quell’olio insieme ad altro ligure toscano o pugliese, con l’etichetta Olio Dante.
Chimica industriale! – esclamarono in coro durante la riunione per stabilire a quale facoltà universitaria mi sarei dovuto iscrivere, io, figlio e nipote tanto studioso che aveva appena conseguito brillantemente la licenza liceale. La chimica industriale, poiché loro avevano progettato di promuoversi da commercianti ad industriali, costruire là in paese una raffineria e imbottigliare l’olio come i Costa di Genova. E quindi io, divenuto chimico, avrei dovuto dirigere l’impresa. Il più deciso, nell’imporre a me quegli studi, era lo zio Giovanni, il maggiore esperto, tra i suoi fratelli, di olio. Gli portavano, i venditori, i campioni in bottigliette. Stappava, ne versava in bocca un sorso, suggeva, schioccava la lingua, ingoiava e subito sentenziava: due gradi, tre gradi, quattro gradi… E quindi passava alla prova scientifica, con l’olio dentro l’ampolla mischiato a una soluzione che lo colorava di viola, agitato e riversato in un cilindretto centimetrato che rivelava il grado di acidità. L’analisi papillare dello zio e quella tecnica raramente discordavano.
Io, al centro di quel consesso nell’ufficio della ditta, messo di fronte a quelle due terribili parole, chimica industriale, dissi timidamente, arrossendo: “Lettere classiche voglio studiare…” Ci fu un silenzio di meraviglia, d’imbarazzo. Che venne rotto dallo zio Giovanni.
– Ma… Ma quelli sono studi per femmine! – disse.
– Si scivolò quindi verso ingegneria, architettura, medicina, farmacia, economia… Ed io sempre, cocciuto: “No, no, lettere voglio fare!”.
Mio padre allora, impietosito, mi venne incontro, avanzò un compromesso.
– Senti, – disse – una via di mezzo è giurisprudenza… Quella ti apre molte strade, puoi decidere poi, da qui a quattro anni, quello che vuoi fare: avvocato, giudice, notaio, amministratore d’azienda…
– E si guardarono, i quattro, ammiccando: un chimico sicuramente pensarono, avrebbero potuto assumerlo, mentre io, da leguleio, avrei amministrato e diretto la loro industria.
– Accettai. Tanto, pensai, avrei continuato a studiare lettere per conto mio, di nascosto, avrei continuato a leggere romanzi e poesia.
– E dove vuoi andare a studiare, a Palermo, a Messina…. – chiese mio padre.
– No, no, – intervenne uno zio – sempre su quei treni, avanti e indietro… Finisce che si sbanda, che non studia. Al Nord, lo mandiamo al Nord! A te dove piacerebbe andare, a Bologna, a Milano, a Torino?…
– A Milano – risposi deciso. A Milano avevo sempre pensato, dov’erano stati Verga e Capuana, dov’erano allora Vittorini e Quasimodo, dov’era Montale.
E fu così che m’installai nella capitale lombarda, in una casa di piazza Sant’Ambrogio attaccata al portico della basilica, quella “fuori mano” del Giusti, e divenni pensionante, l’unico della signorina Colombo, un’anziana (così sembrava a me allora diciottenne) che vestiva sempre di nero, parlava solo in dialetto e lamentava che le sue giovani nipoti, due gemelle, erano scappate di casa per andare a Nomadelfia, a lavorare nella città dei ragazzi di don Zeno Saltini. Nella piazza, in un grande edificio, era ubicato il coi, Centro Orientamento Immigrati. Là giungevano i tram provenienti dalla stazione Centrale e scaricavano masse di emigranti meridionali che, dopo le visite mediche e disbrigo di pratiche burocratiche, sarebbero andati a lavorare nelle miniere belghe o nelle fabbriche di Svizzera e Francia. Si determinavano, in quegli anni del Dopoguerra, i destini di molti italiani. Era quella la storia che allora più m’interessava, che cercavo di capire con la lettura di libri sulla questione meridionale, i libri di Gramsci, Dorso, Salvemini o Carlo Levi. Letture appassionate fatte insieme al doveroso e penoso studio del diritto privato, filosofia del diritto o economia politica.
Fu uno dei primi mesi del mio soggiorno milanese, che un giorno, di primo mattino, spuntò alla pensione della signorina Colombo lo zio Giovanni, l’esperto di olio, il più grande e più autorevole dei quattro fratelli.
Mi disse: – Io vado a Genova dai Costa. Tu vieni con me.
Giunti alla stazione Principe, c’incamminammo verso piazza Dante, dov’era il grattacielo con gli uffici dei Costa. Lo zio andava con passo veloce, malgrado il peso del valigione, io rallentavo per guardare la gente, mi fermavo per ammirare le facciate dei magnifici palazzi di quella fitta città verticale, delle chiese, mi beavo nel ritrovare la mia luce marina, lasciati i grigiori e le nebbie di Milano.
– Svelto, svelto, cammina. Ho l’appuntamento alle quattro precise. Salimmo, dentro il veloce ascensore, fino al diciassettesimo piano del grattacielo. E fummo introdotti nell’ufficio di uno dei Costa, Giacomo credo si chiamasse. Un signore dall’aria severa, ma dal tratto gentile, ascoltava con attenzione il parlare impacciato e affannoso dello zio Giovanni; io guardavo, al di là di una grande vetrata, il mare in fondo solcato da navi, guardavo la conca del porto con i denti dei suoi ponti, delle sue banchine, sognavo di salire su una di quelle navi e di andare, andare…
Lo zio mi scosse dall’ineducata distrazione, dall’incanto, stringendomi forte a un braccio. Io volsi subito lo sguardo verso quel benevolo signore dietro la scrivania.
– Questo mio nipote studia a Milano. Giurisprudenza – disse con un sospiro – Ma noi speriamo che dopo la laurea verrà giù a lavorare nell’azienda.
E quel signore sorrise, dubbioso sicuramente, nel vedere la mia aria svagata, sognante, di un mio avvenire di azienda, di praticità, di affari.
Dormimmo a Genova, lo zio ed io, e l’indomani, separandoci, egli sarebbe tornato in Sicilia ed io a Milano. Ma dopo che il treno si mosse e lo zio scomparve alla vista, decisi di restare a Genova, solo, libero, ancora per qualche giorno, di conoscere quella città. E la percorsi nei suoi carruggi, via Prè, via del Campo, piazza Banchi, la Ripa, strade strette e affollate, piene di vita, movimento. Mi riportavano, quelle strade, a Palermo, alla Vucciria, al Capo, ai Lattarini, a Ballarò.
Fu quella per me una giornata di gioia, di scoperte. E una giornata infine anche di tristezza, in cui vidi, verso sera, partire una grande nave piena di emigranti, di gente che avrebbe raggiunto gli Stati Uniti o l’Argentina. I parenti, sul molo, salutavano e piangevano.
Comprai in un negozio sotto i portici di Ripa, un souvenir, una sfera di vetro con dentro una nave, una nave che spariva dietro la neve, se appena la sfera si scuoteva. Rimase da allora e ancora oggi quella sfera come ricordo della nave di emigranti che partiva. Ricordo anche di Genova e del suo destino marinaro, di Colombo e Andrea Doria, di tutti i naviganti del Mediterraneo ed oltre le Colonne d’Ercole. Di questa città forte e tenace, di piccola terra e di infinito spazio marino, di ogni inimmaginabile avventura e di conquista prodigiosa. Da quella piccola conca del suo porto nacque la storia della grande Genova, della repubblica della fantasia e del coraggio. Marina, Genova, come Marsiglia Napoli o Istanbul. Ummelumà, la madre del mondo, chiamarono i Turchi Costantinopoli. È madre Istanbul, è madre Napoli “de Italia gloria y aun del mundo lustre”, come la elogia Cervantes; madre Istanbul e così Barcellona e Algeri. Ma Genova è padre, padri sono i suoi navigatori avventurosi, i suoi sagaci imprenditori, simili a quelli che partivano dagli angusti porti fenici, Biblo o Sidone, e scoprivano l’ignoto occidente mediterraneo.
[i] In Genova per noi, Testimonianze di scrittori contemporanei raccolte da Massimo Bacigalupo, Alberto Beniscelli, Giorgio Cavallini e Stefano Verdino, Genova: Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2004, pp. 36-40. Stesso testo, col titolo: Ho fatto l’emigrante per cagioni di cuore, «Stilos», supplemento di «La Sicilia», 20 luglio 2004.
Pubblicato anche su “La mia isola è Las Vegas”
Arnoldo Mondadori Editore, aprile 2012