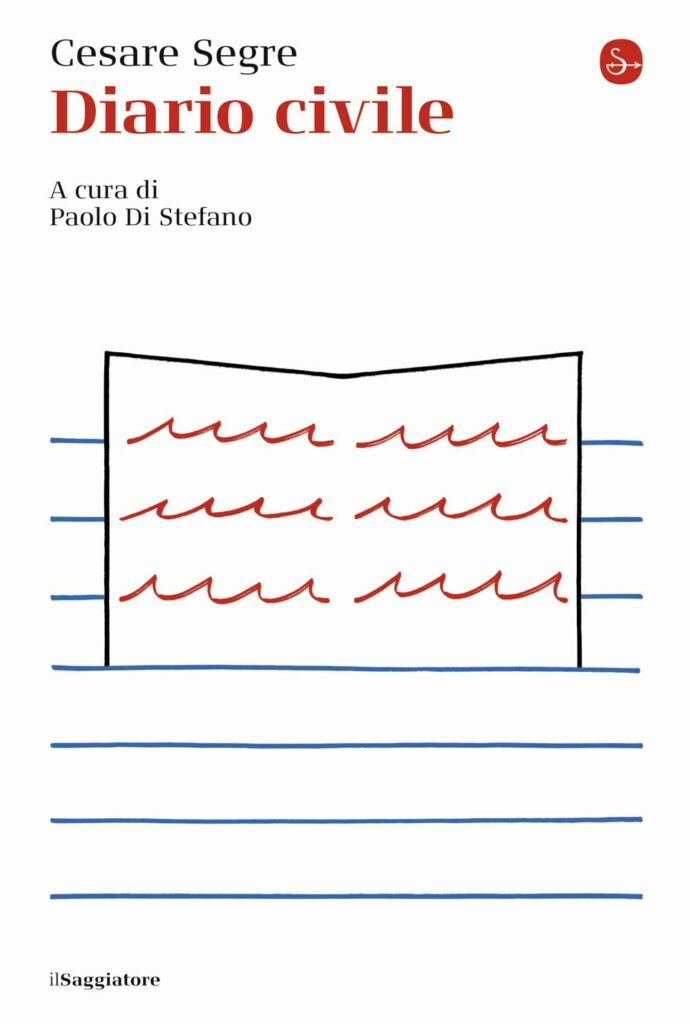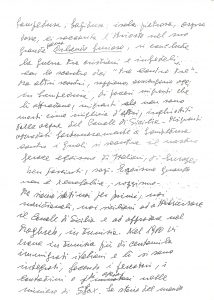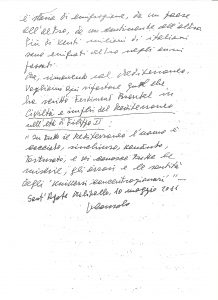Intrecci mediterranei.
La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo
di Massimo Lollini
Cosa in comune quest’isola di culto, questo giardino, i suoi astanti, cosa l’ affabile algerino, tu coi cristiani di Bosnia, Sarajevo, i mercenari d’ogni Africa, i trafficanti d’armamenti, i boia d’ogni scarica e veleno, i Mafiosi del potere? Nel bronzo, si, e la crepa, il varco in ogni sacro testo, ogni decalogo, codice latino o d’altra lingua, dentro te, ognuno in questo tempo feroce e allucinato. (Lo spasimo di Palermo 41-42) Il mare, l’infinito e la guerra Concludendo un’importante riflessione sull’eredita mediterranea nella cultura europealo storico Georges Duby osservava un ventennio fa che “da circa un secolo il Mediterraneo offre a chi lo scruta, agli avamposti della speranza, un volto di violenza” (Duby 282). In realta questo volto violento richiama alla memoria storica la “parte piu tenebrosa” dell’eredita del classicismo greco-romano presente fin nelle origini della civilta mediterranea. Nella ricostruzione dei momenti fondamentali di questa civilta lo stesso Fernand Braudel ha sottolineato il carattere decisivo dei “conflitti tra civilta” da quelli brevi (Maratona, Lepanto) a quelli lunghi, come le tre guerre puniche o le crociate. Secondo Braudel questi conflitti mettono bene in evidenza “quali urti sordi, violenti e reiterati si scambino quegli animali possenti che sono le civilta”; e come le civilta siano “intrise di guerra e di odio, una immensa zona d’ombra che le divora quasi per meta” (Braudel, “La Storia” 110-11). Tuttavia le civilta non sono solo questo odio fabbricato e nutrito per l’altro. Esse rappresentano anche l'”eredita dell’intelligenza” l’accumulo dei beni culturali, sacrificio. Questi due elementi, quello “distruttivo” e quello “costruttivo,” appaiono strettamente intrecciati e appare quanto mai arduo e problematico il tentativo di separarli quasi fossero realta distinte ed autonome, come talora sembra proporre lo storico Braudel. La ricerca sul ruolo del Mediterraneo nella formazione dell’immaginario letterario europeo deve cogliere questo aspetto, se non vuole assecondare la marea montante di parole che puntano a derealizzare l’esistente e a costruire un mondo puramente ideologico che finisce per cancellare ogni consapevolezza della realta in cui si vive. Il saggio prende avvio da una riflessione sul nesso che si stabilisce nella cultura greca da una parte trail mare e l’orientamento verso l’infinito, e dall’altra trail mare e la guerra. Le due nozioni, quella di una ricerca intellettuale infinita e quella della guerra come esito inevitabile dell’attraversamento del mare, trovano un modello esemplare nella figura dell’Ulisse omerico, che i greci hanno lasciato in eredita alle letterature europee dall’antichita fino ai nostri giorni. L’esperienza della guerra di Troia ha segnato Ulisse in maniera profonda, rendendolo capace di un senso di pietas per il dolore proprio e altrui inconcepibile nel contesto dell’Iliade che rimane il “poema della forza” come ha scritto Simone Weil. L’episodio di Odisseo nella reggia feacia che piange sentendo il canto di Demodoco (da lui stesso richiesto) dove si racconta l’inganno del cavallo di Troia, e senza dubbio rivelativo di un profondo mutamento dell’eroe nel passaggio dal primo al secondo poema omerico (Odissea, libro VIII). Ma e la catabasi raccontata nel canto XI che rende manifesto in maniera inequivocabile il cambiamento rispetto al codice dell’eroismo al centro dell’Iliade. L’episodio piu potente rimane l’incontro con l’anima di Achille che preferirebbe essere un servo di una padrone povero piuttosto che essere morto. Emerge qui con forza la novita piu profonda dell’Odissea, il riconoscimento del dolore della propria morte e la scoperta della privazione dell’identita che essa comporta. La discesa di Odisseo nell’Ade rimane centrale nell’economia del racconto omerico cosi come si articola nei due poemi. Odisseo desidera ardentemente incontrare non solo Tiresia per conoscere il proprio destino, ma anche le anime di molti defunti per interrogarle sulle modalith e il senso della morte. In essi Odisseo trova una sapienza che e estranea ai vivi, la consapevolezza profonda del dolore che pervade la vitae il limite invalicabile rappresentato dalla morte. Altri momenti significativi del viaggio di Odisseo nell’Ade sono l’incontro con l’anima del compagno Elpenore e quello con la madre piangente. L’anima di Elpenore e la prima che si fa incontro ad Odisseo e lo implora di seppellire e compiangere il suo corpo rimasto in casa di Circe senza sepoltura. La dimensione del compianto e del lamento funebre per la morte dell’altro e al centro anche dell’incontro con l’ombra della madre. Il figlio vivo si trova qui unito alia madre morta nel comune desiderio di dare espressione al proprio dolore e al proprio pianto. Il viaggio nell’Ade e il lamento funebre sono importanti per Odisseo e la cultura greca e mediterranea almeno nella stessa misura del viaggio in mare. (4) Il viaggio in mare rappresenta cio che si teme piu profondamente, l’esposizione al pericolo infinito e incondizionato, la paura di una morte negli abissi marini senza sepoltura umana. Il viaggio nell’Ade e la sepoltura rappresentano la riconciliazione con gli esseri umani e divini, il conforto rappresentato dal lamento funebre che aiuta a vivere e a dare un senso sia pure straziante alla morte. Ma anche se tu tornassi se le distanze si accorciassero e la guida fiammeggiasse nel tuo sembiante tragico o nel tuo terrore intimo, sempre per me tu saresti la storia della partenza per sempre tu saresti in una terra senza promessa in una terra senza ritorno. Anche se tu tornassi, Ulisse. (Adonis Poesie) Questi versi, letti insieme a quelli di un’altra poesia di Adonis, L’erranza, bastano da soli a far comprendere come la condizione dell’esilio e dell’erranza siano una condizione irreversibile nella cultura mediterranea moderna sia nel mondo cristiano che in quello arabo. I versi di Adonis sono veramente significativi, soprattutto se letti insieme alle sue dichiarazioni di poetica (5): L’erranza, l’erranza L’erranza ci salva e guida i nostri passi L’erranza e chiarezza E il resto e solamente maschera L’erranza ci lega a tutto quello che e altro Ai nostri sogni imprime il volo dei mari E l’erranza e attesa. (Adonis Poesie) Nel verso “L’erranza ci lega a tutto quello che e altro” e contenuto il senso profondo della condizione dell’Odisseo moderno cosi come si manifesta nella tradizione mediterranea araba e cristiana, con molti punti in contatto con analoghe concezioni ebraiche che pure non si riferiscono al mito di Ulisse ma a quello di Abramo. Si tratta di una condizione di continuo esilio che rifiuta ogni certezza in nome di un apprezzamento intrinseco di tutto cio che e altro. Pur comprendendola Dante condanna la ricerca intellettuale di Ulisse dal momento che non e illuminata dalla luce divina. Per questo il viaggio di Ulisse rimane un “folle volo” che mantiene comunque qualcosa in comune con qualunque aspirazione alla conoscenza autentica e creativa, come sapeva bene Dante e come sanno gli scrittori moderni e contemporanei che sono venuti dopo di lui. Vincenzo Consolo dedica un capitolo de L’olivo e l’olivastro (1994) alla riscrittura del viaggio di Odisseo che viene presentato come metafora dell’esperienza del viaggio dello scrittore siciliano attraverso la sua isola e, piu in generale, come figura dell’uomo moderno e dello sradicamento esistenziale e storico provocato dalla civilta tecnologica da lui creata. Dopo la risoluzione del conflitto Ulisse si trova di nuovo immerso nella vastita del mare. Il suo viaggio questa volta procede in verticale e si presenta come “una discesa negli abissi, nelle ignote dimore, dove, a grado a grado, tutto diventa orrifico, subdolo, distruttivo” (19). Il viaggio di Odisseo nasce dall’orrore della guerra e dal senso di colpa per le morti e le distruzioni, e il viaggio di un sopravissuto. (9) E un viaggio dal mare verso la terra, da Oriente ad Occidente, “dall’esistenza alla storia, dalla natura alla cultura” (124) un viaggio al termine del quale non c’e la patria agognata, ma la condizione perenne dell’esilio. L’Itaca che trova l’Ulisse moderno non esiste pit perche e sottoposta ad una continua distruzione, del tutto simile a quella che esperimenta durante la guerra. Per questo, scrive Consolo, Ulisse comprende che Itaca coincide con Troia ed e costretto a ripartire, condannato ad una condizione di erranza. Nessun viaggio penitenziale o liberatorio appare possibile allo scrittore siciliano. Itaca la citta del mito non esiste pit; le citth della memoria e della letteratura appaiono sempre piu lontane. Siamo Iontani dal modello rappresentato da Conversazione in Sicilia di Vittorini che pure ha ispirato gli ultimi due romanzi di Consolo. Il romanzo di Vittorini poteva ancora contare sulla “conversazione” come mezzo per una rigenerazione spirituale e morale. Il ritorno di Silvestro in Sicilia serve proprio a questo e si nutre di un potente linguaggio lirico e simbolico che aiuta il protagonista a ritornare ormai deciso e maturo nella Milano del lavoro, dell’industria e della lotta politica per la costruzione di una nuova Itaca. La critica della cultura per Consolo non si nutre piu di alcuna utopia, mentre la posizione privilegiata della coscienza che valuta e giudica l’ordine delle cose appare sempre piu pervasa da domande inquietanti. Il paesaggio che ci descrive Consolo ha perduto la dimensione lirica e simbolica assumendo una sostanza allegorica in cui non si intravede una via di riscatto. E un paesaggio di rovine quello a cui approda l’Odisseo moderno. Un paesaggio in cui l’immagine di Itaca appare sbiadita al punto da scomparire. L’unica alternativa per lui sembra essere quella, gia indicata da Dante, del naufragio definitivo come conseguenza del “folle volo” di Ulisse. Si tratta di un’immagine drammatica, che Primo Levi ha fatto sua a conclusione del capitolo “Il canto di Ulisse” che non a caso ha un ruolo centrale in Se questo e un uomo. Per Consolo, come per Primo Levi (e Italo Calvino), la posizione etica delia scrittura consiste sempre piu in questa volonta di testimonianza che pone questioni fondamentali sul destino della civilta europea, e si esprime in domande radicali che coinvolgono il gesto stesso della scrittura, intesa come strumento fondamentale della cultura, della tecnologia e del sapere occidentale. Occorre allora chiedersi se la nozione di “esilio” su cui Consolo stesso ha insistito, sia la piu adeguata e dar conto dello spessore della sua ricerca intellettuale. Ritorneremo su questa importante questione nell’ultima parte del saggio. Le domande dello scriba menzogna l’intelligibile, la forma, o verita ulteriore? (Nottetempo 164) E questa la situazione in cui si muove anche il protagonista de Lo spasimo di Palermo (1998), Gioacchino Martinez, scrittore in crisi che si trova sempre piu perplesso e sgomento di fronte al gesto della scrittura: Aveva tentato infinite volte la scrittura, lettere memorie resoconti, ma l’orrore nasceva puntuale per quell’ordine assurdo, quel raggelare la ferita, quella codificazione miserevole dell’assenza prima e poi assoluta, dell’improvviso vuoto, dello sgomento fisso. (53) Questi ragionamenti sulla scrittura, piuttosto che ridursi a puro gesto autoriflessivo e solipsistico, rappresentano la linfa profonda che collega la riflessione di Consolo nella trilogia romanzesca rappresentata dal Sorriso dell’ignoto marinaio, Nottetempo, casa per casa e Lo spasimo di Palermo. Come accade in Primo Levi, Italo Calvino e nei maggiori scrittori del Novecento, Consolo inserisce nell’orizzonte della scrittura letteraria la presenza di un soggetto filosofico che riflette sulla propria attivita, nel tentativo di comprenderne l’orizzonte e il senso. Accade cosi chela domanda sulla possibilita del racconto e della scrittura e la parallela aspirazione a dare una testimonianza vera dei processi storici possono trovare espressione non tanto nella dissoluzione della forma e della soggettivith, ma nel “vuoto della forma” e nella decisione in base alia quale il soggetto filosofico trova nella contingenza della propria vita il proprio modo di abitare la verith (Lollini). Non posso dire di ricordare esattamente come e quando il mio greco scaturi dal nulla. In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra: il mondo intorno a noi sembrava tornato al Caos primigenio, e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava in moil ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi. (I: 226; mia l’enfasi) In maniera significativa la stessa metafora ritorna alia fine, nell’ultima pagina del libro in cui si spiega perche il viaggio di ritorno non e stato ne poteva essere un viaggio liberatorio: … non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. E un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena; eppure provo un’ angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo diverso, tutto cade o si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone e l’angoscia si fa piu intensa e piu precisa. Tutto e ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo: sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o l’inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la casa. (I: 395; mia l’enfasi) Alla fine del lungo e avventuroso cammino che, come buona parte della narrativa di viaggio ha come modello appunto l’Odissea di Omero, Levi deve constatare di non essere riuscito ad allontanarsi dal Campo e che anche nella sua Itaca la memoria del Lager ritorna ossessiva e implacabile: Testimonianza e alterita Non riconosci la terra da cui eri partito. Chi sia, domandano, il reduce avvolto nella nebbia, nascosto dietro la vizza maschera del viso, privo di doni, di bottino. (Lo spasimo di Palermo 101) Le vicende storiche piu recenti, dalla guerra nella ex-Jugoslavia agli attuali conflitti in Afghanistan e Iraq, non fanno che confermare le tendenze remote della storia Europea nell’era della globalizzazione. L’attraversamento del mare finisce per dar luogo anche oggi al conflitto armato e alla fondazione di un ordine mondiale fondato sulla forza e sul mancato riconoscimento dei valori positivi insiti nella diversith culturale. E significativo che l’operazione bellica che ha portato all’ulteriore distruzione dell’Afghanistan gia stremato dalla poverta e dalla guerra pluridecennale sia stata chiamata “Giustizia infinita.” In quell’ aggettivo e da riconoscere un orientamento antico della civilta occidentale nata sulle sponde del mare greco. Ancora una volta il mare non appare un luogo di incontro e di comunicazione, ma di conflitto e di conquista che oggi assumono dimensioni planetarie. L’era attuale e stata preparata dalle rivoluzioni scientifiche e spaziali del diciassettesimo secolo. Sul piano scientifico, come ha scritto Koire si e passati dal mondo cosmico e chiuso della scienza antica aristotelica e tomistico-medievale all’universo infinito della scienza moderna, introdotta dal canocchiale di Galileo. La metafora geometrica e spaziale serve a introdurre la grande rivoluzione della concezione della spazio di cui ha parlato Carl Schmitt che vede in questo secolo e nelle scoperte geografiche che lo hanno preparato l’affermarsi di una dimensione “oceanica” della storia universale, con un’enorme dilatazione dello spazio, fattosi infinito e “vuoto.” Schmitt parla del passaggio dal nomos della terra fondato sulla condizione continentale europea e caratterizzato dal carattere locale dei conflitti al nomos del mare, in cui predomina l’infinito, dell’incondizionato, il movimento e la volonta di potenza, la guerra totale e lo spirito della tecnica senza piu limiti. Il mare di cui parla Schmitt non e piu il Mediterraneo, ma l’Oceano che e il vero protagonista della rivoluzione spaziale moderna e serve per comprendere la dimensione mediterranea in un orizzonte piu vasto e attuale. Schmitt vedeva nella condizione insulare dell’Inghilterra (e a suo modo degli Staff Uniti) il simbolo di questa rivoluzione spaziale alle origini della modernita (Schmitt). Sono fenomeni ancora in corso che si manifestano nei conflitti sempre piu numerosi e incontrollati. Consolo-Odisseo moderno continua i suoi viaggi nel Mediterraneo per portare testimonianza di questi processi violenti in toni che a tratti si fanno apocalittici e profetici. In questa prospettiva si collocano gli scritti giornalistici usciti negli ultimi anni sul Corriere della sera o l’Espresso. Tra questi ultimi spiccano “Viaggio a Sarajevo” e “Viaggio in Israele/Palestina del PIE.” Nel primo testo Consolo racconta di un viaggio fatto con altri scrittori italiani per testimoniare la guerra sanguinosa della ex Jugoslavia. (12) Ritroviamo qui il paesaggio di rovine e distruzione che hanno colpito soprattutto Sarajevo, una citta un tempo civile e fiorente nella tolleranza religiosa ed etnica. La testimonianza di Consolo insiste sulle atrocita commesse da uomini ormai privi di ragione e ridotti a natura, tanto che l’immagine di Sarajevo devastata dalla violenza umana a suoi occhi assomiglia alle immagini di Assisi colpita da un terribile terremoto nei giorni in cui egli si trovava a Sarajevo. n questo ambito di scritti tra testimonianza e profezia occorre ricordare anche il “Memoriale di Basilio Archita” (Consolo, Le pietre di Pantalica 183-91), un breve racconto-saggio dove lo scrittore testimonia di un’altra tragedia che insanguina il Mediterraneo nei nostri giorni. Si tratta del racconto della morte violenta di un gruppo di africani che imbarcatisi clandestinamente su una nave greca sono poi gettati in mare e divorati dai pescecani. La tragedia dei clandestini che muoiono nel tentativo disperato di attraversare il mare per sfuggire ad un destino di fame e poverta non aveva ancora assunto le dimensioni attuali quando Consolo scrive questo testo. Le sue parole assumono qui un ruolo veramente profetico nel mostrare il livello di degenerazione raggiunto dalla civilta greca e mediterranea. I versi del poeta greco Kavafis recitati dal vicecomandante della nave greca non fanno che confermare la decadenza di una cultura priva di un senso di responsabilita o di una visione etica e civile della convivenza umana. Si tratta di una cultura ormai incapace di riconoscere se stessa. La voce narrante del racconto, e quella di Basilio Archita un giovane sfruttato a bordo della nave greca che pure esprime un elementare senso di solidarieta con le vittime. Tuttavia egli non e affatto consapevole dell’origine greca del suo nome e trova un senso di identita unicamente nell’abbigliamento offerto dal consumismo di massa. In questa situazione per tanti aspetti distruttiva risulta veramente preoccupante il venir meno di un vigile senso critico nella cultura contemporaneo come si vede nell’accettazione sempre piu passiva dei fenomeni distruttivi in corso, e nel consenso diffuso che hanno incontrato in occidente le parole d’ordine di guerra dopo gli eventi del terribile il settembre 2001. Minoranze sempre piu esigue si oppongono con la forza della ragione a questo stato di cose dove la violenza del terrorismo e quella degli stati belligeranti non sembra aver piu limiti. Questa situazione ci aiuta oggi a capire il senso profondo delle opere di scrittori come Levi e Consolo che hanno denunciato il carattere pervasivo della maledizione tecnologica e del contagio della violenza distruttiva che domina la storia dell’Occidente. Proprio in questa testimonianza consiste l’attualith e la forza del loro messaggio non tanto nell’adesione al pensiero dell’erranza e dell’esilio che pure e presente nei loro scritti. NOTE (1) Della Weil the considera la guerra come “il principale motore della vita sociale” (Quaderni 1: 189), si veda il fondamentale saggio “L’Iliade poema della forza” (Weil 10-41). Cfr. anche la raccolta di saggi Sulla guerra. Hannah Arendt indica l’esistenza di un rapporto strutturale tra polemos e polis. Sostiene the la violenza e la guerra di per se non sono politiche ma fondano tuttavia la politica. Si veda la raccolta di saggi Arendt tradotia in italiano con il titolo Politica e menzogna (Milano: SugarCo, 1985). Su tutta la questione si veda Esposito. (2) Su questo aspetto si veda Boitani che intende Ulisse come “figura” o umbra nel senso di Auerbach. (3) Su questo punio, si veda Gentiloni. Put criticando l’impostazione schematica di Levinas Gentiloni sottolinea le differenze tra Ulisse e Abramo e indica nel cerchio la metafora della cultura greca e nella freccia quella della cultura ebraica, la logica contro il suo superamento (121). (4) Ernesto de Martino ha mostrato l’esistenza di una modalita mediterranea del lamento funebre a partite da uno studio sul pianio rituale delle donne lucane. Cfr. De Martino. La prima edizione del saggio e del 1958. (5) Adonis sostiene the la modernita non e specifica di un paese o di un popolo. Il suo aspetto universale consiste nello sviluppo scientifico che non si puo evitare. Adonis sostiene una visione creativa della modernita e conclude: .” .. the questions ‘What is knowledge?’, ‘What is truth?’, ‘What is poetry?’ remain open, … knowledge is never complete and truth is a continuing search” (Adonis, An Introduction to Arab Poetics 101). Cacciari, Massimo. Geo-Filosofia dell’Europa. Milano: Adelphi, 1994. Consolo, Vincenzo. Le pietre di Pantalica. Milano: Mondadori, 1988. –. Nottetempo, casa per casa. Milano: Mondadori, 1992. –. L’olivo e l’olivastro. Torino: Einaudi, 1994. –. Lo spasimo di Palermo. Milano: Mondadori, 1998. –. Di qua dal faro. Milano: Mondadori, 1999. –. Il sorriso dell’ignoto marinaio. 1976. Torino: Einaudi, 2000. Consolo, Vincenzo, e Franco Cassano. Rappresentare il Mediterraneo. Lo sguardo Italiano. Messina: Mesogea, 2000. Consolo, Vincenzo, e Mario Nicolao. Il viaggio di Odisseo. Milano: Bompiani, 1999. De Crescenzo, Assunta. “Paesaggio e mito Mediterraneo Nell’opera di Luigi Pirandello.” Il mare ciclope. Per un’identita Mediterranea. III Concerto Spettacolo. Atti del Convegno di Napoli 24 Aprile 1999. Ed. Assuta De Crescenzo e Aristide La Rocca. Napoli: Liguori, 2003. De Martino, Ernesto. Morte e pianto rituale nel mondo antico. Torino: Einaudi, 1958. Duby, Georges. “L’eredita.'” Il Mediterraneo: lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni. Ed. Fernand Braudel. 1985. Milano: Bompiani, 2003. 267-82. Esposito, Roberto. L’origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil? Roma: Donzelli, 1996. Gentiloni, Filippo. “Il viaggio fra mito e religione: Abramo Contro Ulisse.” Il viaggio. Ed. Di Giovanni Gasparini. Roma: Edizioni Lavoro, 2000. 117-32. Koyre, Alexandre. Dal mondo chiuso all’universo infinito. Milano: Feltrinelli, 1988. Levi, Primo. Opere. Ed. Marco Belpoliti. 2 vols. Torino: Einaudi, 1997. Levinas, E. “La signification et le sens.” Revue de Metaphysique et de Morale 2 (1964): 125-56. Lollini, Massimo. Il vuoto della forma. Scrittura, testimonianza e verita. Genova: Marietti 1820, 2001. Mondolfo, Rodolfo. L’infinito nel pensiero dell’antichita classica. Firenze: La Nuova Italia, 1956. Montanari, Franco. “I1 viaggio come motivo mitico. Odisseo, il ritorno al passato e un pensiero a Edipo.” Da Ulisse a Ulisse: il viaggio come mito letterario. Atti Del Convegno Internazionale Imperia, 5-6 Ottobre 2000. Ed. Giorgetta Revelli. Pisa: Istituti editoriali e poligrafici intemazionali, 2001. 37-48. Propp Ja, Vladimir. Morfologia della fiaba–le radici storiche dei racconti di magia. Roma: Newton Compton, 2003. Schmitt, Carl. Terra e mare. Milano: Giuffre, 1986. Shay, Jonayhan. Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character. New York: Atheneum Macmillan, 1994. Spinazzola, Vittorio. Itaca, addio. Vittorini, Pavese, Meneghello, Satta: il romanzo del ritorno. Milano: Il Saggiatore, 2001. Weil, Simone. “L’iliade poema della forza.” La Grecia e le intuizioni precristiane. Roma: Borla, 1984. –. Quaderni. A cura di Giancarlo Gaeta. Vol. 1. Milano: Adelphi, 1982. –. Sulla guerra. Scritti 1933-1943. Milano: Pratiche, 1998. MASSIMO LOLLINI University of Oregon Bibliography for: “Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno Odisseo” Massimo Lollini “Intrecci mediterranei. La testimonianza di Vincenzo Consolo, moderno
Odisseo”.
Italica. FindArticles.com. 21 Feb, 2012.