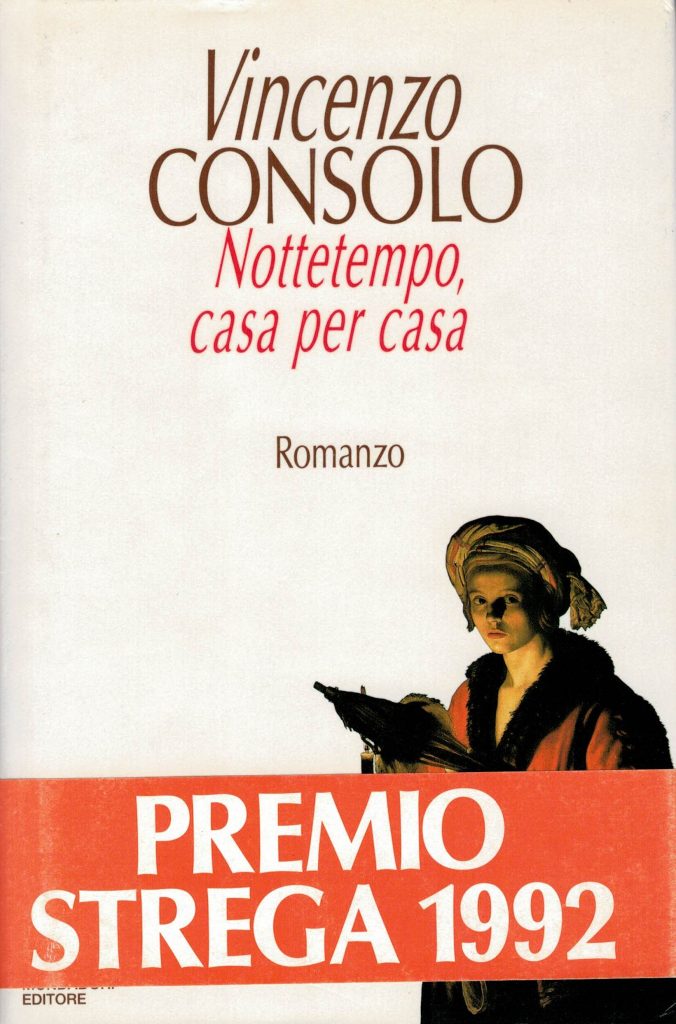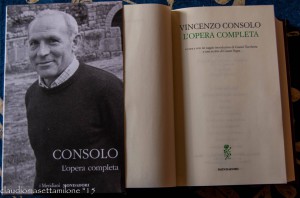Il tema del viaggio è un contenuto della
realtà extratestuale e dell’immaginario (tanto dell’autore quanto del lettore)
che ritorna in opere diverse: si ripete dunque in forme riconoscibili pur
articolandosi ogni volta in modi irripetibili all’interno di costruzioni dotate
ognuna di una propria individualità. Questo contenuto può riguardare
personaggi, passioni, ambienti, eventi, immagini1 . Il viaggio è un evento. In
genere si tratta di un accadimento che coinvolge due o più persone: dopo un
percorso (di una di esse o di tutte, non importa), esse entrano in contatto fra
loro in modo volontario o involontario, programmato in partenza o del tutto
casuale2 . Nel 1993 Consolo ammette: I poli poi, per ragioni di vita e per
scelta ideologica, si sono allontanati, sono diventati Palermo e Milano. E
questi due poli mi hanno fatto essere, oltre che laconico, scrittore scisso,
dalla doppia anima, dal doppio accento. Ma forse no, forse allo storicismo del
vecchio mondo palermitano ho sostituito lo storicismo dell’attuale mondo
milanese3 . I lettori entrano nel mondo della narrazione consoliana attratti non
da questa frase tradizionale “C’era una volta” ma tramite un procedimento ben
diverso e cioè l’uso della congiunzione che apre la storia. E la chiarìa
scialba all’oriente, di là di Sant’Oliva e della Ferla, dall’imo sconfinato
della terra sorgeva nel vasto cielo, si spandeva — ogni astro, ogni tempo
rinasce alle scadenze, agli effimeri, ai perenti si negano i ritorni, siamo
figli del Crudele, pazienza. N, 5 E poi il tempo apre immensi spazi,
indifferenti, accresce le distanze, separa, costringe ai commiati — le braccia
lungo i fianchi, l’ombra prolissa, procede nel silenzio, crede che un altro gli
cammini accanto. SP, 11 Quando la voce del narratore inizia in questo modo, non
è difficile, come sostiene Remo Ceserani, “sospendere la sua vita normale, abbandonare
il mondo in cui scorre la sua vita e trasferirsi, se si sente attirato dalla voce
del narratore e dall’interesse delle vicende narrate […]”4 . Il lettore subito
sin dall’inizio ha impressione di affrontare la continuazione della storia già
raccontata. Consolo riesce a trasformare il passato, anche quello lontano, in
una realtà somigliante agli eventi presenti. Il ciclo della narrativa
consoliana ammette la rappresentazione della Sicilia in varie fasi della sua storia.
L’azione del romanzo Nottetempo3, casa per casa si svolge a Cefalù, negli anni
del sorgere del fascismo. Non è racconto di viaggio, o guida, tuttavia con un
viaggio si onclude. Qui Petro vive una sua educazione sentimentale, politica,
letteraria, scontando sulla propria pelle lo sforzo del rapporto con una realtà
che sfugge ad ogni razionalità, che si lascia dominare da quella “bestia
trionfante” che stravolge quel mondo, che sembra fargli perdere antichi
equilibri e antichi profumi, e trova nel fascismo la sua più compiuta
incarnazione5 . C’è il risentimento verso una patria perduta e le persone che
non si accorgono della perdita. E qui non si parla solo di un confine
siciliano, ma di un oggi che comprende anche altri luoghi. Certo, il discorso
della lingua è chiaro. Consolo ha sempre cercato di scrivere in un’altra lingua
ed è quello che ha sempre irritato i critici, il fatto di “uscire dai codici,
di disobbedire ai codici”6 .
Il viaggio di Nottetempo, casa per casa, è la fuga di Petro da un mondo nel
quale egli vede la civiltà in via di travolgimento e per il quale avverte ormai
odio, al punto da fargli maturare una condizione che egli non sa se, ed
eventualmente quando, vorrà modificare, e quando eventualmente (“Non so adesso”
dice, quasi come Fabrizio Clerici diceva dell’itinerario che avrebbe potuto
prendere l’ulteriore sua peregrinazione) perché le ragioni dell’odio sono per
lui diverse da quelle che muovono l’anarchico Schicchi, non politiche in senso stretto,
non di fazione: e tali ha scelto di mantenerle “in attesa che passi la bufera”,
senza fraintendimenti e perciò nello stesso esilio vivendo scostato da
Schicchi, nella cui prassi riconosce la stessa matrice che ha causato la sua
partenza, “la bestia dentro l’uomo che si scatena ed insorge, trascina nel
marasma, la bestia trionfante di quel tremendo tempo, della storia, che
partorisce orrori, sofferenze” (N, 170)7 . La partenza di Petro assume un
valore emblematico, e in realtà, diventa aterritoriale. 5 Il romanzo Nottetempo, casa per casa contiene
il numero maggiore di elementi raffiguranti la nozione di allontanamento:
l’allusione all’inespresso, alla ritrazione, al rischio dell’afasia, del
silenzio. Pervenuto in prossimità di Tunisi, rimasto solo sul ponte del
piroscafo, Petro lascia cadere in mare un libro che l’anarchico gli aveva posto
in mano per alimento politico, e pensa ad un suo quaderno, sentendo che,
“ritrovata calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato,
sciolto il grumo dentro, avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore” (N,
171): un quaderno perciò egli porta con sé quale viatico dell’esilio, dove
potrà da lontano nominare il dolore, e perciò — comprendendolo — risolverlo, e
questo è tutto il corredo che la sua scelta presuppone8 . Il protagonista di
Nottetempo, casa per casa è un esiliato che rompe a un tratto la condizione di esilio
attraverso la scrittura, diversamente dagli altri, dal padre, ad esempio, che
non può farlo. Il libro si apre con una scena notturna in cui si disegna la
figura oggi rara della malinconia, desueta almeno, in cui la depressione si
svela nel rapporto con la luna piena: quella del licantropo. La cultura
popolare ci ha tramandato vari frammenti intessuti su questa figura, dominata
da un dolore insopportabile che equivale ad un esilio. Come dice l’epigrafe
della Kristeva posta all’inizio del libro, quel dolore equivale a vivere sotto
un sole nero, che può anche stare per l’immagine della luna. È un tentativo di
liberazione dell’angoscia attraverso l’animalità, la fuga, la corsa9 . La
coscienza del dolore proprio e altrui indica una prospettiva che rende
possibile la riflessione su un altra persona. La sofferenza non è qualcosa di
peggiore che richiede il rimandere nascosti. Al contrario, è necessario
prenderla in considerazione quando si vogliono determinare i limiti del potere
umano. Consolo, indicando la sofferenza come l’esperienza fondamentale
dell’esistenza, non si discosta dal discorso sempre più urgente sulla
condizione degli emarginati nel mondo postmoderno. Così Petro fugge, come
Consolo, e “spariva la sua terra mentre egli se ne andava (N, 168).
Petro è spinto da una parte dalla forza
irrazionale di un fascismo che prometteva giustizia e riscossa, specchietti
delle allodole delle dittature incipienti, dall’altra è attratto da quel
socialismo-anarchico la cui contestazione, però, gli appare violenta e
drasticamente tragica. Decide per una ”fuga”, che non è disimpegno, ma scelta
chiara, il che illustra la scena finale: “si ritrovò il libro dell’anarchico,
aprì le mani e lo lasciò cadere in mare” (N, 171). La marginalità del gesto,
tuttavia, non gli scongiura la necessità della fuga da Cefalù, dalla città che
aveva amato nelle cose e nelle persone, e che ora gli era caduta dal cuore “per
quello ch’era avvenuto, il sopravvenuto, il dominio che aveva presa la peggiore
gente, la più infame, l’ignoranza, la violenza, la caduta d’ogni usanza,
rispetto, pietà…” (N, 166); e perciò egli si spinge all’esilio in Tunisia, dove
si reca partendo nottetempo da Palermo, su di un vapore che pure nasconde il
capo anarchico Paolo Schicchi (altro personaggio reale)10. Anche Consolo,
quando si è trasferito a Milano aveva intenzione di raccontare quella Milano
dei contadini siciliani che diventano operai. Ben presto capì che per farlo
aveva bisogno della distanza della metafora storica. È quello che Cesare Segre
acutamente ha sottolineato come peculiarità del suo modo di scrivere: “è il
distanziamento, il bisogno di distanziarsi, anche geograficamente”11. Il motivo
del viaggio, nel primo lavoro: La ferita dell’aprile, si svolge sul doppio
versante del riportarsi all’indietro dell’io narrante al tempo della propria
adolescenza, e di un attraversamento di diversi piani linguistici alla ricerca
di uno stile che si conquista una propria misura espressiva12. E per restituire
alla storia il misterioso e l’ignorato che è nell’uomo e nella collettività,
Consolo sceglie fin da questo primo romanzo la dimensione della memoria e
l’idea del viaggio13. Il labirinto evidenzia cioè nella sua stessa forma
figurale, in quanto metafora assoluta che si sostanzia di un retroterra
religioso e mitologico, la struttura del congetturare dialettico, di quel
mirare alla fine 10 del processo ermeneutico come al proprio fine, implicito
nel viaggioverso-il-centro e nel viaggio-di-ritorno di Teseo come in tutte le
successive varianti del mitologema14. In appendice ai capitoli di più acuminato
spessore del suo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, Consolo ha inserito,
infatti, un ventaglio di documenti storici che fanno corpo organico con la
narrazione, esplicitando ciò che essa lascia nel margine dell’intuitivo. Aldo
M. Morace sostiene che così viene spezzata l’unità tipica del racconto storico,
ma anche la finzione narrativa stessa, in modo da chiamare in causa il lettore,
secondo l’esigenza brechtiana dello straniamento e secondo la suggestione
adorniana circa la necessità, per l’opera d’arte, di portare impresse nelle
proprie strutture formali le stigmate della negatività rinunciando alla forma
compatta ed armoniosa che attesterebbe la conciliazione con la società
esistente15. Se il romanzo, e in particolare il romanzo storico si esprime
attraverso le tensioni formali, come sostiene Flora Di Legami16, la prosa di
Consolo corrisponde pienamente a questa immagine. L’autore introduce,
trasformato, il topos ottocentesco del manoscritto: esso non è più l’espediente
narrativo su cui costruire la trama del romanzo, ma un documento immaginario
capace di suffragare, con la sua verosimiglianza linguistica, l’effettualità
degli avvenimenti narrati. E così il Mandralisca, mosso dall’ansia di
verificare le affermazioni dell’Interdonato, compie un viaggio in alcuni paesi
del messinese, che gli farà conoscere le condizioni di miseria e sfruttamento
in cui versano i contadini, ma soprattutto lo porterà ad essere testimone
diretto dell’insurrezione di Alcara contro i Borboni nel maggio 1860. Quello del
Mandralisca risulta un viaggio di tipo vittoriniano, di progressiva maturazione
e di crescita etico-politica, ma anche di discesa del nostro tempo. Interviste
a Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Ignazio Buttita, dal
programma radiofonico di Loredana Cacicia e Sergio Palumbo, prodotto e
trasmesso da Rai Sicilia nel 1991. Palermo, Officine Grafiche Riunite, 2013, p.
52. L’intellettuale
al caffé. Incontri con testimoni e interpreti all’interno
delle contraddizioni della storia e della ragione, di cui sperimenta
l’impotenza operativa17. Nel contesto della dominazione anche fisica delle
nuove forze — come prova di contrapposizione ad esse — appare anche il problema
delle riflessioni morali che espongono solo la dimensione degli abusi. Consolo
la rievoca tramite l’introduzione della situazione di caos: accanto alle forze
naziste spuntano le proteste degli operai, crescono l’incitazione intorno alla
Targa Florio e infine la sconfitta degli anarchisti. Questo caos viene
preceduto nella narrazione dal segnale riferito alla follia della famiglia
Marano, il che suggerisce la conseguente spirale della perdita di senno. Solo
la ragione si oppone al regime, al male atavico dell’uomo, alla distruzione
della memoria e dei valori della terra e della società18: Ora sembrava che un
terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo fra gli uomini e
il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale, spingesse ognuno
nella sfasatura, nella confusione, nell’insania. E corrompeva il linguaggio, stracangiava
le parole, il senso loro, il pane si faceva pena, la pasta peste, la pace pece,
il senno sonno. N, 140 Il linguaggio, trasgressivo e straniato, arcaicizzante e
artificioso, nasce da una spinta molto forte, così da richiedere una strategia
di difesa e di allontanamento, e una immersione nella vita “nel suo infinito
variare”. È un linguaggio che diviene canto, sonante e alto, fatto di cadenze e
ritmi poetici (per esempio, di ben individuabili, ossessivamente presenti,
endecasillabi: “E la chia-rì-a scial-ba all’- or-ien-te / di là di
Sant’-O-li-ve-del-la Fer-la”)19. Consolo ha spesso affermato di sentirsi parte
di una linea della letteratura italiana che proviene dalla Sicilia e che
comprende Verga, Pirandello, Vittorini, Brancati, Tomasi di Lampedusa,
Sciascia, ma nello stesso tempo ribadisce17 la provenienza da una zona
periferica d’Italia. La sua narrazione diventa la testimonianza della credenza
nella possibilità dei contributi innovativi alla cultura da quella isolana20. L’abbandono
della predominanza del senso della vista a favore dell’abilità del parlare
implica la riduzione della distanza rispetto all’oggetto dell’analisi. La
facoltà di parlare richiede la mancanza di dominazione e indica invece l’impegno
dei processi cognitivi nelle differenti prospettive degli interlocutori. La
Sicilia attraversata da Clerici è quella storica del primo Settecento, afflitta
da povertà, ignoranza e violenza; e tuttavia i vari paesi diventano contrade dell’anima
dove pensieri ed emozioni balzano in primo piano, e i personaggi incontrati
hanno sempre consistenza reale e favolosa, come i ladri delle terme segestane.
Sono luoghi in cui il narratore sospende il tempo della narrazione per
abbandonarsi all’incanto del mondo favoloso e lontano. Lo spazio sociale con i
suoi conflitti non è, in questo romanzo, il centro palpitante; lo percorre
invece una vibrata inquietudine ed un febbrile desiderio di lontananza21. Nel
romanzo Lo spasimo di Palermo l’autore legge una vicenda personale e
collettiva, partendo da un tempo che apre immensi spazi. In principio è la
lontananza, la terra straniera e il distacco che “costringe ai commiati”22. Nel
caso del protagonista del romanzo menzionato, lo scrittore Gioacchino Martinez,
cupo e angosciato eroe che vuole rappresentare la realtà senza incanto, che era
quello di un sogno infantile, e smuovere altri ricordi. Sono proprio i ricordi
che lo devastano e nello stesso tempo lo mantengono in vita: il protagonista torna
in Sicilia, da dove se ne era fuggito, per l’impossibilità di opporsi alla
violenza, all’ingiustizia. È un affondo nel rammarico, nei dolori della
memoria: l’adolescenza nel dopoguerra siciliano, l’amato zio studioso di
botanica, l’adorata Lucia che poi sposerà e perderà con strazio, il rifugio in
una Milano ritenuta proba, antitesi al ma
rasma 20, gli anni del terrorismo e la pena per il figlio compromesso. Piero Gelli parla direttamente del risveglio di un’illusione: la città civile di Porta, Verri e Beccaria, di Gadda e Montale non esiste più, sommersa dalle acque infette dell’intolleranza e dalla melma della corruzione23. Se si prende per esempio la descrizione dell’albergo che sebbene non sia un luogo sotterraneo, rivela tutta la sua angustia: “La dixième muse era il nome dell’albergo. L’angusto ingresso, il buio corridoio…” (SP, 11). Spostandosi all’indietro nei ricordi assomigliava ai rifugi antiaerei o alle cantine. Dopo il bombardamento all’oratorio Chino ”tornò affannato nell’androne, attraversò il cavedio, discese nel catoio” (SP, 16). È significativo anche che cupi, nascosti ed in profondità siano i luoghi in cui si consuma la relazione fra il padre di Gioacchino e la siracusana. Quindi colpa e menzogna da cui Chino fugge sempre, in modo antonimico, seguendo il percorso contrario, verso la luce e la superficie. È la fuga da una realtà che non vuole conoscere. Una tana sarà anche il luogo prediletto dal ragazzo per i suoi giochi e le sue fughe: “Corse al marabutto, al rifugio incognito e sepolto dal terriccio” (SP, 19). A un certo momento del libro il protagonista parla così: “Non so adesso… Adesso odio il paese, l’isola, odio questa nazione disonorata, il governo criminale, la gentaglia che lo vuole… odio finanche la lingua che si parla”. Mai come adesso la scrittura si ritaglia come il luogo di una distanza difficilmente colmabile in cui non ci sono luoghi cui dedicare una presunta fedeltà: “Dietro queste parole scopertamente riferite all’oggi c’è il risentimento personale di chi scrive verso un luogo che ha dovuto lasciare”24. Una soluzione più simile al concetto di viaggio si può da ricavare nel romanzo Retablo. La seconda sezione del libro, quella centrale o la più distesa, è il diario di viaggio che Clerici scrive per Teresa Blasco, la donna amata, da cui cerca di allontanarsi compiendo la sua “peregrinazione” attraverso la Sicilia. È solo attraverso il “collaudato23 contravveleno della distanza”, infatti, che Clerici riesce a ritrovare quell’“aura irreale o trasognata” che gli consente di dedicarsi alla scrittura e alla pittura (R, 87). E per ottenere il necessario estraniamento, analogo a quello operato dallo scrittore di Sant’Agata di Militello con il trasferimento a Milano, fungono spesso da testimoni o il cavaliere e l’artista lombardo Clerici, o il mistificatore inglese: Crowley. Lo stile barocco, fitto di sicilianismi, fornisce il coinvolgente e inconfondibile colore locale25.
Title: Rompere il silenzio : i romanzi di Vincenzo Consolo Author: Aneta Chmiel Citation style: Chmiel Aneta. (2015). Rompere il silenzio : i romanzi di Vincenzo Consolo. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
***
1 F. Orlando: Costanti tematiche, varianti estetiche e precedenti storici. In: M. Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica. Firenze, Sansoni, 2003 [1996], p. VII. 2 R. Luperini: L’incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell’uomo occidentale. Roma—Bari, Editori Laterza, 2007, pp. 4—8. 168 Capitolo V: L’allontanamento V. Consolo: La poesia e la storia. In: Gli spazi della diversita. Atti del Convegno Internazionale. Rinnovamento del codice narrativo in Italia dal 1945 al 1992. Leuven —Louvain-la Neuve—Namur—Bruxelles, 3—8 maggio 1993. Vol. 2. A cura di S. Vanvolsem, F. Musarra, B. Van den Bossche. Roma, Bulzoni, 1995, pp. 583— 586.4 A. Bernardelli, R. Ceserani: Il testo narrativo. Istruzioni per la lettura e l’interpretazione. Bologna, Il Mulino, 2013, p. 135. Il viaggio o la fuga? 169 G. Ferroni: La sconfitta della notte. “L’Unità” 1992, il 27 aprile. 6 R. Andò: Vincenzo Consolo: La follia, l’indignazione, la scrittura. “Nuove Effemeridi” 1995, n. 29, p. 11. 7 S. Mazzarella: Dell’olivo e dell’olivastro, ossia d’un viaggiatore. “Nuove Effemeridi” 1995, n. 29, p. 63. 170 Capitolo V: ” (N, 168). Petro è spinto da una parte dalla for8 Ibidem, pp. 63—64. 9 R. Andò: Vincenzo Consolo…, pp. 8—9. S. Mazzarella: Dell’olivo e dell’olivastro…, pp. 62—63. 11 V. Consolo: Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia. Roma, Donzelli editore, pp. 9—10. 12 F. Di Legami: Vincenzo Consolo. La figura e l’opera. Marina di Patti, Pungitopo, 1990, p. 12. 13 Ibidem, pp. 7—9. 172 Capitolo V: , 14 Cfr. K. Kerényi: Nel labirinto. Torino, Bollati Boringhieri, 1983, p. 9. 15 Cfr. A.M. Morace: Orbite novecentesche. Napoli, Edizioni Scolastiche Italiane, 2001, pp. 212—213. 16 Cfr. F. Di Legami: Cfr. F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, pp. 24—25. 18 Cfr. C. Ternullo: Vincenzo Consolo: dalla Ferita allo Spasimo. Catania, Prova d’Autore, 1998, p. 58. 19 R. Ceserani: Vincenzo Consolo. “Retablo”. “Belfagor” 1988, anno XLIII, Leo S. Olschki, Firenze, pp. 233 — 234. 174 Capitolo V: L’allontanamento cfr. A. Bartalucci: L’orrore e l’attesa. Intervista a Vincenzo Consolo. “Allegoria. Rivista quadrimestrale” 2000, anno XII, nn. 34—35, gennaio—agosto, 21 Cfr. F. Di Legami: Vincenzo Consolo…, p. 40. 22 G. Amoroso: Il notaio della Via Lattea. Narrativa italiana 1996—1998. Caltanisetta—Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, p. 464. Cfr. P. Gelli: Epitaffio per un Inferno. La rabbia e la speranza di Consolo. “L’Unità” 1998, il 12 ottobre, p. 3. 24 R. Andò: Vincenzo Consolo…, p. 11.