Nicola Izzo
Negli anni Ottanta, la produzione di Consolo è
contraddistinta dalla stilizzazione barocca, che raggiunge il suo culmine con
Retablo (1987), opera-laboratorio e straordinario compendio letterario. Tale
studio si concentra sulla pratica di riscrittura espletata dall’autore
siciliano, che, quale il Pierre Menard autore del Chisciotte borgesiano, ricrea
e rivisita testi importanti della letteratura italiana (Leopardi, Ariosto) ed
europea (Goethe, Jaufré Rudel, Eliot).
Parole chiave:Consolo , Retablo , Leopardi , Ariosto ,
Genette , intertestualità , palinsesto , parodia , ribaltamento
1 Retablo è un che si contraddistingue per la sua fitta
stratificazione linguistica e letteraria, che va a termine – declinandosi
attraverso un’abile e ricercata commistione di prosa e lirismo, raffinato
pastiche espressionistico di toni e stili un vero e proprio palinsesto, che
richiama quanto teorizzato da Gerard Genette a proposito della letteratura
della seconda metà del Novecento (Genette 1982). L’intento di tale studio è
pertanto di penetrare tra i vari livelli dell’opera, alla ricerca dei numerosi
riferimenti intertestuali presenti, estrinsecandone in modo speciale i giochi
di parodie e ribaltamenti operati da Consolo.
A ciò va premio che la struttura di Retablo ricalca quella dell’omonimo
polittico e che la comp (…)
2 Il primo obiettivo è quello di analizzare il modo in cui i
personaggi dell’opera interagiscono all’interno del microcosmo consolano. La
passione che lega frate Isidoro a Rosalia e il sentimento di Fabrizio Clerici
sono manifestazioni di due opposte concezioni amorose, che rimandano a topoi
medievali attestati repertorio della letteratura.
3 Per quanto riguarda Isidoro: «Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato,
rosa che ha confuso, ro (…)
Alle prime intense parole d’ordine di utilizzatore», non notare quanto esse
presentino le medesime caratteristiche li forma che Guiette identificava nel
modello utilizzato, riconoscevi «la supremazia dell’ordine estetico utilizzato
per il suo valore incantatorio» e sublimato « ove «il linguaggio verrà
utilizzato per suo valore incantatorio» e sublimato « dalla sua collocazione,
dal suo volume, dall’uso che ne viene fatto» (Guiette 1990: 140).
4 La vexata quaestio sul nome del giullare autore dell’opera è tuttavia risolta
più avanti da Conso (…)
Il racconto di Isidoro e Rosalia è affiancabile al contrasto di Cielo o Ciullo
d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima , breve composizione che il De Sanctis
identificava come il primo testo della letteratura italiana (De Sanctis 1981:
59) e che rielaborava il modello della pastorella (sottogenere della lirica
medievale che Bec inserimento nel registro popolareggiante) (Formisano 1990:
123) attraverso la «rottura del contrasto un po’ meccanico fra il portatore
delle convenzioni cortesi e la detentrice dell’istintiva diffidenza e
riottosità dell’ambiente plebeo» ( Pasquini 1987: 119).
5 Alcune concordanze possono anche il gioco evidenziabili e confermerebbero
letterario operato dallo scrittore siciliano:
Ahi, non abènto , e majormente ora ch’uscii di Vicarìa (Consolo 1987: 19).
Per te non ajo abènto notte e dia (Rosa fresca aulentissima, str. I, v. 4).
O ancora:
[…] la quale m’illudeva che, giunti a un numero bastevole di onze , smesso il
saio, avrei impalmato la figlia sua adorata Rosaliuzza (Consolo 1987: 23).
Intendi bene ciò che bol[io] dire?
men’este di mill’ onze lo tuo abere (Rosa fresca aulentissima, str. XVIII, vv.
4-5).
Il rivolgersi in prima persona al proprio amato scandendone il nome in funzione
vocativa richiamerebbe una certa teatralità, non estranea all’ambito
giullaresco e popolaresco (Apollonio 1981: 107-109); tuttavia, alle prime
intense evocazioni dei due incipit di Oratorio e Veritas , vi sono due cesure
orientate ad includere le due opposte della versione vicenda che deve l’ini
afflato lirico-sentimentale a una struttura dal respiro diegetico più ampio, la
cui vivacità e concretezza ricondurrebbero alla tradizione dei fabliaux .
6 Un modesto chierico e un’umile popolana si configurano
come due protagonisti ideali di un ipotetico fabliau , dacché, come afferma
Charmaine Lee «i frequentatori di questi luoghi ci vengono descritti con
abbondanza di dettagli, e quasi con una sorta di compiacimento nel ritrarre gli
aspetti più bassi della realtà» ( Lee 1976: 27) . E racconto senso di
concretezza si declina nell’accezione tutta erotica dell’amore che congiunge i
due protagonisti.
5 Cfr. «[…] la narrativa dei fabliaux , sbrigativa e salace, imperniata su
personaggi della borghesi (…)
7 Considerata la coscienza tabuizzata medievale, l’oscenità
andava infatti a costituire un serbatoio rilevante di temi per i fabliaux ;
seppure tale licenziosità non fosse affatto l’esito di menti pretestuosamente
lubriche, bensì espressione di un carnevalesco e faceto senso del contrario che
si risolveva nella parodia del modello di riferimento, ovvero quel fin’amor
cortese che plasmava il modello curiale e che in Retablo è riconoscibile nel
racconto di Fabrizio intorno al quale ruota il secondo capitolo dell’opera,
Peregrinazione 5 .
8 Questo senso del contrario è rilevabile anche attraverso la maniera in cui
Isidoro e Rosalia utilizza l’immaginario religioso. Le fattezze di Rosalia
nella mente d’Isidoro si ricollegano alla statua dell’omonima Santa (Consolo
1987: 19), così come l’aspetto del fraticello viene da lei giudicato «torvo,
nero come un san Calogero» (Consolo 1987: 194) paragonato al giovane «biondo e
rizzuto come un San Giovanni» (Consolo 1987: 194) di cui ella s’infatua
all’inizio del racconto. Tale operazione di sniženie bachtiniano, di
iconoclastico abbassamento sul piano materiale e corporeo di figure spirituali
(invero giocato al limite della blasfemia), porta con sé una non trascurabile
carica di irriverenza; e al devotamente suscettibile uditorio medievale non
poteva che destare il riso (o quantomeno suscitarne lo scandalo) (Bachtin 1979:
25).
9 L’amore che lega Rosalia ed Isidoro è un sentimento denso
di passione e di sensualità, che, come canta Ariosto, «guarda e involva e
stempre/ogni nostro disegno razionale» (Ariosto 1976: XIII, 20) e che alla fine
conduce all ‘insania il protagonista. Tale immagine di follia amorosa – «questo
furore che riduce l’uomo, come quel paladin famoso, a nuda e pura bestia,
privato vale a dire del cervello» (Consolo 1987: 58) – non può che rievocare le
mirabolanti vicende dell’Orlando Furioso, verso cui lo scioglimento di alcuni
nodi intertestuali riconduce il lettore di Retablo.
10 Già lo stesso elegiaco lamento di Isidoro, che occupa le pagine iniziali di
Oratorio , rende assimilabile la percezione del proprio sentimento a
quell’effetto insieme inebriante e stuporoso cantato dall’Ariosto:
[…] libame oppioso, licore affatturato, letale pozione
(Consolo 1987: 17).
«e questo hanno causato due fontane
che di effetto liquore
ambe in Ardenna, e non sono lontane:
d’amoroso disio l’una empie core;
che bee de l’altra, senza amor rimane» (Ariosto 1976: I, 78).
6 Ma anche Ariosto 1976: X, 46: «il suo amore ha dagli altri
differenza:/speme o timor negli altri (…)Passione che logora e consuma,
provocando quel «duol che sempre il rode e lima» (Ariosto 1976: I, 41) 6 , ea
cui Consolo in Retablo conferisce maggiore carnalità rispetto all’accezione
intellettuale ariostesca:
lima che sordamente mi corrose l’ossa (Consolo 1987: 18).
che ‘l poco ingegno ad o ad o mi lima (Ariosto 1976: I, 2).
Tale poche erotismo viene riassunto nelle righe che narrano della ben celata
dote del fraticello,
[…] e t’appressasti a me che già dormivo, ah Isidoro, Dio benedica, io subito
m’accorsi che la bellezza tua stava nascosta. Bella, la verità (Consolo 1987:
194). E che rievocano parodisticamente uno dei più salaci episodi ariosteschi,
quello di Bradamante, Ricciardetto e Fiordispina.
E se non fosse che senza dimora
Vi potete chiarir, non credereste:
e qual nell’altro sesso, in questo ancora
ho le mie voglie ad ubbidirvi preste.
Commandate lor pur, che fieno o ora
e sempre mai per voi vigile e deste.
Così le dissi; e feci ch’ella istessa
Trovò con man la veritade espressa (Ariosto 1976: XXV, 65)
11 La voluttuosa follia di Isidoro, in cui convivono
illusione e eros, è al centro anche di Peregrinazione , secondo capitolo di
Retablo in cui – invertendo lo schema diegetico ariostesco in cui un chierico,
Turpino, narrava la furia del cavaliere Orlando – il cavaliere Fabrizio narra
le penose conseguenze della passione del fraticello «che per amor venne in
furore e matto» (Ariosto 1976: I, 2)
[…] divenne matto: crollato in terra, si contorse, schiumò, lacerossi gli
abiti, la faccia, quindi nel vico si diede a piangere, a urlare come un
forsennato (Consolo 1987: 186).
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo
l’ispido ventre e tutto ‘l petto e ‘l tergo;
e cominciò la gran follia, sì orrenda,
che de la più non sarà mai ch’intenda. (Ariosto 1976: XXIII,
133)
D’altronde al lettore colto di Retablo non sarà sfuggito che il racconto di
Fabrizio Clerici si avvicina per rutilante vitalismo, visività e inventiva
all’opera ariostesca, ovvero a quell’ideale di rappresentazione della vita
«nella sua più reale consistenza e nelle sue fughe fantastiche e irreali»
(Consolo 1987: 63).
12 Il viaggio di Fabrizio in Sicilia presenta, attraverso
efficaci immagini e ironici capovolgimenti, una realtà in cui il confine con la
menzogna risulta labile, ove ci si imbatte in «venditori d’incanti e illusioni»
(Consolo 1987: 63), in retablos de las maravillas che trasportano in lontani
castelli d’Atlante in cui «a tutti par che quella cosa sia,/ che più ciascun
brama e desia» (Ariosto 1976: XII, 20), attraverso una lunga e immaginifica
sequela di visioni in cui sfilano anche io potenziale:
Ecco che in mezzo a voi passa, sul suo destrier bianco e lo stendardo in mano
del Redentore nostro Gesù Cristo, seguito da’ chiari e baldi, dai più arditi
cavalèr normanni, il Conte magno, Roggiero d’Altavilla, il grande condottiero
che l ‘isola liberò dal giogo saracino […] (Consolo 1987: 65).
A tal proposito, è d’uopo rimarcare che Consolo, richiamando il poema
ariostesco, ne dissolve il proposito encomiastico in un ironico rovesciamento
di prospettiva, in linea con i suoi propositi critici ed estetico-ideologici.
L’autore di Retablo è stato uno scrittore permanentemente protetto alla ricerca
della verità, in lotta contro le falsificazioni imposte dai poteri costituiti,
rappresentati un tempo proprio da quella cavalleria cantata da Ludovico
Ariosto, e di cui con sarcasmo egli mette in dubbio i valori, come è
evidenziabile in questo passaggio: «voglia il cielo che in fatto d’armi, di
violenze e guerre, valga comunque e sempre la finzione» (Consolo 1987: 112).
13 Valori dissolti in una dimensione etica che appare infatti contraddittoria,
ambigua, manipolata. Sa lo scrittore siciliano che l’asservimento è costume
troppo frequent, come deplorava già San Giovanni ad Astolfo riconoscendo «la
giù ruffiani, adulatori, / buffon, cinedi, accusatori, e quelli/che viveno alle
corti e che vi sono/più grati assai che ‘il virtuoso e ‘l buono» (Ariosto 1976:
XXXV, 20) e come Fabrizio stigmatizza nella sua invettiva a mo’ di serventese, scagliandosi
contro «l’impostore, il bauscia, ciarlatan» (Consolo 1987: 128).
14 In Retablo , Consolo si confronta soprattutto con il tema metaletterario
della mistificazione artistica ad uso del potere, rappresentato da «il falso
artista, el teatrant vacant e pien de vanitaa» e dal «poeta dalla putrida
grascia brianzola» (Consolo 1987: 128), domanda che già Ariosto aveva posto
cinque secoli o sono:
Non fu sì santo né benigno Augusto
Come la tuba di Virgilio suona.
L’aver avuto in poesia buon gusto
La proscrizion iniqua gli perdona (Ariosto 1976: XXXV, 26)
Chiedendosi se in «questo che tutti chiamano il teatro del gran mondo, vale
sovente la rappresentazione, la maschera, il romore vuoto che la sostanza vera
della realtate» (Consolo 1987: 112).
15 Come accennato in precedenza, al sentimento segnato dalla
carnalità e dalla sensualità di Isidoro si contrappone l’aureo amore ideale di
Fabrizio, narratoci da lui stesso in Peregrinazione.
7 Albertocchi (2005: 95-111) dedica un esauriente articolo alla reale figura
storica di Teresa Blas (…)
16 Già in epigrafe Consolo consegna al lettore attento e
meticoloso la chiave per aprire il portello centrale di Retablo, dove ci viene
narrato il sentimento di Fabrizio Clerici per la contessina Teresa Blasco 7:
Avendo gran disio,
dipinsi una figura
bella, a voi somigliante.
Come in questa canzonetta Jacopo da Lentini rielabora e
adatta al proprio substrato culturale stilemi e temi della lirica trobadorica
provenzale, l’autore di Retablo svolge in questo capitolo – riprendendolo e
proponendone un’ironica lettura in prospettiva postmoderna – il leitmotiv del
fin’amor , l’amore inteso come suprema forma di affinamento spirituale.
Fin’amor che contrapponendosi al fals’amor , l’amore nel senso carnale che lega
Isidoro a Rosalia, va a formare una struttura a chiasmo in cui le due coppie –
Isidoro e Rosalia, Fabrizio e Teresa – si pongono l’una al polo contrario
dell’altra.
17 In Retablo sono presenti quei già largamente attestati
nella retorica mediolatina che tutti i simboli devono riconoscersi subito quali
importanti punti di riferimento per l’interpretazione artistica e il cui
ricorso implicava, per i poeti, collocarsi nell’alveo di una tradizione
consolidata e insieme approfondirla (Di Girolamo 1989: 36).
8 Per il lessico specifico trobadorico, oltre ai già citati testi di Formisano
e Di Girolamo, si ri (…)
9 È Fabrizia Ramondino, estimatrice e critica della prima ora di Retablo , a
suggerire, nella sua re (…)
10 Questi versi e quelli successivi sono ripresi da Roncaglia 1961: 304-307.
18 Sin dalla dedicatoria il cavaliere Fabrizio pone in
risalto la sottomissione alla sua domna 8 , doña Teresa, raffigurata come
sublime figura («donna bella e sagace, amica mia, che un padre di Spagna e una
madre di Sicilia ornaro di virtù speciali», Ret .:33) attorniata da una turba
di savai , uomini vili («sciocchi e muffi e mercantili», Ret .: 33). E, mentre
procede egli nella sua quête 9 cavalleresca, il pittore milanese vagheggia
della propria amata, la cui dimensione platonica viene caricata da Consolo nei
suoi tratti d’irraggiung. irraggiungibilità che si collega al tema della
distanza (e quan me sui partitz de lai/remembram, d’un amor de lonh ) 10 che
nel fitto repertorio della letteratura provenzale è trattato da Jaufré Rudel.
11 Si rimanda per un rapido sunto ancora a Di Girolamo 1989: 63, e approfonditi
da Picone 1979. Si c (…)12 Ibidem.
19 Quelle che rimangono ad oggi alcune delle più
interessanti interpretazioni date all’ amor del lonh rudeliano 11 sono
sovrapponibili al sentimento di Fabrizio ea «quel volontario vallo», «gelida
distanza» (Consolo 1987: 76) che pone egli tra sé e la sua dama. L ‘amor de
lonh di Fabrizio Clerici traduce in concreto quel sottile senso di angoscia
compendiato nel paradosso cristiano di un «reale irreale» (il mondo invisibile
esiste mentre quello visibile non ha nessuna esistenza) 12, come del resto
conferme le sue inquietudini metafisiche («cos’è mai questa terribile,
meravigliosa e oscura vita, questo duro enigma che l’uomo sempre ha declinato
in mito, in racconto favoloso, […]?», (Consolo 1987: 134)). Da qui
laperegrinazione come forma di affinamento spirituale.
20 Tuttavia, questo esemplare riconducibile al filone
dell’amor cortese viene anch’esso capovolto in Retablo . Come è narrato nella
sua vida , Jaufré Rudel dirigeva il suo amore verso la Contessa di Tripoli,
donna che non aveva mai visto, ma di cui aveva ascoltato la descrizione,
procedendo dunque dall’ideale al concreto. Al contrario, Fabrizio vagola alla
ricerca di un’astrazione da ricondurre al concreto modello di partenza, di un
«frammentario brano di poesia o d’un eccelso modello di beltà» (Consolo 1987:
77). Questo di Fabrizio è un amore dunque perfettamente intellettualistico,
totalmente contemplativo, e che nulla concede al desiderio de «le carni ascose
immaginate» (Consolo 1987: 172).
21 Tale eccesso di mezura – per usare un efficace ossimoro –
non porta ad alcuno forma di elevazione e perfezione spirituale quale prevista
dal fin’amor . Il nostro protagonista, alla fine della sua peregrinazione, si
ritroverà più smarrito di prima e l’unico cambiamento inferto alla sua
condizione di partenza sarà la notizia del matrimonio tra la sua amata Teresa
Blasco e il Marchese Cesare Beccaria.
22 In Retablo, nel finale, si verifica anche questo estremo
ribaltamento dello schema di riferimento: il protagonista non accetterà il
«compromesso» che è posto alla base del fin’amor : all’ amor del lonh preferirà
un’errabonda solitudine e alla servitium amoris un prematuro comiat : «Ora
addio, donna bella e sagace, che foste amica mia. Addio Teresa Blasco, addio
marchesina Beccaria» (Consolo 1987: 189).
13 Dietro i personaggi del Cavaliere Fabrizio e del suo servo Isidoro che
compiono il loro Grand Tou (…)
23 Siamo giunti in questo modo alla fine del percorso
compiuto dai protagonisti, percorso che presenta molti tratti assimilabili alla
tradizione della narrativa picaresca 13. Tuttavia, poiché poiché Consolo
rovescia anche la struttura del Bildungsroman , Fabrizio, alla fine del suo
cammino, non avrà raggiunto né una crescita interiore, né tantomeno una calma
accettazione del presente, ma vivrà per sempre con quello che definisce un
«dolore senza nome» (Consolo 1987: 140).
24 Questo senso di ineluttabilità non è soltanto un’angoscia individuale, ma in
Retablo si collega alla concezione postmoderna della Storia, («[…] noi
naufraghi di una storia infranta», (Consolo 1987: 146)), di cui è andata persa
l ‘idea di causalità. Ed è in questa atmosfera rarefatta di disincanto che
riecheggiano i versi del Leopardi, la cui memoria letteraria è importante anche
per l’analisi dell’altra grande opera barocca di Consolo, Lunaria (Consolo 1985
e 1996) , pubblicata due anni prima di Retablo . Il dialogo col poeta di
Recanati non è solo poetico, ma anche filosofico, in quanto il pessimismo di
Fabrizio Clerici è assimilabile a quello che pervade i Canti leopardiani.
25 Inequivocabili sono le concordanze con L’infinito :
sedendo e mirando , e ascoltando… (Consolo 1987 : 101)
14 Si veda Leopardi 2007 (qui e di seguito, per tutte le citazioni
leopardiane).
Ma sedendo e mirando … (L’Infinito , v. 4) 14
26 E con La Ginestra :
O secol nostro superbo di conquiste e di scienza, secolo illuso, sciocco e
involuto!» (Consolo 1987: 128)
Qui mira e qui ti specchia,
Secol superbo e sciocco (La Ginestra, vv. 52-53)
15 È doveroso qui richiamare Alejo Carpentier e il suo El Siglo de Las Luces,
romanzo storico pubbli (…)
Il pessimismo storico di Leopardi viene da Consolo tradotto
nello scetticismo antilluministico di Fabrizio Clerici («peggiori di quanto noi
pensiamo sono i tempi che viviamo!»; Consolo 1987: 42) che porta questi ad
allontanarsi dalla Milano illustri dove intellettuali come i fratelli Verri e
Cesare Beccaria, l’autore del saggio Dei delitti e delle pene, che diffondendo
le nuove idee del Secolo dei Lumi 15.
27 La critica antistoricistica postmoderna si esprime in Retablo attraverso la
caduta del mito del progresso. E, riflesso nella finzione romanzesca
settecentesca, è riconoscibile il giudizio che dà l’autore agli anni Ottanta
del Novecento, anni in cui alla composizione letteraria egli affianca la
pratica giornalistica. La Milano tanto odiata da Fabrizio Clerici è la stessa
città contro cui l’autore scaglia la propria invettiva. Erano quelli gli anni
del governo socialista di Bettino Craxi (che darà vita dieci anni dopo allo
scandalo di Tangentopoli) e in cui in Italia c’era una diffusa idea di
benessere. Consolo, da grande intellettuale, individua proprio in quel periodo
la nascita del degrado sociale e culturale italiano, e non esita a condannarlo
dalle pagine del suo romanzo:
Arrasso, arrasso, mia nobile signora, arrasso dalla Milano attiva, mercatora, dalla
stupida e volgare mia città che ha fede solo nel danee, ove impera e trionfa
l’impostore, il bauscia, il ciarlatan, il falso artista, el teatrant vacant e
pien de vanitaa, il governante ladro, il prete trafficone, il gazzettier
potente, il fanatico credente e il poeta della putrica grascia brianzola.
Arrasso dalla mia terra e dal mio tempo, via, via, lontan! (Consolo 1987: 128)
Al tema storico di Retablo si coniuga anche il tema metafisico del Tempo. Uno
dei temi più ricorrenti nell’opera di Consolo è proprio il «male di vivere», la
profonda consapevolezza della caducità delle cose. Le rovine di antiche civiltà
presenti durante la Peregrinazione dei nostri protagonisti ci vengono come
destino «simboli indecifrati ed allarmanti» (Consolo 1987: 42), manifestazioni
della contingenza che domina il destino dell’Uomo.
28 Fabrizio si reca tra gli antichi templi siciliani per
abbandonare il concetto di Tempo escatologico e tornare al Tempo classico e
circolare del mito e finalmente ritrovare ristoro dalle proprie angosce nella
«stasi metafisica» (Consolo 1987: 40).
16 Il viaggio del grande autore di tedesco si svolge tuttavia nel 1787, circa
un ventennio dopo quel (…)
29 Il tour siciliano di Fabrizio avviene nella stessa epoca
in cui si colloca un altro importante resoconto di viaggio, quasi parallelo al
tour del nostro protagonista, quello di Goethe in Sicilia 16 , parte centrale
del suo tour italico alla ricerca delle radici culturali e civili dell’
Occidente. Il grande poeta – che all’epoca aveva trentasette anni, nel pieno
del suo fulgore artistico – arriva in Sicilia dopo averto le raffinate
suggestioni di Venezia, l’eleganza colorata rinascimentale di Ferrara, la
maestosità di Roma, la confusa e vivacità di Napoli , ed aver goduto sia dei
diversi paesaggi culturali sia dei vasti campionari minerali, vegetali e
paesaggistici offerti dalla penisola.
30 Alle tre pomeridiane del 2 aprile, allo sguardo estasiato
del poeta tedesco, si offrì «il più ridente dei panorami», Palermo:
La città, situata ai piedi d’alte montagne, guarda verso nord; su di essa,
conforme all’ora del giorno, splendeva il sole, al cui riverbero tutte le
facciate in ombra delle case ci apparivano chiare. A destra il Monte Pellegrino
con la sua elegante linea in piena luce, a sinistra la lunga distesa della
costa, rotta da baie, penisolette, promontori. Nuovo fascino aggiungevano al
quadro certi slanciati alberi dal delicato color verde, le cui cime, illuminate
di luce riflessa, ondeggiavano come grandi sciami di lucciole vegetali davanti
alle case buie. (Goethe 1983: 255-257)
Il medesimo spettacolo si offre a Fabrizio, assalito sul ponte nave dalle prime
impressioni antelucane di una Palermo immersa nell’incantevole aria mattutina e
inondata di luce:
[…] in oscillìo lieve di cime, arbori, guglie e campanili, in sfavillìo di
smalti, cornici e fastigi valenciani, matronali cupole, terrazze con giare e
vasi, in latteggiar purissimo de’ marmi nelle porte, colonne e monumenti, in
rosseggiar d ‘antemurali, lanterne, forti e di castell’a mare, in barbaglìo di
vetri de’ palagi, e d’oro e specchi di carrozze che lontano correvano le
strade. (Consolo 1987: 35)
17 Cfr. Capponi P., «Della luce e della visibilità, considerazioni in margine
all’opera di Vincenzo (…)
Gli effetti di luce e di riverbero su cui indugiano le consoliane fanno parte
di quella «retorica della luce» 17 descritto da Paola Capponi, e in cui pagine
va considerata la stessa esperienza biografica dello scrittore. La
polarizzazione su cui è incentrata tale riflessione si basa ancora su due
coppie disposte a chiasmo: una che si muove sul piano orizzontale e diatopico –
la Milano di Fabrizio Clerici e dell’ emigréVincenzo Consolo contrapposta ai
luoghi natii dello scrittore siciliano – e l’altra di ordine verticale e
diacronico – che si muove tra il grigio presente lombardo e le atmosfere
mediterranee del suo passato: «Di luce in luce, donna Teresita, di oro in oro.
» (Consolo 1987: 34). E la memoria influenza così la percezione dei fenomeni
esterni, come viene espresso in queste righe:
«E sognare è viepiù lo scrivere, lo scriver memorando del passato come
sospensione del presente, del viver quotidiano. E un sognare infine, in suprema
forma, è lo scriver d’un viaggio, e d’un viaggio nella terra del passato»
(Consolo 1987: 95).
31 Ma ciò si verifica soltanto in quella metaforica camera
oscura ove acquistano forma le reminiscenze dell’autore. Infatti nella
dimensione reale e presente, come ha modo di testimoniare il milanese Fabrizio
ad Alcamo, ove vige un iniquo sistema di poteri, lo splendore isolano si
effonde anche sulla miseria ed ha forza abbacinante, dissimulatoria:
Ma fu quello come il segnale d’un assalto nella guerra, la guerra intendo,
antica e vana, contra il nemico della fama. Che non si scorge qui, di primo
acchitto, come da noi ne’ nebbiosi e gelati inverni nella campagna bassa o su
per le valli sopra i laghi o sotto le gran montagne delle Alpi, ovvero meglio
in alcuni quartieri popolosi e infetti di Milano, per la chiarità del cielo e
pei colori, per la natura benevola e accogliente […] (Consolo 1987: 69).
Anche Goethe, perso nelle sue ricognizioni artistiche e scientifiche, ha modo
di assistere, proprio ad Alcamo, al penoso spettacolo di questa «guerra tra
poveri»:
Qualche cane ingoiava avido le pelli di salame che noi gettavamo; un piccolo
mendicante cacciò via i cani, divorò di buon appetito le bucce delle nostre
mele e venne a sua volta messo in fuga dal vecchio accattone. La gelosia di
mestiere è di casa ovunque. (Goethe 1983: 297)
e di misurare la propria indignazione sulle problematiche sociali dell’isola,
di biasimarne l’ambiguo e corrotto sistema di poteri che fa perno sulla
religiosità cristiana,
[…] l’intera cristianità, che da milleottocento anni asside il suo dominio, la
sua pompa ei suoi solenni tripudi sulla miseria dei propri fondatori e dei più
zelanti seguaci (Goethe 1983: 264)
e di cui siamo efficaci ragguaglio anche in Retablo.
E il Soldano in pompa magna, quale sindaco della civitate, in uno con i
decurioni, e con gli amici, seguito da cavalieri e da pedoni, in quella festa
della patrona santa, fece la visita e l’omaggio a tutti i conventi, ritiri ,
orfanotrofi, spedali, chiese, collegi, monasteri e compagnie. E in ognuno, in
sale, refettori o sacrestie, era ogni volta un ricevimento con dolciumi e
creme, rosoli, caffè e cioccolata (Consolo 1987: 60).
La Sicilia si offre quale realtà composita, come egli ha modo di notare appena
sbarcatovi in quel di Palermo «assai facile da osservarsi superficialmente ma
difficile da conoscere» (Goethe 1983: 255); un metaforico vasto retablo,
meraviglioso e vivace, che può rivelare una miserrima realtà.
32 Tuttavia è da notare che l’animo, seppur sensibile, del
grande autore del Werther, non sembra turbarsi intimamente, come accade invece
a Fabrizio Clerici. Ciò è giustificabile con la semplice constatazione che,
mentre il viaggio di Goethe in Sicilia in uno dei tanti tour che uomini di alta
cultura compivano in quel tempo per gustare gli splendori naturali dell’isola e
immergersi nelle sue anticheggianti suggestioni, dietro
Il viaggio letterario del lombardo Fabrizio Clerici si cela il nóstos di
Vincenzo Consolo e il lamento per la sua terra ferita intride di sé le pagine
dell’opera:
Dietro la croce e la Compagnia, venia la gente più miserevole, la più lacera,
malata e infelice. Ed era, così ammassata, così livida, come la teoria d’un
oltretomba, una processione d’ombre, d’umanità priva di vita e di colore
(Consolo 1987: 184).
L’autore siciliano sa che dietro alle mirabolanti facciate come quelle
architettoniche di Trapani, dietro alle bellezze fastose, si cela una realtà di
brutture, su cui si spande un mirabolante, quanto ingannevole, velo:
Mai vid’io insieme tanto orrore, tanto strazio. L’altra faccia, il rovescio o
forse la verità più chiara e netta di questa nostra vita. Che nascondiamo
ognora con l’illusione, i velami, gli oblii, le facciate come quelle teatrali
de’ palazzi della rua Nuova e della Grande, ch’io avea visto e ammirato la sera
avanti, della gente lussuosa, spensierata che là vi dimorava (Consolo 1987:
184).
La prosa consolaana rivela, attraverso la sua efficace espressività, una
tensione maggiore, un più acuto sguardo, laddove Goethe sembra solo intento a
gratificare la propria algida curiosità di visitatore, come accade tra le
rovine della terremotata Messina. Nell’autore tedesco sembra che l’itinerario
siciliano produca nulla più di un vacuo corroboramento del suo gusto
estetizzante e razionale. Laddove Fabrizio sembra inquietarsi, sconfortarsi
sempre più per il desengaño che ad ogni piè sospinto sembra squarciare il velo
di maraviglia che ammanta l’isola, il poeta tedesco sembra esaltarsi:
l’esaltazione poetica che provavo su questo suolo supremamente classico faceva
sì che di tutto quanto apprendevo, vedevo, osservavo, incontravo,
m’impossessassi per custodirlo in una riserva di felicità (Goethe 1983: 333).
Eppure sia Clerici che Goethe giungono in Sicilia con un bagaglio estetico e
culturale similitudine. Goethiana infatti è l’intenzione di risalita alle
origini, storiche e culturali in prima istanza, ma anche naturali, a cui
Fabrizio aggiunge un ulteriore fattore sentimentale:
[…] mi pare di viaggiare alla ricerca degli stampi o matrici del vostro
meraviglioso sembiante, della grazia che dagli avoli del corno di Sicilia
ereditaste, in tanto che viaggio in cerca delle tracce d’ogni più antica
civiltate. (Consolo 1987: 77).
Mentre la ricerca del poeta tedesco sembra focalizzarsi su una più asettica
analisi biologica, ovvero uno studio sull’ Urpflanze , la pianta originaria che
egli stesso aveva teorizzato:
Di fronte a tante forme nuove o rinnovate si ridestò in me la vecchia idea
fissa se non sia possibile scoprire fra quell’abbondanza la pianta originaria
(Goethe 1983: 295).
Ma soprattutto il poeta dell’ Italienische Reise e il pittore di Retablo –
dalla predilezione artistica tuttavia analoga a quella del compagno di viaggio
di Goethe, il pittore Christoph Heinrich Kniep – sono accomunati dal medesimo
punto di riferimento artistico: quel canone neoclassico ed ellenizzante,
winkelmanniano , ravvisabile nell’opera di Consolo nell’episodio della statua
moziese:
Più che un umano atleta trionfante, un dio mi parve, un Apolline, dalle forme
classiche, ideali, di quelle tanto amate dal Winkelmano.(Consolo 1987: 159)
e rintracciabile più volte nelle proprie di Goethe. Tuttavia equilibrio il
poeta tedesco vi dimostra un più legame, rivelando una maggior aderenza a
quell’ sintesi d’armonia, compostezza e razionalità mediato dal von Riedesel:
«[…] alludo all’eccellente von Riedesel, il cuicino custodisco in seno come
breviario o talismano.» (Goethe 1983: 307). Mentre, per quanto riguarda il
protagonista dell’opera di Consolo, nel gusto della descrizione-elencazione
sono ravvisabili influssi barocchi.
33 Efficace, a tal proposito, è il raffronto che può essere
operato attraverso le opposte rappresentazioni del tempio di Segesta, al centro
di una delle scene più suggestive di Retablo, ove si palesa la differenza
sostanziale di atteggiamento dei due viaggiatori:
Le colonne sono tutte ritte; due, ch’erano cadute, sono state risollevate di
recente. Se rivela o no uno zoccolo è difficile definire, e non esiste un
disegno che c’illumini al riguardo […]. Un architetto potrebbe risolvere la
questione (Goethe 1983: 306).
Il diametro di tutte le colonne è di 6 piedi, quattro
pollici, sei linee; l’altezza di 28 piedi, e sei pollici… E potrei viepiù continuare
se non temessi di tediarvi con altezze e larghezze e volumi, con piedi e
pollici e linee (Consolo 1987: 97)
Laddove Goethe rivolge la sua attenzione alla semplice ricognizione
tecnico-strutturale, il pittore milanese si lascia rapire dalla fascinazione
«del tempio che vorrei ritrarre in modo distanziato, come fosse una realtà che
poggia sopra un altro pianoforte, in un’aura irreale o trasognata» (Consolo
1987: 109); e alle speculazioni estetico-architettoniche goethiane si
contrappongono le riflessioni di carattere metafisico del protagonista
consolano:
[…] Come porta o passaggio concepire verso l’ignoto, verso l’eternitate e
l’infinito. (Consolo 1987: 99)
Goethe, come ci suggerisce lo stesso Consolo, giunge in Sicilia, questa realtà
eterogenea e prismatica, cercando non di raccontarla, bensì di «misurarla», con
la capziosa – o piuttosto presuntuosa – crede di decifrare il mistero
siciliano:
Sono, ripetiamo, queste certezze riposte nella bellezza, nell’ordine,
nell’armonia, nella cognizione e classificazione della natura, gli argini, le
barriere contro l’indistinto, il caos, l’imprevedibile, il disordine. Contro
l’infinito (Consolo 2001: 246).
A differenza di Goethe, Fabrizio riesce a spogliarsi dei suoi oberanti metri
illuministici e riesce ad abbandonare gli stereotipi estetizzanti e
classicheggianti legati al mito siciliano. Le antiche vestigia così alimentano
le sue inquietudini in quanto tracce degli orrori alla storia dell’Uomo che
«vive sopravvivendo sordo, cieco e indifferente su una distesa di struttura e
di dolore, calpesta inconsciamente chi soccombe» (Consolo 1987: 151). Nel
viaggio storico del poeta tedesco invece non vi è traccia di tali riflessioni,
da cui, anzi, sembra rifuggire:
Non bastava, osservai, che di tempo in tempo le sementi venivaro, se non da
elefanti, calpestate da cavalli e uomini? Che bisogno c’era di ridestare
bruscamente dal suo sogno di pace la fantasia risuscitando tali frastuoni?
(Goethe 1983: 259)
Clerici si arrenderà al mistero siciliano, alla sua ricchezza ed al suo
fascino, contrariamente al poeta tedesco che schiavo della sua razionale
riluttanza di non varcare, nel viaggio a ritroso verso l’antichità della
storia, verso l’origine della civiltà, la soglia dell’ignoto, di non inoltrarsi
nell’oscura e indecifrabile eternità; di non smarrirsi, immerso in una natura
troppo evidente e prorompente, nell’indistinto, nel caos infinito. (Consolo
2001: 244)
18 «Misera. La seule ha scelto qui nous console de nos misères est le divertissement,
et cependant c’est (…)
34 Come è stato scritto da Genette «une dialettique perplexe
de la veille et du rêve, du réel et de l’imaginaire, de la sagesse et de la
folie, traverse toute la pensée baroque» (Genette 1996: 18). Opera barocca per
eccellenza, Retablo gioca sull’oscillazione tra i temi della maravilla ed il
desengaño , della verità e della mistificazione, tra le percezioni sensibili
della superficie dei fenomeni e l’abisso dell’esistenza, tra le visioni che il
mondo propone ei riflessi capovolti di esse. I protagonisti consoliani si
trovano quindi «a passare dal sogno e dall’incanto al risveglio più lucido», e
ciò lungo il corso di un divertissement letterario, che – collegandosi e
capovolgendo un celebre pensiero di Blaise Pascal 18– non spinge alla
distrazione dalle domande dell’interiorità, ma ne esprime attraverso un’intensa
sensibilità stilistica, dacché come affermare ancora Genette «l’univers baroque
est ce sophisme pathétique où le tourment de la vision se résout – et s ‘achève
– en bonheur d’expression».
O mia Medusa, mia Sfinge, mia Europa, mia Persefone, mio sogno e mio
pensiero, cos’è mai questa terribile, meravigliosa e oscura vita, questo duro
enigma che l’uomo sempre ha declinato in mito, in racconto favoloso,
leggendario, per cercar di rispecchiarla, di decifrarla per allusione, per
metafora? (Consolo 1987:135)
Bibliografia
I DOI vengono aggiunti
automaticamente ai riferimenti da Bilbo, lo strumento di annotazione
bibliografica di OpenEdition.
AA.VV., 2005, «Leggere V. Consolo» , Quaderns d’Italià , 10, Barcellona,
Universitat Autonoma de Barcelona.
AA.VV., 2007, Vincenzo Consolo punto de union entre Sicilia y Espaňa, los
treinta aňos de «Il sorriso dell’ignoto marinaio», Valencia, Generalitat
Valenciana, Universitat de Valencia.
Adamo G., 2006, La parola scritta e pronunciata, nuovi saggi sulla narrativa di
Vincenzo Consolo , San Cesario di Lecce, Manni.
Apollonio M., 1981, Storia del teatro italiano, vol. Io, Firenze, Sansoni.
Ariosto L., 1976, Orlando Furioso , Milano, Mondadori.
Bachtin M., 1979, L’opera di Rabelais e la cultura popolare , Torino, Einaudi.
Borges J.L., 1984, Finzioni , in: Borges J.L., Tutte le opere , vol. Io,
Milano, Mondadori.
Bouchard N., 2005, «Vincenzo Consolo e la scrittura postmoderna della
malinconia», Italica, 82, I.
Ceserani R., 1988, «Recensione a Retablo», Belfagor , XLIII, 2/3.
Cherchi P., 1979, Andrea Cappellano, i Trovatori e altri temi romanzi , Roma,
Bulzoni.
Chiarini G. (a cura di), Rudel J., 2003, L’amore di lontano , Roma, Carocci.
Consolo V., 1999, Di qua dal faro, Milano, Mondadori.
Consolo V., 1993, Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia,
Roma, Donzelli.
Consolo V., 1987, Retablo, Palermo, Sellerio.
De Sanctis F., 1981, Storia della Letteratura Italiana, vol. Io, Torino, UTET.
Di Girolamo C., 1989, I Trovatori, Torino, Bollati Boringhieri.
Di Girolamo C., 1986, La lirica dei trovatori, Bologna, il Mulino.
Di Legami F., 1990, Vincenzo Consolo, la figura e l’opera, Marina di Patti,
Pungitopo.
Dombroski R. S., 2005, «Consolo and the Fictions of History», in: Bouchard N.,
Risorgimento in Modern Italian Culture: Revisiting the 19th Century Past in
History, Narrative and Cinema , New Jersey, Farleigh Dickinson University
Press.
Dombroski R.S., 1998, Re-writing Sicily: Postmodern Perspectives, in: Jane
Schneider, Italy’s «Southern Question», Oxford-New York, Berg Press.
Frabetti A., 1995, «L’infinita derivanza». Intertestualità e parodia in
Vincenzo Consolo, www.culturitalia.uibk.ac.at.
Ferretti G.C., 1988, «Il segno di Retablo», L’Unità, 8/6.
Ferroni G., 1998, «Il mondo salvato da uno scriba» , Corriere della Sera ,
30/9.
Ferroni G., 1991, Storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi.
Finzi A.-Finzi M., 1978, «Strutture metriche nella prosa di Consolo»,
Linguistica e Letteratura , III, 2.
Formisano L., 1990, La lirica, Bologna, il Mulino.
Genette G., 1966, Figure I, Parigi, Éditions du Seuil.
Genette G., 1982, Palimpsestes , Parigi, Édition du Seuil.
Goethe JW, 1983, Opere , Viaggio in Italia , Sicilia , Milano, Mondadori.
Grassia S., 2011, La ricreazione della mente. Una lettura del «Sorriso
dell’ignoto marinaio», Palermo, Sellerio.
Guiette R., 1990, «Di una poesia formale nel medioevo [D’une poésie formelle en
France au moyen âge]», in: Formisano L. (a cura di), La lirica , Bologna, Il
Mulino, p. 137–143 [1949].
Jameson F., 1989, Il Postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo,
Milano, Garzanti.
Lee C., 1976, «I fabliaux e le convenzioni della parodia», in: Lee C. et al .,
Prospettive sui fabliaux. Contesto, sistema, realizzazioni, Padova, Liviana.
Leopardi G., 2007, I canti, Milano, Garzanti.
Madrignani CA, 2007, Effetto Sicilia, genesi del romanzo moderno, Macerata,
Quodlibet.
DOI: 10.2307/j.ctv125jrq2
Manzoni A., 1973, Del romanzo storico, in Opere, Milano, Mursia.Marazzini C.,
2008, Da Dante alla lingua selvaggia. Sette secoli di dibattiti sull’italiano,
Roma, Carocci.
Mauri P., 1987, «Fabrizio delle meraviglie», La Repubblica, 8/10.
Meneghetti ML, 1992, Il pubblico dei trovatori, Torino, Einaudi.
O’Connell D., 2008, «Consolo narratore e scrittore palincestuoso», Quaderns
d’Italià , Barcellona, Universitat Autonoma de Barcelona.
O’Connell D., 2009, Vincenzo Consolo e la critica del potere , in: Albertazzi
D., Brook C., Ross C. (ed.), Resisting the tide. Culture dell’opposizione sotto
Berlusconi (2001-2006) Rotherberg N., New York-Londra, Continuum.
Onofri M., 2003 Consolo per lumi sparsi. La modernità infelice. Saggi sulla
letteratura siciliana del Novecento, Roma, Avagliano.
Onofri M., 2007, «Nel magma italiano: considerazioni su Consolo scrittore
politico e sperimentale, in “Mapping Sicilian Literature”: Place Text in
Bufalino and Consolo», Italian Studies, LXI, 1.
Papa E. (ed.), 2004, Per Vincenzo Consolo, Atti delle giornate di studio in
onore di Vincenzo Consolo, Siracusa, 2-3 maggio 2003, San Cesario di Lecce,
Manni.
Pascal B., 1971, Pensieri in Œuvres complètes, Parigi, Hachette.
Pasquini E., 1981, La Letteratura didattica e la poesia popolare del Duecento,
Bari, Laterza.
Ramondino F., 1987, «Ode alla Sicilia (ea Rosalia)», Il Mattino , 3/11.
Roncaglia A., 1961, Poesia dell’età cortese , Milano, Nuova Accademia editrice.
Rutebeuf, 2007, I Fabliaux , a cura di Alberto Limentani , Roma, Carocci.
Sciascia L., 1987, «Il sogno dei Lumi tra Palermo e Milano», Corriere della
Sera, 18/12.
Scuderi A., 1997, Scrittura senza fine. Le metafore malinconiche di Vincenzo
Consolo, Enna, Il Lunario.
Traina G., 2001, Vincenzo Consolo, Fiesole, Cadmo.
Traina G., 2004, «Rilettura di Retablo», in: Papa E., Per Vincenzo Consolo,
Atti delle giornate di studio in onore di Vincenzo Consolo, Siracusa, 2-3
maggio 2003, San Cesario di Lecce, Manni.
Trovato S., 2001, Italiano regionale, letteratura, traduzione. Pirandello,
D’Arrigo, Consolo, Occhiato, Leonforte, Euno Edizioni.
Turchetta G., 1990, Introduzione a V. Consolo, Le Pietre di Pantalica, Milano,
Mondadori.
Tusini S., 2004, «Il romanzo post-storico», Allegoria, 47.
Vattimo G., 1989, La Società Trasparente, Milano, Garzanti.
Zanzotto A., 1990, «Dai monti fatti al sangue di Palermo. Consolo sospeso tra
due Sicilie», in: Zappulla Muscarà S., Narratori siciliani del secondo
dopoguerra, Catania, Maimone.
APPUNTI
2 A ciò va premesso
che la struttura di Retablo ricalca quella dell’omonimo polittico e che la
comprensione e decodifica del racconto di Isidoro e Rosalia – senza dimenticare
la predella situata nell’esatta metà dell’opera – presuppone una lettura
unitaria laddove essa si presenta scissa in due capitoli: Oratorio e Veritas, e
presentanti ciascuno il relativo punto di vista narrativo.
3 Per quanto riguarda Isidoro: «Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato,
rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio cervello
s’è mangiato.» (Consolo 1987: 17-18). A queste parole nella risposta quelle di
Rosalia, su parte finale dell’opera: «Isidoro, dono dell’alma e gioia delle
carni, spirito di miele, verdello della state, suggello d’oro, candela della
Pasqua, battaglio d’ogni festa […]» (Consolo 1987: 193).
4 La vexata quaestio sul nome del giullare autore dell’opera è tuttavia risolta
più avanti da Consolo a favore della seconda ipotesi quando introdurrà,
ammantata da una notevole ironia, la sedicente Accademia poetica de Ciulli
Ardenti. A tal proposito, è interessante notare che anche Dario Fo si è
soffermato su Rosa fresca aulentissima, identificando il nome esatto
dell’autore in Ciullo e scartando l’invalso Cielo, risultato questo di una
mistificazione culturale a scopo censorio (ciulloindica anche membro il
maschile). È quanto meno ipotizzabile che Consolo conosca l’altro e più
scurrile significato della parola, tant’è che sembra giocarci col lettore in
queste righe: «di Ciullo intenno, chiaro al monno intero, e surtutto per nui de
l’Accademia ardente che al nome suo s’appenne» (Consolo 1987: 54).
5 Cfr. «[…] la narrativa dei fabliaux , sbrigativa e salace, imperniata su
personaggi della borghesia, del clero, del contado, o anche dell’aristocrazia,
ma in una chiave beffarda che sembra antitetica a quella del romanzo o del lai
» (Rutebeuf 2007 : 13).
6 Ma anche Ariosto 1976 : X, 46: «il suo amore ha dagli altri differenza:/speme
o timor negli altri il cor ti lima».
7 Albertocchi (2005: 95-111) dedica un esauriente articolo alla reale figura
storica di Teresa Blasco, rivelandone, attraverso i documenti dell’epoca, le
vicende – invero scabrose – che la videro protagonista nella Milano dei Lumi, e
che la allontanano notevolmente dalla figura di donna vereconda tratteggiata
nel diario di viaggio di Fabrizio.
8 Per il lessico specifico trobadorico, oltre ai già citati testi di Formisano
e Di Girolamo, si rimanda al più agevole glossario posto a margine di Cataldi
2006: 226-229.
9 È Fabri Ramondino, estimatrice e critica della prima ora di Retablo, a
suggerire, nella sua recensione all’opera inclusa nel numero del 3 novembre
1987 de «Il Mattino», che il romanzo è costruito secondo lo schema della quête
dei cavalieri erranti: l’orazione, la peregrinazione e la verità ritrovata.
10 Questi versi e quelli successivi sono ripresi da Roncaglia 1961: 304-307.
11 Si rimanda per un rapido sunto ancora a Di Girolamo 1989: 63, e approfonditi
da Picone 1979. Si consiglia inoltre la lettura dell’introduzione dell’edizione
curata da Chiarini 2003.
12 Ibidem.
13 Dietro i personaggi del Cavaliere Fabrizio e del suo servo Isidoro che
compiono il loro Grand Tour siciliano sono intravedibili le sagome dei
personaggi di Jacques le fataliste.
14 Si veda Leopardi 2007 (qui e di seguito, per tutte le citazioni
leopardiane).
15 È doveroso qui richiamare Alejo Carpentier e il suo El Siglo de Las Luces,
romanzo storico pubblicato nel 1962, e che ha sviluppato, per temi e atmosfere,
Vincenzo Consolo.
16 Il viaggio del grande autore di tedesco si svolge tuttavia nel 1787, circa
un ventennio dopo quello del protagonista di Retablo.
17 Cfr. Capponi P., «Della luce e della visibilità, considerazioni in margine
all’opera di Vincenzo Consolo», in: AA.VV. 2005.
18 «Misera. La seule ha scelto qui nous console de nos misères est le
divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos misères. Car c’est
cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre
insensiblement. Sans cela, nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous
pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir. Mais le divertissement
nous amuse, et nous fait arriver insensiblement à la mort .» (Pascal 1971: I,
268).
Nicola Izzo , “Nello scriptorium barocco di Vincenzo Consolo: riprese e
ribaltamenti letterari in Retablo ” ,
reCHERches , 21 | 2018, 113-128.
Nicola Izzo
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
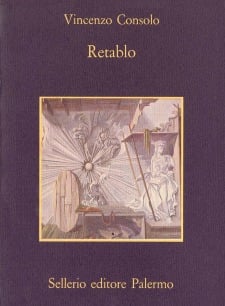



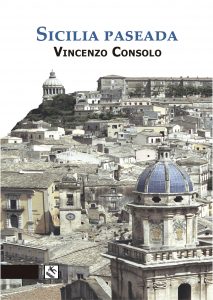
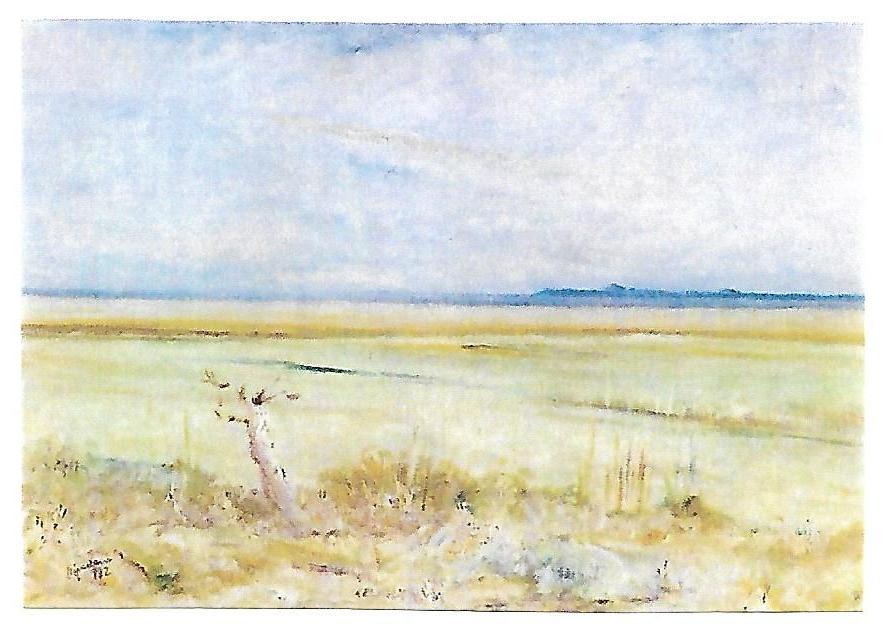
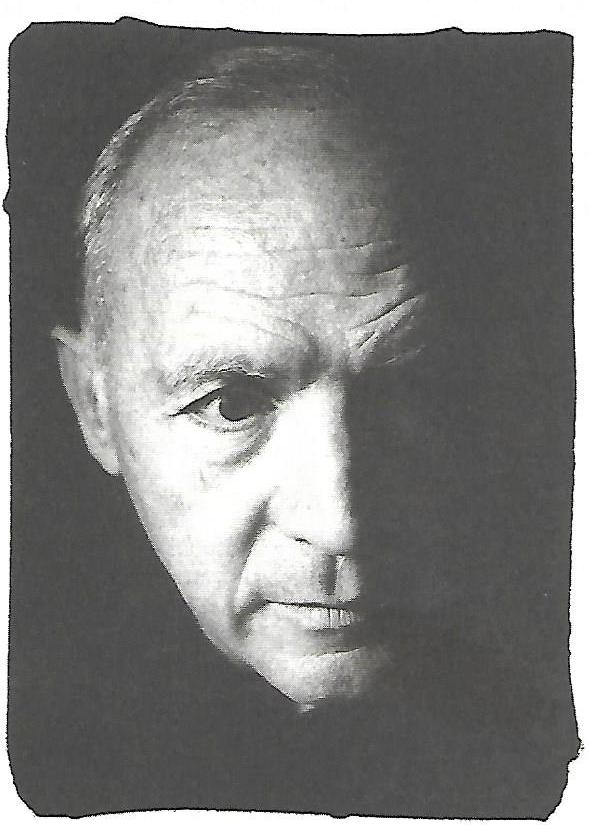


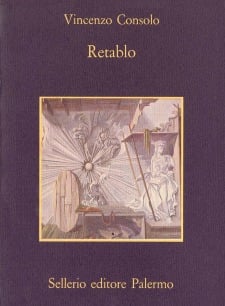

 Vincenzo Consolo, Sicilia paseada, traducción y edición de Miguel Á. Cuevas, Granada, Ediciones Traspiés, 2016
Vincenzo Consolo, Sicilia paseada, traducción y edición de Miguel Á. Cuevas, Granada, Ediciones Traspiés, 2016
