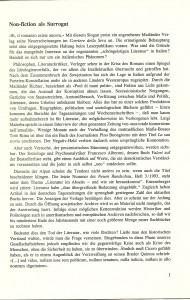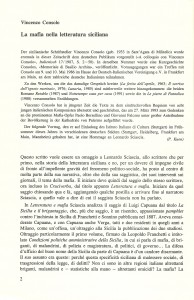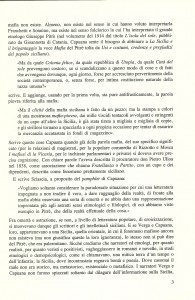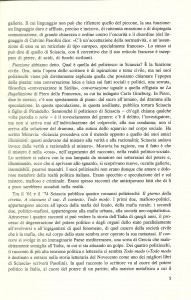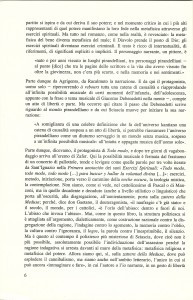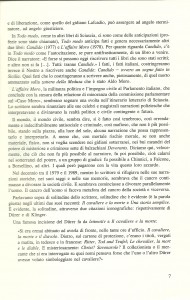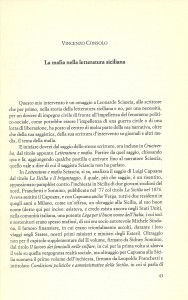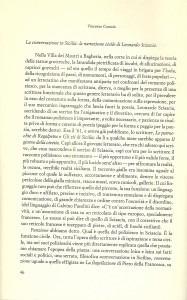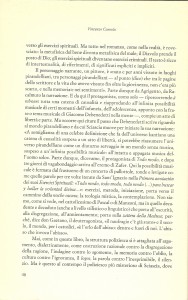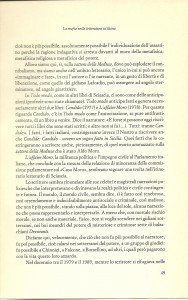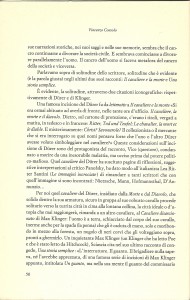VINCENZO CONSOLO
PADOVA, 01/06/1995
Ringrazio i due presentatori, il professor Mariani e il professor Pianezzola. Sono onorato di essere qui a Padova, di essere in questa gloriosa università. Ricordavo al professor Pianezzola che sono già stato qui venti anni fa, nel ‘76, invitato nella sua aula dal prof. Folena, quando era uscito il mio romanzo, che si intitolava Il sorriso di un ignoto marinaio. C’era stato un linguista che aveva messo in versi la mia prosa, rivelando in qualche modo quella che è la mia sperimentazione linguistica e la mia concezione dello scrivere quelli che si chiamano romanzi; ma su questo poi spero di avere occasione di soffermarmi.
Io non ho pratica universitaria; ci sono molti miei colleghi scrittori che sono anche universitari; io li invidio perché, avendo pratica didattica, sono abituati alle aule universitarie. Quindi mi scuso, metto le mani avanti per le mie esitazioni, per le mie inceppature e tutto quanto non rende fluido il linguaggio. Ecco, io non parto, dovendo affrontare questo tema, il tema del ritorno, del nÒstoj, non parto dall’archetipo, da Omero, dall’Odissea, ma voglio partire proprio dalla mia terra, dal primo degli scrittori siciliani che sono emigrati, che sono andati fuori dall’isola e che poi sono tornati: voglio partire da Verga.
La mia terra, l’isola, la Sicilia, è una terra estrema, che ha sempre, da una parte, persone non felici socialmente, che, spinte dalla necessità, sono state portate ad emigrare; ma questo non solo dalla Sicilia, ma da tutto il meridione, come voi sapete, e anche da zone depresse di questo Veneto. Però da parte degli intellettuali, degli scrittori c’è sempre stata, se non la necessità, il desiderio di arrivare al centro, di lasciare questa periferia incerta, cercando un centro che in volta in volta si identificava in Roma, in Firenze, ma soprattutto in Milano.
Verga, per non andare molto lontano, è stato il primo di questi emigranti, il primo di questi scrittori che ha lasciato l’isola per arrivare a Firenze, che era allora capitale d’Italia, e quindi a Milano.
Quando giunse a Milano, un giorno di novembre del 1872, immaginava di trovare una città immobile come era Firenze, capitale allora d’Italia, come dicevo, ma anche capitale della cultura, capitale della lingua; aveva già una carriera ben disegnata di scrittore: fino a quel momento aveva scritto, da giovane, I carbonari della montagna, Amore e Patria, Sulle lagune .
Ma a Firenze aveva lasciato questi temi di tipo storico-patriottico, e aveva intrapreso un altro filone, che poi è stato definito “mondano”: romanzi d’amore e passione, che si chiamano La peccatrice, Eva, Tigre reale, Eros, ecc.
E dunque giunge a Milano nel 1872, con un biglietto di presentazione molto ambizioso e molto gratificante per quell’epoca: era l’autore della Storia di una capinera; era il tema, allora molto di moda, di derivazione diderotiana, manzoniana della malmonacata. E quindi si presentava nei salotti milanesi, nei salotti delle varie contesse, della contessa Maffei, Castiglione o altre contesse, con questo affascinante biglietto da visita. Ma si presentava soprattutto col suo fascino di meridionale, di uomo taciturno e misterioso. Affascinava soprattutto le signore, in questi salotti, al punto da suscitare la gelosia e l’ira di Carducci perché sembra che abbia, in qualche modo, corteggiato l’amante di Carducci, Lidia, e Carducci manda un biglietto iratissimo a questa sua amante, dicendo che questo parvenu si presenta con un falso titolo, come cavaliere; per di più, è uno che ha scritto un romanzo epistolare, che era appunto la Storia di una capinera, e, ancora peggio, è un siciliano e quindi un uomo volgare. Il vate era pieno di furori, come voi sapete.
Quindi Verga immagina la società di Milano come una società assolutamente immobile. Ma Milano, nel ‘72, immobile non era: era in preda alla prima rivoluzione industriale; era una città in grande movimento: si aprivano le fabbriche, si apriva la Pirelli & Co. per la lavorazione della gomma e poi, naturalmente, anche opifici; il conte Melzi d’Eril aveva regalato al Comune delle sue proprietà, dove erano sorti nuovi quartieri; erano sorte nuove stazioni ferroviarie; c’era un grande movimento commerciale. Naturalmente, con questa nuova rivoluzione industriale incominciavano le prime conquiste sociali: nel ‘72 si apriva a Milano la prima sezione dell’Internazionale socialista, a Lodi si stampava un giornale che si chiamava […]; Garibaldi sciveva al direttore di questo giornale, a Bignami, dicendo del grande impegno che aveva questo giornale nei confronti della classe lavoratrice.
Verga, di fronte a questo mondo che non conosceva, che non capiva, si trovò immediatamente spiazzato e cadde in crisi, come spesso capita alla letteratura nei confronti della storia, della storia nel momento in cui si svolge. Questa rivoluzione industriale culmina nel 1881 con l’Esposizione universale di Milano. In questa esposizione Arrigo Boito tiene un discorso in uno dei padiglioni, un discorso tutto inneggiante al progresso, alla nuova era che avanzava; alla Scala si rappresenta il Ballo Excelsior con i versi di Marenco, dove si inneggia appunto alle nuove scoperte, all’elettricità; è una sorta di balletto a ritmo di polka, dove si parla appunto del traforo del Sempione, della scoperta dell’elettricità; insomma, si apriva tutto un mondo di grandi promesse. Verga rimane assolutamente dubbioso di tutto questo e la sua crisi culmina con l’81, l’anno della pubblicazione dei Malavoglia; ma questa svolta stilistica di Verga incomincia già negli anni precedenti. I primi segni si avvertono in un racconto, un racconto singolare che lui poi ha ripudiato, anzi scrive al suo traduttore francese, al […], che è assolutamente un racconto brutto, che non vuole che si traduca in francese. Però è un racconto singolare, perché è una svolta di epifania di quella che poi sarà la sua confessione stilistica, il suo ritorno in Sicilia. Questo racconto si chiama La storia del castello di Trezza. E’ un racconto di tipo gotico, dove c’è una cornice di tipo medievale e poi, dentro questa cornice, una storia contemporanea, dove c’è una contessa, la contessa Violante, che guarda dall’alto di questa torre le casipole e i fariglioni, che sono gli elementi che compariranno poi nei Malavoglia; li guarda dall’alto e prova compassione verso questa povera gente che abita in questa spiaggia, che è la spiaggia di Aci Trezza. Poi, quello che sarà il manifesto della sua svolta stilistica sarà un racconto che si chiama Fantasticheria. Natalino Sapegno dice che Verga, con questa sua crisi, ritorna con la memoria alla terra delle madri, ritorna alla sua Sicilia, al mondo intatto della sua infanzia.
Ecco, lui si portava dentro questo mondo e c’è voluto il contatto, l’impatto con Milano per poter scoprire dentro di sè questa sua memoria. Ma soprattutto scopre una lingua che sino ad allora non aveva praticato, che era un lingua diversa da quella con la quale aveva scritto fino ad allora i cosiddetti romanzi mondani. Era questa antilingua, questa lingua di opposizione al codice linguistico toscano, che non era assolutamente siciliano perché se, in un primo momento, nei racconti della Vita dei campi e poi Novelle rusticane ci sone delle esitazioni, ci sono ancora dei vocaboli siciliani scritti in corsivo, che sono come dei buchi dentro la pagina, a poco a poco questo liguaggio si amalgama; questa lingua non è più dialettale, è una lingua che è irradiata di dialettalità, non arriva mai al dialetto. Anzi Verga, quando prese coscienza di quello che stava facendo, di quello che aveva fatto, prende le distanze dal dialetto perché capisce che la sua operazione era un’operazione assolutamente linguistica, non era un’operazione di tipo dialettale; anzi, aveva avuto un diverbio, una polemica con Capuana, col suo confrère, appunto sull’uso del dialetto. Ecco, lui capiva che aveva inventato un linguaggio che era il linguaggio dei personaggi che lui trattava; era la storia che narrava (proprio per la sua concezione dell’impersonalità), era la storia che si parlava da sè. Si parlava da sè attraverso questa lingua, che è fatta come i versetti di un libro sacro, della Bibbia o del Corano: sono i proverbi tramandati dalla sapienza dei vecchi, dalla sapienza degli antichi, sono questi proverbi che si ripetono e naturalmente sono accettati passivamente da parte dei personaggi dei romanzi e dei racconti che lui va scrivendo. Comunque delinea, proprio nella concezione che Verga aveva di fronte a questa concezione progressiva, di tipo leibniziano o mamiano, quello sul quale avevano appuntato i loro strali ironici da una parte Leopardi e dall’altra Voltaire; Voltaire nei confronti di Leibniz, con il suo romanzo Candide, mentre Leopardi nei confronti di Terenzio Mariani ne La ginestra. Lui si era ripiegato in sé stesso, si era ripiegato nella stagione dell’infanzia, in una terra immobile che era la terra dell’immobilità più […] della Sicilia e che aveva trasferito in una dimensione esistenziale, in una dimensione quasi metafisica. Era la concezione del fato, della assoluta ininfluenza della storia nei confronti dei destini umani. Fato viene da “parlare”, for, faris e, quindi, quello che è detto è detto una volta per tutte, una volta per sempre. C’è, nella cultura arabo-musulmana, una frase del Corano, che dice “men tub” [?]; c’è anche questa matrice araba, non solo greca, nella concezione nella concezione verghiana del fato. “Men tub” significa “Ciò che è scritto è scritto”, e quindi c’è questo mondo circolare di Verga. Ora, io credo che nessuno come Verga poteva avere un concezione, in Sicilia, propria di un uomo che era nato sulle pendici di una terribilità naturale come l’Etna. L’Etna è quel vulcano che continuamente minaccia, che continuamente distrugge. Le popolazioni che sono vissute sulle falde di questo vulcano hanno sempre avuto questa concezione fatalistica della vita; quindi Verga interpreta perfettamente quella che è la concezione di questa popolazione, di questi esseri che vivono proprio sotto le minacce di una natura terribile e distruttiva come può essere quella di un vulcano. Un vulcano che poi non è altro che il simbolo, la pietrificazione di un altro elemento infido, un elemento minaccioso di cui non bisogna fidarsi, che è il mare. Lui pone la prima azione del suo romanzo, de I Malavoglia, al limite di questi due mondi, di questo mare pietrificato che è la lava, la sciara, e di quel mare tempestoso dove i Malavoglia incontreranno la loro sciagura, dove perderanno tutte le loro speranze, dove affogherà, dove si naufragherà la barca che si chiama Provvidenza. Dunque, questo mondo immobile, che è un incrocio fra Leopardi e il mondo tragico di Sofocle o di Euripide o di Eschilo. Naturalmente c’è una assoluta sfiducia nei confronti di una società organizzata, nei confronti della storia. Verga ritorna con la memoria in Sicilia, ma ritorna poi anche fisicamente, biograficamente nella sua Catania. In questa Catania, si chiude nella sua casa di Sant’Anna, pensa di scrivere quello che è il terzo episodio del Ciclo dei Vinti. Ma dissipa il suo tempo, ritorna come in questo alvo materno in cui rimane imprigionato. C’è una sorta di regressione, che già aveva espresso in modo poetico nelle sue opere, ma è anche una regressione di ordine biografico di Verga stesso. Ecco, dice: tutti sanno che sta scrivendo il terzo libro che è La duchessa di Leyra, e invece lo scrive [?]. Quando poi morirà, nel 1922, ecco si scopre che del terzo libro, del terzo episodio, de La duchessa di Leyra aveva tracciato soltanto il primo capitolo. E’ l’assoluta sfiducia che ha Verga nei confronti di un libro che avrebbe dovuto uscire fuori da quella che è la rigidità del poema narrativo rappresentato da I Malavoglia e, in qualche modo, anche dal Mastro don Gesualdo. Uscire fuori è scrivere il terzo romanzo, che avrebbe dovuto avere l’articolazione del romanzo ottocentesco, che avrebbe presupposto una fiducia in una società alla quale rivolgersi. Ma Verga non aveva fiducia più in questa società perché la sua riduzione stilistica, la sua rivoluzione linguistica, la scoperta di questo mondo dei vinti, aveva trovato una assoluta sordità nel mondo che lo circondava.
Ci saranno, come poi io racconto nel mio libro, le celebrazioni degli ottanta anni di Verga nel 1920 e sarà chiamato un personaggio emblematico di quella che è la rottura verghiana a pronunciare un discorso di commemorazione per questo genetliaco di Verga, Luigi Pirandello. Pirandello è stato chiamato perché era l’autore più rappresentativo in quegli anni in Italia, ma, voglio dire, è anche un simbolo di quello che Pirandello rappresenta in questo mondo verghiano. Rappresenta la rottura del cerchio, della condanna del fato verghiano; Pirandello, che viene dall’altra parte della Sicilia, anche lui abitava a Roma in quel periodo, ma viene da Agrigento, in una zona dove non c’è una terribilità naturale come quella della parte orientale, non c’è una presenza come quella del vulcano, ma è una realtà, quella girgentana, coma la chiama Pirandello, dove la storia si è fermata.
C’è un racconto, proprio di Pirandello, dove c’è questa antica storia, la storia dell’antica Grecia, che è come ferma, come cristallizzata in questo mondo agrigentino. Pirandello però vive in una realtà che era una sorta di specularità di quella che era stata la rivoluzione industriale del Nord dell’Italia, della rivoluzione industriale di Milano. Vive nella realtà delle zolfare. Le zolfare in Sicilia: proprio questa scoperta di una industria così penosa, così terribile, così sotterranea, catactonia quasi, ha creato una sorta di verticalizzazione di quello che era il mondo verghiano, il mondo della rassegnazione, il mondo del fato, che era il mondo contadino; verticalizzazione, perché si riproduce, all’interno della miniera di zolfo, quella era la gerarchia dello sfruttamento che esisteva in superficie, e quindi ci sono le varie gradualità, sino ad arrivare dal padrone al picconiere e al caruso. Proprio negli anni in cui Verga era a Milano, nel 1876, era stata fatta la prima inchiesta in Sicilia; ne era stata fatta una promossa dal governo italiano, ma come tutte le incheste burocratiche ufficiali non aveva rivelato la realtà drammatica meridionale, siciliana. Ma nel ‘76 due studiosi, uno piemontese, l’altro toscano, Sonnino e Franchetti, avevano fatto per conto loro questa inchiesta in Sicilia, soprattutto per quanto riguarda la malavita organizzata in Sicilia, per quanto riguarda la mafia, la corruzione delle strutture dello stato in Sicilia. Ma c’era stato un capitolo che aveva fatto indignare l’opinione pubblica italiana, ed era l’ultimo capitolo di quello che riguardava le condizioni dei contadini siciliani: era proprio il lavoro dei carusi, cioè dei bambini nelle miniere di zolfo. Ecco, si scoprì questa realtà terribile, vergognosa dello sfruttamento di questi bambini: i bambini entravano in miniera a cinque anni e rimanevano legati al picconiere; il picconiere pagava un prezzo per avere in affitto questi bambini e le famiglie davano questi bambini, ma dovevano poi pagare questo prezzo che avevano avuto per riscattare, diciamo, questa sorta di piccolo schiavo. Naturalmente il riscatto non avveniva mai, perché le famiglie non avevano la possibiltà di restituire il denaro e quindi questo caruso, che era un bambino, restava caruso fino all’età di trenta anni e oltre. Insomma si scoprì questa realtà dello sfruttamento di questo lavoro dei bambini e il mondo italiano, e non solo italiano, rimase inorridito. Ci furono molti studiosi che poi vollero capire questa realtà. E ci fu una donna inglese […], che era la moglie di un eroe risorgimentale che era arrivata in Sicilia e anche lei aveva fatto una inchiesta su queste miniere di zolfo. Comunque si tendeva a colpevolizzare massimamente il picconiere, ma le colpe erano ben più in alto, erano più da parte dei proprietari e dei commercianti dello zolfo, di questa grande scoperta che si era fatta in Sicilia.
Ma, ripeto, questa terribilità, questo mondo cunicolare, questo mondo sotterraneo era talmente disumano, talmente insopportabile che aveva portato questi uomini a una sorta di rivoluzione culturale. Coincide proprio, questa rivoluzione culturale, con l’avvento di quello che era il messaggio, diciamo come un messaggio religioso, che era il messaggio del socialismo. E quindi questi lavoratori, quelli che non si disgregavano, quelli che non morivano, che non impazzivano, perché marciavano su un crinale molto pericoloso, e prendevano coscienza della loro condizione si univano, e quindi credettero in questo messaggio socialista e cominciarono le prime riunioni; ci furono i primi scontri, ci fu un convegno in un paesino di zolfatari che si chiama Bronte; ci furono i primi scontri del ‘93, quelli che vanno sotto il nome di “Fasci Siciliani”.
Sarebbe troppo lungo raccontare tutta l’epopea di questo mondo delle miniere di zolfo, ma Verga, di fronte a questa realtà, perché pensava sempre a una Sicilia immobile, si ritrasse da Milano, perché non accettò questa rivoluzione industriale; e si ritrasse anche da questa Sicilia che, da immobile che era, cristallizzata, incominciava a muoversi e a prendere coscienza della storia. E scrisse, proprio nel periodo del suo esilio volontario in questa città di Catania, scrisse un dramma che si chiama Dal tuo al mio, dove si scagliava contro queste forme di scioperi, i primi scioperi che si facevano. Naturalmente assieme a lui c’era il Capuana, che seguiva le stesse vicende di Verga; e c’è un episodio emblematico: proprio dopo l’inchiesta che fecero Franchetti e Sonnino, i due letterati si sentirono come offesi, come se la Sicilia da questa inchesta fosse uscita diffamata. Addirittura Capuana ha scitto un pamphlet contro questa inchiesta, che va sotto il nome La Sicilia e il brigantaggio, dove dice: “Perché questa particolarità di malavita organizzata che va sotto il nome di mafia solo in Sicilia? non avvengono delitti anche, con statistiche alla mano, in altre regioni?” Certo, loro non accettavano che in Sicilia ci fosse questo fenomeno; addirittura poi Capuana dice che la mafia è un atteggiamento culturale del siciliano, una sorta di Tarteniade di tipo spagnolo, una sorta di superfetazione dell’io, e riporta come prova di questa sua concezione quella che era la definizione di mafia data da un etnologo di quel periodo che era Giuseppe Pittrè. Pittrè, anche lui, da quel positivista che era, non ammette che esista questo fenomeno in Sicilia. Verga, anche lui, proprio per questa idea di una Sicilia immobile, di una Sicilia “poetica”, non accetta queste novità dell’isola: non accetta, da una parte, che vi siano degli scontri di tipo storico, degli scontri di tipo sociale; non accetta, d’altra parte, che vi siano questi mali, questi mali, nati proprio in Sicilia, della malavita organizzata, dei delitti, di tutto quanto sappiamo sulla mafia. Tutto questo però non impedisce (e questo è un problema centrale di quello che è la letteratura, di quello che è, diciamo, la rivoluzione in letteratura, di quello che è poi l’idea conservativa che ci può essere dietro una rivoluzione stilistica), il conservatorismo, l’idea immobile che Verga ha della Sicilia non gli impedisce però di essere stato il più grande rivoluzionario linguistico e il più grande rivoluzionario stilistico della letteratura moderna. Qui ci sarebbe da fare veramente un discorso su quello che è il linguaggio, il linguaggio del romanzo, soprattutto, non delle poesie; bisognerebbe partire forse da Leopardi, che dice appunto della lingua italiana, mettendola in paragone con il francese nello Zibaldone (in quel grande mare che è lo Zibaldone), dice, per esempio, che la lingua francese, a partire dall’età di Luigi XIV, tende verso l’unicità, mentre l’italiano non è una sola lingua ma è un’infinità di lingue, che questa infinità di lingue vengono continuamente nutrite dai dialetti, dalle parlate popolari, e quindi l”italiano” ha in sè l’infinito che il francese ha perso. La ragione di questa perdita di infinito, di questa geometrizzazione (Leopardi parla proprio di “geometrizzazione” della lingua francese), risiede nel fatto che in Francia incomincò a formarsi una società, e quindi si sviluppò quella lingua di una società, una società in un certo senso armonica, mentre in Italia tutto questo non era accaduto, non esisteva una società e quindi in letteratura e nella vita non si era sviluppata quella lingua di comunicazione perché non era prodotta da una società che non c’era. E quindi c’erano le varie sotto-società, le varie comunità, le varie regioni, che parlavano delle lingue diverse, e gli scrittori parlavano in queste infinità di lingue. Leopardi poi porta come esempio massimo di infinito linguistico uno scrittore del ‘600, Daniello Bartoli, il famoso storico della Compagnia di Gesù, che scrive, oltre a questa Storia, anche altri libri dove la lingua si estende in tutte le sue infinite possibilità; Leopardi porta come esempio massimo di ricchezza linguistica questo esempio secentesco. Esempio secentesco che poi Manzoni rifiuta perché, storicisticamente e volontaristicamente, vuole dare una lingua agli Italiani e quindi, andando a sciacquare i panni in Arno, non fa che parodiare un brano di Daniello Bartoli dove c’è una descrizione di una certa zona della Cina nell’attacco dei Promessi Sposi: “Quel ramo del lago di Como” non è altro che la parodia, proprio con lo stesso schema, della descrizione che fa appunto Daniello Bartoli di una regione della Cina; c’è questo ironico riferimento, ironica parodia del Manzoni, voluta, di Daniello Bartoli. Quindi il rifiuto, diciamo, di quello che è l’infinito e la volontà, da parte del Manzoni, di avere una lingua per una società che lui desiderava si formasse. In Verga c’è questa assoluta sfiducia nella società, ma c’è anche sfiducia nell’esistenza e nella vita.
Così, malamente, ho tracciato quella che è la vicenda verghiana, però forse ho lasciato sospeso il significato della rottura del cerchio, della condanna verghiana e della rottura del cerchio linguistico verghiano da parte di Pirandello. Pirandello è quello che modernizza il fato, la tragedia antica, fa diventare dramma quella che è la tragedia, dramma moderno, attraverso l’intromissione dell’ironia, dell’umorismo lui lo chiama. Pirandello è quello che si chiede del perché di questa condanna, si chiede perché attraverso l’aberrazione, attraverso la parola, la parola incessante…, ecco, il discorso di Pirandello, che non ha assolutamente preoccupazioni stilistiche; Pirandello parla una lingua di estrema comunicazione, ma questa lingua è una lingua da legulei, una lingua da tribunale, una lingua da aberrazione avvocatizia, e attraverso questo continuo domandarsi, attraverso i vari punti di vista, Pirandello cerca di rompere questo cerchio verghiano e di riportare su una linearità quello che è l’antico fato, di far diventare dramma… Dramma viene da dr£w, “fare”, ecco, quindi, dall’immobilità verghiana si passa a questo movimento, movimento verbale che è la concezione di Pirandello stesso. Senonché il trasferimento dal luogo di Aci Trezza, dalle falde dell’Etna, in un ambiente piccolo-borghese o borghese, qual è quello pirandelliano, fa diventare la faccenda molto più dolorosa. La stanza, il salotto borghese pirandelliano diventa, secondo Giovanni Macchia, appunto la stanza della tortura, dove c’è il vacillare della identità, dove c’è questo motiplicarsi dell’io e tutto quello che sapete. Pirandello è anche lui uno che è andato, ma io credo che abbia mosso i suoi primi passi, proprio sin dall’inizio, che sia uscito fuori dalla Sicilia e credo che non abbia avuto mai nessun ritorno; se ritorno c’è stato, in Pirandello, c’è stato nel momento della morte, quando scrive il mito I giganti della montagna, un dramma non finito dove c’è una sorta di ritorno indietro, ritorno alle origini, quando, proprio la notte prima di morire, dice al figlio che nel terzo atto non scritto di questo mito vede un olivo saraceno. L’olivo saraceno è quell’ulivo da cui lui era partito quando, nell’inizio della sua autobiografia, che non mai concluse, dice: “Caddi come una lucciola per caso in un luogo che si chiama il Caos e dietro ad un olivo saraceno”. E quindi vede, alla conclusione di questo dramma, I giganti della montagna, la presenza di un olivo saraceno, su cui si doveva dispiegare il drappo dove Ilse avrebbe dovuto recitare per i giganti della montagna il dramma del figlio cambiato; poi naturalmente Ilse venne uccisa dai giganti della montagna perché nel mondo, diceva Piradello, non era più possibile la poesia, non era più possibile recitare, dice, una poesia. Ecco, quindi c’è questo ritorno, alla fine di tutto il suo arrovellarsi, di tutto il suo discorso, di tutta la sua dialettica, c’è questo ripiegamento, questo ritorno alle origini attraverso questo simbolo forte che è l’olivo.
Da Verga, dopo questo breve passaggio attraverso Pirandello, vorrei adesso parlare di un altro Odisseo, di un altro emigrato che ritorna, e si tratta di Elio Vittorini. Vittorini era andato via giovane dall’isola, quasi adolescente, era scappato così come Quasimodo, scappato di casa per questo mito del centro, questo mito del Nord, ed era approdato a Gorizia e poi a Milano. Nel ‘41 pubblica questo libro, che è stato un po’ il libro di formazione di tutte le nuove generazioni del secondo dopoguerra, è stato una specie di messaggio criptico, un messaggio ermetico da parte delle generazioni che vivevano sotto il fascismo e che dopo la liberazione avevano di nuovo riacquistato la libertà. L’attacco di Conversazione in Sicilia suonava veramente, nel ‘41, come un rintocco di campana. Quando Vittorini inizia: “Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma bisogna ch’io dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere umano perduto.” Il genere umano perduto era naturalmente quello sotto la guerra, sotto la dittatura fascista. Compie Vittorini questo ritono alla terra della madre, non più alla terra delle madri; il titolo Conversazione in Sicilia è mutuato dalle sacre conversazioni di tante pitture italiane; adottando questo titolo Vittorini punta a laicizzare questo topos pittorico, così come aveva fatto Piero della Francesca nel famoso quadro La Flagellazione, che si trova a Urbino. Su questo quadro ha indagato Carlo Ginzburg con quel libro famoso che si chiama Congetture su Piero; c’è, dice appunto Ginzburg, in questo quadro, come un spostamento di piani: in secondo piano c’è la figura del Cristo alla colonna e in primo piano ci sono dei personaggi che conversano, e si capisce che la conversazione di questo personaggi è una conversazione filosofica, una conversazione civile; quindi c’è questo spostamento di piani dal sacro al profano, dal mistico al laico. In Vittorini c’è la volontà di spostare dal piano del mito al piano della storia, al piano della civiltà la conversazione. Il diario di Vittorini naturalmente è all’insegna dell’altro mito, del mito di Enea. Ci sono tutti i connotati del viaggio di Enea verso l’Italia dopo la distruzione di Troia: c’è il passaggio dello stretto di Messina che è come l’attraversamento dell’Acheronte, c’è l’assunzione del cibo iniziatico, del pane che l’eroe Silvestro, il protagonista mangia su questo traghetto, il pane, il pecorino, e poi mangia le arance, che è come una sorta di cibo, mentre attraversa l’Acheronte, prima di approdare a questa terra degli Inferi, a questa terra delle madri.
E quindi in questa Sicilia livida, infernale incontra questa madre, Concezione. Concezione naturalmente è un nome simbolico, che porta i meloni, questa madre feconda, che non lo trattiene, non è una madre distruttiva che ingoia, ma è una madre attiva, che spinge il figlio verso l’azione e la madre fa da Virgilio, da accompagnatrice, in questa discesa agli inferi, quando Silvestro accompagna la madre che fa le iniezioni in questi tuguri di questa Sicilia povera, in questa Sicilia dell’interno. E quindi poi tutto il racconto, con tutti i simboli. Naturalmente il libro è molto simbolico, perché sotto il fascismo non poteva avere un linguaggio molto comunicativo e molto chiaro, ma forse proprio per questa mancanza di libertà di espressione il libro si carica di poesia, proprio per questi simboli che ci sono e quindi incontra l’arrotino, e naturalmente i simboli del coltello, incontra il […]iere che appende panno rosso davanti alla sua bottega, incontra gli operai che bevono in questa specie di caverna, che cantano dondolandosi. E poi incontra il Gran Lombardo, questo Gran Lombardo che è quello che ha un atteggiamento di rivolta, un atteggiamento anarchico nei confronti della autorità e del potere. E quindi poi arriva sino alla discesa agli inferi, all’Ade, alla dimensione dell’aldilà, quando incontra al cimitero il fratello morto in guerra. Quindi un viaggio di ritorno anche questo di Vittorini-Enea, ed un viaggio anche di risalita verso la fiducia nella storia; il romanzo che seguirà poi la Conversazione in Sicilia sarà Le donne di Messina, che è stato riscritto due volte da Vittorini stesso e che narra della nascita di una società, di una nuova società dopo lo sfacelo della guerra; sulle rovine della guerra nasce questa comunità, dove le donne hanno una parte molto importante. Ritornerà ancora una volta Vittorini in Sicilia in un momento particolare, nel momento della scoperta del petrolio; lui aveva creduto in questa sorta di Lombardia siciliana, in questa sorta di attivismo industriale, sull’esempio, di quegli anni, dell’esperienza olivettiana, dell’industria a misura d’uomo; attraverso la scoperta del petrolio in Sicilia e con l’installazione delle raffinerie da parte di Mattei aveva concepito un romanzo pieno di fiducia nel progresso dell’industria e immaginava, da quell’anima generosa che era Vittorini, che per la Sicilia si sarebbe aperta una nuova pagina di storia. E aveva scritto il romanzo che poi aveva lasciato incompiuto, e che è uscito postumo dopo la sua morte, quel libro che si chiama Le città del mondo, dove c’è tutta una Sicilia in movimento, dove ci sono i contadini a cavallo che convergono verso una valle per una riunione in un’assemblea, ci sono ragazze e ragazzi, padri e figli che vanno fuori e camminano, che non si sa dove vanno, ci sono i camionisti. Quindi c’è tutto un atteggiamento ottimistico nei confronti questa Sicilia in movimento. Ma tutto questo poi, come sappiamo, questa utopia vittoriniana dell’industria a misura d’uomo, ecco, si infrangerà contro gli scogli della storia: sappiamo che cosa hanno rappresentato queste installazioni industriali, queste raffinerie in Sicilia, raffinerie installate poi nei luoghi di antica storia, direi sacri a quella che è la cultura, alla nostra cultura mediterranea. Raffinerie installate alle porte di Siracusa, a Priolo, a Melilli, che tanti disastri hanno portato, raffinerie installate a Milazzo e in altri luoghi.
Contemporaneo a Conversazione in Sicilia nel ‘41 esce un altro libro di un siciliano emigrato e che ritorna, Vitaliano Brancati; il romanzo si chiama Don Giovanni in Sicilia, ed è una storia non in termini mitici e drammatici come quella di Vittorini, ma in termini comici, in termini ironici, diciamo. Questo don Giovanni, che aveva lasciato Catania, era emigrato a Milano, a Milano era diventato un uomo attivo, aveva sposato una milanese, si era scrollato di dosso tutta la pigrizia e l’immobilità dei siciliani che vivono sotto questo vulcano; ritorna in vacanza con la moglie a casa e lì viene assistito dalle sorelle, ritorna nel suo letto da scapolo, questo Giovanni Percoto; chiede, dopo il pranzo, di andare a dormire e, dice Brancati: ”E dopo un minuto di sonno duro come un minuto di morte”, c’è questa forma di regressione di uomo che non ha saputo resistere a quella che è la seduzione delle madri, a quella che uno psicanalista chiama l’esilio dell’anima. Questo psicanalista che si chiama Reale, junghiano, lo dice nell’analisi che fa di un racconto di Lampedusa che è Riviera [?], di un professore […], che, studiando i dialetti ionici, così relegandosi in un golfetto, proprio vicino a quei luoghi dove sono state installate le raffinerie, più in là di punta Izzo, come dice, fra Megara Iblea e Siracusa, appunto lì, in questo luglio infuocato, apocalittico, lui vede la sirena, gli appare una sirena, questo essere divino e bestiale, questa fanciulla di antica sapienza che mangia i pesci crudi, ecc., e rimane prigioniero di questa sua allucinazione, la sua anima rimane per sempre siciliana. Questo è il rischio dei ritorni, è stato diciamo, il rischio e il pericolo che ha corso Verga, se non fosse stato quel grande rivoluzionario stilistico di cui vi dicevo. E’ il rischio di tutti i ritorni, di rimanere prigionieri in questa terra delle madri, di rimanere prigionieri nella regressione linguistica, di rimanere prigionieri dei vagheggiamenti, di rimanere prigionieri nell’età d’infanzia, di rimanere prigionieri degli eventi.
A questo proposito dovrei parlare di un altro Ulisse, che è colui che qui vi parla. Anch’io sono uno, se permettete, che ha lasciato l’isola a una certa stagione della sua vita. Avevo lasciato l’isola quando già avevo fatto la mia scelta linguistica, proprio sulla scia di quella rivoluzione stilistica segnata da Verga. E m’ero immesso proprio sulla linea della sperimentazione verghiana; si usciva in quegli anni, negli anni in cui ho mosso i miei primi passi letterari,si concludeva per la verità la stagione chiamata del Neorealismo; Neorealismo, oggi tanto deprecato, che io credo che sia stato una stagione di scrittori di grande generosità, di persone che attraverso quella scrittura delle cose, con quella scrittura di grande comunicazione, aspiravano alla ricostruzione di una nuova società, di una società da ricostruire sulle macerie della guerra, sulle perdite che si erano avute attraverso venti anni di dittatura, attraverso tutto quello che sappiamo. Forse il simbolo massimo di questo Neorealismo è quel grande scrittore, oggi poco frequentato, che è Carlo Levi. Carlo Levi, per quelli della mia generazione, assieme a Vittorini e a pochi altri era stato la guida con Cristo si è fermato a Eboli, facendoci scoprire, al modo di Verga, una realtà meridionale che non conoscevamo e soprattutto, per me, con il libro Le parole sono pietre: era la cronaca, quasi, d’un viaggio in Sicilia negli anni ‘50, dove si parlava di questa realtà terribile della Sicilia. E gli altri scrittori poi, epigoni di Carlo Levi, come Danilo Dolci e altri. Quindi l’idea mia di letteratura è, in quegli anni, essendomi nutrito poi di letture di tipo meridionalista, oltre a queste di tipo letterario, di tipo politico e sociologico (parlo di scrittori come Carlo Dosso, Gramsci, tantissimi altri)…; insomma, m’ero formato su questa letteratura, oltre che sui grandi autori che ogni adolescente legge e che formano le ossa e il sangue nella sua formazione. Ecco, però il momento in cui mi sono trovato a scrivere questa stagione del Neorealismo finiva; finiva perché la speranza di una nuova società si era perduta con un fatto politico importanto che erano state le elezioni dell’aprile del ‘48, dove un partito che si chiama Democrazia Cristiana aveva preso il potere; Carlo Levi racconta tutto questo in un libro magnifico che si chiama L’orologio, la fine di questa speranza, parla degli anni del secondo dopoguerra a Roma, la ricostituzione dei partiti, le aspirazioni che c’erano state. E quindi nel momento in cui mi sono volto a scrivere ho pensato che non avrei mai potuto praticare in quella temperie politica una scrittura di comunicazione, una scrittura dove si ipotizzava, o si sperava, l’esistenza di una società che corrispondeva alle nostre aspirazioni e ai nostri ideali; e quindi mi posi senz’altro nella linea dell’opposizione, della sperimentazione linguistica, in quell’infinito linguistico di cui parla Leopardi. Naturalmente non c’era Verga, ma c’erano quelli che si erano mossi su quelle stesse linee, negli anni in cui io cominciavo a scrivere; i grandi nomi sono appunto Carlo Emilio Gadda, attraverso quella sua straordinaria polifonia linguistica, attraverso quel libro che è il simbolo dell’Italia di quegli anni che è il Pasticciaccio brutto di via Merulana dove c’è questa polifonia dei dialetti italici; naturalmente Pasolini, attraverso il suo passaggio dal dialetto di Casarsa al romanesco e attraverso la tecnica della digressione; così come Gadda, anche Pasolini adottò la tecnica della digressione: a partire dal codice linguistico toscano, a mano a mano regrediva verso il dialetto. Io avevo consapevolezza di quello che stavo facendo e incominciai; pubblicai il mio primo libro nel ‘63; nel ‘63 si svolgeva a Palermo un fatto importante nella letteratura italiana, la riunione del Gruppo ‘63, che era un gruppo avanguardistico. Il libro era già compiuto ed era in stampa quando io sono andato a Palermo ad assistere a queste riunioni del Gruppo ‘63, e capii che non avevo niente da spartire con questo avanguardisti; capii la differenza, e in questo senso mi guidò Pasolini, che c’era fra avanguardia e sperimentalismo. L’avanguardia è l’azzeramento di ogni codice linguistico, è, sull’esempio del Futurismo di Marinetti, che aveva dettato il codice dello scrivere, era qualche cosa di assolutamente artificiale. Appunto quelli del Gruppo ‘63 ipotizzarono, secondo quello che aveva dello Angelo Guglielmi, la destrutturazione dei nessi logici e sintattici della scrittura come immagini della destrutturazione, della confusione della nostra società, il che mi sembrava assolutamente inaccettabile, un’idea non praticabile, insomma; era un tipo di scrittura non attraversabile e poi, diciamo, gli avanguardisti del Gruppo ‘63 finirono per essere i migliori conservatori nel campo della scrittura, diventarono degli scrittori quasi tutti di tipo tradizionale, tradizionale nel senso più vieto, nel senso della conservazione letteraria, non della sperimentazione.
Dicevo che mi posi proprio sul piano della sperimentazione pur adottando, avendo a disposizone un patrimonio linguistico che apparteneva alla mia cultura e che era la ricerca di quello che era il glossario che era stato seppellito in questa mia terra e che tutte le civiltà che erano passate attraverso la Sicilia avevano lasciato. Erano vestigia di una lingua che non appartenevano a un codice linguistico nazionale e che portano al greco, naturalmente al latino, all’arabo, allo spagnolo e io adottai la tecnica dell’innesto, cioè del reperimento di questi reperti linguistici e della loro immissione secondo un’esperienza sonora, oltre che un’esigenza di significato; immetterli in quello che era il discorso, in quello che era la prosa. Ma c’era in me anche una sorta di irrigidimento, di ritrazione da quello che era il linguaggio della prosa e del romanzo, perché il romanzo, come dice uno scrittore sudamericano, Ernesto Sabato, è un ibrido, è uno strano genere letterario dove c’è una parte magica, lui dice, che poi è la parte espressivo-poetica. Ecco invece c’era l’esigenza di spostare, di irrigidirmi sul piano della comunicazione, di essere poco comunicativo, appunto perché non presupponevo, non immaginavo d’altra parte una società con cui comunicare, e c’era uno spostamento verso la zona dell’intimo poetico, del poema narrativo. Questo è stato per me una scoperta e che continuai a praticare poi in altri pochi libri, io ho letto […].
C’è stata in me sempre questa oscillazione, a seconda dei momenti storici, di fiducia in un progetto politico o di sfiducia in questo progetto politico, questo avvicinarmi verso la comunicazione o allontanarmi dalla comunicazione e ritrarmi verso l’espressione e verso il ritmo della poesia. Poco fa vi accennavo della scansione in versi che un professore che si chiama Finzi, proprio qui a Padova, in questa università, aveva fatto del mio libro Il sorriso dell’ignoto marinaio. C’era la scansione in versi, ma c’era anche però un discorso di tipo mimetico-ironico da parte di […]. Era la mimesi di un erudito dell’800, il protagonista del romanzo, barone di Mandralisca, e quindi era una scrittura in negativo, non era una scrittura in positivo.
Ma la rottura linguistica avveniva alla fine del libro quando questa scrittura di tipo ottocentesco si rompeva e apparivano le scritte di quelli che baroni non erano e che erano quei contadini rivoltosi, perché raccontavo proprio di una rivolta popolare del 1860, con l’avvento di Garibaldi. Un romanzo storico, che mi permetteva di approfondire ancora la mia ricerca linguistica e stilistica, e poichè voleva essere metafora, questo 1860, degli anni ‘70, ‘68-’70, gli anni in cui l’Italia concepì questa utopia politica, questa sorta di rivoluzione culturale, che ha rappresentato il ‘68 in Europa e non solo in Europa… Trasferendomi a Milano, essendo anch’io un emigrato, subii, arrivando a Milano nel ‘68, in questa Milano industriale e in preda a gran movimento operaio e quindi l’attività di scontri politici, subii anch’io una sorta di spaesamento, di afasia, perché mi trovai di fronte un mondo che non conoscevo, che non potevo rappresentare; ho avuto tredici anni di silenzio dal primo libro al secondo. Tredici anni sono veramente un tempo scandaloso per uno scrittore, quando uno scrittore poi non scrive un capolavoro, ed io capolavori non ne ho scritti; insomma credo che non ci sia giustificazione per una pausa così lunga. Però il silenzio, questa pausa così lunga, è dovuta a questa sorta di spaesamento, e capii anch’io che per poter continuare a mantenere la mia integrità di scrittore, per poter continuare a scrivere dovevo tornare in Sicilia, ma non alla terra delle madri, dovevo sprofondare, diciamo, nel sottoterra dell Sicilia, forse in una zona più profonda di quello che è il grembo materno, diciamo, e poi da lì risalire per arrivare al linguaggio paterno, al linguaggio della comunicazione. Quindi il mio destino era di questa oscillazione, di questo sprofondamento nella realtà linguistica, in questo cercare di portare questi reperti, queste scorie che andavo trovando, di riportarle alla superficie, di riportarle sul piano della comunicazione come segno di opposizione, come segno anche di ricerca, diciamo, di un infinito. Luigi Russo dice che appunto attraverso lo scontro linguistico, l’opposizione linguistica, nasce la poesia. E io speravo che nascesse la poesia proprio da questo scontro linguistico. Ecco dicevo appunto che questo oscillare, a seconda dei momenti storici, dalla comunicazione verso l’espressione, e forse il libro mio più comunicativo è stato, pur con le sue fratture, le sue rotture nella struttura stessa del romanzo, che non è un romanzo storico di tipo tradizionale ottocentesco, in tutta la sua rotondità, naturalmente con delle fratture, con delle spezzature, con dei documenti che io chiamo appendice, che fanno da riempitivo, da tessuto connettivo della storia che io voglio raccontare, forse il mio libro più comunicativo è appunto Il sorriso di un ignoto marinaio. Sono venuti altri libri, ma penso che i libri abbiano fra loro un legame, quindi debbano avere una loro necessità. Ecco, non sono dei libri così, dettati dalla volontà di scrivere un libro, devono essere necessitanti. Ecco, da questo libro della speranza, dell’utopia, un po’ come poteva essere la Conversazione in Sicilia di Vittorini, quella è stata la mia conversazione, ecco ho scritto un secondo libro, che è legato a Il sorriso di un ignoto marinaio, che si chiama Nottetempo, casa per casa. L’ho scritto nel ‘92, è stato pubblicato nel ‘92 ed è un romanzo dove voglio raccontare la fine di una utopia politica nel processo di deterioramento di una civiltà, di una società qual è quella italiana. L’ho raccontato naturalmente ancora in modo storico, storico-metaforico, ambientando il romanzo a Cefalù, ancora nello stesso teatro de Il sorriso di un ignoto marinaio, negli anni ‘19-’20. Ho raccontato la nascita del fascismo in Italia attraverso questo piccolo teatro, che era il teatro di Cefalù, che aveva fatto già da sfondo a Il sorriso di un ignoto marinaio. E’ un romanzo pieno di disillusione, amarezza per il crollo di questa utopia politica, per questa società che si è a mano a mano involuta negli anni e che ha portato poi a delle forme fascistiche, il fascismo degli anni ‘19, i cui segni erano nel decadentismo culturale, decadentismo il cui personaggio portante diciamo, in figura di funzione, come diceva Vittorini, era un satanista inglese, di nome Crowley, personaggio storico. Ed era un signore, uno di questi decadenti inglesi di inizio del secolo, che aveva girato tutto il mondo e che poi era approdato in questo piccolo paese di Cefalù, come c’erano state le comunità di decadenti a Capri, o a Taormina; c’era stato questo signore solitario che era approdato a Cefalù e che aveva fondato una sorta di chiesa, di comunità, che lui chiamò al modo di […] l’abbazia di Thélème, dove la legge era: “Fa’ ciò che vuoi”, e aveva concepito, portando al seguito degli spostati, dei personaggi, le attrici di Hollywood, o dei professori di matematica del Sudafrica, e personaggi simili, aveva immaginato di soppiantare il cristianesimo dal mondo e di instaurare il satanismo, al posto del cristianesimo. Comunque erano forme di follia. Il libro è appunto un libro sulla follia, sulla follia esistenziale, rappresentato dalla follia del protagonista, che si chiama Petro Marano, e dalla follia della storia. Il protagonista, che è un piccolo intellettuale, un maestro elementare, si chiama Marano in omaggio ad uno scrittore meridionale, che è Jovine: appunto, il protagonista de Le terre del sacramento si chiama Luca Marano; io l’ho chiamato Petro Marano, ma Marano perché ha anche un altro senso, perché ho pensato che Marano derivasse da marrano. Marrano è quello che è stato forzato ad abbandonare la propria identità e cultura, la propria religione e convertirsi al cristianesimo, nel 1492, perché in Sicilia è avvenuto quello che è avvenuto in Spagna, perché eravamo sotto gli spagnoli, nel ‘92, e quindi c’era questo primo sradicamento e perdita d’identità che era come una memoria atavica in questa famigliola, famigliola di contadini che poi erano diventati piccoli proprietari terrieri e quindi piccoli borghesi e che avevano dovuto lasciare quella che era la loro cultura popolare, per farsi una nuova cultura piccolo borghese, pagando dei prezzi molto alti, pagando con la depressione il padre,la schizofrenia della sorella che rinuncia all’amore, eccetera, eccetera. Questo giovane intellettuale degli anni ‘20 immagina che, in una società più armonica, il dolore privato si possa distribuire nella società, ma quando si impegna politicamente si accorge che fuori, nella storia, nella società, c’è altrettanta follia che dentro a casa sua, e quindi compie un gesto disperato e deve scappare dalla Sicilia e rifugiarsi in Tunisia. Lì incontra un anarchico che era anche lui un folle, un anarchico individualista che si chiama Paolo Schiehic [?], personaggio storico anche lui. E le ultime parole del libro, prima che il protagonista approdi con la nave a Tunisi, sono queste: “Pensò al suo quaderno, pensò che, ritrovata la calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro, avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore.” Ecco la fiducia nella letteratura, perché solo la letteratura può raccontare il dolore dell’uomo. Ecco io credo che non ci sia nessuna storiografia, che non ci sia nessuna politica, che non ci sia nessun documento che possa raccontare il dolore dell’uomo, se non la letteratura. Il dolore, e altri sentimenti alti, come l’amore o altri sentimenti. Questo libro, L’olivo e l’olivastro, che è l’ultimo mio edito è assolutamente legato a Nottetempo, casa per casa, dove racconto la nascita del fascismo, il fascismo che purtroppo è arrivato in questo nostro paese, questo bisogna dirlo e ricordarlo sempre. E questo libro incomincia proprio con le parole: […], diciamo che, raccontato il dolore, ora non è più possibile raccontare quella che è la finzione letteraria, l’inganno del romanzo, bisogna raccontare in altre chiavi, e l’unica chiave che mi è stata data, che ho trovato, è l’archetipo della narrazione, è l’Odissea. Ecco ho immaginato il protagonista che ritorna, se non da Tunisi, ritorna da Milano. Un io narrante che è approdato a Milano nel ‘68, che ritorna assieme a un lavoratore, a un terremotato, anche lui scappato dalla Sicilia, in occasione del terremoto del Belice. I due si incontrano alla stazione di Milano e poi si perdono. Uno emigra in Svizzera, e l’altro rimane a Milano a fare l’intellettuale.
Ritorna in Sicilia, ritorna nella sua Itaca , ed è un’Itaca che non ritrova più, perché le Itache non esistono più, non esiste più la possibilità di ricucire questo che è il vuoto dovuto alla colpa che Ulisse si porta. Ulisse è il più colpevole degli eroi greci, perché è il più astuto, perché è il più intelligente, anche se spesso è il più valoroso, il più consapevole, il più uomo. Si porta la grande colpa Ulisse perché aveva inventato l’arma sleale, che è il cavallo di Troia. Ecco io ho immaginato che il cavallo di Troia fosse poi rappresentato in questo mondo onirico, la professoressa Maria Grazia Ciani, dice che il viaggio, il nÒstoj, è proprio un lungo naufragio in cui l’unica terraferma, la sola realtà, il vero sogno è Itaca. Tutto il viaggio di Ulisse, il racconto in prima persona dell’Odissea incomincia nella terra dei Feaci, nella terra di Alcinoo, quando questo ignoto naufrago, che arriva lì ignudo, ecco, è uno sconosciuto, e quando si può muovere, di fronte al canto del divino Demodoco, del cantore cieco, ecco a quel punto, sollecitato da Alcinoo rivela la sua identità. Incomincia la sua grande narrazione, la narrazione dell’Odissea, con la parola “Io”: “Io sono Ulisse, figlio di Laerte, sono nato ad Itaca, ecc.” E poi conclude: “Non conosco altra cosa più dolce per l’uomo se non la propria terra”. Ecco, io credo che nel mondo d’oggi questa Itaca non esiste più. Il racconto di Ulisse, io credo, ho sempre pensato, che l’Odissea, la prima parte, la Telemachia è il romanzo dell’iniziazione, della formazione, della conoscenza, mentre l’Odissea è il romanzo in questa dimensione onirica fantastica, è il romanzo della espiazione della colpa. Ecco tutte le disavventure, le perdite, gli incantesimi, cui Ulisse va incontro, non sono altro che i vari gradi di espiazione di questa grande colpa. Fino ad arrivare al rischio estremo, che è l’attraversamento dello Stretto di Scilla e Cariddi.
Io credo che nel mondo d’oggi questa colpa non è più individuale. Noi abbiamo delle colpe collettive, che sono le colpe della Storia, sono le colpe che sono state preconizzate dai grandi scrittori della fine dell’Ottocento, come Kafka, Musil, tutti quelli che volete, tutti i grandi scrittori, fino allo stesso Pirandello, che oggi queste colpe del nostro subconscio si sono materializzate, sono diventate colpe oggettive, colpe della Storia. Io credo che, dopo Auschwitz e dopo Hiroshima, non si possono più scrivere dei romanzi di tipo psicologico, non si può più parlare del nostro subconscio, veramente il romanzo ha a che fare con la Storia. Bisogna affrontare questi mostri, bisogna lottare con questi mostri. Però, quello che è il segno della nostra epoca, non c’è più la chiusura dell’avventura omerica, dell’avventura di Ulisse, il ritorno a Itaca e il ricongiungimento con la propria storia, con il proprio potere, con i propri affetti. Oggi viviamo in una linearità infinita, in cui Itaca non esiste più, ed è irraggiungibile.






 La rovina di Siracusa
La rovina di Siracusa