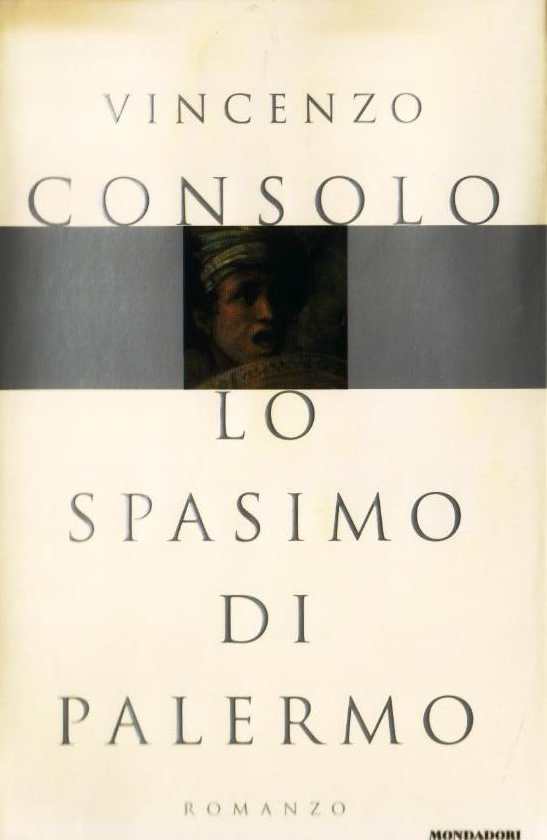Vincenzo Consolo
Più nessuno mi poterà nel sud commentava Quasimodo. Invece – se m’è concesso il confronto – io nel sud ritorno sovente. Da Milano, dove risiedo, con un volo di un’ora e mezza, atterro in Sicilia. Dalla costa d’oriente o d’occidente, ogni volta, come per ossessione, vizio coazione a ripetere, celebrazione d’un rito, percorro l’isola da un capo a un altro, vado per città e paesi, sperduti villaggi, deserte campagne, per monti e per piane. per luoghi visti e rivisti non so quante volte; incontro vecchie persone, ne conosco di nuove; registro ogni volta, in quella mia terra, che esito a chiamare patria come invece con foga la chiama il poeta, il degrado continuo, le perdite irreparabili, la scomparsa d’ogni vestigia ammirevole, l’inarrestabile imbarbarimento, gli atroci misfatti, gli assassini, le stragi, il saccheggio d’ogni memoria, d’ogni reliquia di civiltà e bellezza. Vado in Sicilia e ne fuggo ogni volta, ritorno a Milano, la città dove da sempre, fuggendo dal Sud, si sono rifugiati poeti e scrittori, artisti, credendo trovarvi, via dalla periferia, da una mediterranea deriva, vicino a un centro d’Europa, per illuministici retaggi, per eredità di probo governo, decenza civile, rispetto di leggi e diritti, a Milano, in Lombardia, in un Nord di lavoro e sviluppo dove da sempre sono emigrati, come da ogni Sud d’immobilità, privazione e offesa, masse di lavoratori in cerca di un nuovo destino. Ritorno a Milano e scrivo, riverso nelle parole, nella scrittura, in racconti e diari, cronache d’avventure sempre uguali e sempre nuove negli esiti orrendi, pene e furori, rimpianti e denunzie, malinconie e invettive. Credo sia questo ormai il destino d’ogni ulisside d’oggi, di tornare sovente nell’Itaca del distacco e della memoria e di fuggirne ogni volta, di restare prigioniero nella reggia d’Alcinoo, in quel regno di supposta utopia, d’irreale armonia, condannato a narrare all’infinito, come un cieco cantore, un vecchio svanito, i suoi nostoi, le sue odissee. E questo che sto facendo ancora da alcuni mesi, faccio in questo giorno di scorcio d’aprile: narro del mio ultimo viaggio dell’estate scorsa in Sicilia, scrivo un libro che Porta un titolo, L’olivo e l’olivastro, colto in Omero, nell’episodio in cui Ulisse naufrago della grande tempesta, nudo e martoriato, mette piede a Scheria, sulla terra del Feaci, si rifugia sotto due arbusti nati da un medesimo Cippo: uno d’olivo, l’altro d’olivastro. Mi è sembrata l’immagine, un simbolo della biforcazione, dei due sentieri o destini che s’aprono nella vita d’un uomo, nell’a storia d’un paese; del coltivato e del selvatico, del civile e del barbarico. Mi è sembrato il simbolo più pregnante della Sicilia, la quale diventa sempre, come si dice, metafora dell’Italia (dell’Europa, del mondo?). In questo penultimo giorno d’aprile, dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, aver scansato il rischio mortale di Scilla e Cariddi, aver lasciato sulle falde dell’Etna i mostruosi Ciclopi, dentro la sua caverna di lava il bestiale Polifemo, mi trovo a girare per Siracusa, a muovermi nel cuore d’Ortigia, nelle altre parti di questa antica metropoli, il Tiche, Acradina, Epípoli, Neapoli, nel presente suo squallido e oscuro e il passato suo di potenza e splendore. Muovermi tra la retta e la spirale, il rigore e la grazia, il teorema d’Archimede e la poesia di Pindaro, l’equilibrio dorico e il capriccio barocco, nella piazza a forma d’occhio dove regna Lucia, la signora della luce e della vista. Sta la santa Sibilla dei messaggi visivi nell’antro dove sono ingemmate, in trionfo di mura cristiane, greche colonne di pura geometria, dov’è incastonato il tempio d’Atena, la dea dell’olivo e dell’olio, del nutrimento e della luce, della ragione e della sapienza. Mi trovo, confuso, smarrito, in questo teatro di profonda memoria, di continui richiami, in questa scena odierna di degrado e macerie, deserta di parola, poesia, in questa cavea di urla e fragori, sotto un cielo di spesse caligini, presso un mare di petroli e liquami. In Siracusa è scritta la storia dell’infinito tramonto della civiltà nostra e cultura, dell’umano sentire, è impressa la notte della ragione e della pietà Questo ventinove aprile mi alzo all’alba, come ogni mattina, scrivo dell’ultimo tramonto di Siracusa attraverso il racconto di personaggi che in quella città son passati nel momento più drammatico della loro vita, uomini prossimi alla fine. Racconto del disperato Caravaggio che, fuggito dal carcere a Malta, approda in una Siracusa stremata da terremoti, carestie e pesti, immersa nel buio della Controriforma, dipinge per una chiesa il grande quadro del Seppellimento di Santa Lucia: il cadavere gonfio d’una fanciulla posto a terra, due ignudi becchini in primo piano che scavano la fossa, gli astanti schiacciati alla parete alta d’una latomia, la luce livida d’una catacomba. Racconto del ceroplasta siracusano Zummo che crea teche, teatri di peste, di contagio, di cataste di cadaveri in decomposizione, di avelli di scheletri, di mummie su cui scorrazzano topi, gechi, degli effetti sui corpi della sifilide; crea con le cere colorate perfette anatomie di teste, membra, organi… Racconto di un’arte necrofila, maniacale per cui lo Zummo è onorato alla corte di un Medici a Firenze e a quella del Re Sole a Versailles: la rivoluzione spazzerà via la sua tomba a Saint-Sulpice, spazzerà via gli altari per dare luce, spazio alla dea Ragione. Racconto del poeta von Platen che a Siracusa finisce i suoi giorni, in una misera locanda presso la fonte Aretusa, consumato dalle febbri del colera, dal vomito, dalla dissenteria. E racconto ancora di Guy de Maupassant che a Siracusa, rapito davanti al corpo luminoso della Venere Anadiomene, cova nel sangue il bacillo dell’infezione, della malattia che lo porterà alla demenza, alla morte. Nella scansione del tempo che m’impongo, a mezzogiorno interrompo il lavoro e vado, con desiderio e insieme titubanza, a comprare i giornali. E il momento, quello, della frattura, del ritorno brusco nella prosa offensiva del presente, dell’ingresso nel grigio miserevole teatro di questo regno dei Feaci, di questa Milano in cui sono approdato da più di venticinque anni e da cui non riesco più ad imbarcarmi per l’Isola che un giorno abbandonai. Non riesco a lasciare questa città del disinganno, dell’utopia crollata, della mediocrità più squallida, della nevrosi e dell’aggressività, del deserto d’ogni gioia, d’ogni bellezza, perché non c’è più un’Itaca dove ridurmi e conciliarmi, in cui ricomporre l’armonia perduta, non c’è più espiazione e liberazione dalle colpe dopo il lungo racconto di mostri, di malie e di tempeste; perché i mostri non abitano più nel nostro subconscio, nei nostri sogni, non abitano più in ignote dimore, abissi marini o caverne etnee, non sono dei mondi pre-civili, dei regni dell’olivastro, ma sono della nostra storia, del nostro tempo, sono reali e ovunque presenti, sono quelli che ci hanno predetto Kafka, Baudelaire, Eliot, Joyce, Camus, Pirandello, tutti i poeti-profeti, sono quelli comparsi ieri ad Auschwitz, Hiroshima, Siberia, quelli comparsi oggi a Sarajevo, in Ruanda, in tanti altri luoghi di morte e di massacro; sono quelli che, dopo cinquant’anni, minacciano di ricomparire, ahinoi, in Italia… L’amico giornalaio Bruno mi dà subito le prime notizie con l’espressione del volto, col modo di guardarmi, col far svolazzare, da dentro la nicchia della sua edicola, simile all’antro della Sibilla Cumana, qualche parola che può sembrar casuale, ma che è carica d’allusioni, messaggi. «Ha sentito che cattivo odore, che puzza nell’aria stamane? Sarà scoppiata qualche fogna qui attorno, sarà sfuggito veleno da qualche fabbrica chimica…. Capisco allora, mentre Bruno mi porge i giornali, che le notizie sono pessime, come del resto ogni mattina da molto tempo a questa parte; lo capisco dal malumore, dal brontolare di Bruno che ogni giorno diventa sempre più cupo. E la notizia che era nell’aria, che già si temeva, dopo la stragrande vittoria alle elezioni della destra, del patito del signor Berlusconi, alleato con i revanscisti, i vandeani del signor Bossi , e con vecchi fascisti (neo o post-fascisti loro pretendono d’esser chiamati) e del signor Fini, eccola qua, in prima pagina su tutti i giornali, con titoli a caratteri cubitali: Berlusconi al potere – Berlusconi: vi darò la miglior squadra – Il regime all’opera – Governo, è l’ora di Berlusconi – Silvio Berlusconi s’apprête à accéder au pouvoir… Sì, è fatta, il leader di Forza Italia è stato incaricato dal capo dello Stato di formare il nuovo governo, il cinquantatreesimo dalla fine del fascismo, dall’avvento della democrazia. Illusione, sogno, felicità da spot pubblicitario, mondo d’inganno, di ombre televisive, di degradata, miserabile caverna platonica, regime telecratico, potere d’una squadra di samurai dell’azienda, d’un manipolo di sacerdoti della religione della bottega, di mistici della réclame e del profitto: di questo parlano i giornali. Riportano anche oggi in prima pagina la condanna a otto anni di carcere del finanziere Sergio Cusani, un giovanotto di buona famiglia napoletana, d’un passato a Milano di militanza nel Movimento Studentesco, di marxista rivoluzionario. La sentenza arriva dopo sei mesi di processo trasmesso alla televisione e goduto dai telespettatori come un grande, appassionante spettacolo, in cui sono sfilati i più grandi finanzieri e industriali, i leaders politici, in cui si è mostrato la corruzione, il disfacimento di un potere, il crollo di un sistema simile a quello di Bisanzio prima dell’arrivo dei barbari, quel mondo che ci ha narrato Procopio di Cesarea. La gente che aveva mandato al potere Andreotti e Craxi ha guardato il processo, ha tifato per il giudice di Mani Pulite Di Pietro, si è assolta, e in marzo ha votato per Berlusconi, per Bossi e per Fini. «È disperante. Andiamo via, via da quest’orrenda città, via dall’Italia..» dice mia moglie. «Aspettiamo… Almeno fino a domani» rispondo scherzando. Sappiamo, l’indomani, che il Papa, uscendo dalla doccia, è caduto e s’è rotto il collo del femore. Doveva partire quest’oggi, Giovanni Paolo II, per Siracusa, avrebbe dovuto in quella città consacrare un santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime, a un piccolo bassorilievo di gesso colorato che negli anni Cinquanta, in occasione di una tornata elettorale, si dice abbia pianto nella casa di un operaio comunista. Il santuario, un alto edificio in cemento a forma di cono scanalato, una sorta di rampa per il lancio di missili, è stato costruito di fronte al museo dov’è custodita la Venere Anadiomene, nel giardino dov’è la tomba di von Platen. Tutto ormai in questo Paese è di banalità e orrore, di degrado e oblio, è tramonto infinito, è Siracusa, è fiammella d’olio o di candela che si spegne, è buio di catacomba; tutto è Milano del fascismo, del leghismo e del berlusconismo, è squallore e ignoranza, è ricchezza volgare che corrompe, aggredisce e offende.