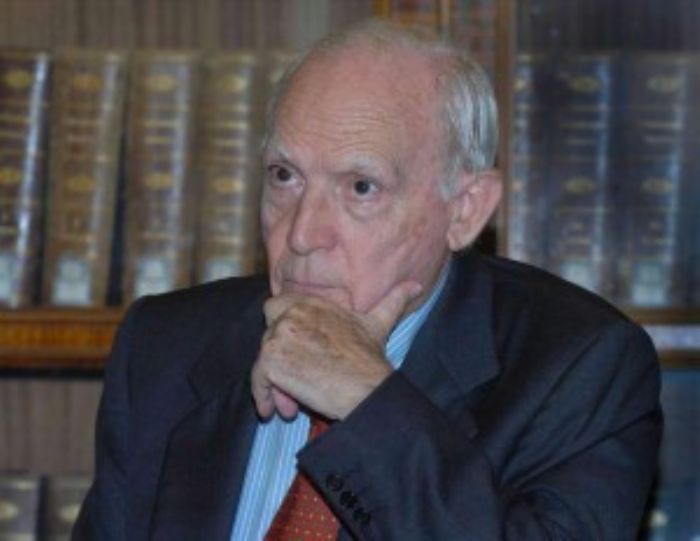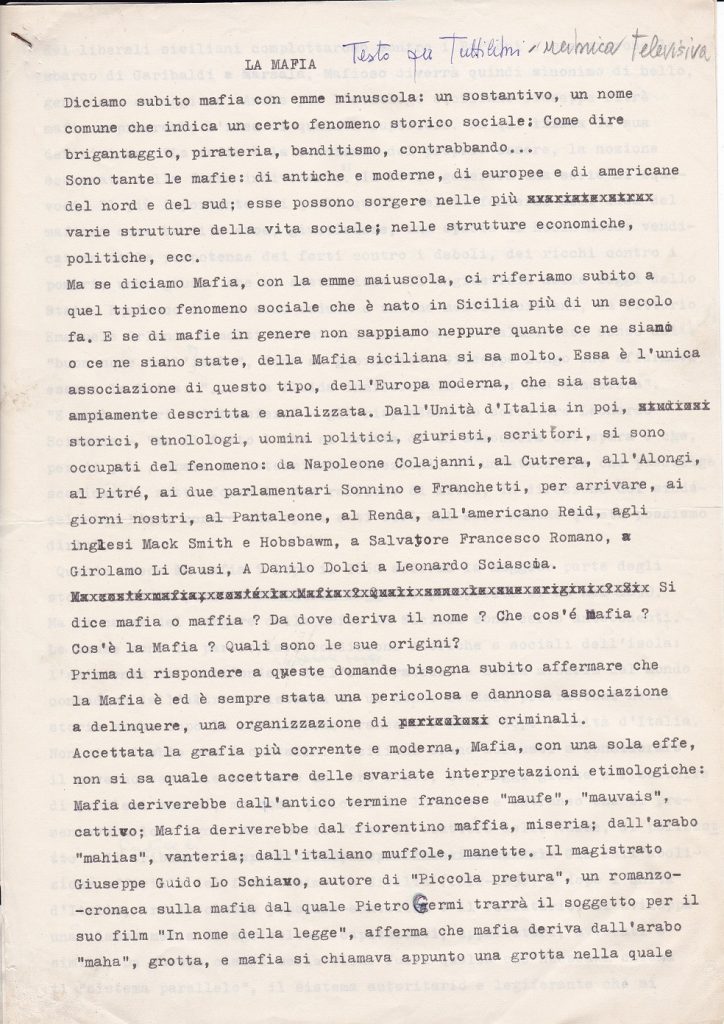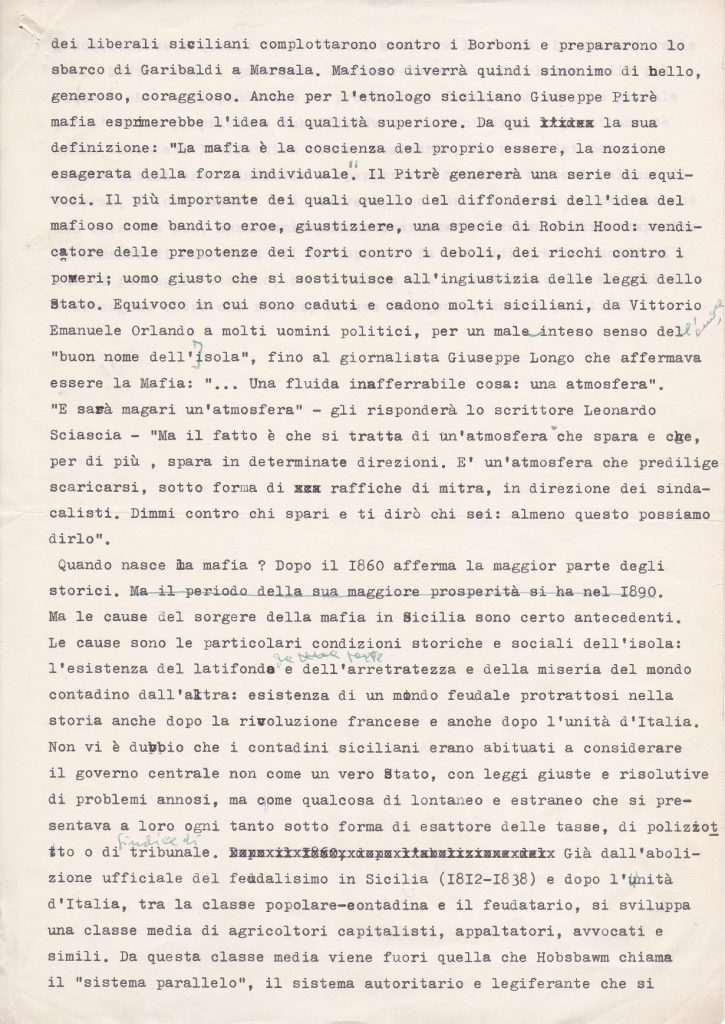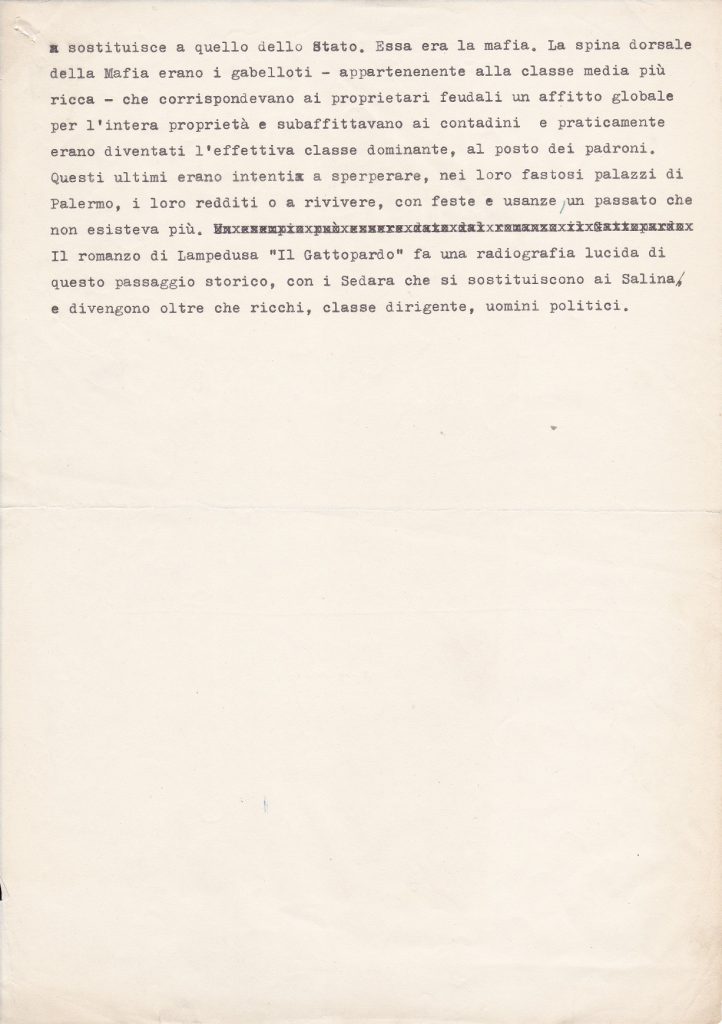La mafia 1
Diciamo subito mafia con emme minuscola: un sostantivo,
un nome comune che indica un certo fenomeno storico‐
sociale: come dire brigantaggio, pirateria, banditismo,
contrabbando… Sono tante le mafie: di antiche e moderne,
di europee e di americane del Nord e del Sud; esse possono
sorgere nelle più varie strutture della vita sociale; nelle
strutture economiche, politiche, ecc.
Ma se diciamo Mafia, con la emme maiuscola, ci riferiamo
subito a quel tipico fenomeno sociale che è nato in
Sicilia più di un secolo fa. E se di mafie in genere non sappiamo
neppure quante ce ne siano o ce ne siano state, della
Mafia siciliana si sa molto. Essa è l’unica associazione di
questo tipo, dell’Europa moderna, che sia stata ampiamente
descritta e analizzata. Dall’unità d’Italia in poi storici,
etnologi, uomini politici, giuristi, scrittori, si sono occupati
del fenomeno: da Napoleone Colajanni al Cutrera,
all’Alongi, al Pitrè, ai due parlamentari Sonnino e Franchetti,
per arrivare, ai giorni nostri, al Pantaleone, al Renda,
all’americano Reid, agli inglesi Smith e Hobsbawm, a
Salvatore Francesco Romano, Girolamo Li Causi, a Danilo
Dolci, a Leonardo Sciascia.
Si dice mafia o maffia? Da dove deriva il nome? Che
cos’è mafia? Cos’è la Mafia? Quali sono le sue origini? Prima
di rispondere a queste domande bisogna subito affermare
che la Mafia è ed è sempre stata una pericolosa e
dannosa associazione a delinquere, una organizzazione di
criminali. Accettata la grafia più corrente moderna, Mafia,
con una sola effe, non si sa quale accettare delle svariate
interpretazioni etimologiche: Mafia deriverebbe dall’antico
termine francese “maufe”, “mauvais”, cattivo; Mafia
deriverebbe dal fiorentino maffia, miseria; dall’arabo “mahias”,
vanteria; dall’italiano “muffole”, manette. Il magistrato
Giuseppe Guido Lo Schiavo, autore di Piccola Pretura,
un romanzo‐cronaca sulla mafia dal quale Pietro Germi
trarrà il soggetto per il suo film In nome della legge, afferma
che mafia deriva dall’arabo “maha”, grotta, e mafia
si chiamava appunto una grotta nella quale dei liberali
siciliani complottavano contro i Borboni e prepararono lo
sbarco di Garibaldi a Marsala. Mafioso diverrà quindi sinonimo
di bello, generoso, coraggioso. Anche per l’etnologo
siciliano Giuseppe Pitrè mafia esprimerebbe l’idea di
qualità superiore. Da qui la sua definizione: «La mafia è la
coscienza del proprio essere, la nozione esagerata della
forza individuale». Il Pitrè genererà una serie di equivoci.
Il più importante dei quali quello del diffondersi dell’idea
del mafioso come bandito eroe, giustiziere, una specie di
Robin Hood: vendicatore delle prepotenze dei forti contro
i deboli, dei ricchi contro i poveri; uomo giusto che si sostituisce
all’ingiustizia delle leggi dello stato. Equivoco in
cui sono caduti e cadono molti siciliani, da Vittorio Emanuele
Orlando a molti uomini politici, per un malinteso
senso dell’onore, del “buon nome dell’Isola”, fino al giornalista
Giuseppe Longa che affermava essere la Mafia: «una
fluida inafferrabile cosa: una atmosfera». «E sarà magari
un’atmosfera – gli risponderà lo scrittore Leonardo Sciascia
– ma il fatto è che si tratta di un’atmosfera che spara e
che, per di più, spara in determinate direzioni. È un’atmosfera
che predilige scaricarsi sotto forma di raffiche di mitra,
in direzione dei sindacalisti. Dimmi contro chi spari e
ti dirò chi sei: almeno questo possiamo dirlo».
Quando nasce la mafia? Dopo il 1860 afferma, la maggior
parte degli storici. Ma le cause del sorgere della Mafia
in Sicilia sono certo antecedenti. Le cause sono le parti9
colari condizioni storiche e sociali dell’isola: l’esistenza del
latifondo da una parte e dell’arretratezza e della miseria
del mondo contadino dall’altra: esistenza di un mondo
feudale protrattosi nella storia anche dopo la Rivoluzione
Francese e anche dopo l’unità d’Italia. Non vi è dubbio che
i contadini siciliani erano abituati a considerare il governo
centrale non come un vero stato, con leggi giuste e risolutive
di problemi annosi, ma come qualcosa di lontano ed
estraneo che si presentava a loro ogni tanto sotto forma di
esattore delle tasse, di poliziotto o di giudice di tribunale.
Già dall’abolizione ufficiale del feudalesimo in Sicilia
(1812‐1838) e dopo l’Unità d’Italia, tra la classe popolarecontadina
e il feudatario si sviluppa una classe media di
agricoltori capitalisti appaltatori, avvocati e simili. Da questa
classe media viene fuori quella che Hobsbawm chiama
il «sistema‐parallelo», il sistema autoritario e legiferante
che si sostituisce a quello dello stato: la mafia. La spina
dorsale della Mafia erano i gabellotti – appartenenti alla
classe media più ricca – che corrispondevano ai proprietari
feudali un affitto globale per l’intera proprietà e subaffittavano
ai contadini e praticamente erano diventati l’effettiva
classe dominante al posto dei padroni. Questi ultimi
erano intenti a sperperare, nei loro fastosi palazzi di
Palermo, i loro redditi o a rivivere, con feste e usanze, un
passato che non esisteva più. Il romanzo di Lampedusa Il
Gattopardo fa una radiografia lucida di questo passaggio
storico, con i Sedara che si sostituiscono ai Salina e divengono
oltre che ricchi, classe dirigente, uomini politici.
Nel 1865, il prefetto Gualtiero, scrivendo una relazione
sulla situazione dell’ordine pubblico in Sicilia affermava
che «l’origine del sempre maggior turbamento esistente
nello spirito pubblico dell’isola e della scarsa autorità morale
che le autorità esercitavano era un grave, prolungato
malinteso tra il Paese e l’autorità». In queste condizioni
era stato dunque facile, secondo il Prefetto, il diffondersi
della «cosidetta mafia», «associazione malandrinesca»,
che, per il Gualtiero ha sempre avuto in Sicilia dirette rela10
zioni con la vita politica. Il carattere particolare della mafia
siciliana era anzi da individuare nella particolare abitudine
e necessità di legame tra malandrinaggio e partiti politici.
Giacché, anche negli anni seguenti, delitti e “malandrinaggio”
non mostrano d’aver fine, i responsabili politici
italiani si renderanno lentamente conto della necessità
di conoscere meglio la situazione dell’isola: mentre, da
privati, due onorevoli toscani, Franchetti e Sonnino, intraprendono,
dopo il ‘70, un’indagine sulla situazione siciliana,
il 29 giugno 1875 il Senato approvava così una legge
che portava come denominazione quella di Inchiesta sulle
condizioni sociali ed economiche della Sicilia e sull’andamento
dei pubblici servizi. La commissione creata a questo scopo
avrà un anno di tempo per condurre un’indagine approfondita
con estesi poteri, sui fenomeni di “malandrinaggio”.
La relazione della commissione verrà pubblicata nel
1876, ma gli atti completi dell’inchiesta, che ha incontrato
numerosi ostacoli e resistenze, verranno praticamente
ignorati fino ad oggi. Gli interrogatori, i verbali delle sedute
verranno così pubblicati solo nel 1969, per iniziativa
dell’Archivio Centrale dello stato. Si tratta di un materiale
che rappresenta molto meglio della reticente relazione finale,
un’interessante e preziosa miniera di notizie, che serve
anche a ricostruire la storia del nostro sud dopo l’unità.
Ecco cosa afferma, per esempio, a proposito dell’andamento
della giustizia nell’Isola, nella sua relazione alla
Commissione d’inchiesta, il procuratore di Girgenti: «…
Se capitano dei poveri disgraziati che non hanno protezioni,
impegni denari, né appartengono alla maffia, si può
star sicuri, non troveranno indulgenza alcuna, e si avranno
verdetti severi e giusti. Ben altro è poi se gli imputati
appartengono a classe agiata; ovvero alla maffia; per qualunque
atroce crimine si può star sicuri d’ottenere verdetti
di incolpabilità: o, se il fatto fosse di tale evidenza di prove
da non potersi, se non con spudoratezza, negare, saranno
sempre ammesse dai giurati tutte quelle circostanze introdotte
dalla difesa, risultino oppure no, dal dibattimento,
che valgano a ridurre ai minimi termini l’imputazione e la
relativa pena».
La precisa e coraggiosa descrizione del procuratore
non ha bisogno di commenti. Man mano che le gerarchie
andavano potenziandosi e che si delimitavano le varie zone
di influenza mafiosa e man mano che il prestigio dell’“
onorata società” andava sempre più sostituendosi, di
fatto, ai poteri legittimi, accadde naturalmente che la mafia
andasse al di là delle sue attribuzioni originarie, e dei
suoi primitivi interessi, per rivolgere la sua attività ad ogni
settore della vita pubblica; ed anche questo può essere
desunto dai verbali dell’inchiesta.
Altrettanto bene se ne ricava, leggendo ad esempio l’interrogatorio
dell’ex deputato avv. Salvatore Carnazza, il
senso di sfiducia verso il nuovo stato che assumerà agli occhi
delle masse l’aspetto di uno stato repressivo. Infatti il
sud si era ribellato ai Borboni per il loro malgoverno. «Il
generale Garibaldi attraversava il Paese accompagnato
dalla rivoluzione. Egli portava in trionfo la bandiera dell’unità.
Ma la bandiera era piantata in un Paese in rivoluzione
», affermava De Pretis nell’ottobre del 1860, all’epoca
del dibattito alla Camera sull’annessione delle Provincie
meridionali. I motivi che avevano spinto i siciliani a fare la
rivoluzione erano ancora quelli che avevano prodotto i
vecchi moti: abbattere le strutture feudali, con tutte le ingiustizie,
le violenze, le corruzioni prodotte da quel sistema.
Come rileverà il De Cordova, deputato moderato al
Parlamento, «quando un Governo riceve un Paese non da
una conquista ma dalle mani della rivoluzione, deve domandarsi
per quali bisogni questa rivoluzione si è fatta, e
pensare a soddisfarli». Niente di tutto ciò, invece, verrà
fatto, e lo si vede già scorrendo le pagine della inchiesta.
Le proteste dei contadini delusi verranno così duramente
represse, sin dagli inizi, anche con la forza dalle truppe
dell’esercito garibaldino con fucilazioni e condanne sommarie;
la più nota repressione è quella eseguita dalla 15a
divisione di Nino Bixio, al quale verrà data la missione,
come scriverà alla moglie, «di dare il terribile esempio alla
popolazione di Bronte e dei paesi vicini». Dalle pagine
dell’opera ricaviamo pure l’incredibile indifferenza e ignoranza
di molti governi nei confronti dei problemi reali della
Sicilia. Quella Sicilia che per il Minghetti era la plaga
più fertile d’Europa, così come per il Cavour era invece in
base agli impressionanti dati raccolti dagli inquirenti la regione
in preda alla più profonda miseria e da questa miseria
la mafia traeva la sua forza.
Secondo molti uomini politici, dopo l’unificazione sotto
un governo finalmente “civile”, i siciliani avrebbero dovuto
rapidamente e automaticamente emanciparsi dalla
loro miseria e godere così delle ricchezze della loro Terra.
Con sorpresa generale le condizioni della Sicilia al contrario
non muteranno affatto: i delitti continueranno, si continuerà
a parlare sempre più frequentemente di mafia. A
un generico ottimismo succederà un altro generico e facile
pessimismo e gli abitanti verranno così definiti da un
membro responsabile del governo come «un esercito di
barbari accampato fra di noi», e D’Azeglio suggerirà di separare
nuovamente il Sud dall’Italia, mentre De Pretis parlerà
di «un paradiso governato da Satana».
Le repressioni di cui si è detto e il trattamento da cittadini
di seconda classe da parte del nuovo governo, che
considerava a questo punto, non ancora pervenute al grado
di “civiltà” del resto d’Italia le masse isolane, e quindi
largheggiava in provvedimenti restrittivi, terranno dunque
viva la sfiducia verso lo stato e daranno maggior fiato
alla mafia, in un drammatico circolo vizioso, perché questi
provvedimenti rinfocolavano l’ostilità della popolazione e
questo, a sua volta, dava motivo per altri provvedimenti
repressivi. Favorita da questo contesto sociale, la mafia assumeva
un aspetto sempre più organizzato e ragguardevole.
Era tutto un mondo dove la dipendenza personale
dal ricco e dal potente era sentita continuamente come una
necessità che assicurava al debole il soddisfacimento di bisogni
elementari: trovar lavoro, essere difeso nelle liti, ecc.
e offriva allo stesso tempo al forte lo strumento di una potenza
capace di passare al di sopra della legge ufficiale, o
in cui questa s’inchinava alla legge clandestina: un distinto
avvocato di Messina fu mandato alla corte di Assise di
Caltanissetta e fu assolto perché «quanto ci poteva essere
di protezioni, di intrighi, di impegni della mafia messinese
tutto si rivolse in Messina nel giorno dell’arresto. In breve
fu assolto e il giorno appresso pretese di essere rimesso in
ufficio, e io aveva fatto il rapporto per la destituzione».
Così afferma alla Commissione Vincenzo Calenda, procuratore
generale della Corte d’Appello di Palermo.
Questo è il quadro necessariamente schematico che
presenta il fenomeno della mafia al momento del suo
maggior sviluppo, che va, press’a poco, dall’unità d’Italia
al 1918 e che i risultati dell’inchiesta del 1875 ci fanno vedere
chiaramente. Concisamente Leonardo Sciascia, siciliano
e autore di saggi e romanzi basati sulla mafia, così definirà
la mafia giunta al suo processo finale di chiarificazione:
«Un’associazione a delinquere, con fini di illecito
arricchimento per i propri associati e che si pone come elemento
di mediazione tra la proprietà e il lavoro: mediazione
si capisce parassitaria e imposta con mezzi violenti».
L’Hobsbawm – analizzando la storia della mafia – vedrà
come essa a poco a poco, da oppositrice al potere politico,
diverrà di esso alleata. Man mano che le masse contadine
prenderanno coscienza e si organizzeranno politicamente,
essa si sposterà sempre più verso la reazione.
Nei moti contadini del 1894 – i fasci siciliani – essi [i mafiosi]
saranno alleati con le forze della repressione. E così,
fino al 1947, alla strage di Portella delle Ginestre, dove la
mafia si servirà della banda Giuliano per sparare su masse
contadine inermi e riunite per festeggiare il primo maggio.
87 anni dopo l’inchiesta di cui ci siamo occupati la mafia,
che nel frattempo ha continuato a evolversi e ha spostato
la sua attività nelle città, dopo aver “congelato” almeno
nelle parti più vistosamente esterne la sua attività
durante il fascismo, essendo divenuta, una volta abolite le
libertà democratiche, una sovrastruttura costosa e nociva
agli interessi della classe agraria, è ancora viva. Essa sarà
oggetto di un’altra inchiesta: con legge 20 dicembre 1962
- 1720, veniva infatti costituita la commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. Il 30
giugno 1963, a Ciaculli, una località vicino a Palermo, una
Giulietta carica di tritolo esplodeva uccidendo alcuni
membri delle forze dell’ordine, tra cui un giovane tenente
dei Carabinieri. Il 6 luglio dello stesso anno la Commissione
parlamentare si mette al lavoro. Il 6 agosto 1966 l’allora
Presidente della commissione, il senatore Donato Pafundi
in un’intervista al Giornale di Sicilia dichiarava che «l’archivio
della commissione poteva paragonarsi a una polveriera
». A tutt’oggi comunque i risultati non sono stati resi
noti, tranne una breve relazione di tre pagine sull’andamento
dei lavori. Di questa inchiesta si occupa il secondo
libro Antimafia: occasione mancata, del noto saggista Michele
Pantaleone, un siciliano di Villalba, un paese tradizionalmente
dominato dalla mafia. Nel volume in questione
Pantaleone si occupa tra l’altro dello scandalo di Agrigento,
della mafia dei mercati generali di Palermo, degli enti
locali, del Banco di Sicilia, riferendosi sempre all’attività
della commissione antimafia. Grazie a queste due opere
dunque il panorama della mafia siciliana si offre al nostro
interesse in un arco ininterrotto di quasi un secolo.
1 Dattiloscritto inedito di nove carte, non datato (1969?).