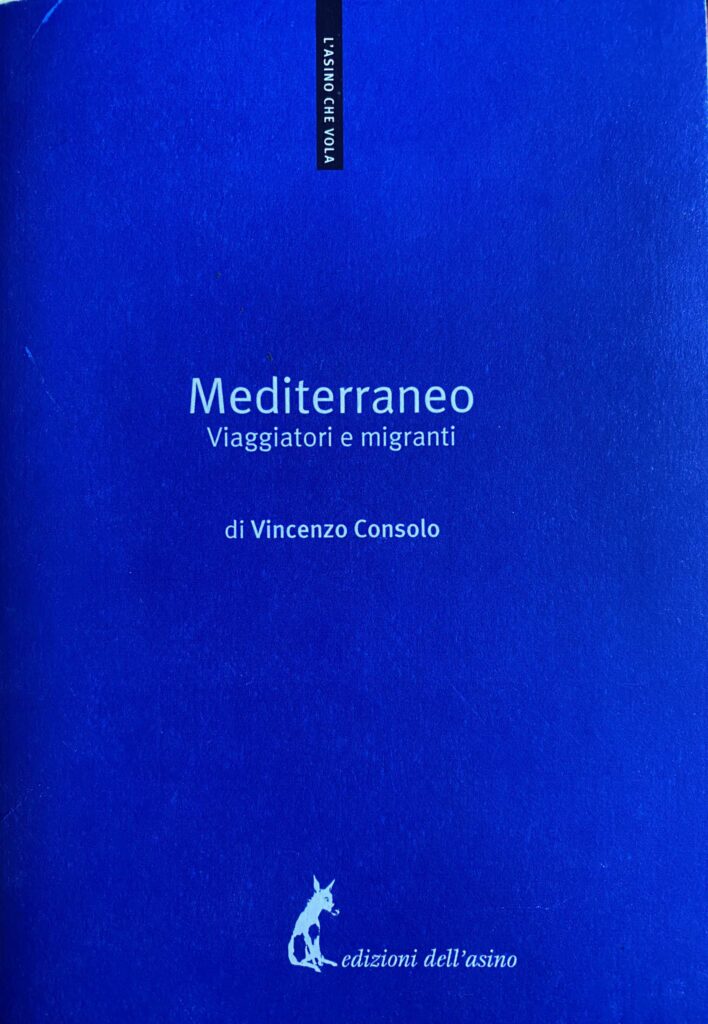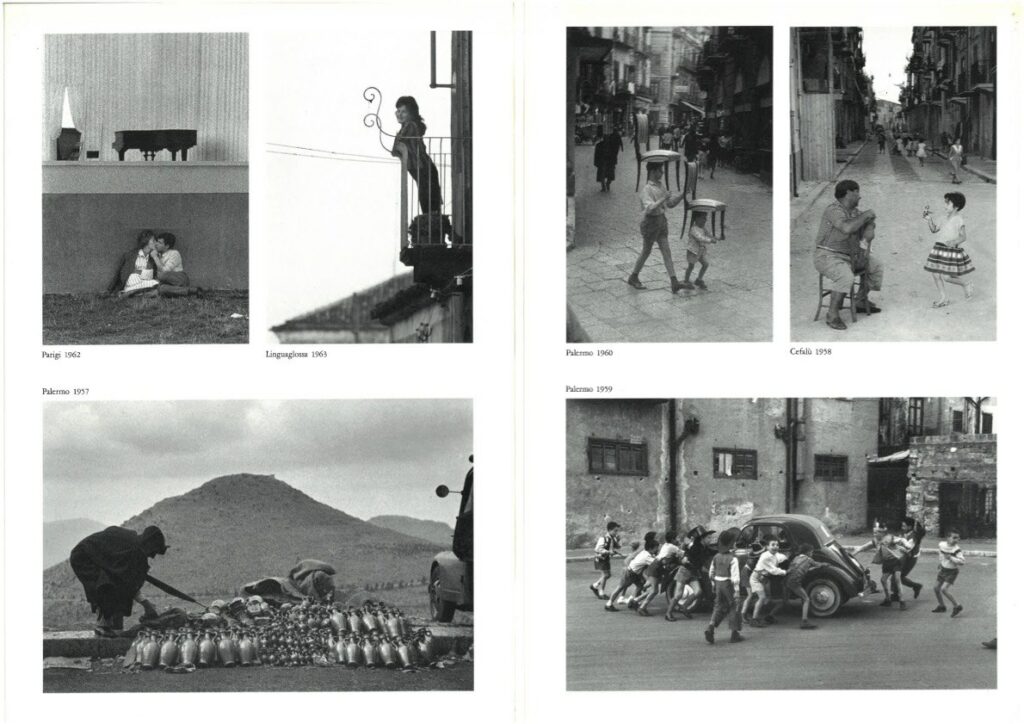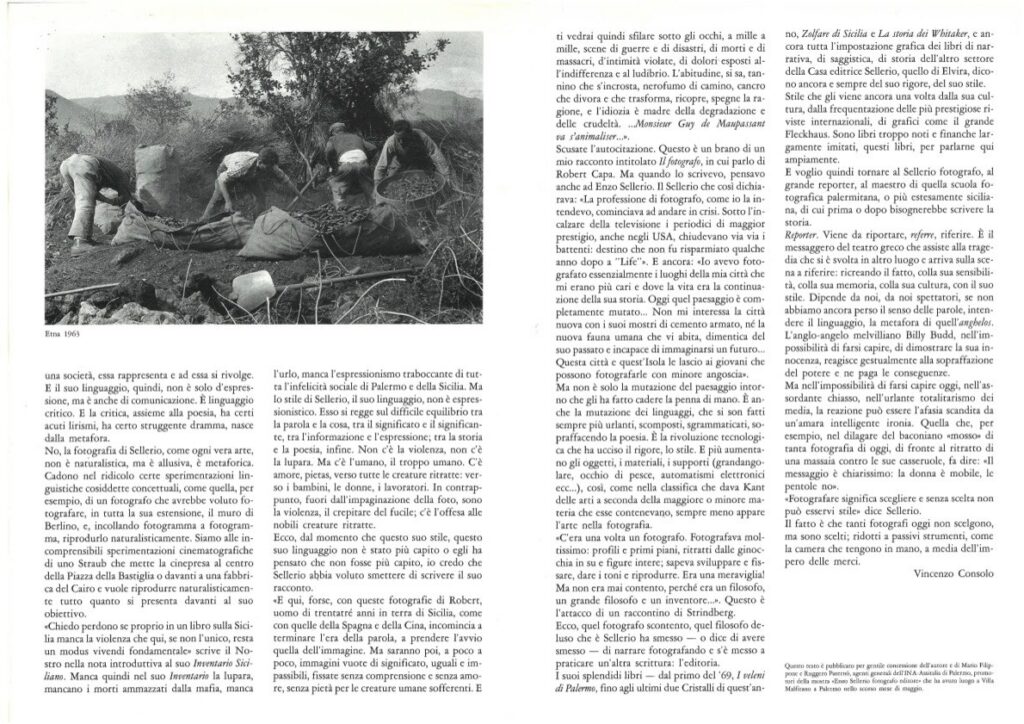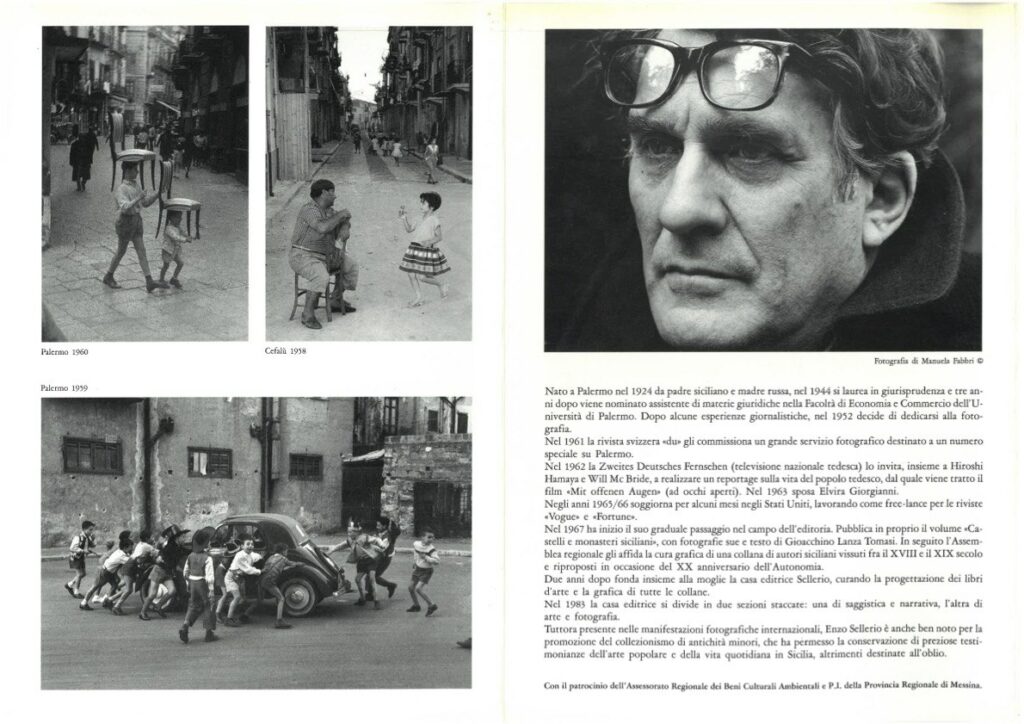Gostanza, di nobile e ricca famiglia di Lipari, ama, riamata, il povero pescatore Martuccio. Per l’impossibile amore, il giovane abbandona l’isola, si fa corsaro per il Mediterraneo. Gostanza, avuta notizia che Martuccio era morto, disperata, sale su una barca per andare alla ventura e lasciarsi morire, ma il vento la sospinge e la fa approdare sulla costa di Barberia, nei pressi di Susa. Sulla spiaggia la fanciulla s’imbatte in una donna che parla latino e che è al servizio di pescatori cristiani. Questo è l’argomento della Novella Seconda della Giornata Quinta del Decamerone di Boccaccio. In cui, al di là della storia d’amore che poi felicemente si concluderà, ci colpisce il fatto che pescatori cristiani, trapanesi, tranquilli soggiornassero e pescassero nelle acque della musulmana Tunisia, di Susa, oggi Sousse. E ci conferma nella consapevolezza che ancora nel medioevo quel canale, quel breve braccio di mare tra la Sicilia e le coste africane, libiche tunisine algerine, non fosse ancora frontiera, barriera fra due mondi, ma una via di comunicazione e di scambio, che quelle acque anzi venissero allora percorse solo in un senso, dai lavoratori di Sicilia, di Calabria, di Sardegna, che volendo sfuggire alla fame cercavano fortuna in quelle ricche terre degli “infedeli”. Provetti “tonnaroti”, lavoratori delle tonnare, pescatori di alici e di sarde, di spugne e di coralli, da Trapani, da Pantelleria, da Lampedusa, s’avventuravano sulle loro esili barche per quel canale, e insieme contadini, pastori, murifabbri, minatori da ogni parte del nostro Meridione.
S’ interruppe questa comunicazione, questa provvidenziale emigrazione, con la dominazione turca sulle coste africane e quella spagnola in Sicilia, con l’insorgere delle guerre corsare. Carlo V si spinse fino in Tunisia per combattere e umiliare il nemico. La battaglia di Lepanto significò lo scontro più alto e simbolico fra le due fedi, i due imperi, quello cristiano e quello ottomano. Vittoria di Lepanto che però non riuscì a domare, a scemare le incursioni barbaresche nelle nostre contrade. E corsari si fecero anche ammiragli e principi cristiani, incursioni praticarono sulle coste africane, razziando uomini e cose, riducendo in schiavitù. Ai mercati di schiavi di Algeri o di Tunisi corrispondevano quelli cristiani di Livorno o di Genova. Scrive Braudel in Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari'”.
Prigionia in Algeri patirà Miguel de Cervantes, che già aveva pagato il suo tributo alla guerra nella battaglia di Lepanto con l’amputazione di una mano. Lascerà memoria di quella sua triste esperienza nel Don Chisciotte e in altre sue opere.
Si hanno notizie ancora dettagliate, precise, di quel mondo di allora sulle coste africane nel secentesco libro del frate Diego de Haedo Topographia e Historia Generai de Argel. Dal quale si apprende, fra l’altro, che una nuova, massiccia emigrazione avveniva allora di italiani nel mondo ottomano. Erano, costoro, emigranti della fede, cristiani vale a dire rinnegati, che si facevano musulmani, “turcos deprofesión”, che divenivano capi corsari, razziatori nelle loro stesse terre d’origine, mercanti di schiavi.
Finisce questa pagina tremenda, questa lunga guerra corsara fra le due sponde del Mediterraneo, nel 1830, con la conquista di Algeri da parte dei francesi. Ma si apre anche in quella data, nel Maghreb, la piaga del colonialismo.
Riprende l’emigrazione italiana nel Maghreb nei primi anni dell’Ottocento. È un’emigrazione questa volta intellettuale e borghese, di fuoriusciti politici, di professionisti di imprenditori. Liberali, giacobini e carbonari, si rifugiano in Algeria e in Tunisia. Scrive Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli: “Erano quelli regni barbari i soli in questa età civile che dessero cortese rifugio ai fuoriusciti”.
E ancora negli anni ’30, ’40 e fino all’Unità, reduci da congiure, moti rivoluzionari repressi, qui si rifugiano. Dopo i falliti moti di Genova, in Tunisia approda una prima volta, nel 1836, Garibaldi, sotto il falso nome di Giuseppe Pane. Nel 49 ancora si fa esule a Tunisi.
A Tunisi s’era stabilita da tempo una nutrita colonia di imprenditori, commercianti, banchieri ebrei provenienti dalla Toscana, da Livorno soprattutto, primo loro rifugio dopo la cacciata del 1492 dalla Spagna. Conviveva, la nostra comunità, insieme alla ricca borghesia europea, un misto di venti nazioni, che s’era stanziata a Tunisi. Accanto alla borghesia, v’era poi tutto un proletariato italiano di lavoratori stagionali, pescatori di Palermo, di Tra-pani, di Lampedusa che soggiornavano per buona parte dell’anno sulle coste maghrebine. Ma la grossa ondata migratoria di bracciantato italiano in Tunisia avvenne sul finire dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, con la crisi economica che colpì le nostre regioni meridionali.
Si stabilirono questi emigranti sfuggiti alla miseria nei porti della Goletta, di Biserta, di Susa, di Monastir, di Mahdia, nelle campagne di Kelibia e di Capo Bon, nelle regioni minerarie di Sfax e di Gafsa. Nel 1880 nel Consolato italiano erano registrate 12.000 presenze italiane, ma molti sfuggivano alla registrazione, e fra questi, naturalmente, gli irregolari, renitenti alla leva o colpevoli di reati.
Nel 1911, le statistiche davano una presenza italiana di 90.000 unità. Alla Goletta, a Tunisi, in varie altre città dell’interno, v’erano popolosi quartieri che erano chiamati “Piccola Sicilia” o “Piccola Calabria”. Si aprono scuole, istituti religiosi, orfanotrofi, ospedali italiani. La preponderante presenza italiana in Tunisia, sia a livello popolare che imprenditoriale (i collegamenti marittimi nel Canale di Sicilia erano di compagnie italiane, italiana, dei Rubattino, era la compagnia che costruiva la ferrovia Tunisi-Algeria), fece sì che la Francia si attivasse con la sua sperimentata diplomazia e con la sua solida imprenditoria, per togliere all’Italia questa supremazia. Tutto questo portò al Trattato del Bardo del 1881 e qualche anno dopo alla Convenzione della Marsa, che stabilirono il protettorato francese sulla Tunisia.
“L’Italia non è abbastanza ricca per pagarsi il lusso di un’Algeria” aveva dichiarato il ministro degli Esteri Visconti Ventosa dell’allora governo di Benedetto Cairoli. La Francia, con il protettorato, iniziò la sua politica di espansione economica e culturale in Tunisia, aprendo scuole gratuite, diffondendo la lingua francese, concedendo, su richiesta, agli stranieri residenti la cittadinanza francese. Anche sotto il protettorato, l’immigrazione di lavoratori italiani in Tunisia continuò sempre più massiccia. Ci furono vari episodi di naufragi, di perdite di vite umane nell’attraversamento del Canale su mezzi di fortuna. La reggenza francese, di fronte a quel continuo affluire di diseredati, ricorse ai rimpatri. Nei primi cinque anni del Novecento ben 13.000 furono rimpatriati. Quelli già inseriti, al di là o al di sopra di ogni nazionalismo, erano organizzati in sindacati, società operaie, società di mutuo soccorso, patronati degli emigranti. Nel 1914 giunge a Tunisi Andrea Costa, in quel momento vicepresidente della Camera. Visita le regioni dove vivevano le comunità italiane. Così dice ai rappresentanti dei lavoratori: “Ho percorso la Tunisia da un capo all’altro; sono stato fra i minatori del Sud e fra gli sterratori delle strade nascenti, e ne ho ricavato il convincimento che i nostri governanti si disonorano nella propria viltà, abbandonandovi pecorinamente alla vostra sorte”.
I riflessi che la guerra di Libia, la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale e il dopoguerra poi hanno avuto sulla comunità italiana di Tunisia è storia molto complessa per poterla qui riassumere. Rimandiamo perciò al libro di Nullo Pasotti, Italiani e Italia in Tunisia, libro dal quale abbiamo attinto per stendere questa memoria.
La fine degli anni ’60 segna la data fatidica dell’inversione di rotta della corrente migratoria nel Canale di Sicilia, dell’inizio di una storia parallela, speculare a quella nostra. A partire dal 1968 sono tunisini, algerini, marocchini che approdano sulle nostre coste. Approdano soprattutto in Sicilia, a Trapani, si stanziano a Mazara del Vallo, il porto dove erano approdati i loro antenati musulmani per la conquista della Sicilia.
A Mazara, una comunità di 5.000 tunisini riempie quei vuoti, nella pesca, nell’edilizia, nell’agricoltura, che l’emigrazione interna italiana aveva lasciato. Questa prima emigrazione maghrebina nel nostro paese coincide con lo scoppio di quella che fu chiamata la quarta guerra punica, la ” guerra” del pesce, il contrasto vale a dire fra gli armatori siciliani e le autorità libiche e tunisine. In questi con-fitti, quelli che ne pagavano le conseguenze erano gli immigrati arabi, i quali, oltre ad essere sfruttati, venivano di tempo in tempo perseguitati. Odiosi episodi sono avvenuti, in quella parte meridionale della Sicilia, di “caccia al tunisino”.
“. Su questa prima emarginazione maghrebina in Sicilia, un giovane sociologo di Mazara, Antonio Cusumano, ha scritto un libro documentato, preciso, Il ritorno infelice, pubblicato nel 1976 da Sellerio.
Sono passati trent’anni dall’inizio di questo fenomeno migratorio. Da allora, nessuna previsione, nessuna progettazione, nessun accordo fra governi, fino a giungere all’emigrazione massiccia, inarrestabile di disperati che fuggono dalla fame e dalle guerre, emigrazione che si è cercato di arginare con improvvisati metodi duri, drastici, violando anche quelli che sono i diritti fondamentali dell’uomo.
Di fronte a episodi di contenzione di questi disperati in gabbie infuocate, di ribellioni, fughe, scontri con le forze dell’ordine, scioperi della fame e gesti di autolesionismo, si rimane esterrefatti. Ci tornano allora in mente le parole che Braudel riferiva a un’epoca passata: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato…”.
Mediterraneo
Viaggiatori e Migranti