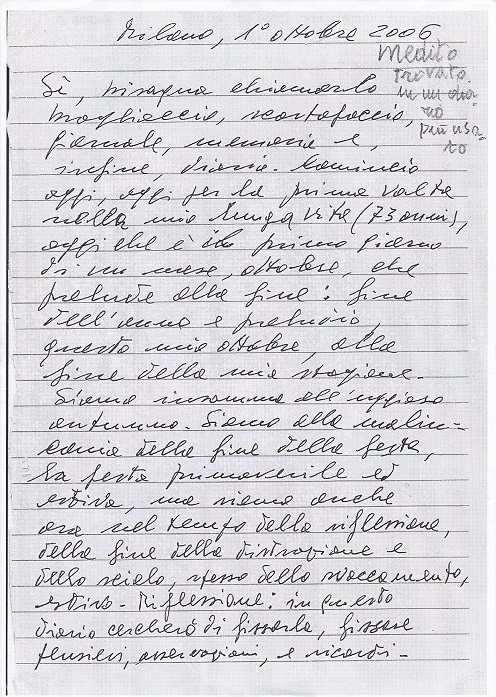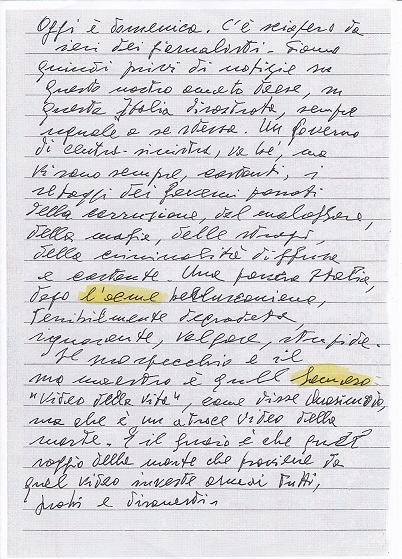Giulio Ferroni Università La Sapienza
La lingua di Vincenzo Consolo sembra come scavare la realtà,
sfidandone la sostanza fisica, l’evidenza visiva, la materia pullulante
che la costituisce: e il capitolo iniziale de Il sorriso dell’ignoto
marinaio, subito dopo la sintesi dell’ Antefatto si muove subito
in due direzioni essenziali, verso l’apertura “geografica” e storica
su di vastissimo ambiente fisico e umano, con la visione della
Sicilia che il Mandralisca ha dalla nave che si avvicina, e verso la
presa in carico del dolore umano, con il «rantolo» del malato, il
cavatore di pomice di Lipari, che sorge dal buio della stessa nave.
È un vero e proprio “quadro”, in cui l’eco di quel lacerante dolore
sembra come sovrapporsi allo svelarsi e al progressivo definirsi
del paesaggio, che quella lingua a forte caratura “poetica” sembra
come voler catturare nella densità delle presenze che lo abitano:
con un’espressività che si addensa intorno alle cose, che mira a
rivelare il loro pulsare, il loro sofferto palpitare, la loro espansione
nella luce o nel buio, ma che non si risolve mai in liricità
pura, producendo movimento, procedendo anche verso atti e gesti
fulminanti (che spesso giungono improvvisamente a rilevarsi
e fissarsi nei finali dei capitoli, nelle clausole quasi lapidarie che
li serrano).
Il primo circostanziato segno visivo, dopo la più indefinita
rivelazione della «grande isola», è costituito dai «fani sulle torri
della costa», con i loro colori e l’incerto oscillare della loro luce
(«erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci
»). Dopo questa prima apertura l’attenzione ritorna all’interno
del bastimento, sembra come ritrarsi nel buio, nel fragore delle
acque e nel cigolio delle vele squassate dal vento che avevano segnato
il percorso notturno della nave e nel presente silenzio del
«mare placato e come torpido», lacerato dal «respiro penoso» e dal
«lieve lamento» del malato. Questo respiro suscita l’immagine del
corpo sofferente, dei «polmoni rigidi, contratti», delle contrazioni
della «canna del collo», della «bocca che s’indovinava spalancata»:
s’indovinava, appunto, perché questa visione di dolore è solo
intuita, non vista; quello che il Mandralisca vede è solo «un luccichio
bianco che forse poteva essere di occhi». Ma proprio a partire
da questo bianco che sinistramente viene a fendere il buio,
la visione viene ad allargarsi verso il cielo ed ancora verso i fani
sopra le torri, che ora definiscono più nettamente il loro aspetto
ed evocano i nomi dei feudatari:
“Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte,
i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i
lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangersi di
tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella,
del Lauro e Gioiosa, del Brolo…”.
La serie dei nomi fa sì che dall’ultimo appaia improvvisamente
uno squarcio di un passato, con l’immagine di una dama affacciata
sul «verone», ma in posa molto realistica, lontana da ogni stilizzazione
cortese: è Bianca de’ Lancia di Brolo, che ha in grembo
Manfredi, figlio di Federico II e che ha la nausea e i contorcimenti
della gravidanza («Al castello de’ Lancia, sul verone, madonna
Bianca sta nauseata. Sospira e sputa, guata l’orizzonte»): è Federico
II, evocato in termini danteschi (il «vento di Soave», da Paradiso,
III) ad aver segnato le sue viscere, è il suo seme ad agire
nervosamente sul suo corpo («il vento di Soave la contorce»); e da
tutto si svolge la parola stessa dell’imperatore, con la citazione di
versi che si immaginano rivolti direttamente al falcone, strumento
essenziale della sua passione per la caccia. Ma ancora, dopo la
citazione, lo sguardo si apre sulla costa, verso le città sepolte, che
non ci sono più ma che sono vagheggiate dall’avidità conoscitiva,
dal gusto storico ed archeologico del barone:
“Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano
Abacena e Agatirno, Alunzio e Apollonia, Alesa… Città nelle
quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni,
fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una
moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente
vaghi, suoni, sogni”.
Ma questo pensiero alle città sepolte, all’improbabile ipotesi di
un loro ritorno alla luce, riconduce poi il Mandralisca alla certezza
della tavoletta «avvolta nella tela cerata» che stringe al petto e
in cui sente persistere gli odori della bottega dello speziale che
gliel’ha venduta. Ma poi questi odori sono sopraffatti da quelli
che ormai provengono da terra, come il buio è sopraffatto ormai
dalla luce («svanirono le stelle, i fani sulle torri impallidirono»):
e ciò porta finalmente alla visione del malato e della donna che
lo assiste e lo soccorre. Da questa visione scaturisce poi la voce
che designa il male dello sventurato; e solo dopo la voce si rivela
la figura dell’ignoto marinaio, col suo «strano sorriso sulle
labbra. Un sorriso ironico, pungente e nello stesso tempo amaro,
di uno che molto sa e molto ha visto, sa del presente e intuisce
del futuro; di uno che si difende dal dolore della conoscenza e
da un moto continuo di pietà». Il sorriso dell’ignoto marinaio è
insomma affidato soprattutto allo sguardo (di uno che molto sa
e molto ha visto); la descrizione si appunta sui suoi occhi («E gli
occhi aveva piccoli e puntuti, sotto l’arco nero delle sopracciglia»);
e anche se è vestito come un marinaio, a guardarlo si evidenzia
tutta la sua stranezza («in guardandolo, colui mostravasi uno strano
marinaio») e la forza penetrante della sua «vivace attenzione».
E dopo aver parlato dei cavatori di pomice di Lipari e delle loro
malattie, l’ignoto sorride, mentre il barone si chiede dove mai
l’aveva già visto e, sotto il suo sguardo, vede balenare dentro
di sé le immagini dei cavatori di pomice, del loro duro lavoro e
della loro sofferenza, sotto cui si nascondono ed emergono altre
immagini, quelle per lui consuete dei molluschi che studia e
colleziona e dei volumi degli studi ad essi dedicati, il tutto come
sottoposto ancora allo sguardo criticamente ironico del marinaio.
Si tratta di una formidabile serie di passaggi visivi, segnati da
questo sguardo che tocca il personaggio sconosciuto e che da lui
si svolge: passaggi che toccano le immagini che sorgono dentro
la coscienza stessa del barone e che, pur se solo interne a lui,
egli sente come scrutate e indagate dal marinaio, che gli sembra
addirittura leggere i titoli di quei libri, ironizzando sulla futilità di
quelle così minute ricerche:
Il marinaio lesse, e sorrise, con ironica commiserazione.
Quel sorriso sembra come suscitare il senso di colpa del ricco
intellettuale e amateur, per le sue così marginali predilezioni,
confrontate con la dura realtà dei cavatori di pomice. Ma a questo
punto si sentono i clamori e i rumori dell’ancoraggio, dell’arrivo
ad Olivèri, che fa sorgere un nuovo, vastissimo sguardo all’affollato
paesaggio che pullula sulla riva; sguardo che si svolge a partire
dalla luce che dal sole sorgente riceve la rocca in alto, per scendere
giù fino agli splendori mattutini della spiaggia, alle presenze
animali, alle barche immobili come relitti; distesa visione da cui
balenano ancora le immagini di un passato sepolto, del crollo
dell’antica città, dei «tesori dispersi» vagheggiati dal barone. E poi
ancora uno sguardo indietro, ad una scena del passato, ancora
ad una donna del medioevo, Adelasia (o Adelaide) di Monferrato,
la moglie giovanissima del sessantenne Ruggero I e fondatrice
di un convento a Patti, nei pressi di Tindari, la cui figura, fissata
nell’«alabastro» di un sarcofago, sembra aver atteso impassibile
la rovina del convento, e infine l’immagine del santuario della
madonna nera: «sopra la rocca, sull’orlo del precipizio, il piccolo
santuario custodiva la nigra Bizantina, la Vergine formosa chiusa
nel perfetto triangolo del manto splendente di granati, di perle,
d’acquemarine, l’impassibile Regina, la muta Sibilla, líbico èbano,
dall’unico gesto della mano che stringe il gambo dello scettro,
l’argento di tre gigli». Dopo la discussione col «criato» Sasà, la
spinta visiva si rivolge allo sciamare dei pellegrini che si affollano
per scendere dalla nave, alle offerte e agli ex-voto che essi portano
con sé: e tra di essi viene come centrata ancora la figura del
cavatore malato e della moglie che lo accompagna. Al barcone
che raccoglie i pellegrini che scendono dalla nave fa poi come
da pendant la «speronara» che porta via marmi antichi e piante
di agrumi e si allontana dalla riva, passando sotto il veliero da
dove la osserva il Mandralisca («ebbe modo così di osservare
a suo piacimento»); e infine, dopo la riflessione (appoggiata su
una citazione in corsivo da un testo del Landolina) si ritorna alla
visione dei pellegrini, che stanno salendo in processione verso il
santuario; dal loro canto si svolge improvvisamente quello osceno
di una ragazza che è nel barcone, tra i pellegrini scesi dal
veliero, fermata dalla madre che nella concitazione lascia cadere
in acqua una testa di cera.
La successione e i passaggi continui di dati visivi, intrecciati a
più riprese a dati sonori, vengono a creare, in questo avvio del
romanzo, una sorta di disteso movimento panoramico, in continui
passaggi tra campi lunghi e primi piani, formidabili zoomate
che procedono attraverso distensioni e concentrazioni della parola.
Lo sguardo di Consolo, quello del barone Mandralisca, quello
dell’ignoto marinaio (che, sappiamo è lo stesso della tavoletta di
Antonello e di Giovanni Interdonato), sono come animati da una
tensione a “vedere” che tocca le grandi distese dello spazio, la
vita che variamente si muove in esse, e mette a fuoco non solo
ciò che vi è direttamente visibile, ma anche il peso di quanto
esse hanno alle spalle, ciò che sono state, nel passato storico e
biologico: la visione coglie l’esistere che si distende, il suo carico
di presenze, di memorie, di suggestioni, l’agitazione che lo
sommuove, l’offerta che esso sembra fare di sé, l’ostinazione e la
volontà di vita che lo corrode, il suo stesso disperdersi e consumarsi
nell’aria.
Se si attraversa tutto il romanzo, emerge in piena evidenza
l’intreccio e l’essenzialità dei dati visivi, fissata del resto già nello
stesso riferimento del titolo alla tavola di Antonello. In questa
dominante della visività, è determinante la disposizione ad allargarne
i confini: il volto e il sorriso dell’individuo effigiato dal pittore
sono il punto di irradiazione di una apertura verso i grandi
spazi, verso una moltiplicazione delle presenze e delle evidenze.
Consolo “vede” la Sicilia come un grande corpo brulicante di
vita, esuberante, malsano, appassionato, lacerato, ne vuol rendere
conto come di una totalità; cerca di comprenderne il senso
afferrandone un’evidenza visiva che in ogni squarcio sembra
voler rivelare la densità, la fascinazione e la tremenda rovinosa
disgregazione del tutto, di un insieme di corpi che vi annaspano,
vi soffrono, vi si espandono, vi si mostrano.
La disposizione di Consolo a seguire l’evidenza degli slarghi
che si presentano all’occhio agisce del resto in modo vigoroso anche
nella sua scrittura saggistica, nei suoi larghi percorsi sul territorio
siciliano (in primis ne Le pietre di Pantalica). Qui nel Sorriso
un altro eccezionale squarcio d’insieme è quello su Cefalù, a cui
l’Interdonato si avvicina entrando in porto con il San Cristoforo,
all’inizio del capitolo secondo. Si comincia con la visione dell’affollarsi
di barche nel porto, salendo poi verso le case più vicine:
“Il San Cristoforo entrava dentro il porto mentre che ne uscivano
le barche, caicchi e, coi pescatori ai remi alle corde vele reti lampe
sego stoppa feccia, trafficanti, con voci e urla e con richiami,
dentro la barca, tra barca e barca, tra barca e la banchina, affollata
di vecchi, di donne e di bambini, urlanti parimenti e agitati;
altra folla alle case saracene sopra il porto: finestrelle balconi
altane terrazzini tetti muriccioli bastioni archi, acuti e tondi, fori
che s’aprivano impensati, a caso, con tende panni robe tovaglie
moccichini sventolanti”.
Poi l’obiettivo si muove rapidamente al polo opposto, concentrandosi
sulla rocca lassù in alto e scendendo poi più lentamente
sulle torri del duomo, che addirittura sembrano generate dalla
rocca stessa:
“Sopra il subbuglio basso, il brulicame chiassoso dello sbarcatoio
e delle case, per contrasto, la calma maestosa della rocca,
pietra viva, rosa, con la polveriera, il tempio di Diana, le cisterne
e col castello in cima. E sopra la bassa fila delle case, contro
il fondale della rocca, si stagliavano le due torri possenti del
gran duomo, con cuspidi a piramidi, bifore e monofore, soffuse
anch’esse d’una luce rosa sì da parere dalla rocca generate,
create per distacco di tremuoto o lavorio sapiente e millenario
di buriane, venti, acque dolci di cielo e acque salse corrosive di
marosi”.
Si torna poi all’agitazione furiosa del porto per la pesca abbondante,
alla gara delle barche per piazzarsi «sul filo giusto dei sessanta
passi», allo sbattere delle imposte e ai bagliori del sole che
si distende poi su di un ampio spazio geografico, slargando verso
le località della costa, con un gioco di immagini (il palpitare «a
scaglie» della luce sulla costa) che riconduce dentro il duomo, ai
dorati mosaici del Pantocratore:
“Tanta agitazione era per le pesche abbondanti di quei giorni.
Si diceva di cantàri e cantàri di sarde sàuri sgombri anciove,
passata portentosa di pesce azzurro per quel mare che manco i
vecchi a memoria loro rammentavano.
E venne su la febbre, gara tra flotta e flotta, ciurma e ciurma,
corsa a chi arrivava primo a piazzarsi sul filo giusto dei sessanta
passi. E gara tra famiglie, guerra. Smesso lo sventolio dei
pannizzi, il vociare, si chiusero le imposte con dispetto. I vetri
saettarono bagliori pel sole in faccia, orizzontale, calante verso
la punta là, Santa Lucia, e verso Imera Solunto l’Aspra il Pellegrino”.
Quando più tardi l’Interdonato scende dalla nave, si para in
modo più diretto davanti a lui e al ragazzo che l’accompagna il
pulsare della «gran vita» della città, delle diverse figure umane,
con il loro muoversi affaccendato, su cui echeggiano i segni sonori
del lavoro di chi non si vede, che è intento all’opera nel buio
degli interni:
“Discesi che furono sullo sbarcatoio, passata la Porta a Mare,
imboccarono la strada detta Fiume. Giovanni era eccitato e divertito
per la gran vita che c’era in questa strada: carusi a frotte
correndo sbucavano da strada della Corte, da Porto Salvo, da
Vetrani, da vanelle, bagli e piani, su da fondaci interrati, giù da
scale che s’aprivano nei muri e finivano nel nulla, in alto, verso
il cielo; vecchi avanti agli usci intenti a riparare rizzelle e nasse;
donne arroganti, ceste enormi strapiene di robe gocciolanti in
equilibrio sopra la testa e le mani puntate contro i fianchi, che
tornavano dal fiume sotterraneo, il Cefalino, alla foce sotto le
case Pirajno e Martino, con vasche e basole per uso già da secoli
a bagno e lavatoio. Sui discorsi, le voci, le grida e le risate, dominavano
i colpi cadenzati sopra i cuoi dei martelli degli scarpari,
innumeri e invisibili dentro i catoi.
Il mercatante, come dal San Cristoforo allo spettacolo dello sbarcatoio,
guardava dappertutto estasiato e sorrideva”.
E una Cefalù distesa e panoramica ritorna ancora, più avanti,
nello studio del barone visitato dall’Interdonato, nella copia della
pianta della città del secentesco Passa fiume, «ingrandita e colorata,
eseguita su commissione del barone dal pittore Bevilacqua»:
“La citta era vista come dall’alto, dall’occhio di un uccello che
vi plani, murata tutt’attorno verso il mare con quattro bastioni
alle sue porte sormontati da bandiere sventolanti. Le piccole
case, uguali e fitte come pecore dentro lo stazzo formato dal
semicerchio delle mura verso il mare e dalla rocca dietro che
chiudeva, erano tagliate a blocchi ben squadrati dalla strada
Regale in trasversale e dalle strade verticali che dalle falde scendevano
sul mare. Dominavano il gregge delle case come grandi
pastori guardiani il Duomo e il Vescovado, l’Osterio Magno, la
Badia di Santa Caterina e il Convento dei Domenicani. Nel porto
fatto rizzo per il vento, si dondolavano galee feluche brigantini.
Sul cielo si spiegava a onde, come orifiamma o controfiocco,
un cartiglione, con sopra scritto CEPHALEDUM SICILIAE URBS
PLACENTISSIMA. E sopra il cartiglio lo stemma ovale, in cornice
a volute, tagliato per metà, in cui di sopra si vede re Ruggero
che offre al Salvatore la fabbrica del Duomo e nella mezzania di
sotto tre cefali lunghi disposti a stella che addentano al contempo
una pagnotta”.
La visione dello stemma con i tre cefali dà poi luogo ad un
vero e proprio corto circuito con una visione precedente, quella
di una «guastella» gettata in mare dal ragazzo che accompagna
l’Interdonato e rapidamente divorata da un branco di cefali; e da
qui sorge una riflessione “politica” su Cefalù, la Sicilia, la speranza
del superamento della feroce lotta per la vita e di un trionfo
dell’eguaglianza, della solidarietà, della ragione:
“L’Interdonato, alla vista dello stemma, si ricordò della guastella
buttata dentro l’acqua da Giovanni e subito morsicata dai cefali
del porto. La sua mente venne attraversata da lampi di pensieri,
figure, fantasie. Stemma di Cefalù e anche di Trinacria per via
delle tre code divergenti, ma stemma universale di questo globo
che si chiama Terra, simbolo di storia dalla nascita dell’uomo
fino a questi giorni: lotta per la pagnotta, guerra bestiale dove
il forte prevale e il debole soccombe… (Qu’est-ce-que la propriété?)
… Ma già è la vigilia del Grande Mutamento: tutti i cefali
si disporranno sullo stesso piano e la pagnotta la divideranno
in parti uguali, senza ammazzamenti, senza sopraffazioni animalesche.
E cefalo come Cefalù vuol dire testa; e testa significa
ragione, mente, uomo… Vuoi vedere che da questa terra?…”.
In un romanzo successivo come Nottetempo casa per casa si
aprono altri squarci eccezionali su Cefalù e dintorni, che sembrano
seguire un movimento che attraversa lo spazio casa per casa
e ne coglie l’effetto globale, la configurazione rivelatrice: affidandosi
in primo luogo alla forza evocativa dei nomi, alla precisione
dell’onomastica geografica e topografica, che viene come ad addensare
in sé la vita vibrante del mondo, le esistenze molteplici,
esuberanti e disperate, trionfanti e rapprese, le luci e le ombre
che lo abitano. Nello stesso romanzo il capitolo IV, La torre, apre
anche uno squarcio su Palermo, seguendo il percorso compiutovi
dal protagonista Petro, venuto a partecipare ad una manifestazione
socialista: ai nomi che fissano i dati urbanistici, architettonici,
storici, si mescolano i dati “moderni” delle insegne pubbliche e
della pubblicità e poi quelli delle scritte dei cartelli di un corteo
(mentre dal palco del comizio, su Piazza Politeama, si svolge un
nuovo slargo verso il paesaggio marino, riconosciuto nei suoi più
definiti dati geografici).
Lì, come nel Sorriso, e nelle stesse pagine che abbiamo citato,
i nomi costituiscono un strumento più determinante della resa
espressiva: nomi propri e nomi comuni, sostantivi rari e preziosi,
di forte sostanza letteraria o di rude carica realistica, nomi che
emergono da un passato ancestrale o nomi legati al più dimesso
fare quotidiano, nomi radicati nel fondo dell’esperienza popolare,
nelle pratiche artigiane o contadine o portati dall’invasione della
modernità, dalle sue spinte liberatrici o dai suoi miti più distruttivi
e perversi. L’elencazione seriale, che costituisce il dato stilistico
più diffuso e ben riconoscibile della scrittura di Consolo, agisce
soprattutto nell’ambito dei nomi, collegandosi talvolta a scatti
improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il
linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo
ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità
delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco
della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone
l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo
appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a
farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso
di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro.
Chiuso nella torre (il vecchio mulino avuto in lascito da don
Michele) a meditare sul dolore della propria famiglia (oltre la malattia
del padre, la disperata follia della sorella Lucia), il Petro di
Nottetempo si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di
tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce
come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da
cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un
rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata
dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere
dato dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà
senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del
tempo:
“E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete.
Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo.
Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna.
Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza.
Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno…» scandì come a
voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento
in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si
svolgeva serena, sereno il tempo” (IV, La torre).
Si noti qui come nell’elencazione, che la punteggiatura fissa
in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi,
riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione
che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del
volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno.
Nel Sorriso, peraltro, nel capitolo sesto, rivolgendosi
all’Interdonato nel presentare la sua Memoria sui fatti d’Alcàra Li
Fusi, il Mandralisca rifletteva sulla lingua e sull’«impostura» della
scrittura e proiettava verso il futuro l’utopia di «parole nuove»,
vere anche per gli esclusi dal linguaggio colto, per coloro che
non hanno avuto ancora la possibilità di comprendere le parole
della moderna democrazia:
“E dunque noi diciamo Rivoluzione, diciamo Libertà, Egualità,
Democrazia, riempiamo d’esse parole fogli, gazzette, libri, lapidi,
pandette, costituzioni, noi, che quei valori abbiamo già conquisi
e posseduti, se pure li abbiam veduti anche distrutti o minacciati
dal Tiranno o dall’Imperatore, dall’Austria o dal Borbone. E gli
altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la
terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioia e l’istruzione,
questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle
parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno
quei valori, ed essi allora li chiameranno con parole
nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i
nomi saranno interamente riempiti dalle cose”.
Ma sappiamo (e ce lo mostrerà il Petro di Nottetempo) che forse
la piena solidarietà tra i nomi e le cose si dà solo nella fantasia
del ritorno alla loro origine, nell’utopia della letteratura, di quella
scrittura che certo tradisce la vita col suo dolore e con la sua
evidenza, ma che sola cerca di dirla e di “vederla”, più a fondo
possibile.
Irene Romera Pintor (coord.)
Editores: Generalidad Valenciana = Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport : Universidad de Valencia = Universitat de València
Año de publicación: 2007
Recoge los contenidos presentados a:Vincenzo Consolo: punto de unión entre Sicilia y España. Los treinta años de “Il sorriso dell’ignoto marinaio” (1. 2006. Valencia).