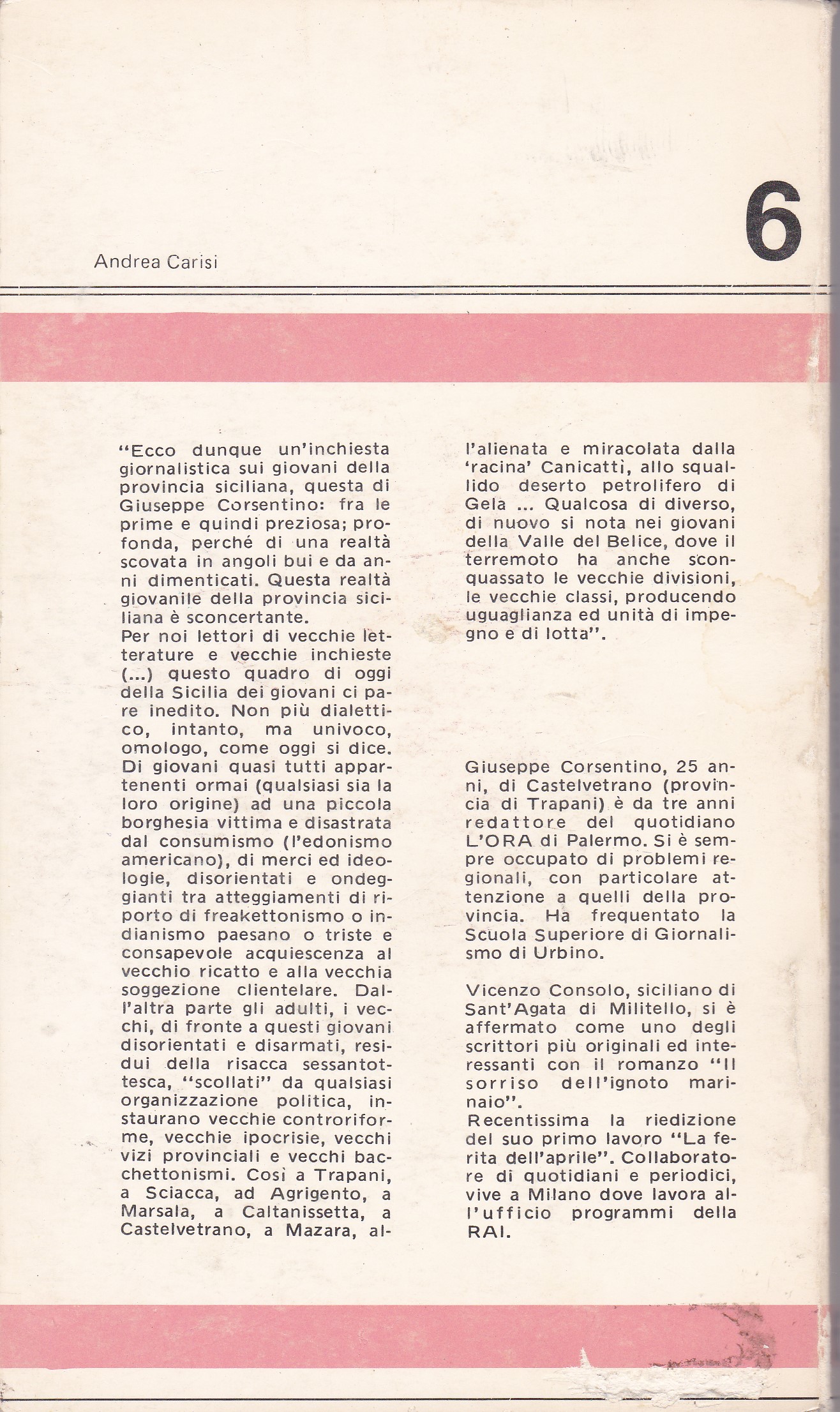“Per la nostra Sicilia invoco una vera solidarietà regionale, una concordia sacra, una pace feconda e operosa. Giustizia per la Sicilia! Tregua di Dio per la Sicilia!” declamava alla prima seduta dell’Assemblea regionale il presidente (per anzianità) Francesco Paolo Lo Presti. A Palermo, nel pomeriggio di domenica 25 maggio 1947. Nel- la sala detta d’Ercole per gli affreschi alle pareti d’un Velasquez che raccontano le fatiche del semidio enfio di coraggio e di muscoli di quel palazzo che era stato sede di emiri, di re e viceré, i novanta deputati erano disposti secondo gli schieramenti politici: a sinistra i comunisti e i socialisti del Blocco del popolo, i saragattiani e i repubblicani, al centro democristiani e separatisti; a destra monarchici, liberali e qualunquisti. Tra di essi, i protagonisti della infuocata battaglia politica che aveva preceduto le elezioni del 20 aprile: Li Causi, Colajanni, Finocchiaro Aprile, Alessi, Aldisio, Alliata… E in prima fila, al centro, tra le autorità, quel cardinale Ernesto Ruffini che implorerà “di cuore sul nuovo Parlamento siciliano l’abbondanza delle celesti benedizioni». (Una travolgente abbondanza di voti, di potere e di vantaggi s’abbatterà di lì a poco solo su quel gruppo democristiano che col cardinal Ruffini intreccerà unita d’ intenti e di voleri), Cosa voleva dire quella implorata “concordia sacra” “tregua di Dio” del presidente Lo Presti? Era che sala d’ Ercole, tra gli scranni, un profondo fossato era aperto, tra la sinistra e il resto degli schieramenti, un fossato entro cui scorreva la paura del centro e della destra per i seicentomila voti ottenuti dal Blocco del popolo. Paura che alcuni avevano cercato di fugare armando la mano d’un bandito, Giuliano, contro gli inermi lavoratori festeggianti il I° maggio a Portella delle Ginestre. «N’ammazzarono tanti in uno spiazzo (c’erano madri e cerano bambini), come pecore chiuse nel recinto, sprangata la portella. Girarono come pazzi in cerca di riparo ma li buttò riversi sulle pietre una rosa maligna/nel petto e nella tempia: negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lava, di deserto. La pezza s’inzuppò e rosso sopra rosso è un’illusione, ancora un’illusione. Disse una vecchia, ferma, i piedi larghi piantati sul terreno: – Femmine, che sono ‘sti lamenti e queste grida con la schiuma in bocca? Non è la fine: sparagnate il fiato e la vestina per quella manica di morti che verranno appresso!” Ora il sangue delle undici vittime e dei feriti di Portella rigava quel fossato, ancora a demarcare, ancora a dividere le due Sicilie di sempre: quella proletaria dei contadini e dei braccianti e l’altra dei principi, dei sedara, dei gabelloti, dei campieri, dei mandanti e dei sicari. Sono, questi ultimi, i siciliani che si sentono eredi della storia illustre dell’Isola, che ne difendono l’antica civiltà e l’onore, sono questi che si riconosceranno nei “perfetti dei? del Gattopardo: d’un olimpo disumano, violento e sopraffattore, mafioso e “democristiano”. E mettiamo democristiano tra virgolette volendo dire che, messa da parte la componente popolare e sociale di quel partito, prevalendo l’altra, quella borghese delle clientele e delle cosche, niente ci sembra più siciliano del partito democristiano (come niente è stato in origine più padano, più lombardo del fascismo agrario e cattolico), di pratica politica cioè intesa in senso familiare e tribale, in senso mafioso e clientelare. Trent’anni sono passati da quel 25 maggio del ’47. Cosa è successo da allora lo sappiamo. Quella Sicilia di là dal fossato, la Sicilia che, dopo ottant’anni di unità sabauda, per non parlare di prima, dopo i vent’anni di fascismo con gli ultimi quattro anni di guerra, accesasi per l’ultima volta nella speranza di una nuova storia, di fare essa la nuova storia dell’Isola, è costretta a emigrare, a spargersi per l’Italia e l’Europa. E non erano, questi siciliani dell’emigrazione, solo contadini e braccianti, erano anche intellettuali. Restava nell’Isola, sequestrata dal potere, stretta nella morsa della promessa del favore e del ricatto, quella classe intermedia che riempiva uffici, riceveva assistenza, sovvenzioni, emolumenti. E in quei contadini e in quegli intellettuali emigrati, oltre la rabbia, era sempre dentro la speranza che nell’Isola prima o dopo qualcosa potesse cambiare, che prima o dopo fosse possibile il ritorno. Anche uno scrittore come Vittorini, che sempre respinse l’idea-sentimento di una patria-Sicilia, creandosi una dimensione ideologico-poetica di Sicilia-Lombardia, anche il Vittorini delle “‘tensioni” europee, nutrì per un momento la speranza di un cambia- mento. Si era intorno al ’50, e lo scrittore degli astratti furori di Conversazione, del notturno viaggio nel dolore e nella rassegnazione, tornato in Sicilia, assiste al grande movimento per la scoperta del petrolio: erano gli anni di Gela e di Mattei. Rapportò, o innestò, questa speranza dell’Isola a quella del Nord per l’industria “umana” e olivettiana, la speranza della nascita di una nuova società. Scrisse allora Le città del mondo, libro diurno e di grande movimento, di personaggi in lingua dalle rassegnazione dalle stasi di camionisti per le strade, di contadini a cavallo convergenti in una valle per una grande assemblea) Hai, quando la poesia si fa illusione e utopia, quando la storia taglia il filo che l’aggancia alla realtà. Nel maggio di quest’anno si è celebrato il trentennale dell’Autonomia siciliana. In quella sala d’Ercole del palazzo dei Normanni, accanto a Pancrazio De Pasquale, il primo, dopo trent’anni, presidente comunista del ‘Assemblea, cerano Andreotti, Ingrao e Murmura (quest’ultimo in rappresentanza di Fanfani). Ha parlato De Pasquale, ha risposto Andreotti, e da una parte c’era la richiesta di attuazione completa dello statuto e dall’altra la promessa, data la convinzione che è proprio dal rilancio della autonomia locale che può e deve scaturire a livello civile, culturale, umano il primo elemento di ricomposizione della società? e data la speranza che “dal Meridione e dalla Sicilia potrebbe emergere oggi, invertendo l’itinerario del secolo scorso, la riaggregazione a più alto livello dell’attuale società nazionale tanto turbata”. Il clima di ricorrenza e di celebrazione, chiaro, permette di eludere le analisi, i processi e le imputazioni, ché allora ci sarebbe stato davvero da sghignazzare, se non da gridare, alle parole di un presidente del Consiglio di quel partito della maggioranza che da trent’anni detiene il potere nel Paese, responsabile quindi delle condizioni di oggi della Sicilia, del Meridione, che appunta le speranze nelle autonomie locali di una ricomposizione- a livello, civile, culturale, umano della nostra società disgregata, di un nuovo risorgimento nazionale che parta dal Sud. E solo quest’ironia allora ci permettiamo menti avvertiti come siamo in fatto di risorgi i chi è che lascia oggi Pisacane per Cavour e i Savoia? Chi baratta la rivoluzione per il risorgimento, chi sono oggi questi nuovi Garibaldi del Sud? Intanto, quel fossato apertosi tra i banchi di sala d’Ercole, quello rigato di sangue, di cui si parlava all’inizio di questo scritto, è stato riempito. Il I° maggio di quest’anno s’è anche commemorata per la prima volta all’Assemblea regionale la strage di Portella delle Ginestre. Un’altra commemorazione a Piana degli Albanesi, sul luogo della strage, l’hanno fatta i sindacati unitari. Ma domenica 5 giugno a Palermo, mentre Pajetta commemorava da una parte Girolamo Li Causi, il grande capitano delle lotte del ’47, dall’altra parte il Centro Siciliano di documentazione svolgeva un convegno di studi sul tema: 1947- 1977. Portella delle Ginestre: una strage per il centrismo”: una controcelebrazione del trentennale? E in questo nostro paese di telegrammi ufficiali, di lacrime di coccodrillo, di corone di fiori di commemorazioni, di controcelebrazioni ce n’è gran bisogno: bisogno di analisi, di processi e di imputazioni. Cosa sappiamo, intanto, della Sicilia, del Meridione, dopo questi trenta anni di malgoverno, cosa sappiamo delle condizioni in cui sono state lasciate queste terre “di rapina”? Abbiamo avuto notizie solo di altre stragi, di sindacalisti ammazzati, di sciagure naturali che scoperchiavano altre e millenarie sciagure storiche, di mafia, di rapine, di corruzioni, di speculazioni, di intrighi e di compromissioni della classe dirigente: vasta è la letteratura a riguardo, e spesso romanzata fino al folklore, fino all’amenità, fino a perdere forza di verità, forza di denunzia. Ma dei siciliani che nell’Isola sono rimasti, dei loro mutamenti sociali e politici in questi anni poco sappiamo. La letteratura, a riguardo, crediamo che sia inesistente Ci sovviene soltanto qualche meritoria inchiesta giornalistica, come quella per esempio di Mario Farinella raccolta in volume sotto il titolo di “Profonda Sicilia”, una ricognizione per l’Isola sul finire degli anni ’60. E dei giovani meridionali, dei giovani siciliani di questa fine degli anni settanta, cosa sappiamo? Di questi, di cui non si può dire ormai che siano una generazione, ma una classe (una situazione esistenziale che è immediatamente storica Ed è allora, per questo che loro, i ragazzi, hanno sentito il bisogno di rivendiate, tra le altre cose, il principio che il personale è politico?): per l’emarginazione. il cui li abbiamo spinti, noi, i loro padri, per il deserto di valori in cui li costringiamo a vivere; por le varie crisi che gli abbiamo apparecchiato; per la distruzione di speranze, per le lande senza orizzonti in cui li abbiamo relegati, spogli di cultura e identità. Fino a poco tempo fa, dire giovani, dire siciliani, calabresi o lucani, appariva subito una definizione astratta se non qualunquistica, priva com’era di una distinzione di classe. Dire oggi giovani o giovani siciliani non è più sospettabile. Anzi. In questi, nei giovani siciliani, o giovani calabresi o giovani pugliesi, c’è già una doppia connotazione storica: in quanto giovani e in quanto meridionali. Di una storia che non è più uguale a quella delle generazioni precedenti. Tra queste ultime (del subito dopo- guerra, degli anni cinquanta o sessanta, del sessantotto o del dopo sessantotto) e le generazioni di questa fine degli anni settanta, sembra che dei terremoti siano avvenuti, a scavare abissi, voragini, a creare profondi mutamenti. A decifrare i quali non servono più i metri conosciuti e praticati sin qui. Quali nuovi metri allora si usano? Le sofisticate e asettiche analisi di laboratorio su campionature o cavie che gli scienziati, antropologi e sociologi, praticano con quel distacco e quella iattante autorevolezza che a noi – col rischio di apparire corrivi o vecchi umanisti superati – tanno nascere il dubbio di verità o deduzioni sospette perchè nate da quella scientificità “‘pura che è già ‘”socialdemocratica”; quando non risultano, queste analisi nel chiuso del laboratorio, immediatamente superate dallo svolgersi e radicalmente rivolgersi della realtà esterna. E allora preferiamo la vecchia, esposta. non-scientifica, non-rigorosa, ma “calda” e reale inchiesta giornalistica. E preferiamo anche la pratica di una realtà umana come quella giovanile (e spero che i lettori di questo scritto non siano portati a facili e offensive alla loro stessa intelligenza – battute cosiddette di spirito) di un poeta come Pasolini che lo portava a dolorose constatazioni, a inquietanti profezie. Ecco dunque un’inchiesta giornalistica sui giovani della provincia siciliana, questa di Giuseppe Corsentino: fra le prime e quindi preziosa; profonda, perchè di una realtà scovata in angolo bui e da anni dimenticati. Questa realtà giovanile della provincia siciliana è sconcertante. Per noi, lettori di vecchie letterature e vecchie inchieste sulla Sicilia, dove le classi separate davano un quadro dialetti- co e storicistico (gli zolfatari e i padroni di miniere, i contadini occupanti le terre incolte e i baroni e campieri, le speculazioni edilizie e le stragi a scoppi di tritolo e colpi di lupara, i cortili di Palermo e gli sprechi messi in luce da Dolci, le parole che erano pietre delle madri dei sindacalisti uccisi dalla mafia riportate da Levi, la fame dei bambini e i bottoni nella loro minestra, i salinari e il potere che si ricostituiva nel dopoguerra come ce li ha fatti vedere lo Sciascia de “Le parrocchie di Regalpetra”…), questo quadro di oggi della Sicilia dei giovani ci appare inedito (come inedito deve essere il quadro della realtà giovanile del resto delle regioni meridionali) non più dialettico, intanto, ma univoco, omologo, come oggi si dice. Di giovani quasi tutti appartenenti ormai (qualsiasi sia la loro origine) a una piccola borghesia vittima e disastrata dal consumismo (l’edonismo americano), di merci e di ideologie, disorientati e ondeggianti tra atteggiamenti di riporto di freakettonismo o indianismo paesano o triste e consapevole acquiescenza al vecchio ricatto e alla vecchia soggezione clientelare. Dall’altra parte, gli adulti, i vecchi, di fronte a questi giovani disorientati e disarmati, residui della risacca sessantottesca, “‘scollati” da qualsiasi organizzazione politica, instaurano vecchie controriforme, vecchie ipocrisie, vecchi vizii provinciali e bacchettonismi. Così è a Trapani a Sciacca, ad Agrigento, a Mazara, a Caltanissetta, a Castelvetrano, alienata e miracolata racina Canicattì, allo squallido deserto periferico di Gela… Qualcosa di diverso, di muovo, si nota noi giovani della Valle del Belice, dove il terremoto ha anche sconquassato le vecchie divisioni, le vecchie classi producendo, a prezzo di tanto dolore, uguaglianza e unità di impegno e di lotta. Siamo partiti da lontano: dalla Sicilia del 47. Questa è la Sicilia di oggi. Ma è anche il Meridione di oggi. Di questo Meridione che si è voluto cacciare dalle campagne e dai paesi, lo si è portato nelle fabbriche del Nord in nome della dea industria, che lo si è eletto a terra di conquista per i consumi, che si è spogliato di cultura e di identità. Oggi che quella divinità industriale dai piedi di argilla è crollata, c’è il marasma e lo smarrimento, nei giovani, soprattutto, i più fragili e vulnerabili. Per essi, la unica novità è la recente legge per l’avviamento al lavoro, e quale? In essi, intanto, c’ è il desiderio di un ritorno alla campagna: ci sono le rioccupazioni delle terre come negli anni ’50, si formano le comuni agricole, le cooperative. E questo significa che c’è nei giovani, oltre a una volontà di una vita diversa, anche il bisogno della ricerca di una cultura più “umana” di una identità più vera e più solida. Il governo, le forze economiche nazionali e non, terranno conto di questo loro bisogno?
VINCENZO CONSOLO Milano, 26 agosto 1977