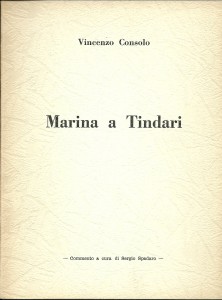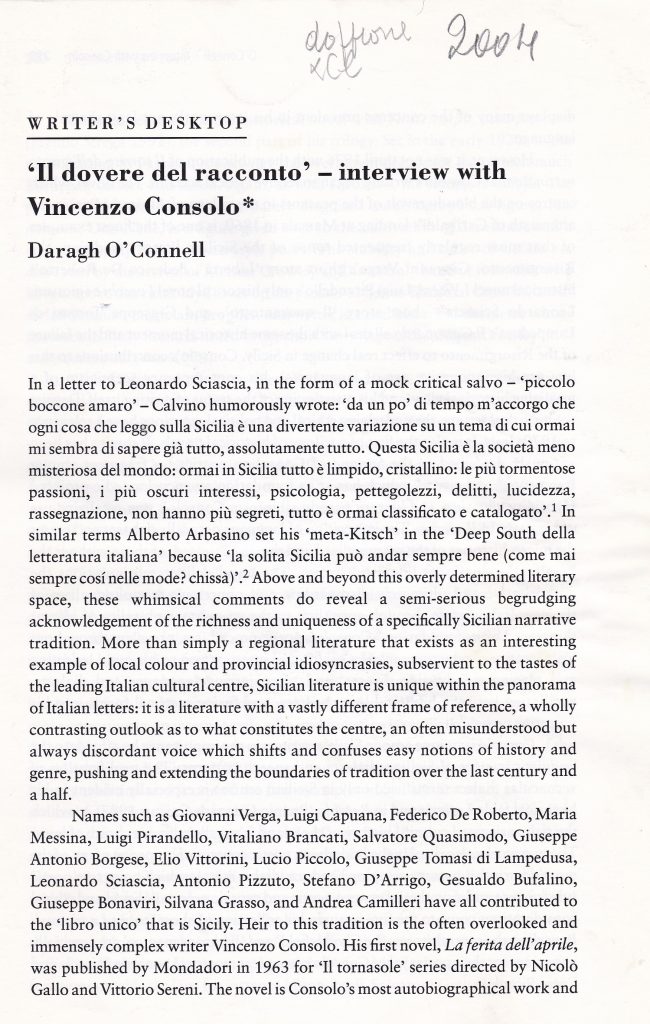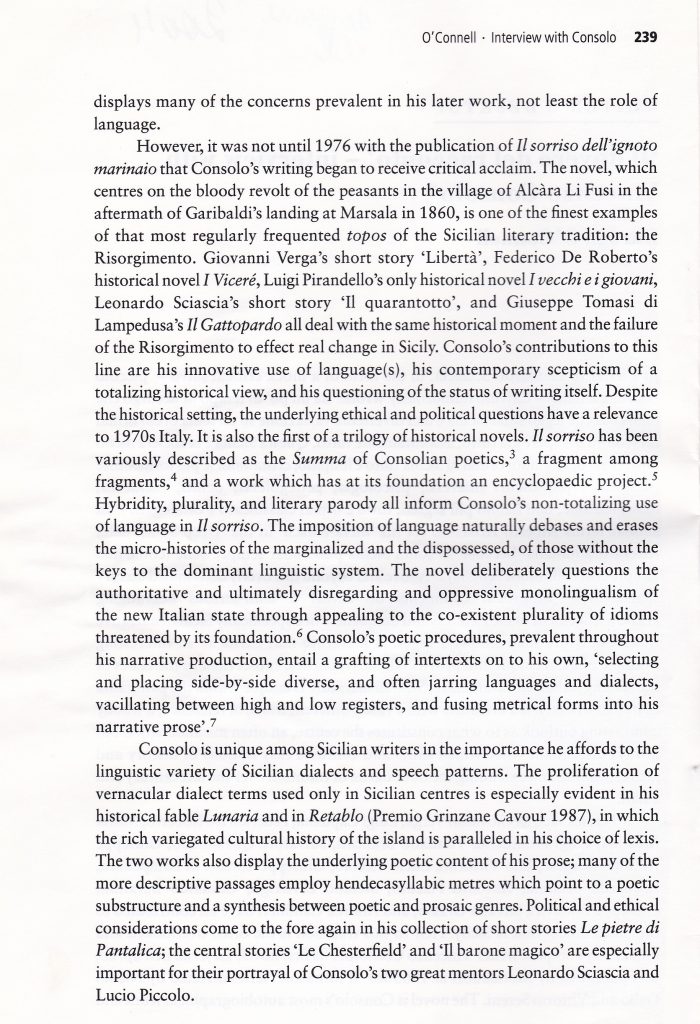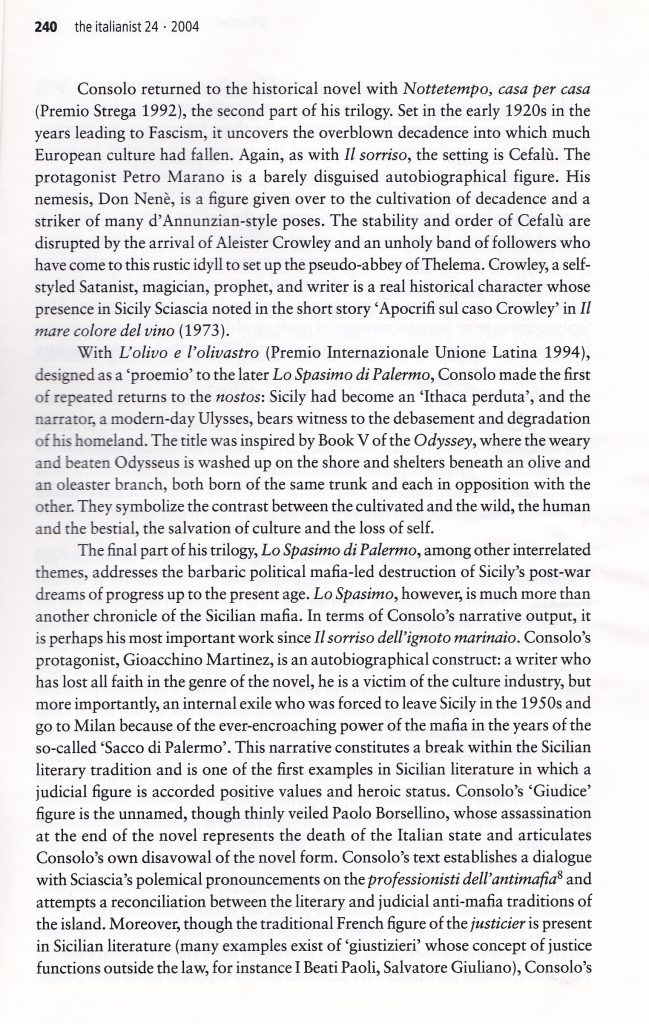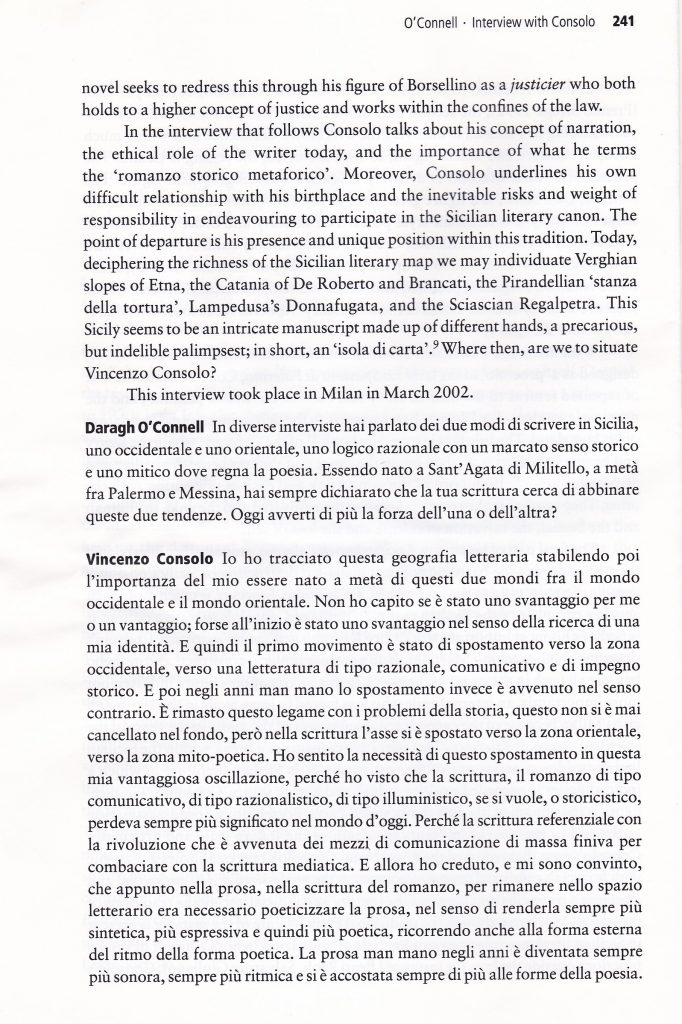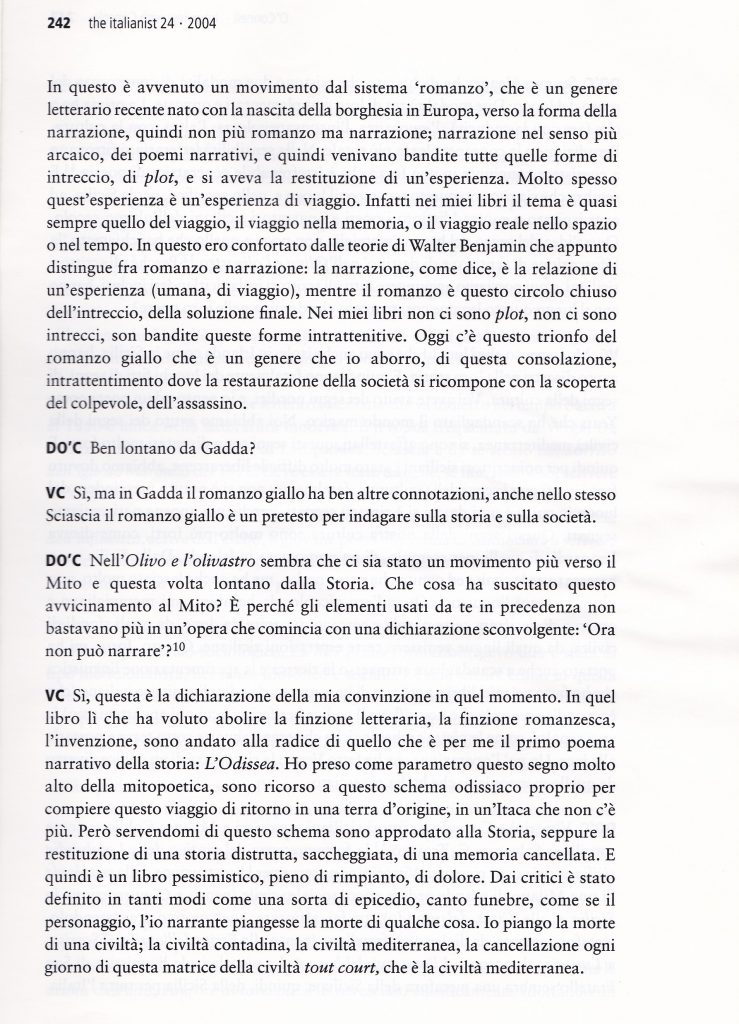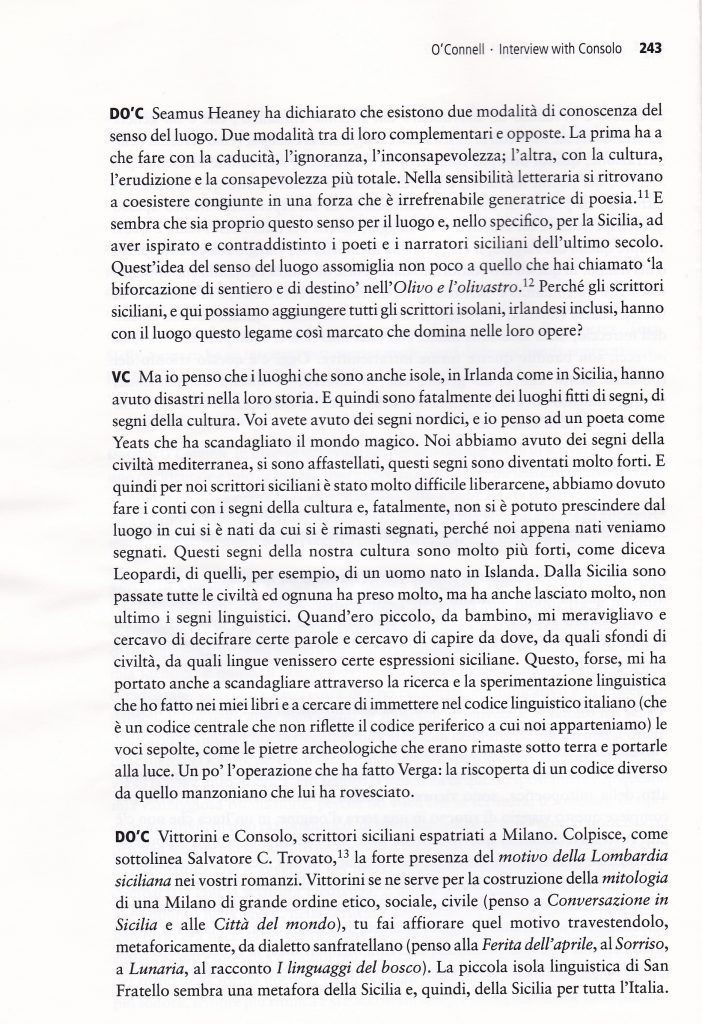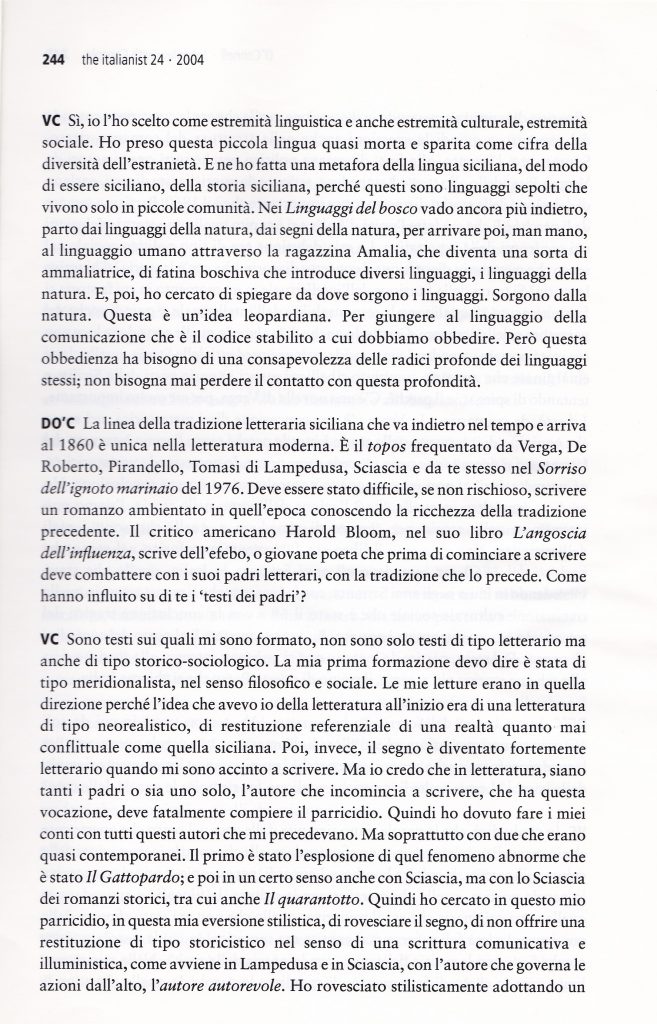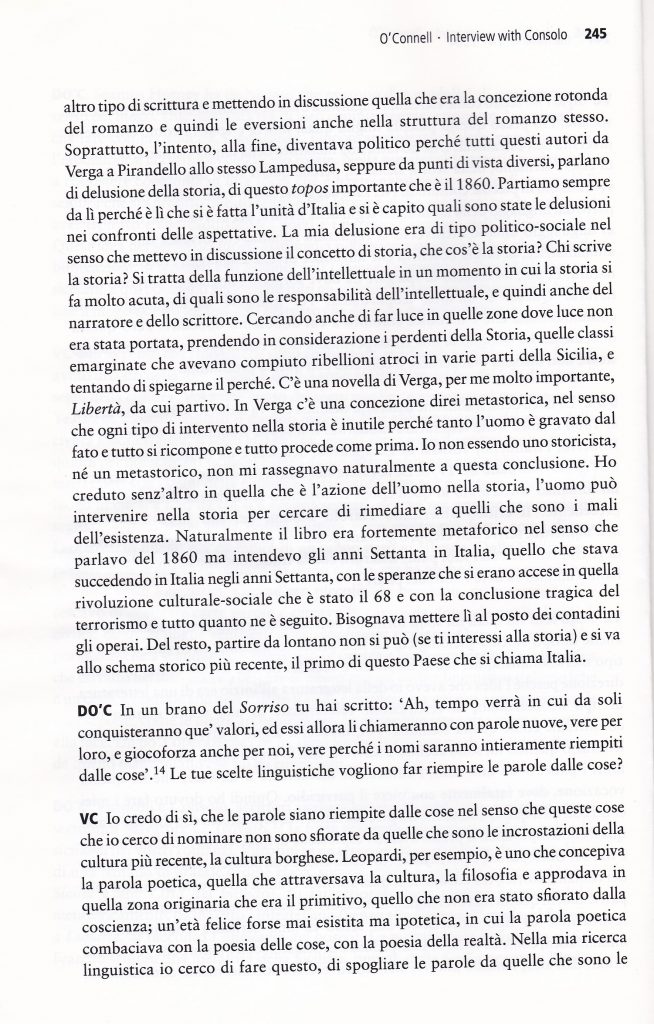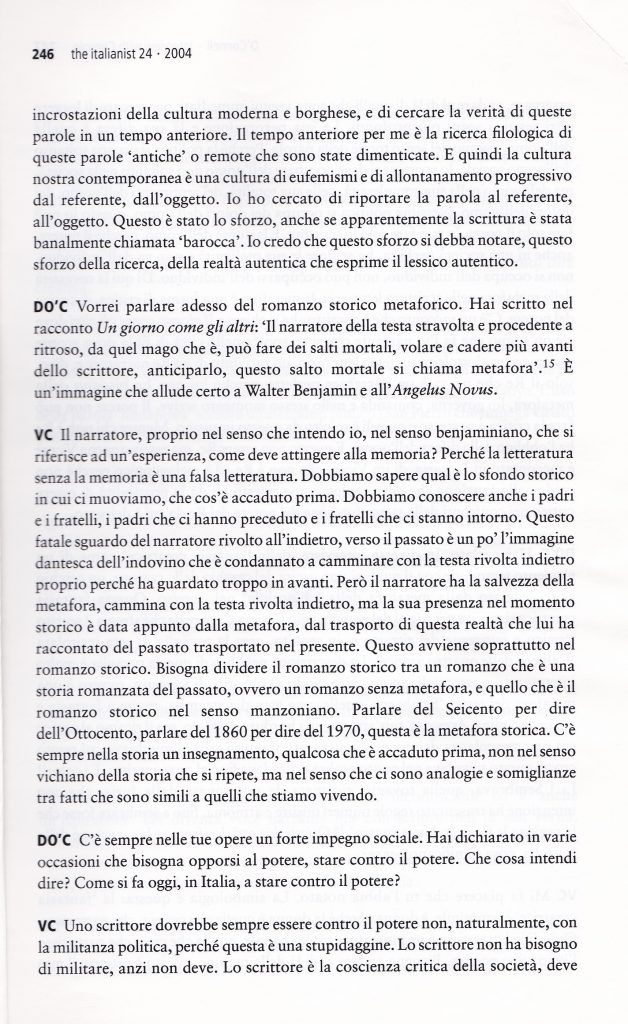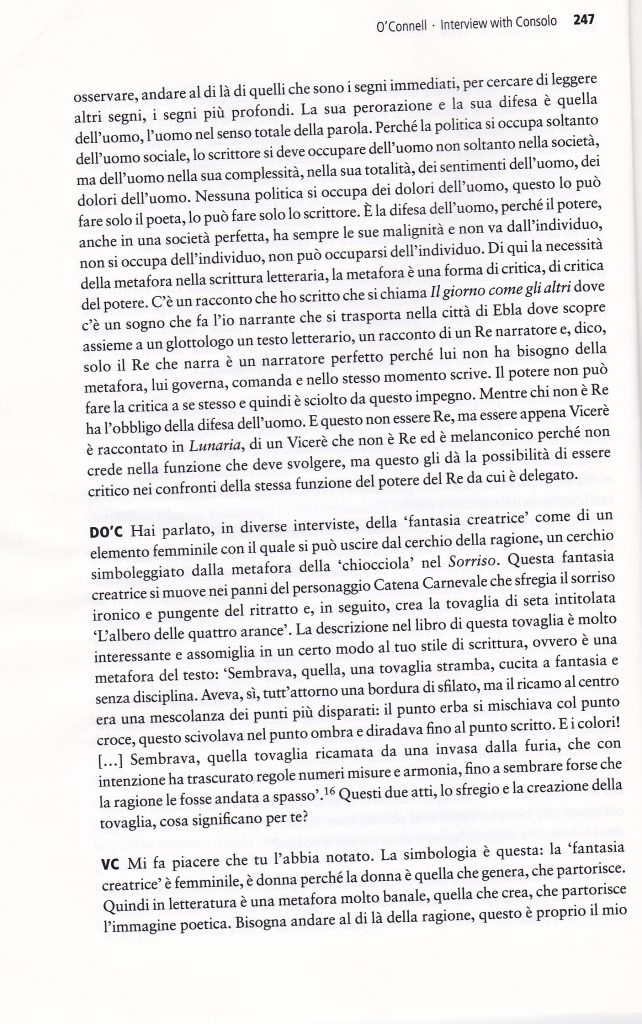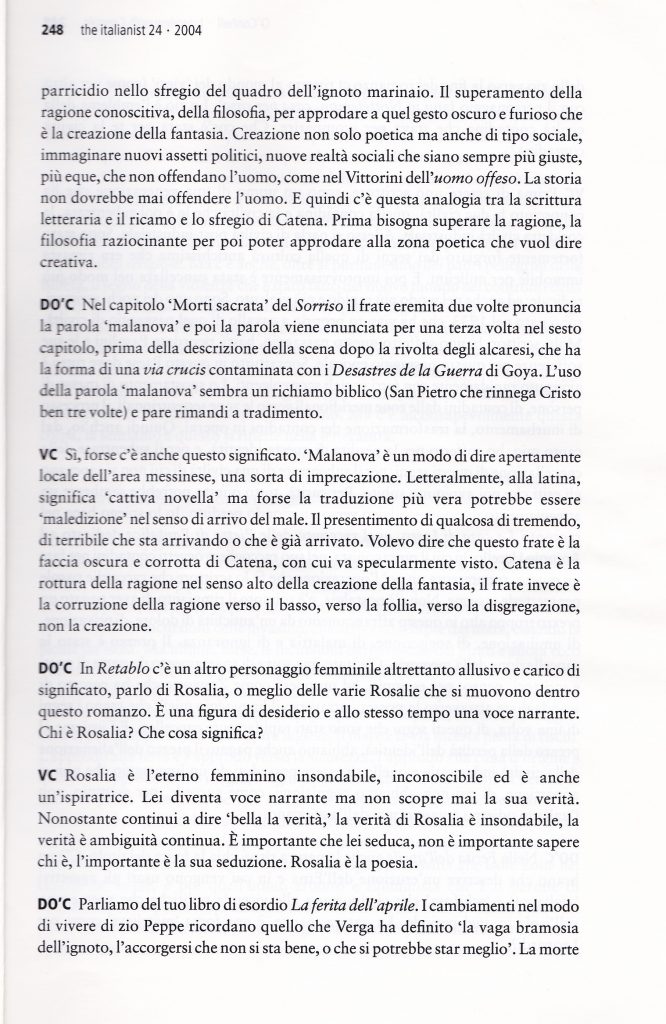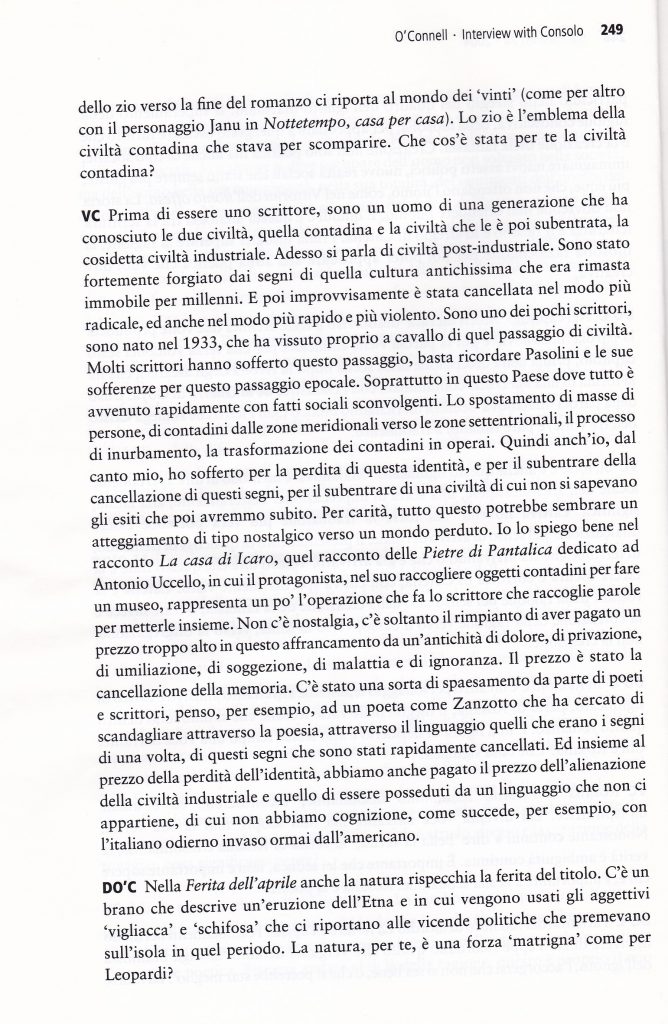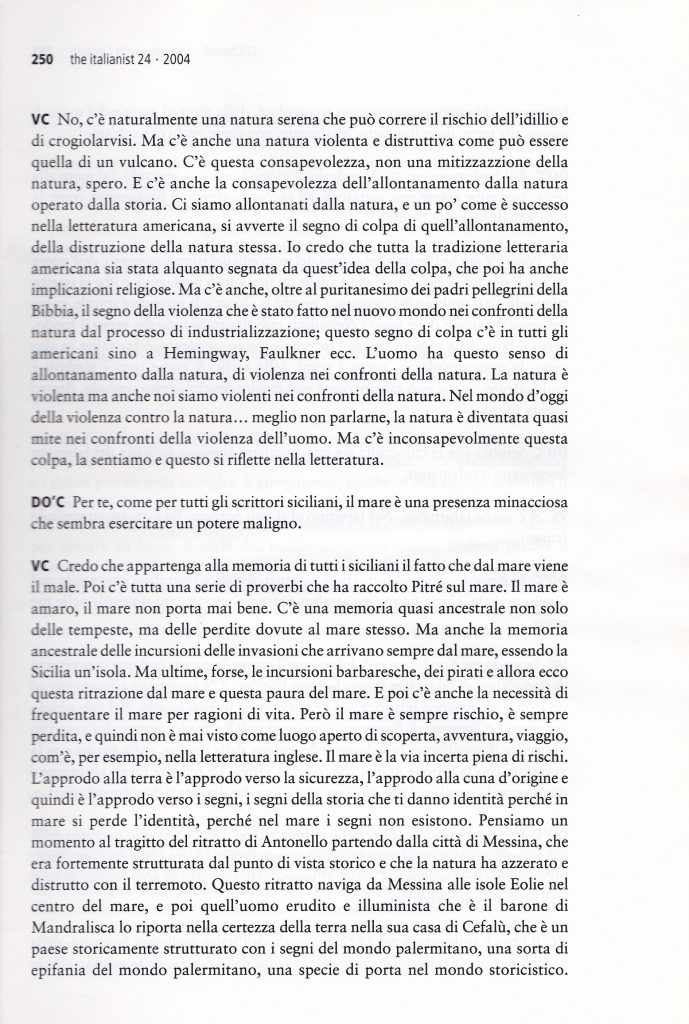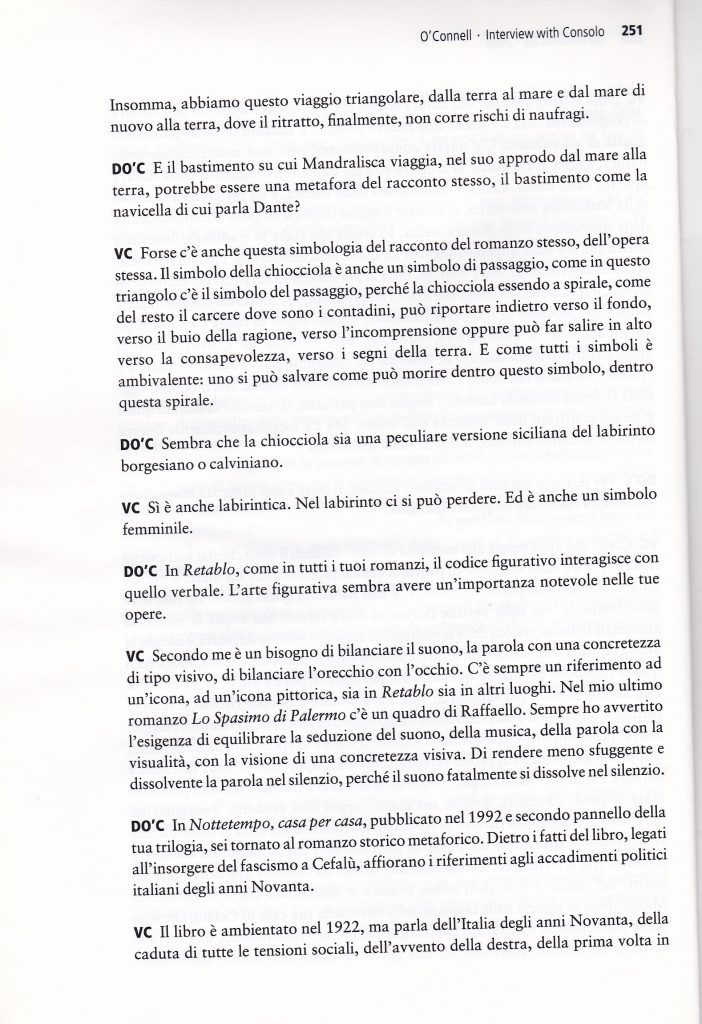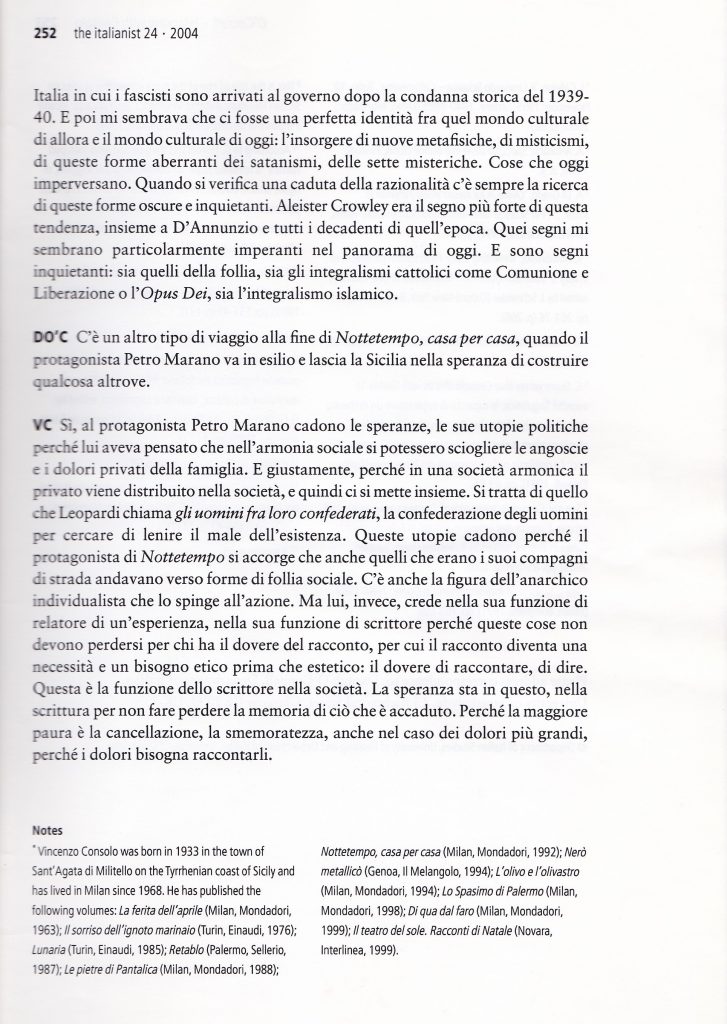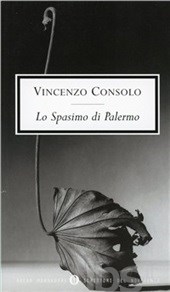
*
«Noi siàn le triste penne isbigotite».
Lo spasimo di Palermo di Vincenzo Consolo.
Con l’eccezione di pochissimi interpreti, in linea di massima la critica ricorre ad una approssimazione per definire Lo Spasimo di Palermo (1998) di Vincenzo Consolo: perlopiù schivando il termine ‘romanzo’ (e Consolo ormai dichiarava il genere invilito e impraticabile), chiama questo oggetto letterario per nome (lo Spasimo) oppure nelle varianti di ‘opera’, ‘libro’, ‘testo; e lo dice ‘vicino alla poesia’, o ‘vicino ai silenzi della poesia’, agli ‘approdi della lirica’, avvalendosi di simili locuzioni, tutte versatili e debitamente laconiche, e apertissime alle inferenze del lettore. Espressioni insomma vagamente oracolari, concise e scontornanti insieme: che additano ad uno scarto rispetto ai libri precedenti dell’autore, e forse accennano (ma assai in aenigmate) a uno scavalcamento dei dominî specifici di prosa e poesia e allo squilibrio netto della narrazione in direzione di quest’ultima; ma perifrasi che pure – e anche quando non siano diventate formule abusate (come accade), o maniera collaudata per sbrigarsi da un’impasse, non soltanto classificatoria – pure sembrano aggirarsi, tra allarmate e reticenti, intorno a un nucleo di non detto.
Perché certo è reale la dilagata ‘verticalità’ della scrittura consoliana, la sua innegabilmente cresciuta e fortissima contiguità alla lirica; ma dacché poi sempre poetica è stata la pagina dello scrittore siciliano – cadenzata, assonanzata, rimata; e gremita di echi letterari, colta, rara, di lingua incantata – a voler marcare le differenze rispetto al passato bisognerà mettere da parte la retorica e puntare piuttosto al rasciugamento della lingua e all’accentuarsi della contrazione testuale (della ritrazione autoriale); e dunque al modo ampiamente scorciato ed ellittico, allo ‘spasimo’, che è del periodo e del racconto.
Il mutamento, tuttavia, era annunciato. A guardare indietro, gli indizi stavano nell’acuirsi di un disagio peculiare in Consolo: se vogliamo in una sorta di insicurezza, una perenne quasi scontentezza delle strade già percorse, spesso anche ritentate, ma poi dismesse, accantonate; e in una crescente palpabile desolazione, nella fatica strana della penna. Le avvisaglie erano nei lunghi intervalli tra i libri tutto sommato pochi di questo autore che disperatamente e attardatamente ancora, nel pianeta ignorante e immorale, nel mercimonio globale, si ostinava a voltare le spalle al mercato e a voler fare Letteratura, a voler essere artista e scrittore ‘impegnato’, ‘civile’: un affabulatore, un incantatore, epperò al tempo stesso l’intellettuale utile ad arginare, curare, denunciare: magari a prevenire e a impedire il dolore del mondo, come insegnava una bellissima utopia di Vittorini. Le tracce si leggono nel succedersi dei testi: distanti uno dall’altro non solo cronologicamente, ma veramente poi ognuno a suo modo, nella lingua e nello stile: ogni volta a riprovare la forza della scrittura per piccoli aggiustamenti o inversioni di rotta o a furia di rimaneggiamenti; e con esiti più o meno felici, opachi o splendidi, ma forse, al fondo, con sempre meno entusiasmo. E stanno, le tracce, in una oscillazione tra due poli, nell’opzione combattuta – d’un tratto nettamente divaricata e poi stranamente mischiata, impazzita o violentemente turbata – tra ‘scrivere’ e ‘narrare’, tra certe punte aride, cronachistiche, e un progressivo spostarsi o arroccarsi nella zona della ‘espressione’. E vogliamo dire che il mutamento è andato al passo con l’approfondirsi di una riflessione (o di uno scoramento) che ha una radice antica, se è vero, come sembra a noi, che è dallo squieto interrogarsi del Sorriso dell’ignoto marinaio (1976), dall’assillo della ‘scrittura-impostura’ (ornamento, fiore bizantino, e comunque voce di secondo grado sempre: sempre finzione), se da quel tarlo discende il «rimorso» dello Spasimo. Un «rimorso» che Consolo ha affrontato per gradi, da Catarsi (1989) e Nottetempo casa per casa (1992); e poi ha scandito in due tempi, nell’Olivo e l’olivastro (1994) e qui, nel testo ultimo. Ci ha messo due libri per dircelo o per dirlo a se stesso, e lo ha fatto senza più volute e riccioli e sontuosità barocche, togliendosi la cifra così sua e spettacolare di fasto e di vertigine, elidendo la bellezza. E non perché lo Spasimo non sia bello, al contrario. Ma se nessuno dei testi di Consolo è facile, più degli altri è difficile questo: che porta il nome di un quadro della Passione, di una chiesa votata alla rovina, di un affanno che tortura, di «uno scatto di tendini e nervi» per «allucinato dolore»[1], e che come un dolore è difficile; come la dichiarazione di una colpa, come la confessione di un fallimento, è faticoso.
E davanti a questa scrittura quasi impossibile da realizzare e da sopportare – tutta a risalti e rilievi di pena, terremotata nella sintassi, smagrita nella lingua e nelle immagini, e tenace nella volontà di tormentare se stessa – chiudere la vicenda e frettolosamente siglarla con l’apparentamento spesso meccanicamente ripetuto con la lirica e i suoi «ardui approdi» o i suoi «silenzi», è quasi un non voler guardare, pare il tentativo di aggirare e di scansare il silenzio verso cui davvero Consolo si è mosso (e quanti ‘addii’ ci sono in questo libro?). La storia poi è sempre uguale. Sembra, come davanti al Tramonto della luna di Leopardi, di trovarsi di fronte a un eguale imbarazzo della critica, al non voler prendere atto – allora come adesso – di una messa in liquidazione.
Quando troppo sbrigativamente si afferma che la pagina di Consolo s’è fatta più vicina ai silenzi della poesia, l’impressione è che più sotto ci sia una questione semplicissima ma essenziale di cui si tace, quella di una scrittura che non vuole più incantare. Dov’è infatti la lingua che gremiva ed affollava Lunaria (1985), la «parola suavissima», la «notte di Palermo» («Nutta, nuce, melània / […] deh dura perdura, […] non porgere il tuo cuore / alla lama crudele dell’Aurora»; LUN, 13-14)? Che fine ha fatto la Luna?
Era «lucore», «faro nittinno», «fiore albicolante», la Luna: e cadeva, certo, nel sogno di un malinconico Viceré, come in un sogno famoso di Leopardi (Frammento XXXVII); e veramente pioveva giù dal cielo, lentamente in garze si sfaldava, spariva, moriva, lasciava in alto solo vacuo nero, vuoto. Ma poi dopo, in una Contrada senza nome, in un luogo che aveva conservato le parole antiche, la memoria, magicamente si ricomponeva, bianchissima risorgeva; e favolosamente rifaceva il sipario della quiete, l’inganno del cuore, la malìa, il «sogno che lenisce e che consola», la Poesia.
Per i poeti è un indicatore importante la Luna. Che pure nello Spasimo compare, però fugacemente, e per tre volte. La prima, in una rammemorazione, un idillio accennato e appena bruttato del tempo dell’infanzia. Lei piena ed aprilina splende, e la luce e la sua bellezza spande sopra il mare, il paese, i pesci che vengono a galla affatturati; e sopra un corpo massacrato, un morto ammazzato (SP, 15)[2]:
Era luna lucente in quell’aprile, gravida, incombente, notte di soste per anciove e sarde, di barche sui parati, di lampare spente, e conche d’ombra ai platani, alle palme. Urlavano donne in cerchio sulla piazza, alzavano le braccia. Era al centro il corpo steso e morto del Muto che pittava sulle prore sirene draghi occhi apotropaici. Il sangue cagliava e s’anneriva torno alla testa disgranata e pesta, al torso, al ventre.
È soltanto un momento, forse istintivamente canonico (ricorda un modo montaliano, o intimamente leopardiano : «E tu dal mar cui nostro sangue irriga, / Candida luna, sorgi […]»): una rapida incarnazione dell’indifferenza – e però c’è quasi una malignità sottesa in quel suo incombere di «gravida», che ce la mostra sovrastante, alta, e minacciosa di cascarci addosso, tutta peso.
Più inquietante è la seconda messa in scena lunare, con il protagonista dello Spasimo che si aggira tra i barboni di Milano, ma il luogo potrebbe essere una qualsiasi metropoli con la sua risacca di rifiuti e di degrado, col suo moderno paesaggio di rovine (SP, 70-71):
Stanno nel tempo loro, nell’immota notte […]. Proni, supini, acchiocciolati contro balaustre, muri, statue che in volute di drappi, spiegamento d’ali, slanci fingono l’estro […]. La luna imbianca groppe, balze, il gioco delle mante. Da dove giungono questi pellegrini, quale giorno li vide camminare, eludere dogane, quale raggio scoprì crepe, frane, il velo sopra l’occhio, la patina sul volto, i segni bassi della differenza? Sono gli stanziali dei margini, le sentinelle della voragine […], il segno dello squilibrio ingiusto, del cieco brulichio, dell’ottusa prepotenza. La terrosa schiera, il canto o il silenzio delle rotte senza approdo.
Non ha sempre questa tonalità cupa lo Spasimo, questo colore impastato e vischioso, agglutinato nell’allucinazione: il brano è il rimaneggiamento di un testo composto per un catalogo d’arte, nel 1995[3]; e la tecnica del riuso (che sia recupero, tessitura, accostamento, incollaggio o inserimento spinto delle pagine già scritte, delle proprie vecchie, sparse e disparate cose) è una prassi di Consolo, pericolosamente frequente. Però torniamo alla Luna: Lei che
in un altro tempo era «virgilia», guida e «malofora celeste»; che lieve e greve, malinconica atra o candente, faceva germogliare le parole, leniva la pena, accendeva e affollava il teatro delle meraviglie. E invece adesso sta in un rigo ed è nome senza aggettivi: «imbianca groppe» – non schiene; «balze» – si dice di un rilievo topografico, una roccia, una collina, un cumulo di terra; «il gioco delle mante» di una statuaria desolante. È una cosa, questa luna: un trasudamento o un faro freddo; e pare un sudario, una mano spessa di calcina sopra una umanità cascante imbozzolata in stracci, tra teriomorfa e minerale.
La terza luna (SP, 98-9) sarà di nuovo un simbolo, e la ritroveremo più avanti; ma solamente in parte è quella antica. Perché alla fine è Lei (l’incanto, il sogno, la scrittura) il rimorso di Consolo.
Per fare chiarezza sugli elementi di novità dello Spasimo, proviamo a mettere a confronto due momenti della scrittura dell’autore, gli estremi temporali di una ‘controstoria’ d’Italia costituita da testi autonomi e scandita per epoche di crisi – segnatamente il nodo dell’Unificazione nel Sorriso dell’ignoto marinaio, gli anni dell’avvento del fascismo in Nottetempo casa per casa, e con Lo Spasimo di Palermo quelli dal dopoguerra fino ai giorni nostri, ai giudici ammazzati con le bombe. Specificando che la presenza decrescente di aulicismi e arcaicismi dipende dalla collocazione cronologica delle vicende narrate (dall’età del Risorgimento all’epoca attuale), e sottolineando che i nostri prelievi saranno necessariamente indicativi e non esaustivi, guardiamo dunque al Sorriso, che non è il primo libro dell’autore siciliano ma il testo in cui si palesa la sua cifra stilistica gremita e riconoscibilissima; e quindi allo Spasimo, che della trilogia sta a conclusione. Ne vengon fuori due lingue qualitativamente differenti (una vorticosa, l’altra indurita e come rastremata) e l’esistenza di due diversi tipi o gradi di complessità:
Parlai nel preambolo di sopra d’una memoria mia sopra i fatti, d’una narrazione che più e più volte in tutti questi giorni mi studiai redigere, sottraendo l’ore al sonno, al riposo, e sempre m’è caduta la penna dalla mano, per l’incapacità scopertami a trovare l’avvio, il timbro e il tono, e le parole e la disposizione d’esse per poter trattare quegli avvenimenti, e l’imbarazzo e la vergogna poi che dentro mi crescean a concepire un ordine, una forma, i confini d’un tempo e d’uno spazio, a contenere quell’esplosione, quella fulminea tromba, quel vortice tremendo; e le radici, ancora, le ragioni, il murmure profondo, lontanissimo da cui discendea? (SIM, 125)
Sùbito un murmure di onde, continuo e cavallante, una voce di mare veniva dal profondo, eco di eco che moltiplicandosi nel cammino tortuoso e ascendente per la bocca si sperdea sulla terra e per l’aere della corte, come la voce creduta prigioniera nelle chiocciole, quelle vaghissime di forma e di colore della classe Univalvi Turbinati e specie Orecchiuto o Bùccina o Galeriforme, Flauto o Corno, Umbilicato o Scaragol, Nicchio, d’una di quelle in somma vulgo Brogna, Tritone perciato d’in sull’apice, che i pescatori suonano per allettare i pesci o richiamarsi nel vasto della notte mare, per cui antique alcuni eran detti Conchiliari o Conchiti, onde Plauto: Salvete fures maritimi Conchitae, atque Namiotae, famelica hominum natio, quid agitis? E Virgilio … Ma che dico? Di echi parlavamo. (SIM, 142- 43)
Il primo prelievo è un campione di mìmesi linguistica accusata con posposizione del possessivo, soppressione di preposizione, elisione di articoli e preposizioni, enclisi, imperfetto debole in –ea, troncamento, e terna anaforica battuta sul deittico (quel /quella); il secondo è un esempio di fascinazione, una piccola cavata elencatoria nel ‘barocco’ di Consolo: un periodo che si slarga e si gonfia, che lievita e si espande; e che parrebbe poter continuare a crescere su se stesso divagando ad libitum, o svolgendosi in volute, a spirale, per tortili virate. Che sia assedio o amore di vertigine (o entrambe le cose), si direbbe che la frase sogna: per incidentali, relative, similitudini e apposizioni.
Questo invece è Consolo adesso, questo è lo Spasimo (SP, 25):
Nella libera vita, elusione di regole e castighi, nel crollo d’abitudini e costumi, rimescolio di stati, cadute di ritegni, privo d’imposizioni e di paure, della voce, dello sguardo che ordina e minaccia, solo con Aurelia, Chino visse, nel marasma del paese, nella casa saccheggiata in ogni stanza, nel dammuso e nel catoio, il tempo suo più avventuroso.
Nel libro lo scrittore impiega pressoché esclusivamente il punto e la virgola[4]: una interpunzione che spesso, o come qui, obbliga alla rilettura, dacché per comprendere il testo occorre trovarne il ritmo e la cadenza. Che non sono affatto intuitivi, ma sono questi:
Nella libera vita, [elusione di regole e castighi,] nel crollo d’abitudini e costumi, [rimescolio di stati, cadute di ritegni,] privo d’imposizioni e di paure, [della voce, dello sguardo che ordina e minaccia,] solo con Aurelia, Chino visse[, nel marasma del paese, nella casa saccheggiata in ogni stanza, nel dammuso e nel catoio,] il tempo suo più avventuroso.
Solo rileggendo, insomma, riusciamo ad impostare la voce, ad abbassare la curva intonativa accordandola al senso dell’apposizione, del non altrimenti segnalato inciso, della parentetica. E si guardi alla costruzione peculiare del brano riportato sotto (SP, 24), al disorientante paritetico allinearsi dei membri di una sintassi tra accidentata e scomposta; e al rallentamento musicale prodotto da punteggiatura e ripetizioni – e qui veramente, con una impostazione grafica diversa, semplicemente andando a capo ad ogni virgola, diremmo che si tratta di una poesia:
Lo strazio fu di tutti, di tutti nel tempo il silenzio fermo, la dura pena, il rimorso scuro, come d’ognuno ch’è ragione, cosciente o meno, d’un fatale arresto, d’ognuno che qui resta, o di qua d’un muro, d’una grata, parete di fenolo, vacuo d’una mente, davanti alla scia in mare, all’arco in cielo che dispare, di cherosene.
È una sorta di procedimento (sklovskiano) della ‘forma oscura’: vale ad aumentare la durata della percezione di un oggetto (uno scritto, una musica, una tela), quindi ad accrescerne la permanenza e l’impressione nella memoria rendendone impegnativa la decrittazione, impervia la comprensione. E può essere che Consolo ci stia sfidando con la difficoltà del testo, che voglia costringerci a restare su ogni pagina e a rileggerla finché non la teniamo a mente (nella memoria, appunto): finché sappiamo recitarla sentendoci dentro le pause, gli scatti, la curva della sua voce (della sua pena). Ma pure è forte il sospetto che Consolo dal lettore abbia già preso le distanze, e stia parlando con se stesso. E che la linea faticosa e ‘spezzata’ della scrittura sia un esteso correlativo oggettivo, o come la traccia di un cardiogramma, la mimesi di uno spasimo che si torce nella penna e spezza la voce, e che in tutto il libro sgrana e frantuma la fabula e il discorso. Perché questo non è il passo disteso di un narratore, non c’è mai quell’agio; e lo annunciava, in esergo del testo, il Prometeo eschileo :
«Il racconto è dolore, ma anche il silenzio è dolore» – che significa: ogni cosa mi fa male, parlare o tacere; lo si voglia riferire alla persona dell’autore o al protagonista del libro, Gioacchino Martinez.
Torniamo però al nostro confronto. Si potrebbe pensare, e in un certo senso è così, che prevalentemente semantica sia la difficoltà del Sorriso, nel quale, sebbene la narrazione non si svolga piana come in un romanzo tradizionale, resta maggiore la disponibilità al racconto; e che sintattica sia invece quella dello Spasimo, in cui la forma narrativa si contrae accentuando la tendenza a slogare un periodo solitamente paratattico che avanza come a gomiti, veramente si allarga a spigoli, slontanando soggetto verbo e oggetto (normalmente invertendo in iperbato l’ordo naturalis) a mezzo di colate appositive. Ma si tratterebbe appunto di una verità parziale, poiché la complessità sintattica è anche un fatto, per quanto non il prevalente, del Sorriso (SIM, 143-144):
Prendemmo a camminare in giro declinando. Sul pavimento a ciottoli impetrato ricoverti da scivoloso musco e da licheni, tra le pareti e la volta del cunicolo levigate a malta, jisso, a tratti come spalmate di madreperla pesta, pasta di vetro, vernice d’India o lacca, lustre come porcellane della Cina, porpora in sulle labbra, sfumante in dentro verso il rosa e il latte, a tratti gonfie e scalcinate per penetrazioni d’acqua, che dalla volta gocciola a cannolicchi càlcichi, deturpate da muffe brune e verdi, fiori di salnitro e capelvenere a cascate dalle crepe: luogo di delizie origine, rifugio di frescura pel principe e la corte lungo i tre giorni infocati di scirocco, come le cascatelle della Zisa, i laghi e i ruscelli a Maredolce, i giardini intricati di bergamotti e palme, le spalle a stelle di jasmino, trombette di datura e ricci d’iracò, le cube e le cubale dei califfi musulmani, o come le fantasie contorte d’acque sonanti e di verzure, di pietre e di conchiglie dell’architetto Ligorio Pirro pel Cardinale D’Este.
Tutto questo, addio […].
Introdotta da un periodo breve, fiorisce gigantesca su un imprendibile complemento di luogo la frase nominale che fra chiasmi, allitterazioni e paronomasìe procede in corsa, balza in avanti a cascata gonfiandosi di immagini, aprendo ovunque rivoli, spandendo i suoi tentacoli, ingoiando le cose e generandone poi altre, e inarrestabilmente gremendosi, affollandosi. Ma è un procedere, una estroversione: tagliata in barocco, certo; e al fondo e in superficie è ansia: attorcigliata, srotolata o esplosa, è sempre la solita danza su baratri e sbalanchi, una frenesia di copertura, la maschera sul vuoto: infine una modalità del tragico: un movimento disperato e affannoso, si sa, e incantatorio anche: sforzato e lanciato all’infinito come se questo dire-toccare-accumulare fosse prendere e fermare le infinite cose, o salvarle e salvarsi; però resta un movimento verso fuori. Non è quello introvertito dello Spasimo: del periodo che si sfonda o si incava, che si avvolge e rifà all’indietro la sua spira; e non ingoia le cose, gli oggetti, il mondo, ma se stesso. Si ponga attenzione a questa ipotassi (SP, 52 – la messa in evidenza è nostra), alla parentetica che si dilata tra il soggetto (alla fine della frase) e il suo complemento (all’inizio della proposizione):
Ma anche per lui, per il padre, che pure della sciagura voleva parlare al figlio, dire finalmente, spiegare, e ora che partiva, ritornava laggiù, nella sua isola, ora che dal figlio di più s’allontanava, da quel fuggiasco costretto nell’esilio, la presenza di Daniela era opportuna
Il prelievo, poco illuminante a livello contenutistico, è esemplare dell’andamento macroscopico del racconto.
Lo Spasimo è la storia di un viaggio dalla Sicilia alla Sicilia, via Parigi e Milano. Consolo narra in terza persona, perlomeno prevalentemente; ma sembra che parli di sé. Gioacchino Martinez è uno scrittore invecchiato che non scrive più perché alla propria scrittura non crede. È un padre che si accusa di non aver saputo salvare il figlio dal disastro di una ideologia manipolata, degenerata poi nella violenza degli ‘anni di piombo’; e a Parigi, nell’ennesimo viaggio verso quel figlio con cui non sa parlare e che poco gli parla, da una fotografia sulla parete di un albergo, inizia a ricordare: l’infanzia sull’isola, lo sbarco degli americani nel ’43, il rifugio suo di bambino: il «marabutto», il posto per starsene lontano, col mondo tutto fuori, a immaginare; e il padre lì viene ammazzato dai tedeschi, e forse per colpa di Gioacchino. E ricorda, Martinez, l’amore per la sposa luminosa e fragile, Lucia; la casa di Palermo con lei e il figlio: l’oasi di una vita chiusa tra gli affetti e la scrittura, nel riparo di quelle mura, difesa dal bellissimo giardino; e poi le piante scerpate e avvelenate, la mafia che con le bombe si prende quella terra per lucrare sul cemento e i condominî; e quindi la fuga dalla Sicilia, il viaggio verso Milano pensata umana e civile ma in breve divenuta un altro luogo di terrore e spari, e poi, craxiana, fatta teatro di ogni mercimonio, della volgarità più oscena. E dopo, l’impazzire e il morire di Lucia, il figlio accusato di terrorismo che si rifugia in Francia, i tanti viaggi tra Parigi e Milano; e prosegue la storia fino al ritorno di Gioacchino a una Palermo incancrenita, dove lo scrittore muore, salta per aria nell’attentato a un giudice che assomiglia a Borsellino. Questa, per amplissime linee, la vicenda del libro.
Ma non sappiamo dire, con la straordinaria sicurezza che pure è di qualche interprete, che ‘equivocheremmo’ qualora sovrapponessimo le voci e le figure, se insomma scambiassimo l’afasia di Martinez per una possibile (o temibile) afasia di Consolo[5]. Perché in realtà ci pare che sia proprio di Consolo il rifiuto o l’impossibilità di scrivere del tragico protagonista dello Spasimo – una impossibilità che, per questa critica lontana dal dubbio, varrebbe a registrare «un dato antropologico e sociale» nella generalissima questione (almeno così capiamo noi) del senso della funzione intellettuale oggi.
Certo non intendiamo appiattire lo Spasimo alla dimensione esistenziale dell’autore: la separazione tra l’io che vive e l’io che scrive c’è sempre, innegabilmente; e la finzione, l’invenzione, è la condizione di qualunque narrazione, anche autobiografica. Ma pure se non sapessimo nulla di Consolo, anche se non riconoscessimo opaca in queste pagine un’esperienza sua reale, comunque, davanti all’opera che mette in scena uno scrittore che dichiara l’impasse, e con fatica e con durezza ogni volta torna sul proprio fallimento, che le proprie parole sente false e della propria scrittura recita il mea culpa – non potremmo non pensare che chiunque sia l’autore, in qualche modo stia parlando di sé, del suo rapporto con la Letteratura. E a maggior ragione nello Spasimo, che di tutti i testi di Consolo è veramente il più ‘sovrascritto’ dacché qui la «metrica della memoria» – lo sfondarsi della pagina e il precipitare suo in verticale per il sovrappiù di senso di cui la caricano le voci della Letteratura (e sono tante: Omero, Dante, Cervantes, Tasso, Manzoni, Leopardi, Verga, T.S. Eliot, Vittorini, Montale) – è anche e principalmente memoria fortissima di sé, dei propri libri, di una storia letteraria personale e vera che costantemente richiama se stessa e si mostra per lacerti, accenni, rinvii: da Un giorno come gli altri a Le pietre di Pantalica a Catarsi all’Olivo e l’olivastro.
Neppure sappiamo dire con certezza se lo Spasimo debba chiamarsi romanzo, antiromanzo, o narrazione poematica; e potremmo aiutarci specificando che è insieme tragedia, confessione, racconto del viaggio, o dell’esperienza, oppure un’espiazione, e un addio. Ma la questione dei nomi poi non muta la sostanza dell’oggetto: di questa che è (e rimane) una prosa, con le sue fortissime vibrazioni o fibrillazioni liriche; e che narra una storia, per quanto destrutturandola – con tristezza o con violenza, con qualche esibita trasandatezza, forse con una strana sprezzatura. Lasciamo quindi la definizione esatta dello Spasimo ai catalogatori esperti, ai teorici della letteratura; e in fondo anche ‘romanzo’ può andar bene poiché il genere, elasticissimo, è per natura aperto a tutti gli attraversamenti, a ibridazioni e contaminazioni[6]; e l’avversione al romanzo, ormai più volte espressa da Consolo, è una polemica nei confronti del suo attuale scadimento, una provocazione e una dichiarazione di non-omologazione al mercato cultural-editoriale che di tale ‘etichetta’ costantemente abusa, amalgamando strame e opere di Letteratura[7]. Ma indipendentemente dalle nostre incertezze classificatorie, e pure dal fatto che Consolo, dopo lo Spasimo, abbia realmente scritto oppure no (e a quasi due anni dalla sua scomparsa, ancora non vien fuori L’amor sacro, il «romanzo storico-metaforico» (sic) che egli stesso annunciò finito)[8] comunque non crediamo di sbagliare affermando che lo Spasimo di Palermo ha il modo di una parola ultima. E che è difficile per chi lo legge perché è difficile per chi, disperatamente, lo ha scritto.
La disperazione, insieme alla diminuzione di sé, è un tratto distintivo di Consolo: racconta una pena reale, crescente, e ossessivamente presente nell’ultima sua produzione – si guardi, prima che al massacro pervicacemente operato da Gioacchino Martinez nei confronti di se stesso e della propria scrittura, all’odio di sé che già nel 1989 si sbozzava nei toni gridati enfatici dell’Empedocle di Catarsi (lo scienziato-poeta impazzito per la falsità che sente dentro le parole – anche le proprie – e il cui «odio verso il mondo è pari all’odio per se stesso, pari al suo dolore, al suo rimorso»; Cat, 58), o allo svilimento a «infimo Casella», a
«eroe patetico» che è nell’Olivo e l’olivastro (OO, 107). Dentro c’è la coscienza della «cavea vuota», il senso di parlare «arditamente» – e a Consolo dové parere ‘teatralmente’ – al niente; forse il timore di perdersi nell’alessandrinismo, nella tentazione dell’ornato o nel vaniloquio della parola bella; e anche quello di scadere nella querimonia, nell’infinito lamento del vecchio che si sente escluso, estromesso. E con tutto il valore estetico morale e civile di cui sempre ha considerato depositaria e custode la Letteratura, Consolo deve aver fatto fatica a non smarrire il senso del proprio lavoro, la spinta del proprio scrivere, del suo ostinarsi ad additare dei valori al nostro tempo di ignoranze, di coscienze assordite ed avvilite, ottuse. Probabilmente nello Spasimo è il peso del disinganno che spezza e sgrana il racconto, che blocca il farsi del romanzo, della storia levigata e ‘tonda’; pure se indubbiamente esiste (e sarebbe fuorviante escluderlo), insieme al bisogno (ancora) di dire una parola ‘utile’ al mondo, il desiderio di misurarsi (ancora), di sperimentare la via diversa, il taglio che magari incida la corazza dell’indifferenza mentre attinge un risultato alto, una compiutezza di stile. Meno cesellata e preziosa è la lingua dello Spasimo (come già quella delle Pietre, dell’Olivo) rispetto alla voltura ricchissima, alla esuberanza vertiginosa e tortile cui ci aveva abituato la penna dell’autore siciliano; ma liricamente tesa, musicale per assonanze e rime interne, resta una partitura ritmica; e si presenta più facile all’approccio lessicale, porta i segni di una nuova asciuttezza, quasi la tendenza a una semplificazione che in qualche modo va a bilanciare il tratto singolare, internamente terremotato della struttura. Ma la questione è complessa, se la distanza dalla voce antica è aumentata progressivamente, disegnando e chiarendo un movimento, più che di distacco, di rigetto.
Mancano allo Spasimo le pezze d’appoggio del Sorriso, i documenti veri o contraffatti del romanzo di stirpe manzoniana misto di storia e d’invenzione; gli manca l’ironia, anche amara; e la quinta di teatro, la metafora di un tempo altro. Non ci sono i fatti del 1860 o gli anni Venti di Nottetempo per dire ‘in figura’ le cose di oggi, perché siamo nell’oggi, e la Storia non si esplicita per nomi e date, ma sta inscritta nella scena metropolitana o nell’iconografia stringata di una terra rovinata e guasta; e si aggruma ad ogni passo del racconto, lo incide di veloci apparizioni e di rumori (il traffico, gli spari, certi improvvisi boati) orientando e dirigendo la vicenda. E indubbiamente la narrazione mai facile di Consolo qui si fa più sussultoria dacché sfronda e scolla pesantemente la trama fino a darcela esplosa, confondendoci. Spesso, in un unico capitolo, passato prossimo e remoto (Milano e la Sicilia), il presente degli eventi (all’inizio Parigi, Palermo poi) e quello perenne di incubo e dolore stanno insieme: per paragrafi staccati, sì: epperò uno via l’altro e per continui salti, sempre in assenza di segnalazioni o di appigli che dicano chiari i tempi e i luoghi; e anche qui, per capire, siamo costretti a tornare indietro, a rifare la lettura. Pare sconnessa l’architettura, franata[9]. Che sia ormai insofferenza dell’invecchiato autore, sfida orgogliosa a un uditorio assente, fretta o voglia di finire, l’opera somiglia a un disegno impazzito: e costantemente pasticcia la sua struttura, la svisa, la fa sghemba: quasi a voler mostrare che la mano non sa (o non vuole) più reggere i fili di una compiuta fabula, che sta cedendo – ed è vero – alla stanchezza. Ma a guardar bene, il disegno di Consolo è tutt’altro che confuso: lo Spasimo è un congegno ben pensato, tagliato e montato per frammenti, tra analessi e prolessi, flashback e anticipazioni; e mentre gradualmente rivela la sua tramatura di ‘simboli’ (sono figure equivalenti il giudice, il padre, lo scrittore; e tutti i luoghi del rifugio – o della viltà – sono la scrittura) mentre che pare disperdersi o costruirsi quasi casualmente, si serra a cerchio intorno alla vicenda che si snoda nel presente: un’azione che si interrompe già alla seconda pagina del primo degli undici brevi capitoli del libro; che torna a svolgersi, si chiarisce e (provvisoriamente) si conclude tra il terzo e il quarto, che ancora si blocca in una rammemorazione e riprende poi a scorrere dal nono capitolo fino alla conclusione del testo. È insomma il racconto di un viaggio di ritorno che comincia in medias res, ritrova il suo principio per tornare poi al passo col presente, secondo uno schema antico, omerico. E veramente Consolo ha riscritto un’Odissea, dal tempo dell’Olivo e l’olivastro: però nei modi sgangherati e tragici e con le afonie di un cantore moderno.
Iperbati, anafore, assonanze e rime interne sono frequenti nello Spasimo; consueta è la cadenza degli endecasillabi e pure di senari, settenari, ottonari e novenari mascherati e fitti nel tessuto della prosa: ma è un dato acquisito che ritmi e procedimenti topici della poesia da sempre contraddistinguano la pagina di Consolo. Lirica è la pagina iniziale, quasi una protasi, amara e splendida; lirico e commovente l’addio alla donna morta; e veramente mirabile (un gioiello da antologia) l’addio a Milano (SP, 93-4) così lucido e fermo e dolente (e quanta vita, quanta fede letteraria, quante cose ci sono in questo addio fatto di luoghi di persone di scrittori di poeti) ma che poi cambia il tono suo pacato, si gela e si strozza in una maledizione, in uno sputo – ma potremmo continuare a lungo. E sporgenze, affacci e approssimazioni ai modi della lirica stanno nelle aggettivazioni, parche e però puntute, folgorate, tutte rapprese; e nelle inserzioni citazionali di versi, nelle incongruenze sintattiche violente, in certa fortissima icasticità di dettato; e nei cataloghi dei nomi che adesso non sbocciano fastosi ed opulenti e non si affoltano in vorticosa danza a coprire il vuoto, ilaro-tragici e infebbrati di vertigine, ma in quello cascano o colano gravi, disanimati e nudi. Resta colta e non omologata la lingua di Consolo, però si è incrudita: non gronda più umori densi o olii soavissimi, non si espande per volute, non ricama i suoi vecchi e splendidi arabeschi, ma vuole incidere e pesare, come una pietra: a tratti si fa rasposa per asciuttezza e sempre ha in gola una dissonanza aspra, una caduta, uno stridore, la disarmonia che spezza l’illusione la malìa il lenimento del canto (la tentazione dell’incanto). Per distillazione e smagrimento, per erosione si è rappresa in una bellissima economia verbale che coniuga torsioni incongruenze e lapidarietà sintattiche allo sfondamento in profondità e in espansione, all’appiombo verticale della parola poetica. Ma veramente quel che più rileva e fa la differenza, rispetto al passato, di questa lingua sfrondata, è l’ispessirsi delle sue zone di silenzio: tanti sono gli spazi bianchi che si aprono fra i capoversi o fra i paragrafi staccati; e le virgole, anche ravvicinatissime, che spezzano il fluire del racconto, isolano segmenti quasi versicolari: sono pause che si leggono come se ci fosse un salto d’aria in mezzo, come gli ‘a capo’ della poesia. E questo ispessimento deriva dal ricorrere di un procedimento che appunto porta in sé il silenzio perché implica un margine di non detto, di non spiegato: l’ellissi, che è il vuoto su cui rallentiamo, ci fermiamo; che siamo chiamati a interpretare, o di cui dobbiamo prendere atto.
Elide i nessi Consolo, spesso la consequenzialità narrativa; avanza per associazioni sue, per saltum, e sembra (voler) perdere il filo, o volerlo ingarbugliare a noi. Agisce ellitticamente quando ci confonde sovrapponendo le maschere, le personae in cui si scorpora e parla la voce narrante (io, tu, egli: nello Spasimo è lo stesso); o quando proditoriamente ci spiazza nel giro di una frase o di un capoverso con una posposizione che è un repentino cambio del soggetto (SP, 26):
Ricominciò a poco a poco a frequentare l’intrico dei vicoli dietro la sua casa, il quartiere tra la chiesa e la piazza di fondachi e di antri, casupole col mulo nella stalla, carretti ad aste all’aria, gabbie d’animali, buffette di scarpari, forge fumose, fermenti grassi, fioriture d’untumi, afrori da porte e lucernari, lippi e limaglie tra i ciottoli, ai bordi dello scolo. Sulla soglia, mischiavano le donne vasellina e zolfo per la rogna. Si negava a quel meandro in ogni tempo, come posto dentro una caverna, sotto perenne nuvola di cenere dell’Etna o sabbia del deserto, il sole che nelle cadenze, nel giro naturale temperava questa fascia del mondo, governava i giorni, le stagioni.
Ellittico è il discorso in cui tutte le parole funzionano come una stenografia e hanno dentro un’eco, allargano e sfondano la pagina col peso; ellissi è l’accostamento straniante dei frammenti, oppure l’omissione del verbo, o il comparire suo con impressionante ritardo (è la prassi con cui Consolo sistematicamente ci disorienta) come nel fraseggio apparentemente nominale in chiusura di questa pagina che riportiamo intera ad esemplificare in sequenza quanto appena detto (SP, 42-3):
Oblio di tempo e luogo in quella sosta di ristoro, estraniamento, ritaglio d’un mondo prossimo e lontano, e Abdelkrim mostrò il tramonto, il vuoto intorno, significò la chiusura del giardino, delle porte.
«A demain, monsieur, à demain» il sorriso sul viso nobile, caprigno.
Ancora spinto dal caso, nel cieco vagolare, nelle luci e nelle ombre della sera.
Portavano i passi verso il luogo dov’era la ragione del viaggio, del suo persistere nel mondo, verso quell’uomo esplicito e sfuggente, quel figlio che si negava a ogni confidenza, tentativo di racconto, chiarimento.
Furtivo avanti la libreria a spiare nella sala fumosa e affollata, lui con altri al tavolo, sorridente e ironico, accanto al profetico scrittore riccioluto.
“Piangevi per le nuvole, pei tuoni, ti stringevi a me forte, le nule le nule – lamentavi –, t’ostinavi a contare le stelle, a scovare le cicale, dicevi del veliero sopra il Monte, dei fuochi sopra l’onde, e lei che ridendo più in dentro ti spingeva nelle fole.”
Dentro frotte, masse, che non credea non credea che tante, notturne e inebetite, per viali passaggi impasses, angoli scuri, insegne lampeggianti, video e ordigni sessuali, negre maestose e vecchie consumate, club, guardiani ch’afferrano pel braccio, spacciatori, giovani piegati e barcollanti, uno stordimento, un fiume trascinava, in fondo, fino alla foce calma, alla penombra sotto un arco, ombre immobili e scorrenti.
Il periodo in apertura della citazione mostra due maniere allineate: quella nominale («Oblio di tempo → lontano») e quella predicativa («e Abdelkrim → delle porte»); elidono i verbi
«A demain → caprigno» (e ci lampeggia dentro Saba), «Ancora spinto → della sera», «Furtivo avanti→ riccioluto»; e sono modi scorciati e rappresi, intervallati dall’ordito più tradizionale di «Portavano → chiarimento» (con le anaforiche riprese melodrammatiche e l’euritmia retorica della terna sinonimica in chiusa) e dal frammento di sapore pascoliano
«Piangevi → fole».
In questo contesto, l’eliotiano-dantesco «Dentro frotte, masse → scorrenti», ci sembra immediatamente anch’esso privo di predicato; ma è un’impressione indotta dalla sintassi che procede centripeta tra slogature e agglutinazioni, per membri sbrancati. Il periodo infatti ha
«fiume» per soggetto, «trascinava» per verbo, «ombre» come oggetto e tre complementi di luogo: «dentro», «per» e «fino»; il primo («dentro») complicato dalla citazione che dovrebbe contenere e riportare il commento del protagonista Gioacchino, di cui il libro narra in terza persona; e che però innesta un ulteriore effetto di sbandamento per l’ambiguo sovrapporsi di soggetto narrato e voce narrante, e forse per l’improvviso baluginare o il chiarirsi della identità delle personae grammaticali, di egli-Martinez e di io-Autore-Consolo, dacché l’imperfetto debole credea indubbiamente vale per entrambe le persone, terza e prima; ma appunto la memoria dantesca ed eliotiana (e sono presenze capitali nello Spasimo) generano o rivelano la ‘confusione’; e istintivamente leggiamo come se a parlare fosse la prima («e dietro le venìa sì lunga tratta |di gente, ch’i’ non averei creduto |che morte tanta n’avesse disfatta»; If, III, 54-57; «A crowd flowed over London bridge, so many, /I had not thought death had undone so many»; WL, 61-63; la sottolineatura è nostra).
Ad ogni modo, reputare omesso il predicato è un errore che Consolo ci spinge a compiere. O meglio, lo commettiamo perché lo Spasimo ha una orchestrazione sinfonica, una sua musica: l’autore prende un tema, cambia strada, lo lascia, e poi a distanza, magari dopo molti altri toni e altri motivi, ci ritorna, lo riprende, lo continua. A rigore infatti, nel caso appena esaminato, Consolo sta continuando un ‘tema’ precedente, e ad essere più precisi avremmo dovuto parlare della elisione di un avverbio o di un periodo (o di una serie di periodi) che stanno due pagine prima di quella citata: «Via fino al Quais des Célestins […]. Via da quella zattera di pietra […], dentro borghi, strade, piazzette di dimenticanza, bistrots e librerie, volumi aperti su pagine istoriate, inchiostri multicolori, scrittura ondosa e sibillina. Quindi davanti al muro bianco, alla cupola smagliante, al minareto della moschea» (SP, 40); ma potremmo anche fare come se fosse sottinteso il «girovagò» dell’inizio del capitolo (è lontanissimo, a pagina 33); oppure, veramente, ‘andava’: perché il continuo e affannoso movimento, il desolato e interminabile peregrinare è un motivo che ritorna (ma ce ne sono altri: la colpa, il rimorso, il rifugio, l’addio), una nota dolorosa che lo Spasimo (questo libro che racconta un viaggio) perde e poi riprende. E ‘andava’ sarà il predicato saltato più avanti, in un diverso tempo e luogo della vicenda, a Milano anziché a Parigi; ma il modo ellittico – la ripresa del tema che compare a distanza, come fosse un refrain, in pagine differenti – è analogo a quello indicato in precedenza:
«Andava nell’ora antelucana per la città ignota, per vie, larghi senza nome, per scale, passaggi pedonali, nel neutro lampare dei semafori. Gli egri ippocastani attorno al monumento marcivano le bacche […]» (SP, 69).
E dopo altri coagulati motivi, altri rappresi pensieri (la fiumana del progresso, il Gran Ballo Excelsior, Verga che torna in Sicilia, gli scontri degli anni ’70 a Milano) ‘andare’ torna in anafora (SP, 70) in un altro capoverso:
«Andava in quel crepuscolo, fra lo sbarramento di portoni, di serrande, nel giallo dei fanali, nel vuoto, nell’arresto mattutino. Guardie infilavano i biglietti[…]»;
E più giù, dopo la descrizione della città desolata, la comparsa in scena di Manzoni[10], l’apocalissi dei barboni (questa pagina, che in parte abbiamo citato, staccata dal racconto, separata e chiusa tra due spazi bianchi) lontano insomma, ma ancora eliso, sottinteso, c’è il predicato, ‘andava’:
«Dentro il fitto intrico della cerchia e la curva larga in cui nei muri, negli accessi, erano ancora i segni del Naviglio» (SP, 71).
E muovendoci anche noi per salti, arriviamo all’avvio del testo, che è prologo o protasi o una specie di ‘a se stesso’, o un ‘a parte’: leggiamo l’incipit della scrittura «poematica» dolorosa e franta, l’inizio del viaggio (SP, 9):
Allora tu, i doni fatui degli ospiti beffardi, l’inganno del viatico, l’assillo della meta (nella gabbia dell’acqua, nella voliera del vento hai chiuso i tuoi rimorsi), ed io, voce fioca nell’aria clamorosa, relatore manco del lungo tuo viaggio, andiamo.
Ma più indietro – ché questo libro è un perenne ritornare di Consolo su di sé, sul suo mestiere, i suoi libri, la sua funzione di scrittore – c’è l’andare, il fermarsi, lo scendere, l’entrare, il correre del reduce «patetico» e «smarrito», del viaggiatore disperato di una Sicilia perduta: c’è l’odissea spezzata e fallimentare dell’Olivo; e Consolo doveva tornare su qualcosa che lì, con quel cammino, aveva incominciato a dire.
La parola «rimorso» sta all’inizio e alla fine dell’Olivo e l’olivastro; poi compare (ed è un indicatore di rotta) nell’avvio dello Spasimo; e in realtà sono numerose e tutte rilevanti le occorrenze del termine in queste due variazioni tragiche sul tema della colpa e sul viaggio di matrice omerica, sull’impossibile ritorno a un’Itaca scomparsa.
Si chiama così L’Olivo e l’olivastro perché fra quegli arbusti, nell’intrico fitto e armonico di selvatico e coltivato, ripara Ulisse quando scampa al suo lungo naufragare e tocca un mondo solido, o comunque più solido del mare: Scherìa incantata, la terra dei Feaci. Al personaggio del mito Consolo dedica un intero capitolo (il secondo del libro) rendendo esplicito il parallelismo tra due viaggi che si svolgono nel testo, entrambi di ritorno, epperò segnati da esiti differenti. Perché se Odisseo alla fine del suo travaglioso peregrinare raggiunge Itaca, il protagonista dell’Olivo approda invece a un’isola mutata, devastata: una Sicilia sconciata cementificata incancrenita dannata, ormai dominio dei Proci, del selvatico soltanto, della barbarie. E certamente narra di sé, Consolo: a descrivere il disastro è un personaggio senza nome di cui parla in terza persona ma che in tutto gli somiglia. Prescindendo tuttavia in questa sede dal moltiplicarsi dei ‘giochi a nascondere’ (e qui gli specchi dell’autore sono tanti), ci interessa il carattere espiatorio del cammino dei due erranti: l’antico eroe greco e il moderno protagonista dell’Olivo accomunati dal «rimorso» (otto sono le occorrenze del lemma, solo a contarle da pagina 9 a pagina 28 del testo) e dunque dall’aver commesso una colpa. E però quale?
Ulisse è l’ideatore degli inganni, l’inventore dell’idolo di legno che nasconde nel ventre la morte feroce, le braccia armate che distruggono Troia; e lui che ha coltivato métis e techné per un fine letale (questa è la lettura di Consolo) è il più colpevole degli Achei ma pure l’unico a salvarsi. Non è il guerriero più forte, o il più degno, il più valoroso; e lo sa. Perciò è il più carico di rimorsi: quelli che dovrà affrontare (per una sorta di contrappasso) materializzati in mostri (Ciclopi, Lestrìgoni, Sirene, la «rovina immortale» di Scilla e di Cariddi); e prima ancora, quelli che deve propriamente confessare nella reggia di Antinoo: perché nello
«strazio» del racconto è l’ammenda per cui l’eroe è assolto (OO, 45); e questa specifica ‘catarsi’ è necessaria (dire, narrare, confessare la colpa) acché il ritorno in patria possa compiersi. Ulisse dunque piange e narra: «narra fluente la sua odissea […] diventa […] l’aedo e il poema […] il narrante e il narrato, l’artefice e il giudice, diventa l’inventore d’ogni fola, menzogna, l’espositore impudico e coatto d’ogni suo errore, delitto, rimorso» (OO, 19); e ne vien fuori una strana mistione di vero e falso, confusamente l’impressione che dentro il racconto si insinui e stia acquattata una simulazione, una menzogna di fatto imprescindibile; ma la questione (metaletteraria) della possibile «impostura» della scrittura (che è un assillo tipicamente consoliano) pare solamente accennata qui, nell’Olivo, e si svilupperà poi, dolorosamente, nello Spasimo.
Quanto all’autore che nell’Olivo dice di sé in terza persona – che in apertura del testo dichiara l’impossibilità a narrare («Ora non può più narrare») e tuttavia, in furia o in pianto, pure dietro una maschera, racconta – anch’egli porta una colpa: «con un bagaglio di rimorsi e pene » (OO, 9) lasciò l’Isola bellissima e terribile (lei che tra calcinacci e tufi, corsa dai randagi e abitata dai corvi, è già terra votata all’abbandono, pare fatta di polvere); e se ne andò via, lontano (lontano anche da quella ingombrante imbattibile Natura: rigogliosa o riarsa o minacciosa di lave e terremoti e sempre troppo imparentata con qualche Assoluto: sempre comunicante con l’inutilità del fare, con un impietramento, con l’oblio); via verso la Storia, il cambiamento, una vita di impegno, di lavoro; epperò adesso, dopo tanti anni, lo schiaccia un peso più gravoso e sono «rimorsi», ancora: ma «un infinito tempo» di quelli e di «orrori, fughe, follie, vergogne» (OO, 16). Sembra insomma accusarsi, Consolo: lui che dalla Sicilia partì per andare a vivere, per scrivere a Milano. Si accusa di essere fuggito – ma non crediamo che intenda semplicemente dall’Isola; piuttosto, ci sembra, di non aver fatto quanto andava fatto, o comunque non abbastanza per evitare la frana di una civiltà, di una cultura (ma poi che cosa può in concreto sulla vita, sulla Storia, per la manutenzione del mondo, la penna di uno scrittore, la parola della Letteratura?). E nello smarrimento e nella indignazione, per tagli, in un lunghissimo e angoloso plahn tra cronaca e poesia, veramente nell’Olivo Consolo corre l’Isola intera in un frenetico andare senza soste, con l’urgenza di dirla tutta e dirne lo scempio, quasi che nominare il male lo potesse veramente fermare, o come fosse a salvamento: di lei (Isola e cultura e Storia e mondo) e di sé, di un impegno civile, del lavoro di chi scrive. Però, dall’ira che a volte con fatica monta, e forse ripete le sue parole quasi uguali (pare infatti di stare come fermi, per quanto sempre ci si muova, in questo inferno), da un affanno che è nel dire e maledire, dal lamento continuato, dalla sintassi narrativa che si spezza e ti inciampa (e ti stanca anche, con qualche pesante monotonia) senti che si è incrinata, che è diventata disperata quella superstizione volontaria (o era la fede letteraria) antica.
Certo ha degli slarghi narrativi l’Olivo: a tratti prende la forma e il ritmo del racconto breve e incastona le vicende di nativi, reduci o pellegrini di Sicilia – e tutti come toccati dall’Isola, ammalati (ci sono Verga e Caravaggio, Maupassant, Zummo, von Platen, fra questi ulissidi incupiti o pazzi o moribondi); e pure Consolo continua una sua intenerita o storta e tragica Odissea. Ma il libro è principalmente la cronaca del viaggio dentro una ‘terra guasta’, tutt’altro che vittoriniana: offesa da ignoranza cemento liquami speculazioni e mafie, e chiamata – con l’attuale degrado e con la bellezza violentemente deturpata – a far da emblema di una devastazione in atto, del macroscopico processo che ovunque azzera e imbarbarisce le coscienze cancellando insieme Storia, memoria, umanità e cultura. Più avanti ci fermeremo sui luoghi di questo nervoso periplo siciliano che da Gibellina parte e lì ritorna così chiudendo il suo percorso irregolare e zigzagante: e tante sono le tappe, accomunate dallo stesso orrore, e generalmente articolate sullo schema del confronto, della visione sincronica di un abominevole presente e di un passato splendido e svanito. Però a Segesta, in cima al teatro, lontano dal rumore, dallo spettacolo della reliquia violata e offerta alle mandrie dei turisti distratti, lontano dalla scena in cui si compie simbolicamente una diuturna e commercialissima dissacrazione – a Segesta il viandante dell’Olivo si ferma e sogna; e come sempre accade a questo tristissimo innamorato dell’antico (o potremmo dire del lontano, del perduto) «prova sollievo nella fuga, nel rapimento» (OO, 127). Ma un’altra volta – la terza e ultima sta alla fine del libro – Consolo qui dentro dice ‘io’ (per quanto provi ancora a confonderci indossando un’altra maschera, di un altro ulisside).
Leopardiana al fondo, ma più cupa che in Retablo, è la contemplazione dell’architettura del tempio che si spalanca al cielo «come porta verso l’infinito o come pausa, sosta d’un momento, quale la vita dell’uomo nel processo del tempo inesorabile ed eterno» (OO, 128). E la voce che dice ‘io’ mentre che si smarrisce a guardare il tempio, la notte, le stelle, questa che adesso parla in prima persona (e forse sta ripetendo una cosa che era già dentro le Pietre di Pantalica), sta esprimendo un desiderio di fine, di morte (OO, 128):
[…] all’infinito spazio, mi pongo arreso, supino, e vado, mi perdo […] nella scrittura abbagliante delle stelle, dei soli remoti […]. Rimango immobile e contemplo, sprofondo estatico nei palpiti, nei fuochi, nei bagliori, nei frammenti incandescenti che si staccano, precipitano filando, si spengono, finiscono nel più profondo nero.
Lo stesso che torna nella pagina finale dell’Olivo, quando tra i ruderi, nel teatro allestito sul colle della scomparsa Gibellina antica, si recita un episodio della guerra romano-giudaica, un moderno adattamento della tragedia di Masada narrata da Giuseppe Flavio. Consolo è di nuovo dietro uno schermo, ma in qualche modo crediamo di riconoscerlo nel tono e nei gesti di questi assediati che scelgono di togliersi la vita (OO, 148-9):
Avanza dal fondo Eleazar, il comandante della fortezza, in mezzo ai soldati.
– Da gran tempo avevamo deciso, o miei valorosi, di non riconoscere come nostri padroni né i romani né alcun altro all’infuori del dio… In tale momento badiamo a non coprirci di vergogna…Siamo stati i primi a ribellarci a loro e gli ultimi a deporre le armi. Credo sia una grazia concessa dal dio questa di poter morire con onore e in libertà…Muoiano le nostre mogli senza conoscere il disonore e i nostri figli senza provare la schiavitù…
Narra una voce.
– Così, mentre carezzavano e stringevano al petto le mogli, sollevavano sulle braccia i figli baciandoli tra le lacrime per l’ultima volta, al tempo stesso, come servendosi di mani altrui, mandarono ad effetto il loro disegno.
Tirano poi a sorte chi di loro avrebbe ucciso i compagni.
E così l’ultimo, anche per l’orrore, il rimorso, rivolge il ferro contro se stesso.
I romani, con tute di pelle, con caschi, irrompono sopra motociclette, corrono rombando dentro le crepe del cretto, squarciano il buio coi fari.
Trovano corpi, fiamme, silenzio.
Lo «strazio» del racconto non è dunque servito al viaggiatore dell’Olivo per ritrovare la sua Itaca – mutata è l’isola: non si torna a un mondo che ha smesso di esistere. E l’ultimo soldato di Masada, che uccide i compagni per risparmiare loro il peggio che sicuramente verrà, può solo morire, si uccide. E può essere che il «rimorso» sia in questa resa, in questo abbassare le armi e rivolgerle contro se stesso, nel dovere alle fine ammettere che non c’è speranza o letteratura che tenga.
Guardiamo adesso le occorrenze del termine «rimorso» all’interno dello Spasimo di Palermo. Superato l’esergo eschileo, il testo si apre con una pagina in corsivo che è insieme fuori e dentro il racconto, e in certo modo è la sua chiave. Il nostro lemma è nel paragrafo iniziale (che abbiamo già citato), e tuttavia il proemio vogliamo leggerlo intero. Il tema è ancora quello del viaggio e della colpa, e il ‘tu’ dell’allocuzione non è il lettore (SP, 9-10):
Allora tu, i doni fatui degli ospiti beffardi, l’inganno del viatico, l’assillo della meta (nella gabbia dell’acqua, nella voliera del vento hai chiuso i tuoi rimorsi), ed io, voce fioca nell’aria clamorosa, relatore manco del tuo lungo viaggio, andiamo.
Solca la nave la distesa piana, la corrente scialba, tarda veleggia verso il porto fermo, le fantasime del tempo. La storia è sempre uguale.
S’è placata la tempesta, nella grotta, sulla giara sepolta s’aggruma la falda della spuma. Speri che il cerchio – stimme, macule, lèuci ferventi – quieto si richiuda. Ignora il presagio, il dubbio filologico se per te lontano o dal mare possa giungere. Il segreto che sta nelle radici, nel tronco di quell’albero non sai a chi svelarlo, è vuota la tua casa, il richiamo si perde per le stanze. Avanzi in corridoi di ombre, ti giri e scorgi le tue orme. Una polvere cadde sopra gli occhi, un sonno nell’assenza. Il fumo dello zolfo serva alla tua coscienza. Ora la calma t’aiuti a ritrovare il nome tuo d’un tempo, il punto di partenza:
In the beginning is my end
Ma pure in questa cala urlano sirene, aggallano carcami, approdano navigli clandestini, l’alba apre il volo a uccelli di passaggio. A coppie vanno gendarmi e artificieri, a schiere anime disciolte, a volte si confondono voci volti vie porte d’ingresso e di sortita.
Ricerca nel solaio elenchi mappe, riparti dalle tracce sbiadite, angoscia è il deserto, la pista che la sabbia ha ricoperto. T’assista l’eremita l’esule il recluso, ti guidi la fiamma di lucerna, il suono della sera, t’assolva la tua pena, il tuo smarrimento.
Le marche letterarie forti, l’attacco, slogato in Consolo epperò riconoscibilissimo della Love song of J. Alfred Prufrock («Let us go then, you and I […]») e la memoria aggettivale dantesca (è Virgilio chi «per lungo silenzio parea fioco»; Inf., I, 63) operano già per accumulo, orientandoci contemporaneamente in due direzioni apparentemente divergenti ma contigue e sovrapponibili: un moderno girovagare metropolitano in assenza di senso, e un antico viaggio penitenziale; in entrambi i casi (considerata anche l’epigrafe ‘infernale’ di Prufrock: Inf., XXVII, 61-66) un viaggio nella desolazione, o comunque nel dolore; e a compierlo (almeno così sembra) due viaggiatori tristi ancora sfocati: un ‘tu’ con l’ansia tormentosa di arrivare – ha con sé i doni inconsistenti di ospiti che pare lo abbiano deriso e un viatico che non serve (è la provvista del pellegrino, o la benedizione che si dà ai morenti?): è un ‘tu’ che non ha niente e porta un peso, un carico di «rimorsi» che non gli è riuscito di chiudere da nessuna parte, dentro nessun bagaglio (gli fanno una bufera intorno, devono essergli esondati addosso, perché non ci sono gabbie o sbarre che tengano l’acqua, o che fermino il vento); e poi c’è un ‘io’ di voce «fioca», dice parole che non si sentono nell’aria strepitosa, piena di rumori: e non è nessun Virgilio (sbagliavamo): è un relatore insufficiente, uno che riporta, però a strappi e a brani – forse con poco talento («[…] mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono […].»; SP, 88) – il lungo andare dell’altro.
Qualcuno insomma stanco o forse vecchio (canonicamente «tarda veleggia» la sua imbarcazione) viaggia per qualche placato mare, metaforico o reale (nella «corrente scialba» sembra purgatoriale), naviga verso un «porto fermo», una quiete; e viene da pensare a quella definitiva, alla morte (indipendentemente dai ricordi letterari, che ci sono, cominciando da Petrarca e Foscolo) perché la metafora è semplice: il cerchio che il ‘tu’ spera si richiuda, che non ha ancora concluso il proprio giro e che contiene, come in un crogiuolo, quello che lo ha composto: piaghe e macchie, ma pure luci abbaglianti bianche e ribollenti, può essere la vita; e può essere che il viaggio sia della memoria, che il porto fuori da ogni scorrere, fuori dal mutamento, sia quello che è stato, il passato, i fantasmi – che a riguardarli rivelano una storia «sempre uguale», come fissata in una ripetizione. Pare finita l’erranza, e prende terra questa barca in un riparo, la grotta in cui affiora una «giara sepolta», lambita dalla schiuma – un relitto appropriato alla scena marina, o magari una memoria infantile, un pezzo di storia privata di questo reduce, che è inutile affannarsi a interpretare. Anche se rileva notare che il lemma «sepolta», nello Spasimo, torna due volte soltanto, e sempre associato ad una colpa («colpe sepolte e obliate», SP, 47; «colpa sepolta», SP, 98).
E diventa criptico il discorso rivolto al ‘tu’ dal suo cronista, si fa ellittico: «Ignora il presagio, il dubbio filologico se per te lontano o dal mare possa giungere». Manca infatti il soggetto della proposizione ipotetica: il «relatore manco» non dice cosa possa giungere «dal mare» (evidentemente, lui e questo ‘tu’ silenzioso condividono un codice, si capiscono benissimo), anche se per il lettore l’appiglio alla comprensione sta probabilmente nella figura precedente, nella metafora del cerchio che si chiude. Ma c’è un’indicazione, una traccia letteraria palese che aiuta a sciogliere la contrazione della scrittura mentre che ispessisce e complica la fisionomia del viaggiatore triste. Il «segreto che sta nelle radici» è quanto fonda e tiene la casa di Odisseo: il «letto ben fatto» (Od, XXIII, 189) che non si può spostare e che Ulisse scolpì solido nel tronco di un ulivo centenario («C’era un tronco ricche fronde, d’olivo, dentro il cortile, / florido, rigoglioso; era grosso come una colonna: / intorno a questo murai la stanza […]»; Od, XXIII, 190-192) – la radice è la casa: ciò che uno è, che ha costruito e che trasmette: la vita la storia gli affetti l’esperienza la cultura. Ed è la marca omerica a gettare luce all’indietro sul presagio, la profezia ambigua di Tiresia a Ulisse: la morte (perché era lei il soggetto saltato della proposizione) ti verrà εξ άλός (questo il «dubbio filologico»): «dal mare» oppure da fuori del mare, «lontano» da quello; anche se poi, per questo nostro navigante, solo dal mare la morte può arrivare dacché veramente per lui non c’è terra: l’Odissea è (come nell’Olivo) rovesciata, l’approdo è apparente, imperfetto è il ritorno e la casa è vuota: non c’è nessuno con cui parlare («il richiamo si perde tra le stanze»), nessuno a cui tramandare un «segreto» che non serve.
Forse sulla maceria, nel vuoto, in questa nicchia di niente, ora che non c’è più da andar per mare, affrontare la tempesta, ancora cercare; forse ora che non c’è neanche la rabbia inquieta della giovinezza, ora, nella vecchiezza, in questo porto abborracciato, si può provare a rifare la storia (nella memoria) a cercarne il senso o la crepa: ora che da dove si era partiti si è tornati, per finire. «In my beginning is my end», nel mio principio è la mia fine – e la citazione dai Four quartets di Eliot qui non significa nessuna trascendenza, non allude a nessuna rinascita: sta solo nella pars destruens, come un’epigrafe; ci sta rappresa un’incombenza: un’imminenza (la conclusione è prossima, è vicinissima) e una necessità (l’impossibilità di una conclusione diversa da quella che stava scritta nel principio, o anche il dovere di ripensare a partire da quel principio).
Però la cala del rifugio non ripara dalla pena e non isola dal mondo: a urlare qui non sono le sirene del mito, ma, più prosaicamente, quelle di ambulanze e polizie; e le carcasse che nell’acqua «aggallano» potranno anche essere metaforicamente i punti morti, gli errori, le colpe che mordono il ‘tu’ che si è messo a ricordare, ma assomigliano alle carogne reali del Mediterraneo odierno, le navi a quelle degli attuali contrabbandi e degli sbarchi clandestini. E la ronda di «gendarmi e artificieri», il presidio della zona minacciosa e minacciata dagli ordigni, camminata da «schiere» di «anime disciolte» (significa vaganti? sbrancate? che si disfano? liquefatte?) svelano il quadro presagito dall’inizio (schiere di anime dannate si ammucchiano in attesa di Caronte [Inf, III, 120]; a «schiera larga e piena» [Inf, V, 41] vanno «di qua, di là, di giù, di su», come le mena la bufera) e mostrano la terra desolata dell’approdo, la ‘città irreale’ che in questo libro farà spesso da sfondo (Parigi, Milano, Palermo è lo stesso: «A crowd flowed over London Bridge, so many […] »; «[…] ch’i’ non averei creduto / che morte tanta n’avesse disfatta […]»); e forse il rischio ora è l’allucinazione, la confusione – o il non voler vedere, l’astrazione.
Ma anche se l’inferno batte vicinissimo, pure se la casa è vuota, sparita, anche se non c’è più nessuno ad ascoltare, «riparti»: fruga nella polvere, scava nella sabbia la «pista» che il deserto ha ricoperto (mantieni la memoria) – così dice il cronista di «voce fioca» al reduce sperduto, al cercatore di mappe e di reliquie che dovrà essere assistito dagli angeli strani dell’isolamento e dell’esclusione («l’eremita, l’esule, il recluso») e avrà per guida solo una «fiamma di lucerna» e il «suono della sera»: questo ‘tu’ che nella solitudine, dentro il silenzio, forse nel breve cono di luce di una lampada, somiglia a uno scrittore nel suo studio (l’attitudine è quella, l’immagine è topica); e immediatamente abbiamo pensato a Montale, a lui che con la sardana fuori scatenata, chiuso dentro il guscio, la sfera luminosa del suo pensiero, componeva un diverso (ugualmente amaro, ma quanto più fiero) Piccolo testamento («Questo che a notte balugina / nella calotta del mio pensiero […]. Solo quest’iride posso/ lasciarti a testimonianza / d’una fede che fu combattuta […].»); e ci siamo ricordati di Fortini, che mentre fuori la stessa follia imperversa, la stessa tempesta, in una stanza, al proprio tavolo, traduce le parole di un poeta, si obbliga a farle parlare ancora, a non lasciarle morire:
«Scrivi mi dico, odia / chi con dolcezza guida al niente / […]. La poesia / non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi» (Traducendo Brecht). Non siamo lontani da Consolo: pure se tutto è perduto, scrivi; anche se è dolore, racconta: questo l’invito al viaggio che dà avvio al libro («Allora tu […] ed io […] andiamo»), l’esortazione rivolta al ‘tu’ che forse è semplicemente un doppio dell’ ‘io’, forse è uno scrittore, forse è il protagonista dello Spasimo, forse è Consolo che parla a se stesso. A un ‘tu’ dolente e smarrito che cerca assoluzione («[…] t’assolva la tua pena, il tuo smarrimento»). E deve raccontare una colpa, come Ulisse nell’Olivo – deve scrivere questa storia. Che inizia subito dopo, ma disorientandoci (SP, 11):
E poi il tempo apre immensi spazi, indifferenti, accresce le distanze, separa, costringe ai commiati – le braccia lungo i fianchi, l’ombra prolissa, procede nel silenzio, crede che un altro gli cammini accanto.
L’afflato lirico, il modo scorciato (e il viaggio, la solitudine, gli addii) sono ancora quelli del proemio e difatti sembra che il testo si stia sviluppando esattamente di lì: un’impressione che non dura, perché già al secondo rigo ci accorgiamo di non capire ‘chi’ stia parlando e ‘di chi’ stia parlando. Non c’è più insomma né l’‘io’ né il ‘tu’, bensì qualcuno (un autore) che dice di una terza persona: il soggetto sottinteso (egli) che cammina solo e silenzioso con «le braccia lungo i fianchi» (ha le mani vuote, abbandonate, non ha niente) e che scambia per un-altro-a-fianco-a-sé la sua stessa «ombra prolissa» (che si stampa grande o lunga su una strada o contro un muro di questo paesaggio che non si connota e pare quasi uno spazio metafisico; ma possiamo anche pensarla sovrabbondante quest’ombra, e quindi cascante, stanca). È Gioacchino Martinez il soggetto narrato in terza persona, e certo assomiglia agli attori del proemio: è vecchio, è solo, è uno scrittore smarrito; anche lui tornerà (per finire) alla sua terra (al suo principio), in Sicilia, e non ritroverà la sua isola; e anche lui, che porta un carico di «rimorsi», cerca «remissione» (SP, 12).
Un’altra occorrenza del termine «rimorso» abbiamo incontrato esaminando la sintassi dello Spasimo. Siamo intorno al ’43, dopo lo sbarco americano in Sicilia, quando Martinez ha circa dieci anni. Il padre (con cui il bambino ha un rapporto conflittuale) aiuta un disertore, lo porta in un rifugio; ma i tedeschi li scovano e li uccidono. A rivelare il nascondiglio probabilmente è lo spaventato Gioacchino (SP, 24):
Lo strazio fu di tutti, di tutti nel tempo il silenzio fermo, la dura pena, il rimorso scuro, come d’ognuno ch’è ragione, cosciente o meno, d’un fatale arresto, d’ognuno che qui resta, o di qua d’un muro, d’una grata, parete di fenolo, vacuo d’una mente, davanti alla scia in mare, all’arco in cielo che dispare, di cherosene.
La colpa di cui Martinez sente il peso è quella di aver determinato, «cosciente o meno», la morte del padre (di averla anche in certi momenti, per rabbia, desiderata); ma a noi interessa questa specie di ‘sintomatologia dell’arresto’: l’immobilità, la paralisi, l’«estraniamento» che stanno insieme al «rimorso» e nello Spasimo gli si accompagnano sempre; e dacché il libro tesse una rete sotterranea di simboli, forse non è senza importanza che il posto in cui viene ammazzato il padre di Chino (il posto che da questo momento rappresenta e significa il «rimorso») sia proprio quello in cui il bambino realizza il suo isolamento volontario, la sua fuga dal reale. Ma dobbiamo essere più chiari.
C’è un luogo che si ripete nello Spasimo, un luogo che ogni volta si rifà e torna magari con un nome diverso, ma in fondo è sempre lo stesso, quello in cui Gioacchino si nasconde e sogna. È il suo rifugio segreto, il «marabutto» (viene dagli arabi la parola antica: indicava la dimora dell’eremita, la sua tomba): uno stanzone vuoto – lo strame a terra, la volta a cupola, una parete con le figurine saracene: un ricovero di capre mezzo sepolto dal terriccio, celato dalle frasche. Qui corre e si ripara Chino, ombroso, senza madre; qui si intana in odio al padre o a tutto il mondo, deciso a stare sempre lontano, solo; e nella finta caverna, nella solitudine, dentro la mezza luce la pena si quieta, vengono le figure; e inizia ogni racconto, il cinema, l’incanto (SP, 20):
Corse al marabutto, al rifugio incognito, segreto, ov’era deciso a rimanere sempre, solo, fuori da tutti, il mondo, sempre fino alla morte, avrebbe visto il padre, sì, avuto scorno, rimorso infine, pentimento.
S’accucciò in un lato, contro il muro, riguardò ogni cosa, le figure sul fondo celestino, le tortore fra i rami, i veli trasparenti della donna, i seni tondi, la sciarpa svolazzante intorno al corpo, e il cielo cavo della cuba. Ora la lama non piombava netta traverso la fessura, ma s’effondeva in chiaria lieve, lambiva le pareti, i lippi secchi e freschi, i fiori di salnitro, i gechi squamosi e palpitanti.
Gli si fecero appresso ad una ad una, e insieme circonfuse, tutte le donne, la giovane maestra che leggeva a scuola il suo componimento, Urelia col suo caldo e l’ansia acuta d’aglio, la siracusana bella e pregna di confetto, Lucia dorata e crespa, e la madre bianca più del letto, smunta, straziata, che lenta se n’andava.
Tanti nomi per dire una tendenza alla separatezza che è peculiare di Martinez: questa «tana» (SP, 18), lo «stanzino» in cui si chiude da bambino (SP, 21), il «capanno» che si inventa da ragazzo tra le radici pendule di un ficus: la sfera di «separazione, occultamento, letture fantasie proponimenti, nel meriggio pieno, nel silenzio», la cortina che lo cela e lo protegge mentre spia e vede le cose fuori, da sé distanti (SP, 47); e poi l’oasi «degli innesti e delle chimere sorprendenti» (si badi: in tutta la produzione consoliana il ‘luogo degli innesti’ ha sempre valenza metaletteraria): il giardino della casa di Palermo con le infinite piante e i fiori esorbitanti chiamato a fare da barriera intorno alla «quiete fragile» di Gioacchino ormai adulto (SP, 75), al suo sogno di una «vita sequestrata» (SP, 78) difesa dalla violenza e dall’orrore del presente, conclusa tra gli affetti e la scrittura; e ancora, in certo modo, l’Isola stessa, la Sicilia in cui, anziano, sente il bisogno di tornare per «chiudersi, occultarsi, finire nell’oblio» l’avventura della vita (SP, 53). E una separatezza, seppure differente, è il «silenzio» del vecchio: il rifiuto di scrivere detto in questo lamento come a spigoli d’affanno, con una sorta di precipitosa stanchezza nel modo cumulativo, negli incisi che di primo acchito non si distinguono, nella punteggiatura ‘difficile’ dell’avvio (SP, 37):
S’era chiuso nel silenzio, nel dominio della notizia, invasione del resoconto, scomparsa di memoria, nell’assenza o sordità dell’uditorio, vana era ormai ogni storia, finzione e rimando del suo senso diceva e si diceva. Ma sapeva che suo era il panico, l’arresto, sua l’impotenza, l’afasia, il disastro era nella sua vita.
Vanità dunque è raccontare ancora, ostinatamente parlare quando nessuno ascolta; vanità continuare a fare il ‘letterato’ in mezzo a «chiasso» e «scadimento» (Sp, 37), la «voce fioca» contro l’urlo potente delle mode, dei giornali, delle televisioni, del mercato culturale coi suoi mille imbonitori – per la Letteratura non c’è posto; ma resta che a produrre l’afasia è l’«impotenza» propria, la scrittura insufficiente, che non è servita a niente.
E un’ultima variante. Sempre nella vecchiezza, un giorno, a Parigi, scampando a un’aggressione, Martinez di nuovo si nasconde: trova riparo «in una cantina fatiscente, davanti a un film osceno»; ed è solo una contingenza, da quel luogo uscirà immediatamente, però pronunciando un ‘atto di dolore’ o una sorta di anatema, inorridito, più che dalla scena squallida, da se stesso: «Viltà di sempre, fuga dal reale, menzogna e adattamento. Via dalla caverna del rifugio, fuori per la porta d’emergenza […]» (SP, 43). Forse insomma nella
«caverna del rifugio» si annida il ‘vizio’, la viltà, la colpa che sta al fondo.
«Rimorso» ed estraneazione appaiono di nuovo affiancati, e cominciano a chiarire un legame stretto, nel colloquio tra lo scrittore e Mauro, da tempo rifugiato in Francia; il figlio nei cui confronti Martinez sente di aver fallito come padre, e che lo giudica con una punta di sufficienza, forse di disprezzo. La prima battuta è di Gioacchino (SP, 53-54):
« […] Il tempo, la memoria esalta, abbellisce ogni pochezza, ogni squallore, la realtà più vera. Per la memoria, la poesia, l’umanità si è trasfigurata, è salita sull’Olimpo della bellezza e del valore.»
«Ne hanno combinate i letterati!» ironizzò Mauro.
C’era stata ancora intenzione nella frase? Sospettava o aveva conoscenza? Rapida si presentò, unita come sempre al suo rimorso, emblema fisso d’ogni astrazione, latitanza, la sagoma bianca del fantastico bibliotecario, del cieco poeta bonaerense ch’era andato quella volta ad ascoltare nell’affollato anfiteatro.
«Che c’è, s’è risentito lo scrittore?» fece il figlio.
«Sai bene che non sono più scrittore, se mai lo sono stato. Ma perché ti rivolgi sempre a me in modo impersonale? Mai per quel che sono, tuo padre.»
«Padre si trova solo nei romanzi, nelle tragedie […]. Ma che discorsi, che discorsi… siamo tornati indietro di un po’ d’anni, tu giovane, io adolescente…» e rise Mauro.
«È il mio vizio, lo sai, la mia paralisi.»
Viene punto nel vivo il «letterato»; e il suo trasalire ha a che fare con le pratiche della trasfigurazione artistica, della compensazione estetica, col tarlo di una ‘finzione’ che intimamente lo rode; ma probabilmente c’entra anche il «tornare indietro», lo stare sempre fermo sui suoi assilli; e c’entra che il figlio non lo chiami ‘padre’, gli neghi quel nome, la funzione di chi indica la strada, educa, guida, addita una direzione. Il «vizio», la «paralisi» che Martinez confessa è poi la scrittura, questo luogo suo di arresto (la sua compensazione, il suo rifugio); e sta direttamente in rapporto con un «rimorso» di cui Borges è l’«emblema»: la «sa goma bianca» (quasi una apparizione, uno spettro) in cui si incarnano del pari «astrazione» e «latitanza». Borges che incantava con gli scacchi, gli specchi, le immense biblioteche impossibili e sperdenti, i labirinti, i libri magici, i giochi della mente: con l’infinito proliferare della Letteratura da se stessa, l’autofecondazione inarrestabile (mostruosa) che partorisce favole, trame, sogni, enigmi irrisolvibili, in una condizione di totale autosufficienza – di allontanamento dal mondo, di separatezza. E non a caso Borges più avanti ritornerà associato a una «illusione rovinosa» (SP, 80): quella di Mauro perduto dietro l’esaltazione politica negli anni della contestazione studentesca, ma più in profondità la propria, quella di lui, Martinez: «inerte, murato» e ugualmente perduto nell’inseguimento di un miraggio, dietro a un «folle azzardo letterario» (SP, 126). E nel continuato ‘esame di coscienza dello scrittore’ che è lo Spasimo, durissimo e costante (ossessivo) è l’autoaccusarsi del protagonista. Si guardi a questo stranito e quasi-teatrale dialogo ancora tra il padre e il figlio. Le parentesi valgono a riportare il non detto, il non espresso nel colloquio; ma forse siamo di fronte a una specie di Secretum. Inizia Mauro (SP, 35):
« […] ti trovo bene, un po’ più magro…»
«La vecchiaia… […] anticipa poi l’ulteriore smagrimento, e assoluto.»
«Di chi queste allegrie?»
«Mie, solo mie.»
«Fai progressi. Ancora un poco e sei alla poesia.»
(Sempre uguale la tua ironia, costante il tuo rifiuto d’ogni incrinatura, cedimento) (Il tuo lamento, il tuo bisogno di aggrapparti)
(Ti sei nutrito d’astrazioni, dottrine generali, ed ostinato credi che ancora possano salvare)
(Le parole con cui ti mascheri e nascondi sono solo una pazzia recitata, un teatro dell’inganno)
Si può dedurre che Martinez rimproveri al figlio l’eccessiva durezza e una pervicace astrazione ideologica (ma il testo è volutamente ambiguo: «nutrito d’astrazioni», in fondo, è pure lo scrittore con la sua chimera, la sua ‘missione letteraria’); e che a sua volta Mauro ferocemente e silenziosamente irrida il padre, il costante suo «lamento», il tono da tragedia, il patetico ostinarsi a interpretare un ruolo intellettuale mancato o inconsistente, l’insufficienza ad agire sulla storia, i destini, il presente; che disprezzi le parole dietro le quali il vecchio ha mentito e si è nascosto (e dopotutto ancora e sempre è evaso, si è consolato, dal reale si è allontanato: fuori del mondo ha sognato come nella tana antica, nel marabutto). E certo potrebbe essere così: ma dimenticheremmo che molta parte del dialogo (tutto il sottinteso) si svolge in interiore homine, e che probabilmente è solo Martinez a riempire i vuoti della conversazione coi suoi implacati assilli, con l’orrore che ha di sé. Tanto più che nello Spasimo, ad ogni occasione, questo scrittore che non può e non vuole più scrivere, di sé fa strazio: non salva niente. Impietosamente liquida la propria opera: poco talentuosa, perduta «nel ri stagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono…» (SP, 88); e tutti i suoi libri (che poi, richiamati dal testo, sono veramente i libri di Consolo) definisce «storie perenti, lasche prosodie, tentativi inceneriti, miseri resti della sua illusione, del suo fallimento» (SP, 66).
Ha «ripugnanza» della propria scrittura Martinez (SP, 66): di un piacere estetico atteggiato a impegno intellettuale e che invece era latitanza, astrazione, mascherata viltà. E non ha salvato nessuno: la moglie dalla paura, il figlio dalla violenza, il presente dal disastro.
«Rimorsi» assalgono Gioacchino che ancora pensa al figlio, al «candido ribelle» col quale non ha mai saputo parlare e che non è stato in grado di sorreggere, di aiutare, di avvisare dei rischi di una ideologia che poi tutti i più puri ha tradito; pensa a Mauro che scampando il carcere è fuggito dal paese e «da ogni padre imbelle, ipocrita e impotente» (SP, 89) – si è allontanato da lui, Martinez (SP, 81):
S’affrettarono i giudici a dichiarare «il padre no, non c’entra». E invece sì. Come ogni padre, ogni complice allora di quel potere, di quello stato, ogni responsabile della ribellione, dei misfatti di quei giovani.
È un nodo importante dello Spasimo questa tragica e inabile figura paterna: è un’immagine speculare dello scrittore che ha fallito il suo compito, il suo dovere di guida. Poi fallirà anche l’altro che lo stesso dovere incarna, il giudice – all’inizio del libro, Judex, il personaggio di un film muto, è l’eroe del bambino Chino: un portatore di giustizia, un riparatore di torti; e nella conclusione dello Spasimo un magistrato in carne ed ossa che ne ricorda un altro da vicino, che come Borsellino muore in un attentato (e insieme a lui Gioacchino) e soccombe non per sua incapacità o viltà, ma perché lo uccide la mafia, perché è più forte il mondo.
Come scrittore, come padre e come giudice ‘insufficiente’, Martinez si accolla la responsabilità e porta il peso della rovina che non ha fermato – l’attuale degrado, l’involuzione culturale, la perdita di valori, la bestialità e la volgarità imperanti; e lo sbando di una generazione «incenerita», sì, «da un potere criminale», ma smarrita e perduta perché «figlia di padri illusi» anch’essi naufragati (SP, 39): quelli che dopo la guerra «avrebbero dovuto ricostruire […] formare una nuova società, una civile, giusta convivenza» (SP; 126).
Alla fine prende la penna, Gioacchino, e scrive al figlio (SP, 126-128):
Abbiamo fallito, prima di voi e come voi dopo, nel vostro temerario azzardo.
Ci rinnegate, e a ragione, tu anzi con la lucida ragione che ha sempre improntato la tua parola, la tua azione. Ragione che hai negli anni tenacemente acuminato, mentre in casa nostra tenacemente rovinava, nell’innocente tua madre, in me, inerte, murato nel mio impegno, nel folle azzardo letterario.
In quel modo volevo anch’io rinnegare i padri, e ho compiuto come te il parricidio. La parola è forte, ma questa è.
[…] rimaneva in me il bisogno della rivolta […] nella scrittura. Il bisogno di trasferire sulla carta […] il mio parricidio, di compierlo con logico progetto […] per mezzo d’una lingua che fosse contraria a ogni altra logica, fiduciosamente comunicativa, di padri o fratelli – confrères – più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili del disastro sociale.
Ho fatto come te, se permetti, la mia lotta, e ho pagato con la sconfitta, la dimissione, l’abbandono della penna.
Compatisci, Mauro, questo lungo dire di me. È debolezza d’un vecchio, desiderio estremo di confessare finalmente, di chiarire.
La lettera poi si interromperà, forse la confessione non è intera; ma il «rimorso» di Martinez lo conosciamo ormai: la coscienza di non aver salvato niente, di non aver fatto abbastanza col proprio mestiere letterario (ed era già la colpa dell’Olivo) che si accompagna a un acre giudizio di sé, alla condanna feroce della propria scrittura tutta ridotta a menzogna, autoinganno, fuga dal reale, sonorità e cascame.
E siamo arrivati all’ultima occorrenza del «rimorso» e finalmente alla terza e ultima luna di Consolo, con Gioacchino che ritorna in Sicilia:
Tornava nell’isola, il porto da cui era partito, in cui si sarebbe conclusa la sua avventura, la sua vita. Disvio, mora, sottrazione, anestesia, tormento della sorte […]. Vita ferita […]. Spoglia sospesa alla fronda lenta, all’inganno, al miraggio letterario.
Ma ogni viaggio, sapeva, era tempesta, tremito, perdita, dolore, incanto e oblio, degrado, colpa sepolta, rimorso, assillo senza posa.
Era la notte placida, le stelle, l’immacolata luna, la primavera dei risvegli, l’alba della promessa, l’amore che invade, trasfigura […].
Era il miracolo dell’arte, la consolazione della ginestra, il fraterno affetto, la mano porta al naufrago, l’idea fresca, collettiva di volgere la storia, lenire l’esistenza.
È vero che lo Spasimo somiglia alla poesia: lo attesta anche la struttura grafica di questa pagina (SP, 98-9) in cui l’a capo è quello di una composizione in versi liberi, non di un romanzo o di un racconto. Bisogna intendere: «ogni viaggio […] era tempesta […] era la notte placida […] era il miracolo dell’arte […]»; e il «viaggio» del testo, dello scrittore e padre fallito Gioacchino Martinez e della sua vita «sospesa […] all’inganno, al miraggio letterario», è la scrittura: la fabbrica delle consolazioni, l’incanto artificiale, il sogno indotto della «immacolata luna». Lei che è astrazione e latitanza, rifugio, oblio colpevole e «rimorso, assillo senza posa», Lei questo spasimo.
Sull’inutilità e il danno della letteratura, sui consuntivi amarissimi, disperatamente in negativo, in tanti hanno già fatto storia: Verga fingeva di scrivere, chiuso nel silenzio offeso degli ultimi anni a Catania; e prima di lui Foscolo scomponeva e ricomponeva nevroticamente le Grazie senza poterle mai finire; Manzoni disprezzava e negava il suo romanzo – «tiritera» lo chiama, «cantafavola»[11], menzogna; l’elegantissimo Leopardi gettava al macero tutte le illusioni col Tristano, e nel Tramonto della luna faceva precipitare l’astro bianco, a morte metteva la sua Regina antica, la seppelliva: e con lei la propria voce, il desiderio, il canto, il cuore. C’entra naturalmente l’esperienza, la maturità (che «senz’altra forza atterra»), c’entra anche la vecchiezza in Consolo, la perdita fisiologica dell’entusiasmo. Ma la scrittura dello Spasimo, o diciamo meglio, la questione dello spasimo di questa scrittura faticosa e contratta, e difficile per dolore, non può andar disgiunta da un particolare malessere che si produce in chi si ostini, oggi, a fare Letteratura alta e civile – cose, oggi, entrambe azzardate e anacronistiche.
Può essere che in assenza di un uditorio reale, a furia di parlare per o con se stesso, il poeta moderno finisca col dimenticare o col prendere per favola l’urgenza stessa e il valore del suo dire; che addirittura finisca col credere di aver recitato (di aver mentito) per vanità e gusto di esibizione, per il piacere solitario della forma splendida e sonante. E può essere che il disincanto che sta in ogni vecchiezza, assieme alla indisponibilità totale e vera della contemporaneità, abbiano spinto Consolo ad una severità eccessiva, e come a travedere: ad accusarsi, intendiamo dire, di colpe che forse aveva anche rasentato, ma che non gli appartenevano. Perché non era finta la sua disperazione, e neppure erano finti l’impegno, l’arte, l’indignazione; eppure questo autore non ha avuto nessuna pietà per la sua opera, per il suo mestiere: «lasche prosodie», ha detto delle sue cose, lo ripetiamo, «rifugio», «vizio dell’assenza», «vanità», «colpa», «malattia».
Lasciamo stare quanto potesse essere necessario a Consolo un rasciugamento, o quanto la ‘autocorrezione’, lo scarnimento dello Spasimo lo abbiano preservato dal rischio di farsi eco di sé, della lamentazione estenuata o di una barocca e vorace esmesuranza. La parabola di questa scrittura, il suo ridursi a una nuova e scabra essenzialità rinunciando all’alone favoloso, alla meraviglia e anche all’orpello, è un approdo che comunque sorprende, pure se viene dalla stanchezza; ed è una evoluzione, uno scatto, un movimento anomalo e vitale all’interno dell’ambito generalmente conservativo della prosa. Un modo diverso, che già faceva le prove nelle Pietre e nell’Olivo, assai lontano dai lenimenti classici e barocchi, dai sogni della luna, dai fasti tutti d’oro e neri al fondo di Retablo, del Sorriso; ed è la forma più dura e acuminata di una tragedia da sempre percepita ma che adesso alza i toni; e nella sua bellissima nudità è la voce più dolente dell’autore, e la più sincera.
Però resta l’impressione che Consolo abbia attinto la sua nuova maniera come punendosi, tagliandosi la vena che era sua di vertigine e cascame, di febbrile incessante e violentissimo rigoglio; e che della lingua propria abbia finito col provare fastidio, quasi il rimorso di una cosa falsa; e per questo abbia preso a resecarla, fino al rischio di cancellarla. Come con l’intento di adeguarla al silenzio furioso che si è sentito intorno.
Claudia Minerva
[1] E. SICILIANO, Lo Spasimo di Palermo, «La Repubblica», 11 novembre 1998; poi in L’isola. Scritti sulla letteratura siciliana, Manni, Lecce 2003.
[2] Tutte le citazioni da Consolo recano tra parentesi la sigla e il numero arabo che individuano il luogo da cui la citazione è tratta. Queste le sigle (tra parentesi quadre indico la prima edizione; fuori della parentesi quadra è data l’edizione di riferimento):
SIM = Il sorriso dell’ignoto marinaio [1976], Mondadori, Milano 2002.
LUN = Lunaria [1985], Mondadori, Milano 2003.
PP = Le pietre di Pantalica [1988], Mondadori, Milano 1990.
OO = L’olivo e l’olivastro [1994], Mondadori, Milano 1999. SP = Lo Spasimo di Palermo [1998], Mondadori, Milano 2000.
Altre citazioni sono da OMERO, Odissea (trad. R Calzecchi Onesti), Einaudi, Torino 1963; DANTE ALIGHIERI,
Inferno; T.S. ELIOT, The Waste Land. Le sigle adoperate sono rispettivamente Od, Inf, WL.
[3] Sulle molte versioni del testo I barboni, scritto da Consolo per il catalogo dell’artista Ottavio Sgubin, cfr. D. O’CONNELL, Consolo narratore e scrittore palincestuoso, «Quaderns d’Italiá», 13, 2008, pp. 161-184. Riassumendo: Barboni, simbolo inquietante del nuovo medioevo, «Il Messaggero», 3 marzo 1996; poi, Barboni e Natura morte, in Sgubin, Opere 1988-1997, Marsilio, Venezia 1997; poi, in Ottavio Sgubin, edizioni Mario Jerone, ottobre 1999; poi, Barboni, segno dei nostri fallimenti, «L’Unità», 29 Ottobre 2003; infine I barboni di Ottavio Sgubin, in Ottavio Sgubin pittore, aprile 2003.
[4] Sono del tutto assenti nello Spasimo i due punti e il punto e virgola; raro è l’impiego del punto interrogativo, dell’esclamativo e dei puntini di sospensione fuori delle (poche) battute di dialogo; sporadico (ricorre una decina di volte) l’uso del trattino.
[5] Cfr. M. ONOFRI, Nel magma italiano: considerazioni su Consolo scrittore politico e sperimentale, in (a cura di) E. PAPA, Per Vincenzo Consolo, Manni, Lecce 2004, pp. 59-67. Diversamente, ci sembra, all’indomani della scomparsa di Consolo e sull’aver presentito, nello Spasimo, un «congedo» dell’autore, cfr. ancora M. ONOFRI, Vincenzo Consolo, scrittore antagonista in lotta con il potere, «La Nuova Sardegna», 24 gennaio 2012.
[6] Cfr. G. FERRONI, Il mondo salvato da uno scriba, in «Corriere della Sera», 30 novembre 1998. Di ‘romanzo’ parla Ferroni (di una «dizione essenziale» dello Spasimo) e insieme di pagine «volte verso una liricità lacerante», di una «prosa poetica» che addensa su di sé la fatica dell’esistenza, della storia, della cultura, dell’alterarsi del mondo»: una spinta a narrare continuamente controllata dal «rifiuto dell’illusione del narrare», contigua alla fluida disponibilità al racconto tipica di certa disinvoltura postmoderna. In questo libro che «sgomenta», tuttavia, il critico legge tuttavia un segno di speranza nella «ostinata narrazione poetica», nel dialogo con la grande Letteratura, nell’ostinarsi delle parole, nel loro insistere e resistere a cercare giustizia e verità, come mostrerebbe la preghiera muta con cui il libro si chiude: «O gran manu di Diu, ca tantu pisi, / cala, manu di Diu, fatti palisi!». Cfr anche L. CANALI, Che schiaffo, la furia civile di Consolo, «l’Unità», 7 ottobre 1998. Lo Spasimo è forse «il più bello» dei libri di Consolo, dice lo studioso; è «il più duro e compatto»; ed è «un violento schiaffo» a tanta odierna «letteratura di basso consumo». È testo «impervio», «orgoglioso», «difficile»; simile (dice Canali) a una alternanza di deverbia e cantica, come nella tragedia e nella commedia antiche; ed è pieno di una poesia amarissima, «consapevole della inesorabile sconfitta, non solo personale, ma collettiva, delle istituzioni, dello Stato, dei pochi giusti destinati a soccombere alla violenza criminale o alle tresche segrete dei potenti. E questa attitudine è un altro schiaffo dato a chiunque, nel ‘mondo delle lettere’ non creda più nell’impegno civile e anzi talvolta lo beffeggi. È dunque una singolarità, questo ‘romanzo’ di Consolo: ad un massimo di tensione stilistica, semantica, lessicale, culturale, che potrebbe sfociare in un parnassianesimo fatto di essoterismo estetizzante, corrisponde invece un massimo di denuncia sociale sia pure consapevole della probabile inutilità del proprio sacrificio. Mai, come in questo libro, la furia, questa sì dissacrante, di Consolo, e il romanticismo idealistico della sua ispirazione, si erano tanto avvicinati alla lezione dei ‘classici’».
[7] Riportiamo la bella intervista rilasciata da Consolo ad A. Properi nel 1992 (V. CONSOLO, Il suddetto e i parrucconi, «L’Indice», 5, 1992). Sul mondo della letteratura di oggi e i suoi meccanismi editoriali così si esprime lo scrittore siciliano: Diciamo letteratura, ma dobbiamo intendere narrativa, romanzo o racconto. Ché, la poesia, imperturbata e ignorata, procede sempre più nella sua sacra lontananza, nel suo infernale Eliso o nel suo celeste Olimpo. Procede, lei figlia della Memoria, verso l’oblio, in questo nostro presente immenso dell’estrema frontiera del profitto. Presente che ha mutato ogni valore in merce, ogni espressione in assoluta, squallida comunicazione. Il romanzo sta morendo o è già morto (no, non è il ritornello avanguardistico) e mai come oggi si sono prodotti tanti romanzi, mai se ne sono consumati così tanti. E ognuno d’essi è imbonito come capo d’opera, come sommo frutto della più autentica letteratura, ognuno è imposto come indispensabile all’esistenza o quanto meno alla permanenza nello stato sociale in cui ci si è posti. Produce così, l’industria, come avviene per ogni altra merce, il romanzo per le masse, tristi e misere imitazioni d’altri tipi di moderne narrazioni, giornalistiche o televisive, e il romanzo di lusso per l’élite, riproposte di vecchie, già sepolte squisitezze letterarie, neorondismi di professori pensionati o neomanierismi di anemici o brufolosi scolaretti. I quali, professori e scolari, frenetici cottimisti, solitari e alienati lavoratori a domicilio, sono obbligati a produrre sempre più affannosamente per essere sempre più presenti nell’affollata e vociferante borsa dei “titoli”, sempre disponibili nel modesto mercatino rionale o nelle grandi fiere internazionali; sono obbligati a calcare pateticamente ribalte, a cavalcare tigri, a urlare, farsi inverecondi finanche nelle finte, recitate ritrosie. Chi in questa sede è invitato a confessarsi dichiara allora che, dotato di una forte inclinazione a delinquere, ha cercato, fin da quando ha mosso i primi passi nel territorio letterario, di violare le leggi oppressive della comunicazione e del mercato. Ha scritto poco e in un modo in cui la comunicazione era ridotta al minimo necessario, spostando proditoriamente la sua scrittura verso l’espressione, la forma incongrua e irritante della poesia, praticando un linguaggio che fa a pugni, stride fortemente con il codice linguistico stabilito dal potere; s’è tenuto sempre igienicamente lontano dalle accademie, dalle consorterie, dalle massonerie, dai gruppi d’ogni sorta, d’avanguardia o retroguardia. Tutti questi delitti hanno fatto sì che i tutori dell’ordine lo punissero, che i gendarmi lo tenessero sotto controllo come elemento antisociale. Così a ogni rara uscita, a ogni nuovo libro del suddetto, i parrucconi, i piazzisti della merce, istericamente si scompongono, cominciano a urlare: “È siciliano, non scrive in italiano, è barocco, è oscuro, è pesante come una cassata, le sue narrazioni non sono filate, fruibili: ma chi crede di essere, ma come si permette?.
[8] Cfr. «Il Piccolo», 11 giugno 2011; «La Repubblica», 30 giugno 2011.
[9] Una stroncatura viene da C. TERNULLO, Vincenzo Consolo, Dalla ‘Ferita’ allo ‘Spasimo’, Prova d’Autore, Catania 1998: parla di «scadimento», il critico; di una «pertinace sentenziosità» dell’autore che insisterebbe a «farsi ‘cattiva coscienza’ dei tempi» senza però possedere l’equilibrio di Sciascia; e di una «chiara disunità» del libro, di un «accostamento forzato e insincero dei segmenti narrativi» (p.66-7), di un rasentare l’horror nella descrizione della vecchiaia (p. 69) – giudizio ingeneroso e quasi intemperante, come si vede; e del resto, ognuno ha il proprio (ricordiamo comunque a Ternullo che le «voci di dannunziana memoria» alle quali si riferisce a p. 42 del suo libretto, sono leopardiane).
[10] SP, 70: «Quel contrapposto di gale e di cenci, di vanità e miseria»; segnalata dalle virgolette basse, è citazione dal capitolo XXVIII dei Promessi sposi, con la carestia a Milano.
[11] È quanto Manzoni scrive a Monti (15 giugno 1827) e a Cioni (10 ottobre 1827); lo leggo in A. LEONE DE CASTRIS, L’impegno del Manzoni, Sansoni, Firenze 1965, p. 246.