Tag: Sicilia
I riflessi letterari dell’Unità d’Italia nella narrativa siciliana
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura Universitat de Girona
I riflessi letterari dell’Unità d’Italia nella narrativa siciliana Director professor Giovanni Albertocchi Treball final de recerca de Annunziata Falco febbraio 2009
1 Introduzione Questo lavoro di ricerca si propone di offrire un inventario ragionato, di romanzi e novelle di autori siciliani, da Verga alla Agnello Hornby, diversi tra loro per età, cultura e condizione sociale, per rendere evidente la persistenza della riflessione sull’idea del Risorgimento “tradito”, in romanzi ambientati negli anni che vanno dal 1860 al 1894, dallo sbarco dei Mille di Garibaldi in Sicilia alla repressione violenta dei Fasci. Gli autori prescelti, hanno in comune una esperienza di allontanamento dalla Sicilia, per brevi o lunghi periodi a Roma o a Milano, che coincide spesso con il periodo più creativo sul piano letterario, alla ricerca forse di una integrazione,che non ci fu,con gli ambienti culturali italiani, del “continente”. Comune è in loro l’ attenzione ad un ricostruzione degli avvenimenti attraverso i documenti ma anche attraverso la memoria personale e quella familiare dei fatti, comune è la scelta della narrazione storica, rivitalizzata, dopo l’esperienza risorgimentale, che permette di inserire materiali storici assieme a vicende e personaggi inventati, per ricreare un ambiente, una società, una mentalità, una realtà, come quella del Sud così poco conosciuta, con riferimenti precisi, documentati. Negli scrittori prescelti, appare evidente un’ansia di tornare su avvenimenti, sufficientemente vicini per poter capire e per poter far capire, per raccontare e forse per “educare”un pubblico borghese, un pubblico, che però non sempre accolse favorevolmente delle opere che, spesso, non erano in sintonia con il proprio tempo, troppo polemiche, negative, che registravano l’immobilismo di una società, il fallimento della borghesia, anche nel campo dei sentimenti privati, all’interno della famiglia. La necessità di fare i conti con il nostro recente passato, di capire come sia stata possibile un’Unità politica ed istituzionale che non ha avuto ragione delle differenze(anzi le ha acuite)tra Nord e Sud, è sempre più presente tra gli scrittori contemporanei, siciliani e non solo, e le opere dei grandi autori continuano a “fare scuola”, ad essere un modello di riferimento. L’idea,che è sottesa a questo lavoro, è proprio di presentare materiali che possano essere utilizzati in un successivo lavoro di approfondimento, su temi che emergono dai romanzi prescelti. Oltre le essenziali note biografiche e critiche sugli autori si è ritenuto importante presentare delle note storiche di confronto
Estratto.
Vincenzo Consolo.
Vincenzo Consolo,che ama considerarsi “figlio di Verga, l’inventore linguistico per eccellenza “ inizia a scrivere Il sorriso dell’ignoto marinaio nel 1969, ma lo pubblica solo nel 1976. Il libro viene subito salutato come “ il rovescio progressista del Gattopardo” da contrapporre all’immobilismo di Tomasi di Lampedusa . L’immagine dell’Italia è subito rivoluzionaria, la fidanzata di Interdonato, Catena, ha ricamato su una tovaglia un’Italia con dei vulcani al fondo, che inizialmente sembravano delle arance «Sì,è l’Italia»confermò l’Interdonato. E le quattro arance diventarono i vulcani del Regno delle Due Sicilie,il Vesuvio l’Etna Stromboli e Vulcano. Ed è da qui,vuol significar Catena,da queste bocche di fuoco da secoli compresso,e soprattutto dalla Sicilia che ne contiene tre in poco spazio,che sprizzerà la fiamma della rivoluzione che incendierà tutta l’Italia Si tratta di un vero romanzo politico, pienamente all’interno della linea della narrativa storica siciliana, il cui intento è quello di raccontare l’Italia degli anni Settanta attraverso un romanzo ambientato nel 1860, ai tempi dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il romanzo è ricco di materiali testuali eterogenei, come testi documentari, citazioni ironiche, che spezzano l’organicità del romanzo storico e con essa la pretesa dell’autore di governarne e spiegarne l’intreccio, insieme alla pretesa di governare la realtà e la storia. Il romanzo nasce mentre Consolo lavora a Milano e, come Verga, prova uno spaesamento iniziale per la nuova realtà urbana e industriale, la lontana Sicilia gli appare una pietra di paragone, un microcosmo nel quelle far riflettere temi e problemi di ordine universale. Il romanzo storico, e in specie il tema risorgimentale,passo obbligato di tutti gli scrittori siciliani,era l’unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente,le sue istanze e le sue problematiche culturali(l’intellettuale di fronte alla storia,il valore della scrittura storiografica e letteraria,la “voce” di chi non ha il potere della scrittura,per accennarne solo alcune) . Il sorriso dell’ignoto marinaio, che Consolo considera un omaggio a Morte dell’inquisitore di Sciascia, nasce da tre fattori di base: il fascino esercitato dal quadro di Antonello da Messina Ritratto d’ignoto, che è conservato nel Museo Mandralisca di Cefalù;la rivolta di Alcàra nato nel 1933,Sant’ Agata di Militello, in provincia di Messina in una “isola linguistica” gallo-romanza, abitata da discendenti di popolazioni lombarda,trasferito a Milano dal 1968,dove diventa consulente editoriale 295Milano, P.,Un Gattopardo progressista,«L’Espresso»,4 luglio 1976 Consolo, Vincenzo,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.53 In Lunaria vent’anni dopo,Valencia:Generalitat Valenciana-Universitat de Valencia,p.66 80 Li Fusi, avvenuta nel 1860, e un’inchiesta sui cavatori di pomice, che si ammalano di silicosi, che Consolo conduce per un settimanale. A questi si uniscono il dibattito politico e storico sul tema del “Risorgimento tradito”, sulla continuazione della secolare oppressione sotto una nuova veste, un dibattito che si stava ormai trasformando nella consapevolezza dell’esistenza di un secondo Risorgimento non compiuto e tradito: la Resistenza. I personaggi principali sono il barone Enrico Pirajno di Mandralisca, malacologo e collezionista d’arte, che era stato deputato nel 1848, un uomo che dovrà scendere nel carcere, labirintica chiocciola, per passare da un generico riformismo alla comprensione per le esigenze popolari, e l’avvocato Giovanni Interdonato, integerrimo rivoluzionario giacobino, esule dopo il ’48, impegnato a far da collegamento tra i vari gruppi di esuli e i patrioti dell’isola. I due si incontrano su una nave, nel 1852, dopo che il barone ha ricevuto in dono il Ritratto d’ignoto, attribuito ad Antonello da Messina, che la tradizione popolare chiama dell’Ignoto marinaio Mandralisca riconosce in Interdonato il sorriso ironico,pungente e amaro dell’uomo del dipinto, un sorriso che lo richiama continuamente all’azione politica, “il sorriso dell’intelligenza che si può rivolgere alla storia(e alla storia narrata nel romanzo).” I due personaggi si ritrovano in occasione della rivolta di Alcàra Li Fusi e del successivo processo, il barone prenderà le difese dei contadini insorti, che si sono mossi contro La proprietà,la più grossa,mostruosa,divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo e chiederà di aver clemenza a l’Interdonato, che doveva giudicare i rivoltosi, e lui estenderà loro l’amnistia, ritenendo la rivolta un atto politico. Consolo mette al centro del romanzo un aristocratico intellettuale, che riflette e giudica con un certo distacco, che può essere paragonato al principe Salina, ed un giovane rivoluzionario, l’Interdonato, che potrebbe richiamare molto lontanamente la figura di Tancredi, ma il rapporto tra i due personaggi, che era in Lampedusa di contrasto anche generazionale, nel romanzo di Consolo diventa un rapporto dialettico, Interdonato nella seconda parte della storia cercherà di indurre l’altro all’impegno. Negli anni Settanta, oltre alle critiche al mito risorgimentale, vi era stata una riscoperta anche storica dei fatti rivoluzionari, Sciascia, lo ricordiamo,aveva promosso la riedizione del lavoro di Radice sui fatti di Bronte, Vincenzo Consolo dando spazio alle rivolte contadine duramente Fu segretario di Stato per l’interno con Garibaldi,poi Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo e Senatore del Regno nel 1865. Roberto Longhi,storico dell’arte,polemizzava con la tradizione popolare perché i quadri era dipinti su commissione e quindi quello raffigurato non poteva che essere che un signore,un ricco. Segre, Cesare, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino:Einaudi,1991,p.73 Consolo Vincenzo ,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.118 81 represse, quella di Cefalù, del 1856 e quella di Alcàra, del 1860, segnala la differenza tra i moti borghesi di ispirazione carbonara e le sollevazioni contadine, in cui si rivendicava la terra, in cui ci si voleva liberare del peso dei balzelli e dell’usura, e che sfociavano in esplosioni di sangue. Ad Alcàra, dopo la rivolta e l’eccidio, sarà un Interdonato, generale garibaldino cugino dell’altro Giovanni Interdonato, a disarmare e imprigionare i rivoltosi, e sarà il castello di Sant’Agata di Militello, con i suoi sotterranei elicoidali, che li ospiterà. Il castello Immensa chiocciola con la bocca in alto e l’apice in fondo,nel buio e putridume La metafora della chiocciola,come ha notato Segre, attraversa tutto il romanzo e rappresenta l’ingiustizia, i privilegi della cultura, ed acquista una valenza di autocritica nei confronti di Mandralisca che se ne occupa, con amore, nelle sue ricerche. Vincenzo Consolo, rifiutandosi di narrare ciò che era stato già narrato, lascia spazio ai documenti, alle lettere, alle memorie attribuite a personaggi realmente esistiti ma inventate, che hanno il compito di sintetizzare gli avvenimenti, mentre il narratore deve soffermarsi sugli episodi, concedendosi il tempo della riflessione e della descrizione. La struttura del romanzo storico è quindi profondamente modificata, l’impasto linguistico è mirabile, l’effetto non è realistico. Nel 1968 era vivo il dibattito su quello che era il rapporto tra classi sociali e strumenti linguistici, si faceva sempre più evidente che gli oppressi non erano in grado di far sentire la propria voce, Vincenzo Consolo, in questo romanzo, tenta di dare voce a loro, ai braccianti, agli esclusi dalla Storia, che è “ una scrittura continua di privilegiati”, a chi ha visto la propria disperazione deformata da degli scrivani in “istruzioni,dichiarazioni,testimonianze”, la Storia infatti l’hanno scritta i potenti e non gli umili, i vincitori e non i vinti. L’impasto linguistico del romanzo mescola l’italiano sostenuto e barocco, dei primi capitoli, al dialetto siciliano, spesso sommariamente italianizzato, al sanfratellano, il poco noto idioma gallo-romanzo parlato da un brigante recluso, e al napoletano delle guardie o al latino. Mandralisca, poi, usa un siciliano che, con immagine dantesca si può chiamare “illustre” , letterariamente nobilitato e regolarizzato sul latino. In un’intervista Consolo ha affermato Ho voluto creare una lingua che esprimesse una ribellione totale alla storia e ai suoi miti. Ma non è il dialetto. E’ l’immissione nel codice linguistico nazionale di un materiale che non era registrato,è l’innesto di vocaboli che sono stati espulsi e dimenticati306 il suo quindi è “ un lavoro da archeologo”, che riporta alla luce ciò che è sepolto nelle Ibidem,p. Sono di questi anni gli studi di Tullio De Mauro e La lettera ad una professoressa di Don Milani Consolo, Vincenzo,Il sorriso dell’ignoto marinaio,Milano:A.Mondadori,2006,p.112 Lo nota G.Contini La lingua ritrovata :Vincenzo Consolo,a cura di M.Sinibaldi,«Leggere»,2,1988,p.12 82 profondità linguistiche dell’italiano, non è una corruzione dell’italiano, non va “verso il dialettismo di colore”, proprio di autori come Camilleri. Il libro si conclude con il proclama del prodittatore Mordini “agli italiani di Sicilia”, in vista del plebiscito del 21 ottobre del 1860, per l’unificazione. Il barone Mandralisca abbandonerà la sua turris eburnea, brucerà i suoi libri e le sue carte e si darà all’azione, aprirà una biblioteca, un museo e una scuola in modo tale che la prossima volta la storia loro,la storia,la scriveran da sé .
Un moderno Ulisse tra Scilla e Cariddi
di Vincenzo Consolo
Annotava Moravia da qualche parte che alla povertà e infelicità di una terra corrisponde ricchezza e felicità di letteratura, poesia e romanzo. E portava l’esempio dell’America Latina, con Borges e Marquez e tutti gli altri scrittori di quella vasta regione dove la letteratura (il romanzo) cresce ancora rigogliosa e splendida. Bisognerebbe, a questa di Moravia, aggiungere l’osservazione che non di tutte le terre solamente povere è una letteratura che si possa dire propria di una determinata regione, ma di quelle – come insegna Americo Castro – dove più o meno si è formato il “modo d’essere” , dove cioè la realtà da “descrivibile” è divenuta narrabile e quindi storicizzabile. Com’è appunto della Spagna e dell’America Latina. Ma è il romanzo del Settecento in Inghilterra e quello dell’Ottocento in Francia, che infelici non erano ma forse solo inquiete nella loro borghesia? E il romanzo russo? E il romanzo americano? Restano solo domande, per noi che ci muoviamo disarmati. Perché allora bisognerebbe affrontare il vastissimo discorso sulla letteratura. Il romanzo: che cos’è e perché nasce, che funzione e che destino ha. E questo lo lasciamo agli specialisti, a quelli che riescono a spiegare le cose e le ragioni delle cose. A noi solo il piacere di goderle, quelle cose, il piacere di leggere un romanzo. Qui solo vogliamo dire che quell’equazione povertà – infelicità e ricchezza letteraria cade bene anche per la Sicilia e per quella letteratura che si chiama siciliana. E quando una storia della letteratura dell’isola si farà, oltre alla stagione felice del Verga, Capuana, De Roberto, Pirandello, si dovrà pure dire di un’altra, quella di Brancati, Vittorini, Sciascia, Lampedusa, Addamo, Castelli, Bonaviri… ultimo nel tempo, e da ascrivere a questa anagrafe Stefano D’Arrigo, scrittore messinese, di cui a giorni sarà in libreria il poderoso romanzo «Horcynus Orca», edito da Mondadori Ma torniamo per un momento a Castro per avanzare un’ulteriore osservazione riguardo alla letteratura siciliana. E più che a Castro, a Sciascia, che adatta quello schema alla realtà siciliana e dice «storicizzabile» la Sicilia di dopo i normanni, e da questo momento fa nascere il modo d’essere siciliano. Gli arabi, per esempio, lasciarono il loro segno più nella parte occidentale che in quella orientale; il feudo nel Val di Mazara e la piccola proprietà nel Val Demone hanno fatto sì che le popolazioni delle due zone fossero in qualche modo diverse. E diverso è il siciliano dell’interno da quello della costa occidentale e orientale, marino e dell’interno continentale, ha per noi significato riguardo agli scrittori, nella misura in cui essi specchiano nelle loro opere, nella materia che assumono e esprimono queste diversità. Verga ci sembra marino (e non per via dei Malavoglia), De Roberto continentale come Pirandello e Sciascia e Lampedusa. D’Arrigo ci sembra autore marino (e non perché il suo romanzo si svolge sullo Stretto). Vogliamo dire che gli scrittori siciliani sono diversi (diversi sono gli artisti: Greco o Migneco sono diversi da Guttuso) per la diversa realtà che esprimono, a seconda cioè se quella realtà si muove nel descrivibile, nel narrabile o nello storicizzabile: se partecipa più o meno al modo d’essere siciliano. Sciascia, sintetizzando Castro, dice che è descrivibile «una vita che si svolge dentro un mero spazio vitale». E ci soccorre anche Addamo scrivendo: «…Nella prevalenza della natura c’è esattamenente il limite della storia». Ora, le regioni, le città, le popolazioni che per varie ragioni hanno dovuto fare i conti con la natura prima ancora che con la storia, o a dispetto della storia, da esse, ci sembra, non possono venire fuori che, scrittori, che opere i cui temi sono il mito, l’e-pos, la bellezza, il dolore, la vita, la morte… vogliamo dire che queste opere, quando sono vere opere, si muovono dall’universale al particolare e sono siciliane per accidente; mentre le altre, al contrario, partono dal particolare e vanno all’universale e sono siciliane per sostanza. Ma questa non è che una semplicistica classificazione nella quale, come nel letto di procuste, la realtà scappa da tutte le parti. Tuttavia: una città come Messina, per esempio, al limite e al confine, distrutta, ricostruita e ridistrutta da terremoti, ci sembra un luogo dove la vita tende a svolgersi dentro un mero spazio vitale. E figurarsi poi la vita di quella città invisibile e mobile che si stende sullo stretto, quella dei pescatori della costa calabra e della costa siciliana di Scilla e Cariddi, Scilli e Cariddi, anzi, arcaica e sempre uguale, vecchissima e sempre nuova, piccola e vastissima, come il mare. «Lu mari è vecchiu assai. Lu mari è amaru. A lu mari voi truvari fumu?» dicono i pescatori. Ed è qui, su questo mare, su queste acque che si svolge Il romanzo di D’Arrigo. 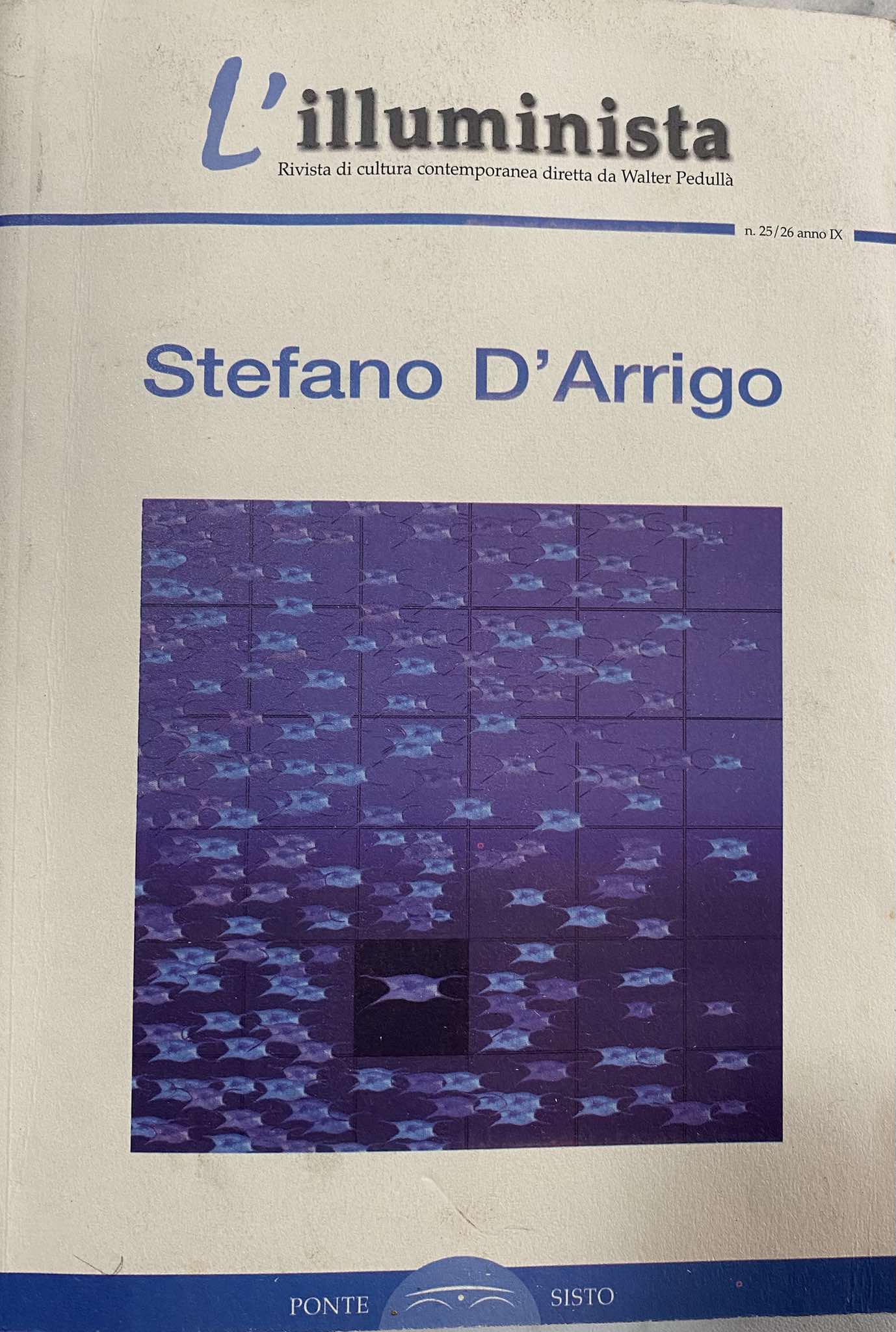
LA MORTE MARINA
«Horcynus Orca» è un romanzo di 1257 pagine a cui l’autore ha lavorato per circa vent’anni. E la storia d’un Ulisse, ‘Ndrja Cambria, marinaio della fu regia marina, pescatore del faro, a Cariddi, che durante l’ultima guerra, nell’autunno del 43 a piedi percorre la costa della Calabria, da Amantea a Scilla, per tornare al suo paese. Quella lingua di mare, lo stretto, lo ferma. Tutto è devastato, distrutto, non ci sono più ferribotti e né barche. Le femminote, le mitiche, arcaiche, libere e matriarcali donne di Bagnara sono ferme anche loro per le coste, in attesa di riprendere come prima il loro contrabbando di sale. Ferme e in attesa sotto i giardini d’aranci e bergamotti in mezzo ai gelsomini, alle olivare e tra le dune delle spiagge. Solo una d’esse possiede una barca, la potente magara Ciccina Circé che, impietosita e ammaliata, trasborda quel reduce, su un mare notturno di cadaveri e di fere bestine. Dopo tanta struggente nostalgia per la sua Itaca, all’approdo, l’Isola appare al reduce sconvolta, diversa, avvilita, scaduta per causa della guerra, ma anche per causa dello stesso ritorno che, come tutti i ritorni, è sempre deludente e atroce. Ritrova il padre, i compagni pescatori, i pellisquadre d’una volta. Ma qui, a Cariddi, sulla spiaggia della «Ricchia», compare improvvisa l’orca, l’Horcynus Orca, com’è scritto sui libri di zoologia, l’orcaferone «quella che dà la morte, mentre lei passa per immortale: lei, la morte marina, sarebbe a dire la morte, in una parola». Solitario, terrificante scorritore di oceani e mari, puzza lontano un miglio, lo precede il terrore, lo segue il deserto e la devastazione. Il mostro arenato, scodato e irriso dalle fere, i feroci delfini dei due mari, il Tirreno e lo Jonio, muore spargendo fetore di cancrena. L’enorme carogna verrà trainata sulla spiaggia dagli inglesi e dai pellisquadre. Il viaggio di ritorno di ‘Ndrja Cambria diventa così viaggio verso un mondo alterato, corrotto: viaggio verso la morte. Ma viaggio anche verso la verità, l’origine della vita. Orcynus è anche orcio, grembo materno, liquido rifugio, mare, principio e fine della vita. ‘Ndrja Cambria morira ucciso sul mare dello stretto, striscia di mare, profonda, abissale, canale e oceano, iato, rottura «naturale» tra una terra e le altre, tra una «storia» e le altre, ucciso da un colpo d’arma che lo raggiungerà alla fronte. E quasi impossibile riassumere questo vastissimo romanzo, magmatico, scandito in quarantanove episodi, dove si muove un’infinita schiera di personaggi e figure. Romanzo dentro il quale tuttora siamo immersi, come in un’avventura, un viaggio eccezionale e affascinante. E per poterne riferire in termini pacati e chiari bisogna prima uscirne, bisogna che cessi lo stupore e l’incanto. Vogliamo adesso soltanto riferire, accennare anche alla Lingua usata dallo scrittore. Lingua che è il dialetto proprio dei pescatori dello Stretto, gergo, suono e atteggiamento assunti e reinventati dall’autore con conoscenza e sapienza magistrale e resi con ritmo e musicalità complessa, larga, polifonica. Una lingua che è ammiccante, allusiva, ora tenera e carezzante, ora dura e sentenziosa, che procede circolarmente per accumuli, e arriva fino al cuore delle cose. E riferire vogliamo anche dello scrittore, di Stefano D’Arrigo. Nato ad Ali nel 1919, passa subito a Messina. Ragazzo, navigava per le Eolie. Sarà entrato nelle celle delle acque saline e calde delle terme di San Calogero, dentro bocche, crateri spenti; si sarà imbattuto nelle necropoli degli uomini antichi, venuti dal mare, nelle olle, negli orci, nei giaroni in cui rannicchiati come nel grembo materno seppellivano i morti, la testa a oriente verso il sole. Si sarà incantato davanti a tutto quanto dal mare si fa schiuma, conchiglia, roccia, terra, e in tutto, che si sfalda e ritorna al mare.
L’INCONTRO CON VITTORINI
A Messina, all’università fa un giornale murale. D’Arrigo scriveva e un suo amico, Felice Canonico, disegnava. Vittorini, chissà per quali vie, da Milano sa di questo giornale e scrive perche vuole vederlo, vuole leggerlo. Gli mandano un numero con un interessante articolo di D’Arrigo, «La crisi della civiltà». E il 1946. Laureatosi in lettere con una tesi su Höderlin («Doveva forse sembrarmi di scorgere in lui, malgrado lui, qualcosa di quel conflitto tra poesia e follia, tra civiltà e barbarie che fa la Germania e in cui alla fine soccombono civiltà e poesia»), nel 1947 parte per Roma. Qui si occupa d’arte. Suoi amici sono Guttuso (e in certe pagine di D’Arrigo c’è quell’aura dei quadri di Guttuso, dei quadri dei pescatori del periodo di Scilla), Mazzuo, Canonico, ma anche Zavattini, De Sica, Ungaretti, Ciarletta. Nella soffitta dello scultore di Graniti, Peppino Mazzullo, si riuniscono, mettono ogni sera un tanto a testa, e mangiano panini e bevono vino. Il pittore Felice Canonico se ne torna a Messina ed è a lui che poi D’Arrigo si rivolge per sapere tutto sulla fera dello Stretto, sul delfino. Canonico va dal direttore dell’istituto talas-sografico di Messina e poi può avere trattati scientifici, storie antiche sul delfino, leggende. E fa anche per D’Arrigo un bel disegno del pesce, un disegno scientifico, a inchiostro di china, come quelli che faceva il Durer dei granchi, dei cetacei.
Nel 1957 D’Arrigo pubblica un libro di versi, «Codice siciliano», presso l’editore Scheiwiller di Milano. Ma è nel 1960 che D’Arrigo viene conosciuto: Vittorini pubblica nella rivista “Menabò 3” due parti, cento pagine, de “‘ giorni della Fera”. come si chiamava prima il romanzo. Scrisse allora Vittorini sulla rivista: «Quanto qui ora pubblichiamo di lui non è opera compiuta. Fa parte di una “Work in progress” ch’io non sono riuscito ad appurare in che anno, e come, e perché, sia stata iniziata, e come sia andata avanti finora ma che ritengo possa restare soggetta a mutamenti e sviluppi anche per un decennio. Di impegno complesso, estremamente ingenuo e estremamente letterario ad un tempo, è di quel genere di lavori cui una volta, fino a metà circa dello scorso secolo, accadeva di vedere dedicare tutta un’esistenza.
IMPEGNO TOTALE
La rivista di Vittorini era uscita nell’agosto del 60. Nel settembre di quell’anno conobbi D’Arrigo a Messina, in una Messina stupefatta e sciroccosa come i fondali dei quadri d’Antonello, alla libreria di Giulio D’Anna sul viale San Martino. Ci tro-vammo, non ricordo bene come, a parlare, a chiacchierare. lo avevo appena finito di leggere le sue pagine sul Menabò e ne avevo ricevuto una grande impressione. D’Arrigo, più che rispondere alle mie, mi fece lui delle domande, domande a non finire, su quello che lui aveva pubblicato e io avevo letto, voleva su tutto la mia impressione di lettore «messinese»: sul linguaggio, il ritmo, i personaggi… Lo incontrai l’anno dopo sempre a Messina, casualmente per la strada. Mi disse che era venuto giù da Roma per verificare, a Sparta, ad Acqualatroni alcuni modi di dire dei Pescatori, parole, frasi. Era pieno di fervore, di vita. Si capiva che il lavoro lo teneva in una forma di frenesia, di entusiasmo creativo. E lo rividi poi ancora a Roma nel 1964. Andai a trovarlo a casa, a Monte Sacro. Era già cominciato il suo completo isolamento. Lavorava dalla mattina alla sera. Il libro era là nel suo studio, in bozze sulla scrivania, sulle sedie, attaccate al muro e con lunghe strisce di carta, scritte a mano, incollate al margine inferiore del foglio e che arrivavano fino al pavimento. D’Arrigo era diverso da quello che avevo conosciuto a Messina. Era tutto calato dentro il suo libro, nel lavoro duro, massacrante, totale che richiedeva il libro. Mi disse che soffriva di cattiva circolazione alle gambe per la vita sedentaria che faceva, lui che aveva giocato da attaccante nella squadra di calcio del Messina. Sono passati anni. Di tanto in tanto leggevo, come tutti di lui sui giornali, brevi note che annunciavano l’imminente pubblicazione del libro presso l’editore Mondadori Nel 73 sono ancora andato a trovare D’Arrigo a Roma. Mi apre la porta e rimane sorpreso, impacciato per la visita improvvisa. Non vede nessuno ormai da anni. Dopo un lungo tempo di silenzio, seduti l’uno di fronte all’altro, D’Arrigo comincia a sciogliersi a parlare, in un flusso straripante di racconto, dove c’è tutto, memoria, progetto, speranza ma soprattutto sentimento e risentimento. Mi parla della moglie Jutta (è assente perché al lavoro), che per tanti anni ha accettato questo calvario accanto a lui, senza mai lamentarsene, stancarsi, sfiduciarsi, sempre spro-nandolo, con speranza intatta e chiara. «A Jutta, che meriterebbe di figurare in copertina col suo Stefano» c’è scritto ora sul frontespizio del libro. Parla degli amici che se ne sono andati, quelli morti (Niccolò Gallo, Vittorini) e quelli allontanatisi, scomparsi in una città grande, caotica e lontanissima che si chiama Roma. E parla di Messina, delle sua Messina, della Sicilia. – Perché un giorno non ce ne torniamo tutti laggiù? – mi dice – e cacciamo via tutti i politicanti, gli affaristi, i mafiosi. – E poi, dopo una lunga pausa; – Ma no, non è possibile – dice – è un’utopia. Ma del libro non parla e io non oso fargli domande. E il libro è lì, sempre in bozze sparse sul tavolo e anche sul divano. E c’è anche la prima pagina, la controcopertina col titolo. «Horcynus Orca» si chiama ora e non più «I giorni della fera». E poi di Dante – è grande in tutte le dimensioni – dice – è iperbolico. La Divina Commedia è il mio libro De Chevet. Mi è servito molto, soprattutto per la lingua. Quello che mi scandalizza sempre è il Manzoni, col suo «Bagno» in Arno. Al momento che devo partire, non vuole lasciarmi andar via, vuole ancora parlare e parlare con me, in quel suo flusso di ricordi, di sentimenti e risentimenti. Certo, D’Arrigo rappresenta un caso, una eccentricità, un fenomeno di impegno totale alla letteratura, alla poesia, che non si riscontra forse più nel mondo d’oggi. Non si sa ancora che ripercussioni avrà il suo libro nei lettori, nei critici. Il rischio più grosso in cui potrà incorrere è quello di essere chiuso, cristallizzato nel fenomeno, nel personaggio. E questo lui lo sa e lo teme. Ma ha anche temuto fino a ieri, soprattutto, di portare a termine il libro, di staccarsene, non lavorarci più, consegnare col «va bene, si stampi», quelle mille e duecento pagine di bozze all’editore. Perché, quando opere come «Horcynus Orca» possono dirsi concluse? Quando si può dire conclusa una vita, la vita, anche se minacciata dall’orca atomica, dall’orca tecnologica, dall’orca della disumanizzazione?
L’illuminista – Rivista di cultura contemporanea diretta da Walter Pedullà
numero 25/26 gennaio/agosto 2009
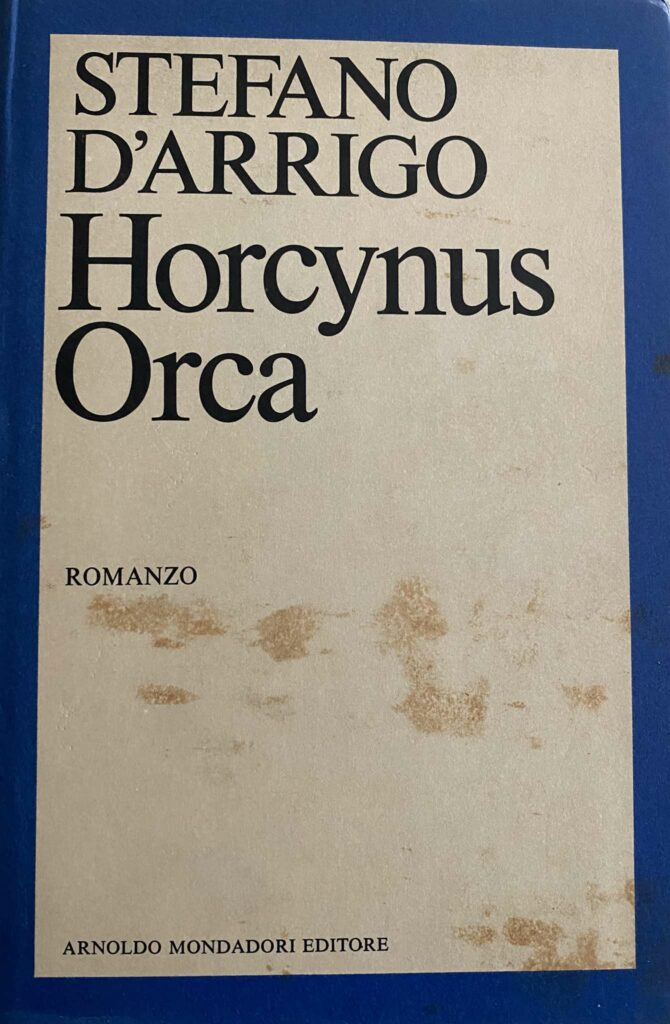
Vincenzo Consolo: romanzo e storia. Storia e storie.
JEAN FRACCHIOLLA
Dire che ogni scrittore vive di storie è un po’ un truismo. Che cosa fa in effetti qualsiasi narratore? Ci racconta delle storie: Sia delle storie che possono appartenere alla realtà quotidiana dell’epoca in cui ci trasporta il narratore, e allora si tratta di un romanzo realista, ciò che Stendhal definisce, per riprendere
la sua celebre immagine, come «le miroir qu’on promène le long d’un chemin».
Sia delle storie che si nutrono di miti radicati nell’immaginario collettivo, e allora abbiamo a che fare con dei racconti che rasentano il meraviglioso, il fantastico, il lirico, l’epico o il tragico… Come ogni romanziere Vincenzo Consolo non sfugge a questa regola: i suoi romanzi sono strapieni di storie, di racconti,
nonché di aneddoti, di notazioni, d’impressioni, come quelle che ci presenterebbe uno scrittore viaggiatore. E qui apro subito una breve parentesi per fare una costatazione che mi sembra importante: tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio. Tutte ci invitano ad un viaggio attraverso dei luoghi privilegiati, quasi sempre in Sicilia, il cui epicentro sembra essere la città di Cefalù; ma tornerò più avanti su questo punto. Però Vincenzo Consolo non è un semplice romanziere realista che si accontenta di registrare e di descrivere la realtà in cui vive (anche se questo gli capita, naturalmente, ad esempio quando egli denuncia il totale degrado in cui sono cadute oggi le grandi città di Sicilia, come Palermo o Siracusa), ma in generale le storie di Consolo affondano le loro radici nella Storia, quella della Sicilia degli anni e dei secoli passati, cioè di una Sicilia splendida nella bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi siti ancora intatti, di una Sicilia pura e vergine nei suoi costumi non ancora corrotti, di una Sicilia mitica (che ci ricorda e rimanda a quella di Verga e Vittorini), di cui il nostro scrittore esprime continuamente la straziante e lacerante nostalgia. Per altro questo rapporto con la Storia caratterizza tutta la tradizione del romanzo italiano moderno, dal Manzoni, passando poi per Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, perfino Sciascia, tradizione nella quale s’inserisce profondamente Vincenzo Consolo, ma in modo molto originale, come vedremo più avanti. Tutti i romanzi e tutte le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Così La ferita dell’aprile, il romanzo che, nel 1963, segna gli inizi letterari di Consolo, misto sapientemente dosato di autobiogafia e di storia, di quotidiano e di mito. La ferita dell’aprile è la storia di un adolescente e di un paese siciliano all’indomani della seconda guerra mondiale. La storia di un adolescente che, alla fi ne di un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e di dolori, giunge alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza. In effetti la «ferita», alla quale allude il titolo, è di sicuro la «ferita» della giovinezza, nella sua esperienza dolorosa di passaggio all’età adulta; ma è anche forse «la ferita» politica delle elezioni del 18 aprile 1948, profondamente risentita dallo scrittore impegnato Consolo, che rimane solidale delle vittime di una storia che gli appare immutevole e insensata. Tra La ferita dell’aprile e il suo secondo romanzo, Il sorriso dell’ignoto marinaio del 1976, dodici anni di silenzio, sui quali potremo chiedere dopo a Vincenzo Consolo qualche chiarimento. Poi viene Lunaria (1985), in cui Consolo tiene un discorso sottilmente politico e storico (notiamo anche, ‘en passant’, come nel nostro autore Storia e politica sono sempre strettamente legate). Lunaria ci presenta una Palermo del Settecento, in cui l’autore
mette in scena un mito poetico, quello della luna contro il potere. La caduta della luna mette in luce «la diversità» di un vicere che non crede nel potere, il ché lo avvicinerà ai suoi sudditi (contadini e popolani), e lo aiuterà a smascherare la falsa scienza ben diversa da quella vera scienza capace di audacia e di spirito concreto. Solo la gente umile, i poeti, i marginali saranno capaci di capire veramente la luna e la forza del suo mito. Ne La ferita dell’aprile, rileviamo questa frase: “Il faro di Cefalù guizzava come un lampo, s’incrociava con la luna, la trapassava, lama dentro un pane tondo: potevano cadere sopra il mare molliche di luna e una barca si faceva sotto per raccoglierle: domani, alla pescheria, molliche di luna a duecento lire il chilo, il doppio delle sarde, lo sfizio si paga; correte femmine, correte, prima che si squagliano”1 . Questa frase annuncia già Lunaria e ci rivela, in nuce, nel suo potente lirismo, due elementi essenziali della poetica di Consolo:
da una parte il faro che invita al viaggio, un viaggio rituale
dall’esistenza alla Storia, che invita quindi alla conoscenza del
mondo e di se stessi. Il faro, cioè la luce, e quindi per Consolo la
ragione che attrae, che illumina in modo intermittente le tenebre;
il faro che simboleggia il tentativo umano, mai completamente
appagato, di penetrare il mistero dell’esistenza.
dall’altra parte la luna, altro topos al quale il nostro autore
è particolarmente legato, che rappresenta il bisogno assoluto di
immaginazione, di creazione poetica. Qui, in quei repentini bagliori del faro di Cefalù che, con la sua luce, trafigge la luna e ne fa cadere le briciole, le molliche nel mare, possiamo rilevare
non soltanto una immagine intensamente poetica, ma anche una
prima e delicata immagine della «violazione» e della «caduta» della
luna che sono precisamente i temi centrali del racconto teatrale
Lunaria.
E qui vediamo anche come, da un’opera all’altra, si stabilisce una rete di corrispondenze e di echi interni. Anche Retablo (1987) è, a modo suo, un romanzo storico, ambientato nel Settecento, nella Sicilia occidentale, che per Consolo è quella della Storia. Retablo si presenta come un racconto di viaggio -forma che ritroveremo ancora ne L’olivo e l’olivastro- quello del Cavaliere Clerici, pittore milanese, in cui, come avviene nei romanzi di avventure, gli episodi si susseguono senza legami necessari tra di loro. Attraverso la Sicilia del Settecento, sontuosa e misera, accecante e cupa, paradisiaca e infernale, deliziosa e squallida, si delinea e dispiega il conflitto tra ‘avere’ e ‘essere’, vale a dire tra i falsi valori (della ricchezza, la nobiltà del nome, del potere) e i valori autentici, cioè quelli che si affermano per sé stessi e che caratterizzano un’umanità umile, marginale, diversa, vale a dire quella dei pastori, dei poeti, dei nobili vegliardi, dei briganti generosi o dei mercanti disinteressati. È con questi umili che simpatizza ovviamente il Cavaliere Clerici (come il vicere di Lunaria di cui costituisce un’eco), intellettuale illuminato del secolo dei lumi, eco anche lui del barone Mandralisca e di Giovanni Interdonato de Il sorriso dell’ignoto marinaio. Le Pietre di Pantalica (1988), non più romanzo ma raccolta di novelle, conservano un legame molto stretto con la storia della Sicilia. L’opera si dipana su un arco di tempo che va dal periodo della liberazione fi no ai conflitti sociali del dopoguerra, dal «boom» economico degli anni’60, ai problemi, ai danni e al degrado causati da questo «boom» nella Sicilia e nell’Italia contemporanea. Siccome la Sicilia e i mali siciliani sono spesso, per non dire sempre, una metafora dell’Italia e dei mali italiani, ritroviamo, ne Le pietre di Pantalica, la critica contro la cultura dei privilegi e del potere; ritroviamo il rapporto-contrasto tra la razionalità e la follia, il «male misterioso ed endemico» di una Sicilia emblematica; ritroviamo la visione di una storia immobile ed immutevole nelle sue prevaricazioni, i suoi inganni e le sue menzogne, nelle sue ingiustizie e le sue esclusioni. Le pagine emblematiche del penultimo racconto, intitolato appunto “Le pietre di Pantalica”, ci offrono un ritratto terrificante delle città che una volta furono tra le più belle della Sicilia, si vuol parlare naturalmente di Siracusa e di Palermo: “Sono tornato a Siracusa dopo più di trent’anni, ancora come spettatore di tragedia. Allora, in quel teatro greco, nel momento in cui Ifi genia faceva il suo terribile racconto del suo sacrificio in Aulide, … o nel momento in cui il coro cantava… in questi alti momenti e in altri, nel teatro greco di Siracusa era tutto un clamore di clacson di automobili, trombe di camion, fischi di treni, scoppiettìo di motorette, sgommate, stridore di freni… Attorno al teatro, dietro la scena, dietro il fondale di pini e cipressi il paesaggio sonoro di Siracusa era orribile, inquinato, selvaggio, barbarico, in confronto al quale, il fragore del mare Inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin… E, usciti dal teatro, che cosa si vede? La distruzione e lo squallore: un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini. Le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche di Melilli e Priolo, alle porte di Siracusa, hanno corroso, avvelenato la città. Nel centro storico, nell’isola di Ortigia, lo spettacolo è ancora più deprimente. La bellissima città medievale, rinascimentale e
barocca, la città ottocentesca e quella dell’inizio del Novecento è completamente degradata: una città marcia, putrefatta”2 . E più avanti: “Palermo è fetida, infetta. In questo luglio fervido, esala odore dolciastro di sangue e gelsomino, odore pungente di creolina e olio fritto. Ristagna sulla città, come un’enorme nuvola compatta, il fumo dei rifiuti che bruciano sopra Bellolampo… Questa città è un macello, le strade sono ‘carnezzerie’ con pozzanghere, rivoli di sangue coperti da giornali e lenzuola. I morti ammazzati, legati mani e piedi come capretti, strozzati, decapitati, evirati, chiusi dentro neri sacchi di plastica, dentro i bagagliai delle auto, dall’inizio di quest’anno, sono più di settanta…”3
Queste pagine annunciano ciò che diventerà il leitmotiv di un’opera successiva di Consolo, cioè L’olivo e l’olivastro, pubblicata nell’agosto del 1994. L’olivo e l’olivastro è una specie di odissea,
di ritorno nella patria natale; è un’immagine desolata, corrotta, apocalittica della Sicilia, quella che ci offre la prosa lirica e barocca di Consolo. Anche qui ritroviamo il tema del viaggio che costituiva la struttura portante di Retablo; però tutto quello che il poeta vede è soggetto a un paragone che oppone la Sicilia mitica di una volta, la Sicilia eterna, superba, splendida attraverso i suoi siti, la sua natura ed i suoi monumenti, alla Sicilia attuale che non è altro che squallore e abbrutimento.
Bisognerebbe citare tutte le pagine che segnano questa trasformazione, quella di Caltagirone, di Gela di cui Consolo ci presenta un ritratto terrificante per non dire raggelante, quella di Segesta, di Mazzara ed infine di Gibellina che si offre come l’ultimo esempio, in quest’opera, di un’antica, nobile e magnifica civiltà, sacrificata agli dei di un modernismo dello scandalo e dell’orrore.
L’olivo e l’olivastro, a parer nostro, costituisce, nel percorso letterario di Vincenzo Consolo, un’opera-somma in cui s’incrociano e si rispondono tutti i temi maggiori della poetica consoliana, e un’opera in cui l’uomo, il romanziere ed il poeta, gridano la loro indignazione ed il loro sgomento di fronte ai templi della bruttezza architettonica e morale di quel che si è soliti chiamare la civiltà moderna. L’olivo e l’olivastro è un libro-chiave per capire tutta l’opera di Consolo. Occorrerebbe poterne citare tutte le pagine, in particolare quelle in cui Consolo rivela al lettore il significato profondo della sua scoperta di Cefalù, ma sarebbe ovviamente troppo lungo, perciò ci accontenteremo di citarne un breve passo: “Si ritrovò così a Cefalù… Ricorda che lo meravigliava, man mano che s’appressava a quel paese, l’alzarsi del tono di ogni cosa, nel paesaggio, negli oggetti, nei visi, nei gesti, negli accenti; il farsi il tono più colorito e forte, più netto ed eloquente, più iattante di quello che aveva lasciato alle sue spalle. Aspra, scogliosa era la costa, con impennate montuose di scabra e aguzza roccia, fi no alla gran rocca tonda sopra il mare -Kefa o Kefalè-, al capo che aveva dato nome e protezione dall’antico a Cefalù… Alti, chiari, dai capelli colore del frumento erano gli abitanti, o scuri e crespi, camusi, come se, dopo secoli, ancora distinti, uno accanto all’altro miracolosamente scorressero i due fi umi, l’arabo e il normanno, siccome accanto e in armonia stavano il gran Duomo o fortezza o castello di Ruggiero e le casipole con archi, altane e finestrelle del porto saraceno, del Vascio o la Giudecca. S’innamorò di Cefalù. Di quel paese che sembrava anticipare nella Rocca il monte Pellegrino, nel porto la Cala, nel Duomo il Duomo, nel Cristo Pantocratore la cappella Palatina e Monreale, nell’Osterio Magno lo Steri chiaramontano, nei quartieri Crucilla e Marchiafava la Kalsa e il Borgo, anticipare la grande capitale. Abitò a Cefalù nell’estate. Gli sembrava, ed era, un altro mondo, un mondo pieno di segni, di messaggi, che volevano essere letti, interpretati”4 .
Così quindi Cefalù, centro del mondo di Consolo, sorta di Aleph borgesiano, citando Borgès: “in cui si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti sotto tutti i punti di vista”, Cefalù è per Consolo la città d’incontro e di scoperta, la città che diventerà la citta-simbolo di un intero universo.
E quale migliore transizione di Cefalù per parlare dei due romanzi senz’altro più compiuti e tra i più importanti di Consolo, e di cui volutamente non si è parlato finora, cioè Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) -cronologicamente il secondo di Consolo- e Nottetempo, casa per casa (1992 -Premio Strega 1992). Cefalù, alfa e omega di Vincenzo Consolo, terra di ogni scoperta e ogni delizia, Cefalù col suo faro, Cefalù e la sua cattedrale, che di opera in opera sono, come i ciottoli seminati da Pollicino, i punti di riferimento di Consolo, Cefalù caput mundi (kefalè=testa), Cefalù è il luogo privilegiato di questi due romanzi, romanzi storici per antonomasia, che costituiscono come ama a ricordarlo il loro autore: «Il dittico di Cefalù». Con Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato integralmente nel 1976, Consolo si tuffa letteralmente nella storia, quella del Risorgimento a Cefalù e in Sicilia, per tentare di capire le ragioni del fallimento parziale degli ideali di uguaglianza e di giustizia che avevano attraversato tutta la prima metà dell’Ottocento, per concretizzarsi momentaneamente nella data dell’undici maggio 1860, giorno dello sbarco di Garibaldi in Sicilia. Il protagonista della prima parte del romanzo, quella di Cefalù, è Enrico Piraino, barone di Mandralisca, malacologo e archeologo, intellettuale impegnato a favore del nuovo corso della storia. Consolo ne fa il portavoce della propria ideologia, delle proprie convinzioni sull’idea di proprietà e delle ingiustizie che da essa derivano. Mandralisca va paragonato al Cavaliere Clerici di Retablo e al Vicere di Lunaria. Consolo è rimasto affascinato dalla statura morale di questo personaggio, decisamente più generoso del principe Salina ne Il Gattopardo di Lampedusa, e personaggio in cui egli sente, per via dell’amore comune che nutrono tutti e due per il viaggio (reale o metaforico), un fratello di elezione. Nei numerosi spostamenti del barone “da Lipari a Cefalù, dal mare alla terra, dall’esistenza alla storia”, come lo dice lui stesso, Consolo ha trovato un antecedente storico al proprio viaggio-scoperta-iniziazione, dalla regione di Messina dove è nato ed ha vissuto la propria infanzia (a Sant’Agata di Militello), e che rappresenta per lui il mondo della natura e del quotidiano, verso la regione di Palermo che rappresenta invece, tramite la tappa intermedia di Cefalù, autentica porta del mondo, la cultura e la Storia.
Mandralisca è l’intellettuale che si pone in modo problematico di fronte alla storia per cercare di capirne il corso e gli sviluppi. È lui peraltro che ha comprato il «Ritratto d’ignoto» d’Antonello da
Messina il cui sorriso e sguardo enigmatici, nel contempo complici e distanti, ironici e aristocraticamente benevoli, ci dicono a che punto quest’uomo la sa lunga sulla vita e i suoi segreti. D’altronde questo sorriso enigmatico dell’uomo misterioso dipinto da Antonello, Consolo lo fa rivivere sul viso di un altro personaggio importante del romanzo, il democratico Giovanni Interdonato, latore di tutti i valori positivi del cambiamento sperato: quello di una Sicilia migliore, in cui il lavoro e la capacità di sacrificio dei suoi abitanti potranno far regnare, alla luce della ragione e dello spirito (la cui sede è il capo, cioè Cefalù / kefalè), una maggiore giustizia. Il sorriso dell’ignoto marinaio ci offre, per lo meno nella sua prima parte, una visione allegra dell’esistenza, che Consolo ci comunica mediante parole che attingono la loro bellezza nella poesia dei luoghi descritti, nel lirismo dei gesti quotidiani, offerti al lettore senza compiacimento paternalistico, ma piuttosto attraverso un’estasi poetica profonda. La seconda parte del dittico, Nottetempo casa per casa (marzo 1992), arriva dopo anni di approfondimenti tematici e di sperimentazioni linguistiche molto personali: l’agonia della poesia in Lunaria, il tema e la metafora del viaggio, il rapporto scritturavita e le riflessioni esacerbate sull’alienazione della nostra epoca (Retablo e Le pietre di Pantalica). Nottetempo casa per casa è storicamente ambientato negli anni 20 del Novecento, scelta naturalmente non affatto casuale. Consolo stabilisce un parallelo implicito tra quel periodo ed il nostro, si serve del passato e della storia per parlarci meglio del presente: in effetti il clima di violenza e d’intolleranza, che s’instaura in Italia con l’avvento del fascismo, trova degli echi nella follia e l’oltraggiosa disconoscenza della dignità umana che regnano oggigiorno. Cefalù, come la Sicilia di Sciascia, diventa in questo romanzo metafora di una realtà generale non solo problematica e contraddittoria, ma anche, per certi aspetti, stretta e volgare. Per tutte queste ragioni, Petro Marano, il protagonista del romanzo, è naturalmente sconcertato -come lo è lo scrittore- davanti a questa realtà che perde la propria consistenza, che si sfrangia e si sfi laccia sotto i colpi dei movimenti irrazionalistici che sembrano fare dei proseliti anche tra i suoi compatrioti: “Sentiva d’esser legato a quel paese, pieno di vita, storie, trame, segni monumenti. Ma pieno soprattutto, piena la sua gente, della capacità di intendere e sostenere il vero, d’essere nel cuore del reale, in armonia con esso. Fino a ieri. Ora sembrava che un terremoto grande avesse creato una frattura, aperto un vallo tra gli uomini e il tempo, la realtà, che una smania, un assillo generale spingesse ognuno nella sfasatura, nella confusione, nell’insania”5 . Mentre ne Il sorriso dell’ignoto marinaio i luoghi di Cefalù erano le contrade dell’utopia, della speranza appassionata di un cambiamento storico e sociale, in Nottetempo casa per casa gli stessi luoghi diventano come le regioni del disincanto, dell’assenza di ragione, della scomparsa temporanea della luce del faro, del
«chiarore della lanterna». Allora la scrittura di Consolo in Nottetempo casa per casa si mette in posizione di attesa, pur rimanendo costruttiva poiché continuare a scrivere, a raccontare, significa per Consolo denunciare la notte della ragione, ma anche continuare a sperare, non abbandonarsi al pessimismo più tetro che genera l’afasia, l’impossibilità di creare e d’inventare. A Cefalù Consolo ha compiuto un «rito di passaggio», di cui lui stesso ha abbondantemente parlato, che gli ha permesso di fare emergere, dal suo magma interno, l’altra parte della verità, l’altro colore dell’esistenza, l’emisfero nascosto della luna. Questo viaggio, senza alcun dubbio, più che un viaggio spaziale vero e proprio, ha un valore piuttosto simbolico di conoscenza e d’iniziazione. Cefalù, «rito di passaggio», unisce strettamente i due romanzi. D’altronde Consolo fa notare che nessun critico aveva notato che i due libri hanno lo stesso incipit: il primo, Il sorriso dell’ignoto marinaio, inizia così: “E ora si scorgeva la grande isola. I fani sulle torri della costa erano rossi e verdi, vacillavano e languivano, riapparivano vivaci”6 . Inizia quindi con una congiunzione, «E», e un’aurora. In altri termini è un libro augurale ed aurorale, è un libro diurno e solare, perché si tratta del romanzo della speranza. il secondo invece, con un effetto di simmetria oppositiva,
inizia con una congiunzione, «E», e un notturno:
“E la chiarìa scialba all’oriente… Sorgeva l’algente luna”7 .
Inizia con il sorgere della luna, con l’apparizione di un personaggio inquietante, anche lui notturno, il padre di Petro Marano, notturno perché soffre di licantropia. Se Il sorriso dell’ignoto marinaio era il libro della speranza, Nottetempo casa per casa è il libro della disperazione e del dolore. Lascio ora la parola a Consolo che citerò lungamente: “Ho voluto rappresentare il dolore… e questo libro è stato da me concepito proprio come una tragedia: la scansione in capitoli del libro è proprio quella delle scene di una tragedia greca… Mi è stato soprattutto rimproverato da un critico, per altro molto acuto, che io cerco consolazione in un genere ormai scaduto, nel romanzo. L’ho trovato offensivo. La letteratura non è scaduta, essa è stata avvilita. Credo che la funzione della letteratura sia ancora quella di essere testimone del nostro tempo. Petro Marano è questo. Di fronte al fallimento dell’utopia politica, di fronte alla follia della storia e alla follia privata, alla sua follia esistenziale, al dolore che lui si porta dentro, capisce che il suo compito è quello dell’anghelos, del messaggero che nella tragedia greca ad un certo punto arrivava sulla scena e raccontava ciò che si era svolto altrove. Ecco, la funzione dello scrittore, di Petro Marano è quella di fare da anghelos, da messaggero. Nei momenti in cui cadono tutti i valori, la funzione della letteratura è di essere testimone non soltanto della storia, ma anche del dolore dell’uomo. È l’unica funzione che la letteratura può avere. La politica si preoccupa delle sorti immediate dell’uomo, la letteratura, invece, va al di là del tempo contingente. Di una letteratura, parlo di narrativa, quanto mai minacciata, oggi, da quella che è la mercificazione di questo genere letterario. È per questo che ho concepito il mio impegno letterario, non soltanto per un fatto di propensione verso il lirismo ma anche ideologicamente devo dire, come difesa dello spazio letterario.
Ho cercato di allontanarmi sempre di più da quel linguaggio senza memoria, insonoro, che i mezzi di comunicazione di massa oggi ci impongono e che ormai ha invaso tutti i settori della nostra vita. Il settore più minacciato, dicevo, è quello della narrativa. Credo che l’unica salvezza per questo genere fortemente appetito dai produttori dell’industria culturale -appunto perché è mercificabile- rimanga quella di avvicinare la narrazione alla poesia”. Ho tenuto a riferire lungamente le parole di Vincenzo Consolo perché, da sole, costituiscono un’ottima conclusione ai miei propositi di oggi. Propositi un po’ brevi e lapidari per una materia così ricca, sulla quale ci sarebbe ancora molto da dire. Ma il mio intento e la mia ambizione erano solo quelli d’introdurre un dibattito con l’autore in persona.
Quindi, per concludere, in Consolo narrativa e Storia sono intimamente legate. La Storia costituisce la trama intima del tessuto romanzesco. Ma Consolo non è uno storico e non è semplicemente, direi, un romanziere storico. È anche e soprattutto, per via di ciò che la sua prosa ha di lussureggiante, colorato, colto, prezioso, spesso barocco e lirico, è anche quindi un poeta della storia e del romanzo. La lettura di alcuni brani citati lo dimostra. I suoi legami e la sua dimestichezza di spirito e di penna con alcuni dei più grandi poeti contemporanei, quali Montale e soprattutto Lucio Piccolo, il grande poeta siciliano che fu amico di Consolo, lo attestano. Ma questo aspetto del nostro scrittore potrebbe essere oggetto di un’altra presentazione e di un altro dibattito.
1 CONSOLO, V. (1989: 31). 2CONSOLO, V. (1988: 165-6).
3CONSOLO, V. (1988: 170). 4 CONSOLO, V. (1994: 123-4).5 CONSOLO, V. (1992: 144). 6 CONSOLO, V. [(1976) ma 1997: 12]. 7 CONSOLO, V. (1992: 5).
BIBLIOGRAFIA:
CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1989): La ferita dell’aprile, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1992): Nottetempo, casa per casa, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1994): L’olivo e l’olivastro, Milano: Mondadori.
CONSOLO, V. (1997): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano: Mondadori
(«Scrittori italiani») [1 ed. 1976, Torino: Einaudi].

L’evidenza del nome nella scrittura di Vincenzo Consolo
Giulio Ferroni
Università La Sapienza
Nel capitolo VI de Il sorriso dell’ignoto marinaio si svolge un’intensa interrogazione del senso della scrittura dei «cosiddetti illuminati», dei «privilegiati» che pure tentano di dar voce ai villani che si sono ribellati alle ingiustizie; se ne rileva il carattere di impostura, di fronte alla
difficoltà e impossibilità di far parlare le lingue “altre”, di trovare «la chiave, il cifrario dell’essere», lo strumento di accesso al mondo delle classi subalterne, alla loro espressione, al loro essere, al loro sentire e al loro risentimento. Entro questa insuperabile difficoltà viene chiamata più specificamente in causa l’insufficienza dei nomi, delle parole del codice politico, fatto di termini che restano estranei alle classi popolari; anche le grandi parole come «Rivoluzione, Libertà, Egualità, Democrazia» mostrano la loro incorreggibile parzialità. Di fronte a questa situazione, si delinea l’attesa di parole nuove, di nomi capaci di afferrare quella realtà che sfugge al linguaggio attualmente disponibile, conquistati dagli stessi soggetti che da quello sono esclusi: “Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose”1 . I nomi vengono ad essere, in effetti, nella loro evidenza, gli strumenti essenziali di un contatto con le cose, qui con una proiezione utopica (che risente ancora delle utopie sessantottesche) verso il sogno di un legame futuro, solidale, tra nomi e cose, verso una conciliazione che cancelli ogni scissione, ogni lacerazione tra il linguaggio e la realtà. 56 Ben presto però, nell’esperienza di Consolo, al di là di questa proiezione in avanti, si impone un movimento opposto che conduce la scrittura, nel confronto con l’evidenza dei nomi, a risalire all’origine, o comunque ad un perduto passato di conciliazione tra la realtà e il linguaggio. Essi si porranno allora come segni persistenti di ciò che è stato lacerato, segni che recano in sé le stigme del dolore, che manifestano la necessità e insieme l’impossibilità di un riconoscimento, di una risposta all’offesa del male e della violenza. Nel testo eponimo de Le pietre di Pantalica lo sguardo agli oltraggi subiti da Siracusa rinvia ad uno scritto di Alberto Savinio (Nivasio Dolcemare), Fame ad Atene, con il terribile ricordo di uno degli oltraggi subiti da Atene nella seconda guerra mondiale (la morte per fame di ottocento persone), e al modo in cui lo scrittore cercò di rievocare e difendere la memoria della città proprio affidandosi ai suoi nomi: “Allora lo scrittore, per quest’offesa all’umanità, per quest’oltraggio alla civiltà, fa una rievocazione della sua Atene servendosi dei nomi: di vie, di piazze, di bar, di ritrovi; di persone, di oggetti; e soprattutto di cibi, di dolci. Nomi scritti nella loro lingua, in greco. Roland Barthes ci ricorda che in latino sapere e sapore hanno la stessa etimologia. E anch’io allora, come Nivasio Dolcemare, vorrei, se ne fossi capace, rievocare la mia Siracusa perduta attraverso i nomi: di piazze, di vie, di luoghi … Ma soprattutto di cibi, di dolci, magari servendomi di un prezioso libretto, Del magiar siracusano, di Antonino Uccello. Ma, Antonino, ha senso oggi trascrivere quei nomi?”2 . La coscienza della divaricazione tra l’originario mondo della tragedia greca e l’uso delle contemporanee rappresentazioni in traduzione (proprio nella disastrata Siracusa) fa poi sorgere un’allocuzione ai mitici personaggi di Argo, città «ridotta a rovine», il cui ricordo può persistere, come quello di Siracusa o di Atene, solo nella parola originaria della poesia: “Vi resti solo la parola, la parola d’Euripide, a mantenere intatta, nel ricordo, quella vostra città”
3 . 2. 3 Ibidem. 57
Il rilievo del nome sostiene l’ampio uso che Consolo fa della enumerazione caotica e dell’elencazione seriale, che dà assoluta evidenza ai sostantivi nei loro diversi tipi, dai nomi propri (luoghi, persone, dati della storia e del mito, ecc.) a quelli comuni di cose materiali e concrete a quelli di cose astratte e ideali, ecc. Queste enumerazioni di nomi si collegano talvolta a scatti improvvisi della sintassi, tra inversioni e alterazioni ritmiche: il linguaggio viene così forzato in una doppia direzione, sia costringendolo ad immergersi verso un centro oscuro, verso l’intimità delle cose e dell’esperienza, verso il fondo più resistente e cieco della materia, il suo inarrivabile hic et nunc, sia allargandone l’orizzonte, dilatandone i connotati nello spazio e nel tempo, portandolo appunto a “vedere” la distesa più ampia dell’ambiente e a farsi carico della sua stessa densità storica, di quanto resta in esso di un lacerato passato e di faticoso proiettarsi verso il futuro. Nel IV capitolo di Nottetempo casa per casa il «maestricchio» Petro Marano, chiuso nella torre del vecchio mulino avuto in lascito, meditando sul dolore della propria famiglia, dopo essersi abbandonato ad un urlo indistinto e senza scampo, si aggrappa alla forza delle parole, che sono prima di tutto «nomi di cose vere, visibili, concrete», nomi che egli scandisce come isolandoli nel loro rilievo primigenio e assoluto e da cui ricava un impossibile sogno di un ritorno alle origini, di un rinominare capace di trarre alla luce una realtà non ancora contaminata dal dolore e dalla rovina. Nuovo inizio potrebbe essere dato appunto dalla trasparenza assoluta di nomi che designano una realtà senza pieghe dolorose, in un nuovo flusso sereno della vita e del tempo: “E s’aggrappò alle parole, ai nomi di cose vere, visibili, concrete. Scandì a voce alta: «Terra. Pietra. Sènia. Casa. Forno. Pane. Ulivo. Carrubo. Sommacco. Capra. Sale. Asino. Rocca. Tempio. Cisterna. Mura. Ficodindia. Pino. Palma. Castello. Cielo. Corvo. Gazza. Colomba. Fringuello. Nuvola. Sole. Arcobaleno …» scandì come a voler rinominare, ricreare il mondo. Ricominciare dal momento 58 in cui nulla era accaduto, nulla perduto ancora, la vicenda si svolgea serena, sereno il tempo”4 . Petro rinvia alla scaturigine dei nomi, che, quando designano cose concrete, sembrano mantenere ancora il nesso primigenio, la misura di quando nulla era ancora accaduto, di quando il male e il dolore non aveva ancora lacerato le possibilità dell’esperienza. E si noti come in questa elencazione, che la punteggiatura fissa in una sorta di forma pura, i vari nomi si succedano a gruppi, riferiti a diversi settori d’esperienza, secondo una progressione che va dalla solidità elementare della terra al richiamo aereo del volo e di uno spazio cosmico, fino alla colorata impalpabilità dell’arcobaleno. Ne Il sorriso dell’ignoto marinaio l’evidenza del nome si impone fi n dalle pagine iniziali, con lo sguardo del barone Mandralisca che si avvicina alla costa della Sicilia, la cui immagine si fissa nei nomi dei feudatari signori delle torri sormontate dai fani (si noti qui la quasi totale assenza degli aggettivi: c’è solo il generico grande e il numerale cinque). “Riguardò la volta del cielo con le stelle, l’isola grande di fronte, i fani sopra le torri. Torrazzi d’arenaria e malta, ch’estollono i lor merli di cinque canne sugli scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi. Erano del Calavà e Calanovella, del Lauro e Gioiosa, del Brolo …”5 . Ai nomi dei feudatari che in quel momento dominano i luoghi succedono poi quelli delle città sepolte, evocate dalla sapienza archeologica del barone: “Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Calacte, Alesa… Città nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o solo una moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni”6 . 6 Ibidem. 59
Ecco poi più avanti un elenco dei pellegrini che procedono verso il santuario di Tindari e degli oggetti che recano con sé: “Erano donne scalze, per voto, scarmigliate; vecchie con panari e fiscelle e bimbi sulle braccia; uomini carichi di sacchi barilotti damigiane. Portavano vino di Pianoconte, malvasia di Canneto, ricotte di Vulcano, frumento di Salina, capperi d’Acquacalda e Quattropani. E tutti poi, alti nelle mani, reggevano teste gambe toraci mammelle organi segreti con qua e là crescenze gonfi ori incrinature, dipinti di blu o nero, i mali che quelle membra di cera rosa, carnicina, deturpavano”7 . E si ricordino ancora più avanti i nomi elencati dal Mandralisca di fronte ai pazienti visitatori della sua casa- museo: “Alle vetrine, alle teche delle lucerne e delle monete, dove il barone si lasciò andare ad una sequela infinita di date, di luoghi, di simboli e valori, quei quattro o cinque che appresso gli restarono, per troppa stima o estrema cortesia, afferrarono qualcosa come Mozia Panormo Lipara Litra Nummo Decadramma”8 . E del resto la figura stessa del Mandralisca, erudito e malacologo, raccoglitore e classificatore di oggetti, di dati e di date, è elettivamente disposta alla ricerca e alla sistemazione dei nomi, alla loro disposizione ed elencazione (e si può ricordare, sempre nel Capitolo primo, il sogno di farsi pirata per impadronirsi della «speronara» che sta trasportando chissà dove dei marmi: se potesse averli farebbe schiattare di rabbia altri collezionisti concorrenti, i cui nomi vengono anch’essi riportati in elenco)9 . Ma in tutta l’opera di Consolo si danno le più diverse variazioni, combinazioni, funzioni in questo uso dei nomi. Così nel racconto di cui qui presentiamo la traduzione di Irene Romera Pintor 7 Si noti qui la sottile scansione, con la successione dei tre membri introdotti nell’ordine da donne, vecchie, uomini, e poi il successivo elenco in cui risaltano i luoghi d’origine dei diversi prodotti, dove l’evidenza delle derrate alimentari è sottolineata dal complemento con il nome proprio, il tutto disposto in una sequenza di quattro settenari e di un endecasillabo: vino di Pianoconte,/ malvasia di Canneto,/ ricotte di Vulcano,/ frumento di Salina,/ capperi d’Acquacalda e Quattropani. 8 «Avrebbe fottuto il Bìscari, l’Asmundo Zappalà, l’Alessi canonico, magari il cardinale Pèpoli, il Bellomo e forse il Landolina».
60 Pintor, Filosofiana, si può trovare una fitta presenza di nomi geografi ci e topografi ci, mentre fortissima suggestione ha l’elenco dei nomi delle erbe pronunciato dall’impostore don Gregorio: “E salmodiando, don Gregorio gettava sopra la balàta le erbe che prendeva a una a una dalla sporta, chiamandole per nome. «Pimpinella,» diceva «Petrosella, Buglossa, Scalogna, Navone, Sellerio, Pastinaca…»”10.
Ma vorrei insistere un po’ più diffusamente su Retablo, che prende avvio proprio da un nome, quello della donna amata da Isidoro, Rosalia, subito scomposto nelle sue due componenti, Rosa e Lia, poi ossessivamente ripetute. Ciascuna di queste due componenti dà avvio ad una serie di esaltate variazioni. La prima variazione scaturisce dal piano semantico di rosa, in un delirio floreale, carico di profumi e di colori, che dà luogo ad altre serie di termini moltiplicati. Dopo il nome e la sua scomposizione, rosa viene ripetuto quattro volte, ogni volta seguito da una relativa che ne specifica l’azione; poi si passa ad una negazione paradossale (Rosa che non è rosa) e a due nuove riprese di rosa, accompagnate ancora da relative, ma stavolta le relative danno luogo a predicati nominali, entro ciascuno dei quali si dispongono quattro termini con nomi di fiori (prima datura, gelsomino, bàlico e viola; poi pomelia, magnolia, zàgara e cardenia). A queste identificazioni della donna con i diversi fi ori succede l’immagine del tramonto, con il suo trascolorare (fissato nell’immagine della sfera d’opalina, cioè di un vetro traslucido e opalescente) e con l’addolcirsi dell’aria (forte l’espressività di sfervora, come se essa riducesse la sua febbre), seguita nel suo penetrare dentro il chiostro del convento e nel suo spandervi nuovi profumi (ancora con elencazioni seriali, prima dei predicati, coglie, coinvolge, spande, poi dei complementi aggettivati, odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi) che sembrano risultare da un’opera di
10 CONSOLO, V. (1988: 92). Vero tour de force quello della traduzione di Romera Pintor, in CONSOLO, V. (2008: 69): “Y mientras salmodiaba, don Gregorio echaba sobre la lápida las hierbas que tomaba una a una del capazo, llamándolas por su nombre./ «Pimpinella» decía «Petrosela, Buglosa, Chalote, Nabo, Apio, Pastinaca…»”. 61
distillazione (e i balsami sono grommosi perché sembrano carichi di incrostazioni, di una sensuale impurità): “Rosalia. Rosa e lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha ròso, il mio cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, magnolia, zàgara e cardenia. Poi il tramonto, al vespero, quando nel cielo appare la sfera d’opalina, e l’aere sfervora, cala misericordia di frescura e la brezza del mare valica il cancello del giardino, scorre fra colonnette e palme del chiostro in clausura, coglie, coinvolge, spande odorosi fiati, olezzi distillati, balsami grommosi. Rosa che punto m’ha, ah!, con la sua spina velenosa in su nel cuore”11. Sul secondo termine della scomposizione si svolge tutta una serie di variazioni foniche a partire dal significante lia, in un viluppo di termini che contengono la sillaba li o la sola labiale l (daliato a lumia a liana a libame, licore, letale, ecc., fi no a liquame). Dal nome Lia si svolge, come un vero e proprio denominale, il verbo liare (che indica un’azione simile a quella che fanno sui denti agrumi come il cedro e la lumia), a cui segue tutta una serie di sostantivi caratterizzati dalla posizione iniziale della sillaba li, da liana (che contiene in sé il nome Lia); si notino le voci dotte libame (latino libamen), «libagione» che agisce come una droga (oppioso), lilio per «giglio», angue per «serpente»; limaccia indica una «lumaca» che lo avvolge nei suoi vischiosi avvolgimenti, attassò, (siciliano da attassari, «assiderare, freddare»); lippo è il siciliano lippu, che indica il musco e in genere ogni pellicola viscosa che si attacca: “Lia che m’ha liato la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa, limaccia che m’invischiò nelle sue spire, lingua che m’attassò come angue che guizza dal pietrame, lioparda imperiosa, lippo dell’alma mia, liquame nero, pece dov’affogai, ahi!, per mia dannazione”12. 12 Ibidem. 62 Ruotando sul nome e scomponendolo, in queste cascate di sostantivi che solo in pochi casi sono accompagnati da aggettivi, si svolge così un canto d’amore cieco e sensuale che si riavvolge su se stesso e che trova una figura esemplare, nel serpe che addenta la sua coda, del riavvolgersi di ogni esperienza su se stessa (è una figura, questa, molto cara a Consolo, come quella simile della chiocciola, riavvolta su di sé, in un percorso circolare che sempre torna al punto di partenza). Dopo questa scomposizione del nome della sua Rosalia, il frate ricorda di averla cercata nei luoghi più diversi di Palermo, fino ad identificarla in modo blasfemo con l’immagine della santa protettrice della città, Rosalia appunto, venerandone il corpo racchiuso nel sepolcro di cristallo nel celebre santuario del Monte Pellegrino: esasperata sensualità, erotismo, ossessione funebre, ritualità spettacolare, senso del peccato e della dannazione si fondono qui in un nesso inscindibile. Il nome di Rosalia viene ripetuto poi più volte, in diversi punti del libro; e al diario della peregrinazione del pittore Fabrizio Clerici si intreccia una confessione di Rosalia, che si scinde e si confonde in un’immagine singola e doppia, la Rosalia di don Vito Sammataro e la Rosalia di Isidoro che è in realtà «solamente la Rosalia d’ognuno che si danna e soffre, e perde per amore»13. Nell’attraversare i luoghi della Sicilia, Fabrizio Clerici ne assapora i nomi propri, trae in luce i signifi cati che addensano in sé; e dalle più semplici etimologie può lasciar scaturire altre cascate di nomi, come qui, che dal nome di Salemi vengono fuori in successione altri nomi astratti, altri nomi geografi ci, altri nomi concreti: “Ma era certo insieme quel paese Salem e Alicia, luogo di sale e luogo di delizia, del rigoglio e del deserto, dell’accoglienza e dell’inospitale, della sterilità e del fico bìfero, ché subito, appena pochi passi oltre l’aridume, ove la terra veniva ristorata dalle fonti di Delia, Ràbisi, Gibèli, Rapicaldo, dal Gorgo della donna, la terra si faceva, come la Promessa, copiosa di frutti d’ogni sorta, e di pascoli, di vigne, d’olivi, di sommacco”14.. 63 Poco più avanti si ascolta don Carmelo Alòsi, esperto nell’arte «degli innesti e della potatura», elencare, come «un unico giardino, unico e sognato, tutti i giardini» che ha conosciuto e in cui ha lavorato: “di Francofonte o di Lentini, della Conca d’Oro o del Peloponneso, di Biserta o d’Orano, di Rabat o di Marrakech o di Valencia. Come pure i giardini di capriccio e d’ornamento, piccoli come quelli di Mokarta, del Patio de los Naranjos sotto la Giralda di Siviglia, del Generalife sopra all’Alhambra di Granada o quello delle latomìe del Paradiso in Siracusa”15. Ma la campionatura dei nomi di Retablo può agevolmente condurre dai nomi geografi ci e topografi ci a quelli mitici. Così da una epigrafe greca di Selinunte sgorga una serie di nomi di classiche divinità: “Vinciamo per Zeus, per Phobos, per Eracle, per Apollo, per Poseidon e per i Tindaridi, per Athena, per Malophoros, per Pasikrateia e per gli altri dèi, ma per Zeus massimamente…”16. Ci sono poi i nomi storici, come quelli delle famiglie nobili di Trapani di cui don Sciavèrio Burgio presenta le dimore, a cui seguono i nomi delle chiese: “- Del barone Xirinda –dicea– del duca Sàura, dei signori Scalabrino, del marchese Fardella, del barone Giardino, Piombo, della Cuddìa, di San Gioacchino, dei signori Pèpoli, Staìti; e ancora: Poma, Todaro, Reda, Milo, Salina, Bartalotta, Riccio, Pandolfina, Rapì, Arcudaci… Quindi le chiese, più belle, più imponenti: del Collegio, di san Lorenzo, di Santo Spirito, della Badia, del Monserrato…”17. In questo delirio dei nomi, quello del poeta Giovanni Meli, ricordato dal pastore Alàimo, dà luogo ad una serie di variazioni paronomastiche: 64 “D’un poeta di qua, mi disse dopo, da tutti conosciuto e frequentato, di nome Meli. Ma Mele dico ei doversi dire, come mele o melle, o meliàca, che ammolla e ammalia ogni malo male”18. Ecco poi gli elenchi di nomi di oggetti, come quelli che popolano la casa-museo del Soldano: “… mi parve d’entrare nel museo più stivato e vario. V’era per tutte le pareti, sopra mobili e mensole, capitelli e basi di colonne, dentro nicchie e stipi, pendenti fi nanco dal soffi tto, ogni più bello e prezioso o più orrido e peregrino oggetto. Integri e lucidi e con disegni limpidi, neri crateri sicoli e attici, anfore oriballi coppe pissidi lecane, teste e gambe e torsi di terre cotte e marmi, arcaici rilievi di frontoni, di corrose metopi, luminosi parii di dèe e divi e d’eroi mitici di grecanica, fattura nobilissima o nei rifacimenti de’ romani; tavole dorate bizantine, croci dipinte, pale dei Fiamminghi, e vaste tele delle scuole del Sanzio, del Merisi o del Vecellio; stemmi, pietre mischie, conche di porfido, retabli gagineschi, calici incensieri cantaglorie, teschi d’avorio o maiolica sopra le cartapecore di codici e messali; cereplaste di Vanitas, morbi, pesti, flagelli e di Memento mori…”19. Come sintesi esemplare di questa furia della nominazione che agisce in ogni momento di Retablo, che agisce allo stesso modo sul frate siciliano sfratato e sul viaggiatore milanese che attraversa la Sicilia (anche se questi mette in bocca molte di queste serie di nomi a siciliani, a ospitali personaggi incontrati durante il suo viaggio), si può ricordare la pagina seguente, che si svolge in accumuli successivi di nomi di ordini diversi, da nomi geografi ci a nomi di navi a nomi di merci di ogni sorta. Siamo davanti al porto di Trapani (come fatto riavvolgere su se stesso attraverso il gioco paronomastico porto/ porta, in più complicato dal superlativo importantissima), la cui immagine balena in tutta evidenza davanti al lettore grazie ad una sorta di litania, attribuita da quel don Sciavèrio che accoglie i viaggiatori (e proprio letàne viene chiamata, non senza una certa ironia, quasi un fuggevole. 65 do autoironico di Consolo alla propria così pervicace e suggestiva passione per i nomi): “In quel porto, ch’è porta importantissima d’ogni incrocio e scambio, d’ogni più vario mondo, d’ogni città di traffico e commercio d’infra e fuori Regno, del settentrione e del meridione, del levante e del ponente, d’ogni isola, costa o continente: di Cipro, Rodi, Candia, Malta e di Pantelleria, d’Amalfi , Procida, Livorno, Lucca, Pisa, Genoa e Milano, di Venezia e di Ragusa, di Barcellona, Malaga, Cadice, Minorca… Vascelli, brigantini, galeoni, feluche, palmotte, sciabecchi, polacche, fregate, corvette, tartane caricavano e scaricavano, nel traffi co, nel chiasso, nell’allegria della banchina, le merci più disparate: sale per primo, e in magna quantitate, poi tonno in barile, di quello rinomato di Formica, Favignana, Scopello e Bonaglia, e asciuttàme, vino, cenere di soda, pasta di regolizia, sommacco, pelli, solfo, tufi , marmi, scope, giummara, formaggi, intrita dolce e amara, oli, olive, carrube, agli, cannamele, seta cruda, cotone, cannavo, lino alessandrino, lana barbarisca, raso di Firenze, carmiscìna, orbàci, panno di Spagna, scotto di Fiandra, tela Olona, saja di Bologna, bajettone d’Inghilterra, velluto, fl anella, còiri tunisini, legnami, tabacco in foglie, rapè, cera rustica, corallo, vetro veneziano, mursia, carta bianca… Queste letàne me le cantò orgoglioso un trapanese, cònsolo del Corpo dei naviganti, patrone di vascelli, don Sciavèrio Burgio…”20.
20 CONSOLO, V. (1987b:132). 66 BIBLIOGRAFIA: CONSOLO, V. (1987a): Il sorriso dell’ignoto marinaio, Introduzione di Cesare Segre, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (1987b): Retablo, Palermo: Sellerio. CONSOLO, V. (1988): Le pietre di Pantalica, Milano: Mondadori. CONSOLO, V. (2006): Nottetempo casa per casa, Prefazione di Giulio Ferroni, Torino: UTET, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. CONSOLO, V. (2008): Filosofiana (relato de Las piedras de Pantálica), Edición, introducción, traducción y notas de Irene Romera Pintor, Madrid: Fundación Updea Publicaciones
La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO
(Homenaje por sus 75 años)
Irene Romera Pintor (Ed.)

Giuseppe Tornatore fotografo Vincenzo Consolo
*
Bisogna subito dire di Bagheria, paese dove è nato e cresciuto Giuseppe Tornatore, questo regista della seconda generazione dei grandi registi italiani del secondo dopoguerra. Dire di Bagheria e di Giuseppe Tornatore fotografo, della sua fotografia come telemachia, prima educazione artistica, primo passo verso il mondo delle immagini, verso il cinema.
Bagheria, singolare paese, rispetto agli altri paesi di Sicilia per il motivo e per il modo in cui esso è nato, si è formato. “Bagheria – latino, Bayharia – Siciliano, Baaria (Val di Mazara). Estesissima ed amena campagna, ad oriente del territorio di Palermo, adorna all’ultima eleganza di casine suburbane di signori; lungo sarebbe descriverle, dirò tuttavia delle primarie. E prima occorre l’amplissima villa del principe Butera (…) Sovrastà ad una altura, a mezzogiorno di quella terra, al villa Valguarnera, dove nulla desideri che tenda alla delizia dell’animo; magnifica altresì quella di Aragona né quella di Cattolica, Filingeri, Palagonìa, Lardaria, sottostanno per fabbriche, ornamenti e disegno; sono palazzi degni tutti di grande città”. Così scrive Vito Amico nel suo Lexicon Siculum (1757), tradotto dal latino e postillato da Gioacchino di Marzo (Dizionario Topografico della Sicilia, 1858). E partiamo dunque dal primo che fece costruire la sua villa in quella “estesissima e amena campagna”, il principe Butera. Un emistichio del Tasso, O corte a dio, e una quartina in lingua spagnola faceva incidere sul primo e sul secondo arco di ingresso alla sua villa a Bagheria don Giuseppe Branciforti, conte di Mazzarino e principe di Butera. A capo di una congiura contro il re di Spagna, Filippo IV, e contro i viceré di Sicilia, don Giovanni d’Austria, l’eroe di Lepanto, nel sogno di divenire re di una Sicilia indipendente, tradito e traditore – la sua delazione, insieme a quella del poeta Simone Rao, costò la vita a sei congiurati – il Butera si ritirò in quel sobborgo di Palermo, tra la fenicia Soluto e la greca Imera, si chiuse dentro quella sua dimora che era fortezza, castello, tomba non di libri e di salme come l’Escorial, ma di orgoglio umiliato e di rimorso.
Ya la esperanza es perdita
Y un solo ben me consuela
Que el tempo que pasa y buela
Lleverà presto al vida.
Congiuravano contro il re di Spagna, i nobili di Sicilia, ma frequentavano i poeti spagnoli. Epigrafava la sua villa, il principe di Butera, con versi tratti dalla Galatea di Miguel de Cervantes. Dopo il Butera, come ci dice l’Amico, costruirono ville nell’amena plaga molti altri nobili, tra di loro in gara di delizia, di sfarzo, fino al rovesciamento nel delirio del barocco, nell’allucinazione pietrificata, nel capriccio goyesco della villa dei Mostri del principe Palagonìa, da cui Goethe, in cerca in Sicilia di una Ellade di luce e d’armonia, si sarebbe allontanato inorridito. Scrive nel suo Viaggio in Italia: “Palermo, lunedì 9 aprile 1787. Abbiamo sciupato tutta la giornata d’oggi dietro le pazzie del principe di Palagonia. (…) Quando il padre del principe attuale costruì la villa, (…) ha concesso libero sfogo al suo capriccio e alla predilezione per il deforme e per il mostruoso”. Certo, per un Goethe che viaggiavo in Sicilia con il metro di Winckelmann in tasca, quella villa Palagonìa non poteva che suscitargli orrore.Le ville di Bagheria. “Di ville, di ville!…di principesche ville” avrebbe esclamato con ironia Gonzalo – Carlo Emilio Gadda, riferendosi a quelle di Lukones, vale a dire della Brianza, ne La cognizione de dolore. Le ville di Bagheria non le hanno certo costruite con le loro mani i nobili, i Gattopardi di Sicilia, il loro progetto villesco, nella loro gara di sfarzo, di lusso, oltre agli architetti, ha attirato là, da Palermo e da altre zone della Sicilia, masse di murifabbri, scalpellini, falegnami, manovali e artigiani, oltre a braccianti, a contadini, per lavorare negli estesi giardini. Gli abitanti di Bagheria, abitanti al di qua delle ville cinte di gran mura come fortezze, erano, ci dice il Di Marzo, nel 1852 quasi diecimila. E oggi sono più di quarantamila. Al di qua delle alte mura delle ville i cui padroni, i famosi “leoni e i gattopardi” lampedusiani sono per la maggior parte tramontati, finiti per isolamento, dissennatezza o alienazione, al di qua sono nati e cresciuti a Bagheria, tra quello che si chiamava il popolo, gli spiriti più acuti, più intelligenti, gli artisti e gli intellettuali più dotati. Facciamo per tutti tre nomi: il poeta Ignazio Buttitta, il pittore Renato Guttuso e il fotografo-regista Giuseppe Tornatore. E qui vogliamo dire, dell’autore di famosi films, come Nuovo Cinema Paradiso, Stanno tutti bene, L’uomo delle stelle, La sconosciuta, e altri, e, in fase di produzione, l’ancora inedito Baarìa, di cui qui compaiono immagini delle riprese. La Baaria funestata oggi da quella mala pianta che si chiama mafia, da quelle “iene e sciacalletti” che sono subentrati ai principi e ai baroni delle famose ville. Giuseppe, anzi Peppuccio Tornatore, muove dunque i primi passi per le strade di Bagheria con una macchina fotografica in mano. La Sibilai, le città e i paesi siciliani, per la loro profondità storica, sono stati da sempre interessanti e “urgenti” per i viaggiatori stranieri, per gli incisori prima, incisori come Houel e Saint-Non, e quindi, con l’avvento della fotografia, è divenuta interessante e “urgente” per fotografi stranieri e per gli stessi siciliani. Ai primordi, verso la fine dell’Ottocento, vale a dire, otografano la Sicilia l’inglese Samuel Butler, l’eccentrico autore de L’autrice dell’Odissea, la grande triade quindi dei veristi siciliani, Capuana, Verga, De Roberto, che nella fotografia vedevano confermate le loro tesi letterarie. E ancora i fratelli Alinari, Giacomo Brogi, l’esteta von Gloeden, Giorgio Sommer. Robert Capa, poi, sbarcato nel ’43 con gli Americani in Sicilia, fotografò la Sicilia di quel momento della Liberazione. Vi fu poi la scuola di fotografi palermitani, da Interguglielmi a Giusto e Nicola Scafidi a Enzo Sellerio, a Ferdinando Scianna, a Melo Minnella. A questa scuola e a questa tradizione ha appartenuto il giovane fotografo Peppuccio Tornatore. Scrive Tornatore nel libro Giuseppe Tornatore fotografo in Siberia: “Dopo mesi e mesi vissuti in moviola, al buio, gli occhi eternamente puntati a vedere, rivedere…Ero in questo limbo dell’immaginazione, mentre mi avviavo a concludere il montaggio di La leggenda del pianista sull’oceano, quando un bel giorno, inaspettatamente, la voce nordica e gentile di Alberto Meomartini giunge a insinuarsi come una nota stonata nel quotidiano coro telefonico: “So che da ragazzo lei è stato fotografo. Se la sentirebbe di tornare a fare fotografie?”. Il Meomartini lo invita dunque ad andare in Siberia con la sua Rolleicord. Sono quelle fotografie di una Siberia innevata, quasi desolata, una terra di Dostoevskij o Solzenicyn, ma sono anche foto di bimbi, di donne, di uomini di grande dignità. E poi, in giro per la Russia, Tornatore ha fotografato Mosca, e in giro per il mondo, la Cina, il Giappone, l’America, la Tunisia. Sono foto che in parte compaiono in questa mostra. Ma a chi qui scrive, da siciliano e sicilianista, senza nessuna ombra di regionalismo, interessa molto il fotografo che “da ragazzo” fotografava la Sicilia, fotografava la sua Baaria, Porticello, Palermo, Portella della Ginestra…Sono fotografie degli anni Sessanta-Settanta di una Baaria ancora povera, contadina, ancora non mutata antropologicamente, fuori ancora crediamo dalla contaminazione corleonese: una Baaria priva di ville, ma nobile, ricca di umanità.
Indiscrezioni
Giuseppe Tornatore fotografie
Edizioni Fratelli Alinari 2008
Giuseppe Tornatore e Vincenzo Consolo a Venezia
foto di Giovanni Giovannetti

L’ape Iblea. Elegia per Noto
Invocazione
eterno transito,
segno della fine e dell’inizio,
d’ogni sciame mi dici
del cielo e della terra.
Dimmi dell’asse rotto,
dell’antico scuotimento
della plaga orientale
che ondeggia come mare
Dimmi dell’arnia d’oro
ricomposta al piano,
di Ibla e di Megara
della ragione e del compasso,
di Noto replicata
per apicule tenaci,
sfida a ulteriori scuotimenti,
sogno di scalpellini e architetti
Antica melodia
Per la porta reale
entra ora nel sogno,
nel teatro delle meraviglie,
inizia il tuo viaggio
nell’eco d’Aretusa,
nel coro vibrante delle api
vai tra le quinte di luce,
i fondali celesti,
le prospettive audaci,
il gioco di specchi sulla pietra opulenta,
il raggio che s’inombra nella spirale
Nell’oscillare della campana,
nel rintocco grave, sciamano uccelli,
svolano dalle canne, dai pantani,
migrano gli aironi, sfiorano la cupola ma la lanterna,
contro il cielo di cobalto
Favola della luna che si sfalda
Ma la Luna la Luna la Luna
la maculata Luna è dissonanza,
è creatura atonica, scorata,
caduta dalla traccia del suo cerchio,
vagante negli spazi desolanti.
È saturnina la Luna, atra,
malinconica, sospesa
nell’attesa infinita della fine
che non arriva mai
Esci, vola Regina degli Iblei
da questo labirinto,
da questo teatro che si disfa,
crolla per sordo terremoto…
… ricerca le dimore,
le arnie dimentiche sul ciglio dei burroni
Labirinto e crollo
E subito il boato,
lo schianto spaventoso,
il crollo della cupola
materna. La polvere
imbianca il cuore
della notte, il mio mantello
asciuga in gola
urlo, gemito
Il nome tuo NO
TO s’è spezzato.
L’ape, crisalide trafitta,
pupilla vuota, ombra
frammenti poetici di, Vincenzo Consolo incisioni di Daniele Montis
L’Ape Iblea maggio 2008 Carlo Delfino Editore
Presentazione del libro Filosofiana, di Vincenzo Consolo racconto tratto dal libro le “Pietre di Pantalica”. Madrid istituto Cervantes. Il 17 di aprile 2008 Presenta: Manuel Gil Esteve (Cattedratico de Filologia Italiana. Universidad Complutense. Partecipano: Renzo Cremante, Cattedratico de Filologia Italiana Director del Fond de Manuscritos de Autores Contemporaneos. Università di Pavia. Salvatore Trovato, Cattedratico de Linguistica Universidad de Catania. Irene Romera Pintor: Professora Titular de Filologia Italiana. Univesidad de Valencia.
“Un sogno perso” por PASQUALE SCIMECA
“Un sogno perso” è il mio secondo film, ed è un film che deve molto a Vincenzo Consolo, ma questo lui non lo sa. Nel 1988, io facevo l’insegnante. Come spesso accadeva a tanti della mia generazione, dopo la laurea, sono andato a lavorare nelle regioni del nord Italia; perché lì c’erano più possibilità.
Durante l’estate tornavo al mio paese per stare un po’ con i miei e ritrovare i vecchi amici. Quella estate del 1988, al mio paese, avevano indetto un concorso di fotografia. Il mio è un piccolo paese con poco più di mille abitanti, nel centro del feudo della Sicilia. I miei amici, che sapevano della mia passione per la fotografi a, mi esortavano a presentare le mie foto a questo concorso. Io, sinceramente, non ero molto interessato alla cosa e non volevo farlo; però quando mi dissero che il Presidente della giuria era Vincenzo Consolo, ho deciso di partecipare per avere così la possibilità di conoscerlo. Il primo premio, per chi vinceva questo concorso, consisteva nella solita “targa”, e cosa più importante, in un milione di lire (circa cinquecento euro di oggi). Così cominciai ad andare in giro per le campagne a fotografare i pastori e i contadini, (quelli che ancora resistevano a quella vita di stenti). Alla fi ne fui io che vinsi il primo premio, e con i soldi mi comprai una cinepresa Arriflex 16 mm di seconda mano. Il possesso di questa cinepresa stimolò la mia antica passione per il cinema; e fu così che iniziò la mia carriera cinematografica. Vincenzo Consolo, suo malgrado, ha dunque una responsabilità molto grande per quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro. Anche perché senza quel milione del premio non avrei mai comprato quella cinepresa (che conservo ancora come un cimelio) e non avrei mai iniziato a fare cinema.
I miei due primi film (La donzelletta e Un sogno perso) li ho fatti con quella cinepresa, e questo mi ha permesso, soprattutto, di sviluppare la mia idea di cinema autoriale; dalla scrittura alla fotografia, dal montaggio alla produzione. Eravamo un gruppo di amici ai quali piaceva il cinema e abbiamo coinvolto altre persone, e così abbiamo fatto, a bassissimo costo, La donzelletta. Poi questo fi lm è stato comprato da Enrico Ghezzi per Fuori Orario che andava (e va ancora) in onda su Rai Tre. E sempre Rai Tre ci ha dato i soldi (cento milioni di lire —cinquantamila euro circa di oggi—) per il secondo film: Un sogno perso.
Dopo questa piccola parentesi, vorrei tornare a parlare dei temi, che in questi due giorni di convegno, hanno affrontato l’opera di Vincenzo Consolo, partendo proprio dal mio secondo film Un sogno perso.
I due primi episodi del film sono tratti dalle opere di due grandi scrittori siciliani: Elio Vittorini e Vincenzo Consolo. Dico scrittori siciliani e non italiani, perché una parte importante della letteratura italiana del secolo scorso è stata opera di autori siciliani (Pirandello, Brancati, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, per citare solo i più noti). Una cosa, questa, che mi ha sempre colpito; perché fi no alla metà del secolo scorso, in Sicilia, l’ ottanta per cento della popolazione era analfabeta. Mi sono sempre chiesto; come è possibile che da un popolo di analfabeti siano potuti uscire questi grandi scrittori? Io credo, che in qualche modo, questo abbia a che fare col fatto che l’arte del racconto, il gusto e il piacere del racconto
(che purtroppo oggi si è perso) è un qualcosa di insito nell’animo del popolo siciliano. In tutti i paesi c’erano delle persone: artigiani, contadini, pescatori, minatori, ecc., che erano stimati e amati solo perché avevano il dono del racconto. Da bambino passavo anch’io il mio tempo seduto nelle botteghe dei barbieri o dei calzolai a sentire i loro racconti. E poi c’erano i Cantastorie con le loro chitarre e i loro cartelloni dipinti, e i pupari, questi artigiani dell’arte che intrattenevano il pubblico, non una sera o due, ma trecento sessanta sere all’anno, ogni sera c’era una puntata, con racconti straordinari che assomigliavano molto a quelli delle Mille e una notte. Un sogno perso è un film di tanti anni fa: del 1992. Un film su un sogno, perso per l’appunto. Il sogno di un mondo, quello della mia infanzia, della civiltà contadina spazzata via da una nuova forma di civiltà che P. P. Pasolini chiamava del consumismo, dove ci sono tutte quelle cose che dicevo prima, ma c’è soprattutto la letteratura. Il primo episodio è tratto da Filosofiana di Consolo e il secondo dall’ultimo romanzo (incompiuto) di Vittorini Le città del mondo.
Quello che ho fatto, rispetto al racconto di Consolo, è un’ opera, diciamo così, di tradimento. Perché dal momento che faccio un film tratto da uno scrittore è chiaro che lo tradisco. Lo tradisco nella forma e nella sostanza. Per me, l’episodio del libro di Consolo Filosofiana è anche un modo per raccontare un’altra cosa (che poi, credo, sia insita, sostanzialmente anche in Consolo), ma per me è una cosa più esplicita. Nel mio caso è una scusa per raccontare qualcosa di questo mondo che andava scomparendo; della Sicilia vista come metafora della civiltà contadina, questa millenaria civiltà contadina che si è riprodotta quasi uguale nel tempo. Per secoli e secoli ha riprodotto se stessa, con pochissime innovazioni, però anche con una pratica culturale e sociale, con un’idea del rapporto con la natura, con la cultura, l’educazione, e che nell’arco di qualche decennio è stata completamente annientata, distrutta. E questo in Sicilia è avvenuto anche fisicamente attraverso l’ emigrazione. Milioni di contadini, che avevano iniziato ad andare via già verso la fi ne dell’Ottocento, quando partivano a migliaia e migliaia, sui piroscafi che li portavano in America, in Argentina, in Brasile e perfino in Sudafrica. Ma negli anni cinquanta del secolo scorso, la cosa è diventata una vera e propria desertificazione, di una civiltà, di una cultura ma anche di una terra che cambiava. Prima di partire in massa i contadini, a dire il vero, avevano tentato una qualche forma di resistenza, disperata, folle, eroica. L’ultimo tentativo di resistenza, sono state le lotte contadine. Negli anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale, centinaia di migliaia di contadini hanno tentato di cambiare se stessi, di cambiare le cose, di scardinare quelle forme di potere feudale che si basavano sulla mafia, sulle classi aristocratiche, sulle gerarchie ecclesiastiche, sulle burocrazie del nuovo Stato unitario. Purtroppo queste lotte sono fallite, e il movimento contadino non si è più ripreso. Non solo il movimento contadino, ma l’intero popolo siciliano ha perso la sua identità e la sua anima. Ho parlato di popolo, ma in realtà, in Sicilia vi erano almeno tre popoli: quello dei pescatori, quello dei minatori e quello dei contadini. Erano mondi separati che spesso non avevano alcun rapporto fra di loro. Il minatore la mattina scendeva in miniera e non sapeva se la sera sarebbe tornato in superficie. Questo fatto determinava un modo di essere, una caratteristica esistenziale che lo distingueva da tutti gli altri. I contadini, ad esempio, si vestivano a festa soltanto in rarissime occasioni (funerali, matrimoni, battesimi, ecc.), mentre i minatori, ogni fi ne settimana si vestivano di modo elegante e andavano ad ubriacarsi nelle taverne, spendevano tutti i soldi che avevano guadagnato e che rimanevano, dopo le spese per la famiglia, perché tanto poi, chi sa se sarebbero tornati vivi dalle viscere della terra, l’ indomani tornando al lavoro. Per non parlare dei pescatori, che spesso parlavano dei dialetti propri, incomprensibili agli altri. Erano veramente tre mondi diversi l’uno dell’altro, ma accumunati da un’ unico destino; quello dell’estinzione. Questi popoli, scomparendo, hanno lasciato un deserto, ed è di questo che si parla nel mio film “Un sogno perso”, che poi è anche il mio sogno perso. Io vengo da un piccolo paese contadino… Per qualsiasi ragazzo del mio paese, Cefalù (la stessa Cefalù dove Consolo ha ambientato II sorriso dell’ignoto marinaio) era la civiltà, era il mondo. Sono andato a studiare a Cefalù dopo le scuole elementari, e quando uscivo per strada, spesso rimanevo sbalordito da questo nuovo mondo: i negozi, le ragazze in costume che si vedevano in estate, la cattedrale imponente, i palazzi signorili… Questo film mi ha aiutato a cercare un sogno che non esiste più. Un sogno che non potrà più ripetersi e qual è il modo migliore di cercare i sogni? Cercare nella letteratura; ecco perché Consolo, ecco perché Vittorini. Questi due episodi che i due grandi scrittori raccontano nei loro libri, mi sembravano fossero molto importanti perché in qualche modo erano degli episodi che seguivano in un arco di tempo (dalla fi ne della guerra fi no agli anni cinquanta), la delusione provocata dal fallimento delle lotte contadine. Vito Parlagreco che cerca di rifarsi una vita comprando questo pezzetto di terra pieno di pietre, perché erano delle vere e proprie pietraie le terre che una falsa riforma agraria dava ai contadini. Così come Vittorini in Le città del mondo ci racconta di quello che succede dopo. L’incomunicabilità tra padri e figli, la paura dei padri per l’ignoto e il desiderio dei figli di partire, di cancellare le orme dei padri. La rottura del Mito, l’inutilità della parola e della scrittura che caratterizzeranno gli ultimi anni di vita di Vittorini, e la ricerca spasmodica, quasi maniacale che Consolo dedica alla scrittura, sono le due facce della stessa medaglia. Si può scrivere di un mondo che sta scomparendo? Si può scrivere con parole che per le generazioni future non avranno più alcun significato? Lo si può fare a condizione di guardare alla storia come fosse l’anima del popolo, a condizione di rinunciare a qualsiasi forma di verismo e di andare all’essenza; “Eschilo, è nato qui, in terra di Sicilia” fa dire Consolo a don Gregorio, l’imbroglione che leva a Parlagreco l’ultima vana illusione. Eschilo il grande tragico… Chissà attraverso quale associazione d’idee mi viene in mente Verga. Forse perché penso che Verga è anche lui un grande tragico. Vittorini non è stato un grande tragico, ma tendeva in qualche modo alla tragedia attraverso la costruzione del mito. Consolo cerca la tragedia attraverso la parola, attraverso questo altro modo di lavorare la parola, di alzare il livello della realtà alla metafisica, scavando le parole come un minatore. Io quando sento parlare di letteratura regionalistica provo un po’ fastidio perché penso che la letteratura siciliana non ha niente di regionale, è pura metafora. È un caso che parla di Sicilia, anche se senza Sicilia non potrebbe esistere. Come diceva Vittorini (in Conversazioni in Sicilia) “È per caso che questa storia si svolge in Sicilia”. Dunque la Sicilia —come diceva un altro grande: Leonardo Sciascia— è una metafora del mondo. Quindi è una bella miniera per uno scrittore, dalla quale poter estrarre i minerali che si sciolgono nella lingua, che tra l’altro è una lingua molto ricca (c’è dentro qualcosa della lingua araba, di quella greca, spagnola, francese, italiana). Una lingua profonda che ha radici, che si nutre della terra. Questo è un po’ l’origine di questo film. Dove non c’è solo un riferimento letterario, ma un processo che parte dalla letteratura e diventa altro – perché il cinema è altro – Un bisogno esistenziale, un tentativo di raccontare la desertificazione di un mondo, la scomparsa di un popolo che può tornare a vivere solo nel sogno. Perché senza questo sogno non c’è letteratura, ma non c’è neanche il cinema. Grazie.
La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO
(Homenaje por sus 75 años)
Irene Romera Pintor (Ed.)
foto di Marino Ciardi
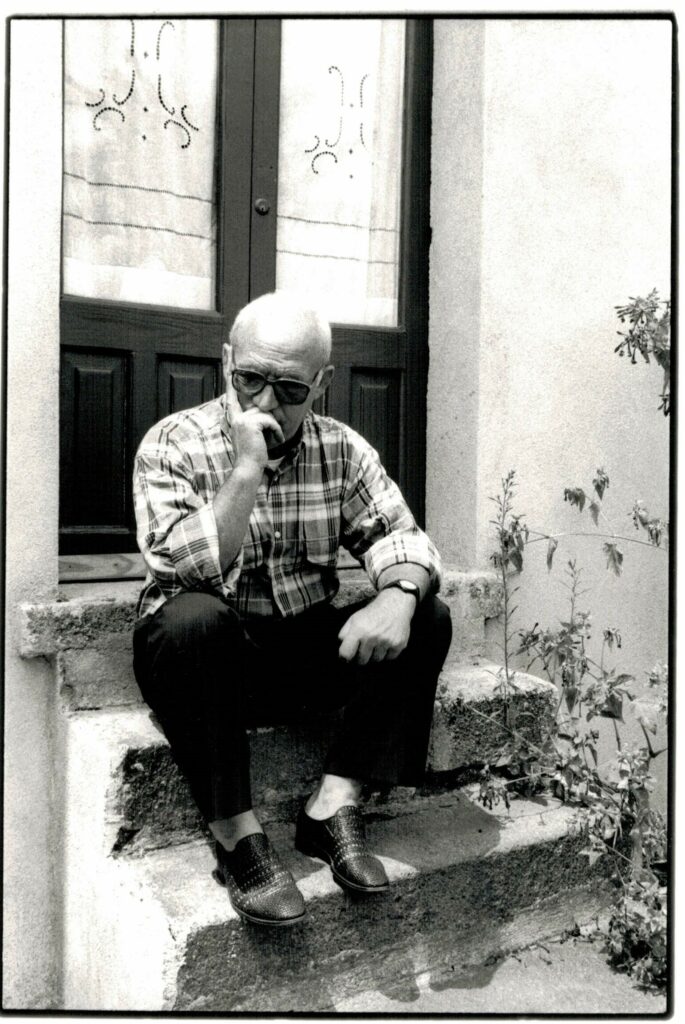
Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano
VINCENZO CONSOLO
“Al Señor Antonio Veneziani. Señor mio: dichiaro alla Signoria Vostra, come cristiano, che sono tante le fantasticherie che mi affaticano, che non mi hanno permesso di portare a compimento come volevo questi versi che Le invio, in segno del desiderio che ho di servirla, già che questo mi ha indotto a far vedere così presto i difetti del mio ingegno, fiducioso che l’alto ingegno della Signoria vostra accoglierà le mie scuse e mi animerà affinché in tempi più tranquilli non tralasci di celebrare come potrò il cielo che così tristemente la trattiene su questa terra, dalla quale ci liberi Dio, e la porti in quella dove vive la vostra Celia.
Ad Algeri, il 6 Novembre del 1579 Della Signoria Vostra vero amico e servitore. Miguel de Cervantes”. Questa lettera e le ottave a Antonio Veneziano, che essa accompagna, furono scoperte nel 1914, nella Biblioteca Nazionale di Palermo, dal professore Eugenio Mele. Lettera e versi entrarono quindi nelle Obras completas di Cervantes, a cura di Rodolfo Schevill e Adolfo Bonilla (Madrid, 1914-31). Questi alcuni versi delle Ottave a Antonio Veneziano: “Il cielo, che contempla il vostro ingegno, ha voluto impiegarvi in queste cose, e segue i vostri passi perché aspira a innalzarvi, per Celia, sino al cielo: (…)
Mi sorprende veder che quel divino ciel di Celia nasconde un vero inferno, e che la forza della sua potenza vi abbia costretto a piangere e a pensare”. Chi era Antonio Veneziano a cui Cervantes indirizza quella lettera, piena di formale deferenza ma venata d’ironia, e le Ottave? el 1894 la palermitana Società di Storia Patria pubblica il fascicolo dedicato ad Antonio Veneziano per il 3º centenario della sua morte. Scrive il bibliotecario della Società Giuseppe Lodi: “Di Antonio Veneziano, l’elegantissimo latinista, il più rinomato poeta siciliano del secolo XVI, ricorreva nell’Agosto del 1893 il terzo centenario della morte, avvenuta per lo scoppio di una polveriera, mentr’egli era detenuto entro il forte di Castellamare. La ricorrenza di questo avvenimento non potea lasciarsi passare inosservata da una Società, come la nostra, la quale (…) non trascura, all’occorrenza di tener desti con solenni commemorazioni l’amore e la riverenza per quanti hanno onorato con il loro ingegno e le loro opere questa non infima parte d’Italia, questa nostra prediletta Sicilia”. C’era spesso nei membri di quelle Società o Accademie un po’ di ampollosità, un po’ di retorica. Retorica non vi è invece in uno scienziato, un demopsicologo o etnologo: Giuseppe Pitré. Scrive nel fascicolo: “io imposi a me stesso l’assoluto silenzio sulla sua vita. Me lo imposi, non per manco di ammirazione per l’illustre poeta, ma per la ferma convinzione ch’ebbi sempre, ed ora più che mai ho, delle inesattezze e, lo dico senza reticenze, dei grossi errori che sono stati scritti su di lui”. Grossi errori, come afferma il Pitré, nati dalla leggenda popolare in cui il Veneziano era stato avvolto, a cui venivano attribuite vicende, spesso fantastiche o surreali, e rime che erano spesso di malaccorti epigoni. Un altro scritto del fascicolo è del monrealese canonico Gaetano Millunzi. Che stende la prima documentata biografi a del Veneziano. Il poeta nasce nel 1543 da una ricca famiglia di origine veneziana, come denuncia il cognome, ma che è ben assestata, già dal Quattrocento, in quel di Monreale, all’ombra della gran cattedrale dei re normanni. Il padre, Antonio, mastro notaro della Curia e pretore, ebbe ben tre mogli, un figlio dalla prima moglie, uno dalla seconda, e ben sette dalla terza, di nome Allegranza Azolina. Antonello, detto Antonio dopo la morte del padre, era il terzo di quest’ultima nidiata. Ancora nella prima adolescenza fu mandato a Palermo per studiare nel collegio dei Gesuiti, quindi a Messina e infine a Roma. È un periodo, questo del Veneziano, di severi studi: di filosofia e teologia, di lingua e letteratura italiana, latina, greca, ebraica. Nel Collegio Romano ha come professore Francesco Toleto, il quale, oltre a insegnare la filosofi a tomista, inizia gli allievi agli studi di giurisprudenza. Studi che saranno utili al Veneziano quando, lasciata la Compagnia di Gesù, ritorna a Monreale e inizia tutta una serie di cause civili contro fratelli e parenti per la divisione della roba, dell’eredità paterna; e cause penali perché accusato non solo dell’omicidio di un tal Polizzi, ma anche del rapimento di Franceschella Porretta, serva della terziaria domenicana suor Eufrigenia Diana. Per questo rapimento la madre lo disereda perché “figlio disubbidiente”, come scrive nel testamento. “Violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti, incostante negli affetti famigliari e negli amori, assolutamente sprovvisto di rispetto per le istituzioni e per gli uomini che le rappresentano”. Scrive del Veneziano Leonardo Sciascia1. E pensa Sciascia, che questo carattere, questo maledettismo del poeta siano stati una reazione alle costrizioni dell’educazione gesuitica. E, malgrado il carattere e la mala condotta, scrive, scrive, il Veneziano, scrive poesie in siciliano, in latino, in spagnolo, prose e composizioni in versi per gli archi di trionfo in onore dei vari viceré che s’installano a Palermo. Ma scrive anche satire contro gli stessi viceré, contro il potere politico, satire anonime
affisse sui muri. Sospettato quale autore di una di queste satire, un cartello, “appizzato alla cantonera di don Pietro Pizzinga allo piano delli Bologni”, contro il viceré conte di Albadeliste, definito uomo “fatale”, vale a dire jettatore, fi nisce nel carcere di Castellamare. Nell’educazione presso i Gesuiti, nell’accusa di omicidio, nella cultura e nelle composizioni poetiche per gli archi di trionfo, nel 1 Sciascia, L. (1967): “Introduzione a Antonio Veneziano”, Ottave, Einaudi: Milano. continuo assillo per le difficoltà economiche, nei disordini della famiglia paterna, nella varie incarcerazioni infine, non possiamo non vedere una curiosa specularità tra la vita di Cervantes e quella di Antonio Veneziano. Specularità che poi diviene immedesimazione nella comune condizione di schiavi nei bagni di Algeri. Il 1574 è l’anno in cui il Veneziano fa donazione di tutti i suoi beni ad Eufemia de Calogero, figlia di sua sorella Vincenza, la quale Eufemia è obbligata per contratto e rimanere nubile e a non farsi monaca. Questa donazione ha fatto sorgere il sospetto che ad Eufemia, la nipote, fossero indirizzate canzoni d’amore della Celia, che fosse insomma, quella di Veneziano, una passione disdicevole, vergognosa. Canta:
“Donna d’auti biddizzi fatta ‘n Celu,
mandata pri ricchezza e gloria in terra,
cu l’occhi toi lu diu di l’aureu telu
fa quasi all’universu ingiuria e guerra;
si sa quanta npi tia m’ardu e querelu,
tempra, si poi, st’arduri chi m’atterra,
ch’in tanta estrema dogghia, affannu e jelu
non dura lungamente omo di terra”.
Il 25 aprile 1578, Veneziano s’imbarca a Palermo sulla galea Sant’Angelo, al seguito di don Carlo d’Aragona, imbarcato a sua volta sulla galea detta Capitana. Al largo di Capri, vengono assalite, le due navi, da galee corsare. La Capitana riesce a fuggire, la Sant’Angelo viene bloccata dai corsari. “Gagliardamente si combatte con mortalità d’entrambe le parti, ma arrivate dopo l’altre da fianchi, dandoli un terribile assalto di saette, e d’archibugiate, furono astretti li difensori a buttare l’armi, a rendersi vivi”. Scrive il monaco cassinese Giovanni Tornamira. Antonio Veneziano viene dunque preso, insieme ad altri, chierici e frati soprattutto, e portato schiavo in Algeri. “Cervantes si trovava schiavo in Algeri da tre anni. Può darsi avesse già conosciuto il Veneziano durante il suo soggiorno a Palermo, nel 1574; certo è che ad Algeri si trovarono (o si ritrovarono) e che tra loro nacque una qualche dimestichezza e un rapporto di reciproca estimazione letteraria, se non di amicizia”. Scrive ancora Sciascia. Ne La nenia così lamenta il Veneziano: “…
l’alma in Sicilia,
già temp’è cattiva,
in manu de la diva,
cinta di forti amurusa catina,
… e lu corpu in Algeri,
fattu di genti barbara suggettu
chì, di lu gran rispettu
di stà partenza e di gran pinseri
acerbamente offi su
era lu cori esanimatu estisu”.
“Ai primi di settembre (1575) Cervantes, soldato aventajado (scelto), s’imbarca a Napoli sulla galera El Sol. Comandata da don Gaspar Pedro de Villena, questa era una delle quattro navi costituenti la piccola fl otta agli ordini di don Sancho de Leiva, che si disponevano a fare rotta per Barcellona (…) Assieme a Miguel, salgono a bordo, oltre al fratello Rodrigo e a qualche loro amico, diverse personalità di rilievo. (…) In capo a qualche giorno la tempesta disperde le galere. Tre di esse riusciranno infi ne ad arrivare in porto; ma l’ultima, El Sol, sarà sorpresa dai corsari barbareschi, e i suoi passeggeri condotti come prigionieri ad Algeri”. Così racconta Jean Canavaggio2 in Cervantes. In questo assalto dei corsari avrà provato, il futuro autore del Don Chisciotte, le stesse ansie, le stesse paure dell’archibugiere Miguel de Cervantes imbarcato sulla Marquesa in quel 7 ottobre del 1571; ma avrà dimostrato lo stesso coraggio, coraggio che allora, nella battaglia di Lepanto, gli costò la perdita della mano sinistra. Sulla mano perduta, così risponderà al falso Avellaneda, l’autore della seconda parte apocrifa del Don Chisciotte, il quale l’accusa d’essere vecchio e monco e quindi incapace di scrivere la seconda parte del suo romanzo: “Ciò di cui non ho potuto fare a meno di dolermi è che mi si accusi d’esser vecchio e monco, come se fosse stato in mio po-
2 CANAVAGGIO, J. (1986): Cervantes, biographie, Mazarine: Paris.
tere fermare il tempo perché non passasse per me, o come se l’esser monco, mi fosse stato cagionato in qualche bettola e non nella più illustre battaglia che abbiano visto i secoli passati e i presenti…”. È il rinnegato albanese Arnaut Mami che porta schiavo in Algeri Cervantes e i suoi compagni. Miguel ha solo ventotto anni quando è portato in catene ai bagni. Ci dice, Cervantes, di questa sua cattività durata cinque anni, nel racconto del Prigioniero nella prima parte del Don Chisciotte, nelle commedie La vita ad Algeri e I bagni di Algeri. Ma una notizia della prigionia di Cervantes ce la dà l’inquisitore di Sicilia, e quindi arcivescovo di Palermo e presidente del Regno di Sicilia, Diego de Haedo, autore della Topographia e Historia general de Argel (Valladolid, 1612). L’Haedo, raccogliendo notizie dagli schiavi cristiani riscattati, ci racconta tutto su Algeri, sui corsari, sui cristiani là prigionieri. Nel Dialogo secundo, il prigioniero capitan Geronimo Ramirez racconta al dottor Sosa del fallito tentativo di fuga da Algeri di Cervantes per il tradimento di un rinnegato di Melilla soprannominato El Dorador, dice che i turchi presero tutti i cristiani che stavano per fuggire, “y particolarmente a Miguel Cervantes, un hidalgo principal de Halcalà Henares, que fuera el autor deste negozio y era portanto mas culpado…”. Avrebbe dovuto essere punito, il nostro don Miguel, ma, ci racconta ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Hassan Agà (il Saavedra) non lo bastonò mai, e neanche gli rivolse mai parole offensive; noi temevamo che sarebbe stato impalato ad ognuno dei suoi tentativi di fuga, cosa di cui lui stesso ebbe paura più di una volta”. E ci racconta ancora Diego de Haedo di Cervantes schiavo di Dali Mami, detto El Cojo, lo zoppo, quindi di Ramadan Pascià e infine del terribile Hassan Agà, un rinnegato veneziano che divenne re di Algeri. Nell’aprile del 1578, quando Antonio Veneziano finisce nel bagno di Algeri, Cervantes è appena uscito dal quarto fallimento di evasione dalla prigione per la delazione del prete rinnegato Juan Blasco. Si conoscono là i due, Cervantes e Veneziano, o si riconoscono dopo il loro primo incontro a Palermo? I due, in carcere, ascoltano la cantilena in sabir, la lingua franca del Mediterraneo, che i ragazzi mori cantavano sotto le finestre dei bagni.
“Non rescatar, non fugir
Don Juan no venir
acà morir…”.
Cantilena riportata da Cervantes in Vita ad Algeri e ne I bagni di Algeri. Tutti e due avranno avuto catene alle caviglie e saranno stati vestiti allo stesso modo, il modo come Cervantes descrive il Prigioniero che entra con Zoraide nella locanda, “… il quale mostrava dagli abiti d’essere un cristiano giunto recentemente da terra di mori, perché era vestito d’una casacca di panno turchino, a falde corte, con mezze maniche e senza collo; anche i calzoni erano di tela turchina, e il berretto dello stesso colore”. Antonio Veneziano giunge in Algeri infiammato d’amore, pazzo d’amore: per la nipote Eufemia o per una bella e irraggiungibile signora? Signora che sarebbe stata, secondo gli studiosi Caterina e Giuseppe Sulli (Antonio Veneziano, Palermo, 1982), Felice Orsini Colonna, moglie di Marc’Antonio Colonna, il comandante della fl otta veneziana nella battaglia di Lepanto, allora viceré di Sicilia, al cui figlio, Ascanio, Cervantes, dedica La Galatea. Ad avanzare l’ipotesi della passione del Veneziano verso la viceregina c’è una ottava del poeta che così termina:
“Pirchi’ mi tratti comu li ‘nnimici?
Rimedia cu lu meghiu modu c’hai,
Filici, fi licissima, Filici”.
Là, nel bagno di Algeri, il Veneziano avrebbe scritto La Celia. E là, nel bagno, sembra che Cervantes abbia scritto Vita ad Algeri e incominciato la stesura de La Galatea. Inimmaginabili sono gli incroci della storia, nonché della poesia. Nel 1650, un gruppo di nobili siciliani congiurava contro il viceré don Giovanni d’Austria, vagheggiando di porre sul trono di un regno indipendente di Sicilia don Giuseppe Branciforti, conte di Mazarino e principe di Butera. La congiura falliva per la delazione del prete Simone Rao e per la confessione dello stesso Branciforti. Sei dei congiurati furono giustiziati. Il Branciforti lasciava quindi Palermo e si ritirava a Bagheria, tra la fenicia Sòlunto e la greca Imera, si faceva là costruire una villa e si chiudeva in quella sua dimora che era fortezza, castello, tomba non di libri e di salme come l’Escorial, ma di orgoglio umiliato e di rimorso. Sull’arco d’ingresso della villa faceva incidere un emistichio del Tasso, O corte a Dio, e oltre, sopra un altro arco, questi versi in spagnolo:
“Ya la esperanza es perdida
Y un solo bien me consuela
Que el tiempo que pasa y buela
Lleverà presto la vida”.
E sono i versi questi che recita Teolinda nel Libro primo de La Galatea di Cervantes. Ma ritorniamo al bagno di Algeri, ai due poeti là rinchiusi, Cervantes e Veneziano. Il monrealese, preso com’è dal “vendaval erótico”, come lo defi nisce Américo Castro, dalla bufera d’amore per la nipote Eufemia o per Felice Orsini, scrive là La Celia, e Cervantes (anche lui forse in quel momento nella bufera d’amore, se nel personaggio di Lauso de La Galatea dobbiamo riconoscere lo stesso autore), e Cervantes scrive là le Ottave per Antonio Veneziano. Veneziano viene riscattato nel 1579, e il cronista Ortolani così scrive:
“Fu fatta festa in Palermu pillu ricattu e ritornu di lu celebri
poeta Veneziano”.
Morirà poi, il povero poeta, il 19 agosto 1593, come sappiamo, per l’incendio (doloso, sembra) e lo scoppio della polveriera nel carcere di Castellamare. E morirà, in quello scoppio, anche Egisto Giuffredi, l’autore di Avvertimenti cristiani. Cervantes, riscattato, lasciava Algeri il 24 ottobre 1580. Dice ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Non c’è sulla terra, secondo il mio parere, gioia che eguagli quella di conseguire la libertà perduta”. E sarà, quella di Cervantes, una vita libera, ma, come quella di prima della prigionia in Algeri, una vita molto tribolata. Nulla però gli impedirà di concepire (nel carcere di Siviglia o in quello di Castro del Rio -1592) e di scrivere quindi le avventure dell’ingegnoso hidalgo, di don Alonso Quijana, ribattezzatosi Don Chisciotte della Mancia, e del suo fi do scudiero Sancio Panza. Don Chisciotte, il primo grande romanzo della storia letteraria, uno dei grandi capolavori dell’umanità. Nel 2005 ricorreva il quarto centenario della prima pubblicazione del romanzo. E, nell’aprile di quell’anno, ad Alcalà de Henares, nella casa natale-museo di Cervantes, si inaugurava la mostra delle prime edizioni del Quijote, in cui compariva l’edizione del 1610, stampata a Milano “por el Heredero de Pedromartir Locarni y Juan Bautista Bidello”, e dedicata dal Cervantes, questa edizione, non più al conte di Bejar, ma “All’Ill.mo Señor el Sig. Conde Vitaliano Vizconde”. Abbiamo voluto sin qui raccontare della prigionia in Algeri di due poeti, Cervantes e Veneziano. Ma abbiamo anche voluto signifi care, soprattutto attraverso Cervantes, la terribile vita che si svolgeva allora, nel ‘500, tra le sponde del Mediterraneo, in questo spazio dove si svolge il grande poema omerico e dove sono nate le prime grandi civiltà della storia umana. Terribile vita allora, nel ‘500, tra le sponde del Mediterraneo. E terribile di nuovo oggi, dopo cinque secoli, per le tragedie quasi quotidiane che tra queste sponde si consumano. Tragedie di poveri infelici che fuggono da luoghi di guerra, di malattia e di fame e che cercano salvezza in questo nostro mondo di opulenza e di alienazione. Infelici che spesso trovano la morte per acqua, come l’eliotiano Phlebas il Fenicio, naufragano presso le sponde di Sicilia e di Spagna. E con dolore dunque possiamo ripetere le parole di Fernand Braudel, riferite all’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari
03/11/2005 – La prigione dei destini incrociati: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano nei bagni di Algeri
Instituto Cervantes Napoli
14/04/2008 Universitat de Valencia. Spagna.La pasión por la lengua: VINCENZO CONSOLO
Antonio Veneziano e Miguel de Cervantes


