— Penso che vincere un premio come lo Strega possa essere, per uno scrittore serio, un’assicurazione contro i faccendoni, e il dilagare della carta. — La carta seppellisce i libri. Una volta gli scrittori lavoravano con la speranza nel futuro1 . Senza troppa esagerazione si può affermare che il tono essenziale della prosa consoliana rimane soprattutto riflessivo e didascalico. E se con questo ci si vuole riferire ad una remota disposizione che si ripresenti nelle opere degli scrittori siciliani, e cioè, una ricorrenza di quella peculiarità, nominata da Leonardo Sciascia una “specie di follia”. In questa zona discorsiva, acquista un rilievo massimo la figura di Luigi Pirandello atteggiata nell’argomentativo e sofistico ritmo di un ragionatore e di un maestro tutto volto a spiegare e insegnare. Ma questa razionalizzante sicilitudine non è da credere che s’aggiri in una forma di cattedratica istruzione o di astratta lezione2 . Al contrario, la meditazione svolta dell’autore, pur nei confini dello schema prestabilito si avvia di acute analisi e di fini notazioni psicologiche
1 F. Parazzoli: Il gioco del mondo. Dialoghi sulla vita, i sogni, le memorie […]. Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1998, p. 23. 2 Cfr. M. Tropea: Nomi, „ethos”, follia negli scrittori siciliani tra Ottocento e Novecento. Caltanissetta, Edizioni Lussografica, 2000, p. 5.
essenza della sicilitudine che superano i consueti limiti del comune repertorio morale. Pirandello, nel modo più autonomo, è riuscito a collegare i motivi siciliani come: mania, follia e superstizioni e grandi temi dello smarrimento dell’animo dell’uomo. Si potrebbe dire, a titolo non solo di paradosso, che lo scrittore avverta la presenza della conoscenza della vita nella totalità dei suoi aspetti come il frutto di un’esperienza non gradita e tendenzialmente rifiutata. Invece la liberazione dei sentimenti e dell’invenzione dal peso del reale presuppone un’intensa partecipazione ad esso, non un rifiuto, non un esilio, ma un’accettazione contrastata e difficile. Ad una maggiore immediatezza d’espressione si torna con l’esperienza di Vitalino Brancati che distingue la cultura della Sicilia in due grandi suddivisioni: “[…] quella occidentale degli arabi, dei cavilli, delle sottigliezze, della malinconia, di Pirandello e di Giovanni Gentile e dei mosaici; e quella orientale dei Fenici, dei Greci, della poesia, della musica, del commercio, dell’inganno, di Stesicoro, Verga, Bellini, San Giuliano”3 . Con le opere di Brancati si rimane sempre nella stessa dimensione della poesia invasa dalla follia che forma la peculiarità dell’anima e della cultura siciliana. Secondo Mario Tropea l’esistenza di una “letteratura siciliana” costituisce una figurazione di una insularità affermata non solamente dal punto di vista storico e antropologico. Nella sua sostanza si conferma una tonalità narrativa della psicologia umana4 . Allo sguardo satirico di Brancati, l’universo siciliano non appare come lo spazio di cui celebrare il fasto, né tanto meno la sede in cui si elaborano progetti politici; esso diviene piuttosto il bersaglio privilegiato di un processo di smascheramento, teso a mettere a nudo l’incapacità dei rappresentanti del potere, l’interesse dei cittadini e il loro stato di umiliante soggezione. In questo senso appare emblematico il punto di vista di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pieno d’ironia, pensata come sintesi di distacco aristocratico. Forse ha capito che allo scrittore non si chiede più l’eroismo di una classe feudale, ma la naturale mutevolezza di caratteri osservati nella
3 Ibidem, p. 6. 4 Cfr. ibidem.
realtà quotidiana. L’ottica dall’interno con cui il mondo della Sicilia è narrato compare nella presenza di nozioni dell’ironia e della storia. L’isola ha una sua storia che la genera e rigenera. Nella scelta di una narrazione mimetica l’insularità diventa una proprietà imprescindibile. Consolo non inventerebbe l’isola se non vi fosse venuto al mondo, se nella vita, nella scrittura non fosse venuto incontro ad esso e se non l’avesse raccontato tramite le vicissitudini dei compaesani. Pubblicando i suoi scritti, Consolo ha salvato dall’oblio inerente all’oralità le storie dolorose e fragili. Sembra che, simbolicamente, lo scrittore abbia saldato un debito nei confronti degli interlocutori del paese natio. Non si tratta, in questa analisi, di propugnare uno scavalcamento delle gerarchie né di rinnegare gli interessi degli scrittori; invano si cercherebbe in queste opere un progetto di riforma della società in base a nuovi valori. Mondo insulare e mondo della penisola sembrano impermeabili. Eclettico Capuana non tanto lontano dalla realtà del naturalismo di Verga rappresenta la follia proprio tramite uno studio “clinico”. Nella poetica che sembra quella di un generico realismo, Consolo varca la soglia della finzione e recupera le forme testuali della verità quasi documentaria: struttura e tono del reportage, appendici forniti dalla storia, narrazione in terza persona. Un’idea di narrazione polimorfica potrebbe risultare una necessità di inquadrarsi all’interno di una prospettiva di moderno umanesimo delle contraddizioni. Ferruccio Parazzoli ha ammesso di sentirsi come Ismaele — il protagonista di Moby Dick. Invece, però di andarsene per mare, lo studioso si accontenta di svolgere la ricerca tra gli amici5 . In Mondadori, la sua casa editrice, Consolo viene considerato uno dei più ascoltati scrittori italiani. “Quando dice fa opinione” — ricorda Parazzoli6 . Se lo scrittore si riferisce alla quotidianità politica, lo fa direttamente come nella constatazione rapportata alla situazione del settembre del 1994: “Io credo che chi ci governa sia affetto da una grave malattia mentale. […] Tutti i suoi gesti, tutte le sue azioni, tutti
5 Cfr. F. Parazzoli: Il gioco del mondo…, p. 54. 6 Ibidem.
gli ordini, tutto quanto lui dispone è all’insegna dell’irrazionalità e della follia”7 .
Prendendo le mosse dal mito sul Cavallo inventato da Ulisse, Consolo cerca di individuare un’ipotesi fondamentale dell’illusione vissuta dall’Italia dopo la seconda guerra mondiale; l’illusione dell’Itaca e cioè dell’armonia, della storia e degli affetti. Dopo le tragedie subite c’era bisogno di razionalità e di ordine che potevano essere visti come tappe di un possibile recupero della ragione. Va poi sottolineato, sul piano delle corrispondenze fra la ragione e la follia che questa oscillazione è diventata una costante della storia dell’Italia. Consolo dichiara decisamente il desiderio di testimoniare il senso storico del suo tempo. In questo caso la testimonianza riguardante la situazione del paese è un espediente narrativo esemplare della tecnica della trasformazione che si gioca su capovolgimenti. La generazione di Consolo ha conosciuto un mondo che era la civiltà contadina è che poi ha cominciato a sostituire la vita con le cose, con la merce. In conseguenza è accaduto lo spostamento della centralità dell’essere e la sua sostituzione con l’avere. La rapidità di questo processo ha lesionato anche le altre sfere dell’attività umana. Secondo Consolo il movimento delle masse contadine ha portato alla distruzione della cultura popolare. Anche un discorso svolto dallo scrittore sui colpevoli di questo stato di cose indica chiaramente i politici un primo luogo e poi gli intellettuali. Questa idea di responsabilità sopravvive nella coscienza letteraria consoliana, specialmente quanto il narratore sottolinea la propria provenienza siciliana. In questo paesaggio dell’Italia corrotta e arrettrata, Milano è cominciata ad essere considerata come la città dell’utopia, senza sopraffazione e violenza. Non è quindi per un caso nemmeno da questo punto di vista, in fondo, che Vincenzo Consolo come Verga e Vittorini, approdì a Milano. Con il passare di tempo nasce la delusione. La cosa da notare subito è la convinzione di Consolo della responsabilità maggiore della Milano moderna, siccome più dotata nel campo di lavoro e di cultura, della digradazione e dell’avvilimento.
7 Ibidem, p. 25.
Si capisce ancora meglio, così, perché sia proprio quest’inclinazione a renderci più coscienziosi e più sensibili ai problemi della realtà circostante. Esaminando il percorso dello sviluppo del romanzo politico, Consolo pronuncia apertamente la sfortuna di Sciascia e di Pasolini. Il primo è stato dimenticato, il secondo invece, è stato imbalsamato in una nicchia di santità laica. Nelle sue narrazioni ci si rivolge come un’ultima volta a uno spazio e a un tempo che stanno per svanire definitivamente. Attingendo ai maestri come Verga, Pirandello, Vittorini, Consolo vuole mettere in evidenza una realtà che si può raccontare. Non consumata dall’informazione, dalla televisione o dai giornali ma capace di far sopportare e di capire la realtà. Una delle caratteristiche di questo modo robusto di narrare è quel ricorso frequente alla parola “armonia” che è diventata una parola chiave nel suo vocabolario di scrittore. Si scopre così che, correntemente alla sua essenza patetica, questa parola, come specchio e rappresentazione dello sguardo che lo affronta, può diventare un espediente che renderà più facile il conciliarsi con la vita e con la realtà. È altrettanto importante mettere in evidenza un’altra costante della produzione letteraria consoliana e cioè, la volontà di decifrare un passato remoto. L’atteggiamento di protesta contro la dissacrazione del nostro tempo. Gli elementi della materia che diventano veri e propri protagonisti della memoria di Consolo sono tra l’altro: le pietre, le piante e il mare. La loro capacità di ipostatizzare lo sguardo che li contempla e di oggettivarlo in una forma visibile, non si trasforma mai in pura contemplazione ma cambia nell’esperienza interiore. La memoria del mondo ormai dimenticato e trascurato diventa anche il modo per salvarlo. Con questo espediente lo scrittore vuole opporsi al senso della precarietà del mondo moderno. Nella prefazione al saggio di Basilio Reale lo scrittore constata: Ho sempre pensato la letteratura siciliana (e non solo la letteratura, ma la pittura, la scultura, la musica: l’arte insomma) svolgersi su due crinali, su due filoni o temi distinti: quello della storia e quello dell’esistenza (o della natura, o del mito)8 .
8 V. Consolo: Prefazione. In: B. Reale: Sirene siciliane. L’anima esiliata in “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Bergamo, Moretti & Vitali Editori, 2001, p. 15.
La memoria di quel mondo viene conservata anche nella dimensione di fuga dal paese. La fuga che è possibile forse solo in letteratura. La letteratura come possibilità di staccarsi dalla Sicilia, pur restando in Sicilia: l’esilio dall’interno. Molto legato ai valori come l’orgoglio, l’umiltà e il pudore, Consolo constata che la mancanza di pudore che ormai fa parte di ogni settore dell’attività umana, lo disorienta e offende. La paragona a una forma di violenza, come nei teatri anatomici quando si squadernavano i corpi. Parlando dell’importanza della memoria, lo scrittore rievoca la testimonianza di Pirandello, vissuta a circa due anni e legata ad un’eclisse solare che diventa un autentico archetipo della scrittura pirandelliana e un’ipostasi che è presente anche nella narrativa di Consolo9 . La prova di ricostruire questa memoria storica riguarda un mondo in cui la memoria sta per annullarsi. Ne rimangono solo delle apparenze e degli stereotipi. Per salvare questa realtà acquisisce soprattutto una forza dell’espressione linguistica, il richiamo alla lingua: unico segno realmente distintivo e significativo di appropriazione del mondo nelle possibilità di narrarlo, il che vuol dire per Consolo di ricrearlo narrativamente. Non a caso Giulio Ferroni riconosce allo scrittore il merito di essersi mosso alla ricerca di un linguaggio capace di unire in sé “la curiosità storica e razionale di Sciascia e il violento plurilinguismo di Gadda”10. Per Consolo la forza stilistica e inventiva diventa simbolo dell’aspirazione barocca a inglobare i diversi aspetti del reale in un complesso eterogeneo, ma organizzato. Le stesse ansie e inquietudini che, come si è visto, stanno a fondamento della ricerca dello scrittore siciliano, permeano altrettanto la prosa di diversi autori legati alla loro terra, alla loro regione, al loro quartiere. Il rapporto con il nichilismo del Novecento, la crisi di valori, la redifinizione dell’identità, i temi fondamentali non solo dell’opera di Consolo non solo hanno volto l’attenzione di molti su
9 Consolo, questa prosa, la nomina “la memoria di un’eclisse”, cfr. F. Parazzoli: Il gioco del mondo…, p. 29. 10 G. Ferroni: Storia della letteratura italiana. Milano, Einaudi, 1991, p. 129.
questi problemi ma sono anche stati oggetto di analisi di vari critici11. Joanna Ugniewska, nella parte conclusiva del saggio di Matteo Collura ci ricorda che l’autore, attingendo al modello vittoriniano del viaggio orientato verso i luoghi dell’isola d’infanzia e di origine, definisce la propria narrazione come il percorso verso luoghi dove la memoria è stata imprigionata12. Nel corso del Novecento la critica aveva riesaminato con accenti più serrati il ruolo degli autori siciliani. Alcuni di loro come Elio Vittorini e Leonardo Sciascia e un po’ più tardi Giuseppe Tomasi di Lampedusa sono stati premiati con il Nobel per la letteratura, gli altri hanno goduto un notevole successo editoriale. Nel quadro di questo pensiero siciliano non sarà luogo d’azione a sancirne il suo carattere originale. È vero che le narrazioni consoliane sono ambientate nella Sicilia, ma accade che le opere degli autori rievocati presentino i contesti geografici più neutri e generici. Da questo punto di vista, dunque, la provenienza potrebbe risultare un mero dato anagrafico. Ma in effetti la personalità consoliana era lungi dal limitarsi a tale rapporto tra la terra di nascita e le scelte future, tra l’aspirazione e i contrasti della vita, rapporto in certo modo risolto nella posizione dello scrittore di estrema apertura verso il reale, quale era propria di una scrittura che avverte in sé il continuo bisogno di nuovi orizzonti e di nuove situazioni. Se si volesse configurare la letteratura d’arte come perenne conflitto di “rappresentazione” e di “intellettualità”, si dovrebbe tornare mentalmente allo Stilnovismo, ma la presenza del momento intellettualistico è percepibile anche nell’arte moderna. Nel suo saggio dedicato agli scrittori siciliani del Novecento, Massimo Naro constata che l’atteggiamento intellettuale degli scrittori isolani si innesta sulla loro provenienza, non solo nel senso anagrafico o geografico, ma molto più profondamente, con le implicazioni etiche come antichi modi
11 Cfr. G. Pellegrino: Lotta, memoria e responsabilità: Eraldo Affinati. In: Scrittori in corso. Osservazioni sul racconto contemporaneo. A cura di L.A. Giuliani, G. Lo Castro. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, p. 155. 12 Cfr. M. Collura: Na Sycylii. Przeł. J. Ugniewska. Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich, 2013, p. 158.
di percepire il mondo a partire dalla terra di nascita13. L’esperienza siciliana diventa una specie di prospettiva nella quale gli autori contrappongono l’isola ad ogni terraferma. Più netti sono i contorni dell’isola, più il mondo fa da sfondo, diventa il miraggio. Così, quando lo sguardo degli scrittori entra “dentro” l’isola, la descrizione della concretezza fisica dello spazio non perde mai di vista gli elementi “strutturali” della Sicilia stessa. Una concretezza descrittiva che non trascura la peculiarità funzionale di questa scrittura, di esprimerne la gratitudine e la nostalgia. Questa caratteristica dell’ottica siciliana viene confermata fortemente nell’analisi del titolo dell’opera di Antonio Di Grado Finis Siciliae14 svolta da Anna Tylusińska-Kowalska nella parte introduttiva al volume dedicato alla produzione artistica di Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Luisa Adorno e Matteo Collura15. Nel commentare il titolo del libro citato del Di Grado e il contenuto del proprio volume, la studiosa sottolinea la funzione del diversificato paesaggio siciliano da cui scaturisce il mito della tradizione, del legame con la terra di nascita e della storia non sempre felice. Pirandello ha già definito le caratteristiche di questa specie di ottica, usando il termine “raziocinare” per questo modo di esaminare: volutamente più lento, più pacato, meno calcolante e più poetico, ma sempre capace di focalizzare l’attenzione sulle questioni problematiche e urgenti del tempo. Le cose hanno un volto diverso nel senso che qui sono appunto gli scrittori a porsi delle domande che nelle altre parti del mondo si pongono dei filosofi: sull’esistenza, sulla verità, sulla giustizia e sul potere. Gli echi dello stesso dibattito sorgono nei pensieri di Gesualdo Bufalino che si chiedeva se ciò che l’uomo sperimenta sia conclusivo o provvisorio, reale o illusorio? Nelle sue
13 Cfr. Sub specie typographica. Domande radicali negli scrittori siciliani del Novecento. A cura di M. Naro. Caltanissetta—Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2003, p. 6. 14 A. Di Grado: Finis Siciliae. Scrittura nell’isola tra resistenza e resa. Acireale— Roma, Bonanno, 2005. 15 Cfr. Literacki pejzaż Sycylii. Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Luisa Adorno, Matteo Collura. Red. A. Tylusińska-Kowalska. Warszawa, Wydawnictwo DiG, 2011, p. 9.
opere l’isola diventa metafora della teatralizzazione della vita16. Vale ancora aggiungere che nella sua ricerca appare chiara la volontà di valutare questa “qualità interrogante” della letteratura siciliana. Questo capitolo, di carattere esclusivamente introduttivo, si limita a considerare alcuni nomi e testi esemplari di questa lunga e complessa storia letteraria. La problematicità della letteratura siciliana si comprende nell’antirazionalità della poesia di Bartolo Cattafi, nell’opposizione tra certezza e dubbio nei libri di Giuseppe Antonio Borgese, nella contrapposizione tra fede e follia nei testi di Lucio Piccolo e Carmelo Samonà nella rappresentazione della dignità umana nelle opere di Elio Vittorini, nella ricerca del senso della vita in Francesco Lanza o in Nino Savarese, nella felicità perduta in Ercole Patti, nel nichilismo esistenziale in Sebastiano Addamo, nel dramma dell’emigrazione nella poesia di Stefano Vilardo, nell’impegno intellettuale di Vincenzo Consolo, nella protesta contro le violenze quotidiane di Dacia Maraini, nell’angoscia esistenziale nella narrativa di Gianni Riotta, Giosuè Calaciura e Roberto Alajmo. Consolo si realizza nella sua coscienza dell’intellettuale, egli misura costantemente la propria sorte d’uomo di cultura. Allude in questo modo alla tradizione l’iniziatore della quale viene considerato Dante — il primo intellettuale in senso moderno. Il sapere ritrovato è tutto orientato in senso “morale” e la reintegrazione della cultura nel destino dell’uomo segno un punto fermo nella storia della civiltà letteraria17. La caratteristica che unisce ambedue i personaggi è la coscienza “militante”. Alla letteratura siciliana è stato quindi assegnato il privilegio di colmare un ritardo, a sua volta necessario per riflettere sul valore e sulla ragione dell’esistenza umana. Giulio Ferroni denuncia la tendenza ad apparizione degli scrittori impegnati su altri terreni. Lo scrittore si pone cioè di fronte a un mondo passato e la sua continuità nel mondo postmoderno con gli strumenti mentali e catalogatori con cui aveva sempre osservato la
16 Cfr. J. Ugniewska: O zaletach peryferyjności, czyli jak można być Sycylijczykiem. W: Literacki pejzaż Sycylii…, p. 37. 17 Cfr. S. Battaglia: Mitografia del personaggio. Milano, Rizzoli Editore, 1968, p. 516.
resistenza della Sicilia continuamente decrescente18. Di qui il richiamo ad un rapporto difficile ma molto efficace tra memoria storica e ricerca linguistica, alle quali Consolo riconosce di essere “a livello d’indagine”. Un “livello” situato evidentemente nell’aver stabilito un nuovo rapporto con la realtà in cui appaiono mutati i fattori stessi del passato. Alla narrativa ha assegnato il dovere di confrontare la violenza del passato e quella del presente e provare la presenza della stessa continuità di un modo di soffrire e di cercare la via di salvezza. L’interesse per questi scrittori, che, con precisa terminologia, sono stati definiti siciliani, non è un fatto recente, ma ancora in fase di sistemazione critica. Nell’ottica della ricezione che esprime l’orizzonte dell’opera letteraria, si scorge negli scrittori siciliani la coscienza di un dramma e di un dissidio psicologico e quindi la profonda serietà morale dell’ispirazione. L’indagine più recente, mentre respinge l’interpretazione che fa degli autori siciliani le figure periferiche, accetta alcune conclusioni critiche precedenti, ma le integra con una nuova serie di proposte e di riconoscimenti. Vincenzo Consolo vive nella tradizione segnata dagli studiosi quasi esclusivamente per il fatto che fu l’amico, l’ammiratore e l’ereditario letterario di Leonardo Sciascia. Ma accanto a questa immagine esiste un’altra figurazione civica di Consolo, quella del letterato enciclopedico, che fa sentire nelle sue opere, con l’ardore della scoperta e l’ansia di comunicarla, tutto l’amore della scienza, della storia e della cultura. E non è da dimenticare il contegno civile di Vincenzo Consolo. Anche se opera nell’ambiente milanese, in uno stadio di involuzione più profonda, non è lontano dall’atteggiamento di partecipazione. Anzi, risulta propenso a stabilire fra la letteratura e la vita quotidiana un legame, in cui si celebri la nuova teorizzata libertà e dignità del letterato. La letteratura che prende avvio dalla Sicilia è caratterizzata dalla straordinaria pluralità e varietà delle voci in cui si esprime 18
Cfr. G. Ferroni, A. Cortellessa, I. Pantani, S. Tatti: Storia della letteratura italiana. La letteratura nell’epoca del postmoderno. Verso una civiltà planetaria 1968—2005. Vol. 17. Milano, Mondadori, 2005, p. 87.
31 il sentimento di una cultura letteraria assai più complessa e insieme obbediente a molte sollecitazioni. Una letteratura di transizione, segnata da parecchie fortissime personalità di orgogliosi cantori della propria terra e capostipiti della civiltà antica, e da una propensione ai tentativi e agli esperimenti, in cui si rispecchia la vita difficile, contradditoria, irta di delusioni e di utopie, di un mondo che si dibatte nella travagliosa ricerca di un nuovo ordine politico, morale ed intellettuale. Esperienza intima e reale è quella che Consolo invera nelle sue opere e che egli fa conoscere distinguendo, su un fondamento assiologico due cose: il valore metaforico di vicende individuali nelle quali ciascuno può ritrovare le proprie passioni e il valore universale dei fatti della storia siciliana con le loro proiezioni ed interpretazioni. Bisogna quindi accostarsi alle opere consoliane come a una cronaca, i cui personaggi rappresentano una specie di dramatis personae, capaci di facilitare il passaggio dalla confessione e dall’indagine psicologica e antropologica ai processi della conoscenza di una più profonda e più complessa realtà, quella che non vive costretta nei limiti di questo, cioè, isolano, spazio. Il significato che assumono gli eventi riportati da Consolo nelle narrazioni, per esempio la strage che conclude il suo ultimo romanzo, risulta assai vasto. Lo spasimo di Palermo sembra una sconfitta della ragione di fronte alla violenza, invece secondo il messaggio metaforico può assumere il valore della presa di coscienza della società civile rinata. Nei romanzi consoliani vi è presente un’immensa esperienza di vita, ed è presente come può esserla a chi non solo la contempla ma anche a chi si mescola fra la vita. I flashback che illuminano l’infanzia difficile dei protagonisti consoliani, la fuga dall’isola e il deludente soggiorno a Milano sono raccontati come il dramma umano che appartiene all’universale travaglio. Questa prosa ci offre, alle soglie della civiltà postmoderna, un’ampia documentazione di fatti e di figure, un quadro mobile e profondo delle società e delle storie diverse. Non sorprende affatto, quindi, che in polemica con l’esistenza e la funzione del confine gli scrittori siciliani non abbandonassero il carattere della loro terra, indicando come correlato della sua consi – 32 Capitolo I: Vincenzo Consolo — essenza della sicilitudine stenza non la limitatezza causata dal mare, ma la fermezza della vicinanza del continente. Nell’immaginario degli autori siciliani l’isola risulta dunque un paesaggio percepito prima staticamente (da lontano) e poi dinamicamente (dall’interno), in una dialettica giustapposta tra “dentro” e “fuori”, tra spazio guardato e spazio vissuto che corrisponde alla duplice essenza dell’isola stessa, che è per definizione un luogo d’accesso posto al confine con mare, uno spazio in cui si abita in uno spazio in cui si viaggia. Per i siciliani le relazioni di spostamento seguono questa fenomenologia lineare di inoltramento (varcare il confine, passare il mare), che si accorda a un’inclinazione all’esplorazione delle direzioni ben determinate come: l’America, l’Italia e l’Europa occidentale. Nell’intreccio di queste istanze antitetiche ancora più nitido sembra il capovolgimento della situazione siciliana, che affonda in complesse dinamiche sociali e antropologiche. La Sicilia, dall’essere terra di emigrazione, è diventata la terra di immigrazione. La sintesi più valida del ribaltamento avvenuto, la dobbiamo a Leonardo Sciascia che nel suo racconto intitolato Il lungo viaggio presenta la partenza dei clandestini da una spiaggia tra Gela e Licata in cui adesso approdano gli immigrati dal Nordafrica. Un’attenzione più dettagliata al rapporto fra la letteratura e la storia viene espressa molte volte nei libri degli scrittori siciliani contemporanei. All’efficacia della storia reinterpretata dalla scrittura non si può non accostare quella della produzione letteraria sempre più florida che spesso coincide con la prima. L’attenzione per la scrittura siciliana è un fenomeno rilevante e procede di pari passo con le vere esplorazioni delle presenze letterarie che si compiono sempre più sistematicamente. Accanto agli autori e ai temi di massima rappresentatività, vi si trovano quelli più recenti che completano l’artistico panorama siciliano. Tra gli argomenti narrati quelli più frequenti riguardano l’espatrio (in America, in Africa, in Germania) e l’attuale condizione della penisola siciliana. Non di rado gli scrittori siciliani tendono a rappresentarsi in questo luogo in cui si concretizza la loro invenzione. Del ritorno in Sicilia scrivono dunque: D’Arrigo, Brancati, Vittorini, Consolo. Secondo Ignazio Romeo: “Tornare significa infatti anche, metaforicamente, Vincenzo Consolo — essenza della sicilitudine 33 scavare in se stessi e nella propria storia, cercare l’estraneo in quello che si è familiare: guardare, insomma, in profondità e a distanza”19. Ma è vero anche che da questo spazio limitato fisicamente si aprono i grandi percorsi della cultura e della fantasia. Sono due elementi fondamentali che reggono l’asse assiologico della letteratura siciliana, il primo riguardante il dibattito relativo all’attuale e storica esistenza umana e il secondo relativo alla letteratura stessa e il suo ruolo nella nostra modernità. Non si tratta di due realtà distintive che finiscono con lo scontrarsi ma di due componenti che complementandosi occupano un posto considerevole nel panorama letterario non solo siciliano o italiano. La forza dell’autoriflessione letteraria degli scrittori siciliani finisce nella maggior parte dei casi come il metadiscorso. Le domande sul senso dell’arte, poste da Verga e Pirandello — i primi esploratori di tale problematica, hanno un carattere ben definito. Una specie di slittamento metonimico da una fase di lotta per la ricchezza ad uno stadio di lotta per la parola, il contrasto essere/apparire, la permanenza del binomio vita/teatro diventano motivi costanti di chi vuole autointerrogarsi. Non meraviglia dunque il fatto che tutto ciò che Pirandello nomina nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore ”il tumulto della civiltà” trae l’ispirazione dalla figura leopardiana del poeta “inattuale” che ha provocato la discussione sulla relazione tra la scrittura e la lettura, l’autore e il pubblico20. Si radica ai nostri occhi l’opinione che la Sicilia sia soltanto il simbolo, l’espediente che consente di stabilire un contatto tra l’uomo e la sua identità. Vincenzo Consolo si dedica alla stesura delle sue opere ricorrendo alla pluralità linguistica che caratterizza la sua espressione letteraria. Accanto all’uso del lessico dell’italiano comune, il prosatore si serve del dialetto siciliano con delle varietà di re19 I. Romeo: Passare il mare. Dall’emigrazione all’immigrazione: cento anni di memorie e racconti nelle pagine degli scrittori siciliani. Palermo, Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente, 2007, p. 12. 20 Cfr. L. Fava Guzzetta: Dalle domande della scrittura alle domande sulla scrittura. La coscienza letteraria dei siciliani. Caltanissetta, Sciascia, 2003, p. 11. 34 Capitolo I: Vincenzo Consolo — essenza della sicilitudine gistri e di toni dal domestico familiare al lirico-volgare21. Giuseppe Bellia, analizzando il modo di scrivere consoliano, parla dell’autonomo sviluppo del filone gaddiano rafforzato dalla ricerca costante di linguaggi antichi, di tradizioni locali e di ritualità arcaiche. E nell’affermato gusto barocco dello scrittore riconosce il meccanismo di un reperimento o di un ritrovamento della parola e non della sua invenzione22. Rifiuta le parole e i pensieri comuni, cerca con accuratezza quelle che rinchiudono il più d’accessori, esimio soprattutto nella scelta degli epiteti e dei verbi. Mira ad esprimere molto in poco. Ha l’idolatria della parola, non solo come espressione dell’idea, ma staccata, presa in sé come suono, attento a separare le parole nobili dalle plebee, le poetiche dalle prosaiche, ed raccontare tutto con sincerità. Anche nell’uso delle parole poetiche Consolo segue l’ultimo Verga che invade lo strato sintattico introducendo le formule dubitative. Con questo procedimento lo scrittore ha dichiarato l’allontanamento dal centro ed ha espresso la mancanza di una univocità dei significati23. La prosa consoliana manifesta un’inquietudine uguale causata dall’assenza dell’interlocutore immediato inscrivendosi nell’attuale discorso sulla comunicazione letteraria. Lia Fava Guzzetta nomina Consolo “un intellettuale meridionale, consapevole di una ‘ferita’, di una esclusione e di uno sradicamento”24 che si applica allo studio profondo del passato troppo facilmente rifiutato dalla società odierna. La difficoltà sta nell’impossibilità dell’abbinare la parola di oggi alla rappresentazione della Sicilia di una volta. La narrazione che avviene per frammenti viene paragonata a volte alla dimensione del reportage giornalistico. Anche Giuseppe Traina nel suo saggio dedicato allo scrittore siciliano mette in rilievo l’importanza di questo genere destinato da Consolo alla testimonianza degli avvenimenti accaduti negli ultimi anni come, per esempio, i funerali dello studente Walter Rossi, militante della sinistra extraparlamentare ucciso
21 Cfr. G. Passarello: Un’isola non abbastanza isola. Palermo, Palumbo, 2007, p. 136. 22 Cfr. G. Bellia: L’obliquo percorso della memoria. La scrittura di Vincenzo Consolo tra storia, ritualità e sdegno. In: Sub specie typographica…
23 Cfr. L. Fava Guzzetta: Dalle domande della scrittura…, p. 15. 24 Ibidem, p. 19.
35 dai neofascisti25. Perciὸ, per evitare l’ambiguità del discorso, Consolo ricorre più volte ad un referente diverso dalla scrittura, appartenente invece al campo delle arti figurative, come i quadri di Antonello, di Caravaggio e di Raffaello, i dipinti di Clerici. Il romanzo Lo spasimo di Palermo vuole essere infatti la manifestazione della forza stilistica orientata verso la ricreazione di una speranza di giustizia e di razionalità nel modo in cui dominano oppressione e terrore anche se la sospensione della comunicazione tra un padre e un figlio espressa tramite il motivo di una lettera rimane una tra le scene più suggestive di questo romanzo che tratta dell’impossibilità della continuazione di scrivere. Consolo è cosciente delle conseguenze della postmodernità così come lo era George Steiner che nel Linguaggio e silenzio parla dell’esaurimento dell’era verbale e del dominio delle forme “postlinguistiche” e addirittura del silenzio parziale26.
25 Cfr. G. Traina: Vincenzo Consolo. Fiesole, Cadmo, 2001, p. 21. 26 Cfr. G. Steiner: Linguaggio e silenzio. Milano, Garzanti, 2001, p. 56.
Aneta Chmiel ” Rompere il silenzio I romanzi di Vincenzo Consolo“
Tag: Carlo Emilio Gadda
Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello: vicinanze e lontananze di due scrittori del secondo Novecento
Giuliana Adamo
L’attenzione critica che qui si vuol dare a un confronto tra Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello trae spunto, a ritroso, dall’evento unico ed ultimo che li ha visti insieme il 20 giugno del 2007, a Palazzo Steri, a Palermo, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Filologia Moderna conferita ad entrambi, in curiosa conclusione del viaggio parallelo dei due scrittori, iniziato proprio nel 1963, anno del loro rispettivo esordio letterario.1 Escono, infatti, nel 1963 La ferita dell’aprile di Consolo – storia di un adolescente che dopo un itinerario fatto di entusiasmi e di delusioni, di gioie e dolori, arriva alla conoscenza della solitudine e del carattere conflittuale dell’esistenza; misto sapientemente dosato di autobiografia e di storia, di quotidiano e di mito – e Libera nos a malo di Meneghello, testo autobiografico che ‘offre un ritratto della vita a Malo, di una incomparabile ricchezza e incisività. È l’Italia […] della prima metà del secolo, nei decenni successivi alla Prima guerra mondiale’ che suscita anche nei lettori che veneti non sono ‘la “scossa del riconoscimento” (lo shock of recognition, come si dice in inglese) – un senso di partecipazione, di familiarità, nonostante le grandi differenze di contesto culturale’.2 Importante richiamare – anche se rapidamente – le superficiali analogie tra le rispettive scelte biografiche che rendono conto, in parte, delle ragioni della posizione peculiare che i due scrittori hanno avuto nel panorama culturale coevo: essendo tra i pochi ad essersi espatriati o dispatriati, con tutte le differenze dei singoli casi (Consolo a Milano, Meneghello a Reading in Inghilterra), dal proprio Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 39 luogo natìo e ad avere vissuto in un costante confronto tra le diverse culture con cui sono venuti a contatto. Entrambi, e ciascuno a suo modo, ulissici nel nóstos continuo con la propria Itaca: la Sicilia per Consolo, Malo per Meneghello. Prima di proseguire è importante ricordare, in sintesi, che il contesto letterario in cui prendono l’avvio i due scrittori è quello a cavallo degli anni ’50 e ’60 del Novecento, momento in cui, in un’Italia che faceva ancora i conti con gli strascichi della già conclusa esperienza del Neorealismo postbellico, imperversavano dibattiti e polemiche riguardanti soprattutto le nuove forme di espressione letteraria da ricercarsi, in ambito linguistico, nei territori che si estendevano tra il ricorso alla lingua italiana e la necessità dell’uso letterario dei dialetti. Per intendere la lezione stilistica di Meneghello sono preziose le parole di Cesare Segre, secondo cui lo scrittore di Malo si muove in uno spazio indipendente di outsider, di dispatriato e apprendista in Inghilterra, da Meneghello chiamata il ‘paese degli angeli’. Lo scrittore di Malo, quindi, ‘ha ben poco a che fare’ – sostiene Segre – con i precedenti più rappresentativi quali Fenoglio, Testori, Pasolini, Mastronardi perché la loro scelta dialettale è connotata da un ‘marchio sociologico’ di eredità neorealistica estraneo alla scrittura di Meneghello. E ha anche poco a che spartire sia con la diversa matrice della dialettalità espressionistica di Gadda; sia con l’uso mimetico del dialetto di Fogazzaro; sia con la dialettalità contenutistica di Verga, e poi di Pavese, in cui il ricorso alla dimensione dialettale esula dalle caratteristiche lessicali e morfosintattiche del dialetto. A queste differenze, si aggiunga, infine, il tratto peculiare della scrittura di Meneghello in cui, benché la funzione del dialetto sia in lui fondativa, il discorso narrativo avviene ‘prevalentemente in lingua’.3 Per Consolo il discorso è differente in quanto lo scrittore siciliano – pur con tutta la sua peculiare originalità espressiva che vede fondere l’eredità barocca di Lucio Piccolo con la ratio illuminista di Sciascia – si inscrive pienamente nella tradizione del romanzo storico siciliano che si estende, notoriamente, dal Verga della novella ‘Libertà’, al De Roberto de I viceré, al Pirandello de I vecchi e i giovani e allo Sciascia de Il consiglio d’Egitto. Tutti i romanzi e le opere di Consolo si riferiscono alla storia più o meno recente della Sicilia e se ne nutrono direttamente. Per quel che riguarda, invece, la sua ricerca linguistica, come da lui stesso ampiamente ribadito nei suoi scritti, essa rimanda alla linea della sperimentazione di Pasolini e di Gadda (in opposizione alla soluzione razionalista e illuminata della lingua di Calvino e Sciascia), risultando in una scrittura che, come coglie la poetessa e scrittrice Maria Attanasio, ‘non è mai rotonda fertilità espressiva, 40 Giuliana Adamo levigato specchio, ma frantumazione caleidoscopica, allusivo aggiramento, inesauribile nominazione; al di là della parola, resta, indicibile, il vivido pulsare della vita’.4 Fatta questa necessaria premessa, torno all’argomento su cui mi soffermo in questa sede. Per il confronto che mi appresto ad abbozzare e a proporre – nulla di esaustivo ovviamente, ma ugualmente passibile, spero, di critiche costruttive, approfondimenti, analisi di differente approccio – il punto di partenza mi è sembrato giusto che fosse dato dalle rispettive lectiones magistrales – in apparenza così diverse – indirizzate, dai due laureandi, al Senato accademico e al pubblico presenti nella sala palermitana. Quella di Consolo, il primo a parlare, dal titolo ‘Due poeti prigionieri in Algeri. Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano’; quella di Meneghello intitolata ‘L’apprendistato’. 5 Le due lectiones mi pare si prestino ad essere usate come specimen delle rispettive opere, permettendo di tracciare linee di contatto e/o distacco, di analogie e/o differenze tra i due autori. Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano La lectio di Consolo, fin dalla dedica alla memoria di Leonardo Sciascia, segnala l’instancabile e appassionata militanza, da sempre parallelamente giornalistica e letteraria, dell’autore siciliano e verte sui temi che costituiscono il cuore di tutta la sua scrittura: 1) Il rapporto tra passato e presente (da cui il suo sguardo storico indagatore trae la linfa vitale: il passato come metafora del presente). 2) L’attenzione particolare alla Storia siciliana inquadrata nel contesto più ampio della storia mediterranea, fatta di incontri e scontri di popoli e civiltà e dalle stratificazioni culturali e linguistiche che ne conseguono. A questo, inoltre, si lega l’immancabile tema dell’opera di Consolo: il viaggio. Tutte le sue opere sono fondate su una storia di viaggio o giocano con la metafora del viaggio: viaggio rituale dall’esistenza alla Storia, che invita alla conoscenza di sé e del mondo. Viaggio alla ricerca della luce-ragione che illumini, pur se in modo intermittente, le tenebre che avvolgono la condizione umana. 3) La necessità ineludibile della poesia (con il ricorso nella sua narrativa ad una lingua poetica, non comunicativa ma espressiva). 4) La citazione e la menzione continue di testi poetici e narrativi, scritti e orali, nelle diverse lingue del mondo consoliano: italiano, siciliano, spagnolo, latino, sabir, nonché il costante intarsio realizzato dalle fedeli Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 41 riprese di cronache e documenti d’epoca ufficiali e non, altro polo costitutivo della poetica e dell’opera di Consolo. Quanto al contenuto della lectio, in parole brevi, che valgono quasi come un sottotitolo, parla della vita terribile nel tardo Rinascimento, vissuto tra le sponde del Mediterraneo, che fa da sfondo alla comune prigionia, nelle carceri di Algeri, di Miguel de Cervantes e del poeta siciliano Antonio Veneziano alludendo, per via di metafora, all’attuale situazione del mare nostrum, crocevia di diverse civiltà e doloroso luogo degli scontri tra di esse. Si pensi, soprattutto, al problema dei migranti, nei confronti del cui trattamento da parte dell’Europa occidentale e, in particolare dell’Italia, la sensibilità dell’intellettuale Consolo ha raggiunto punte estreme di indignazione civile e di profonda pietas. Consolo ricostruisce la oscura biografia di Antonio Veneziano ‘l’elegantissimo latinista, il più rinomato poeta siciliano del secolo XVI’6 vissuto tra 1543 e 1593. Per fare questo, applica il suo rigoroso metodo di indagine storica e storiografica – eredità manzoniana e fondamento dei suoi romanzi storici, o meglio anti-romanzi storici – risalendo alle fonti scritte ed ufficiali e, quando possibile, a fonti più in ombra (archivi, fondi di parrocchie, testimonianze di oscuri cronisti coevi, lettere dimenticate, atti notarili, scritte murali, graffiti, canzoni popolari, etc.).7 In questo caso, Consolo cita, tra gli altri, le testimonianze di Giuseppe Lodi (bibliotecario ottocentesco della palermitana Società di Storia Patria); del demo-psicologo ed etnologo Giuseppe Pitrè; del canonico Gaetano Millunzi; di Leonardo Sciascia che, nel 1967, a proposito del Veneziano ricorda che era: ‘Violento, sensuale, scialacquatore, carico di debiti, incostante negli affetti famigliari e negli amori, assolutamente sprovvisto di rispetto per le istituzioni e per gli uomini che le rappresentano’.8 Tuttavia, ed è questo che interessa a Consolo sia per il plurilinguismo sia per la militanza polemica dell’intellettuale: malgrado il carattere e la mala condotta, scrive, scrive il Veneziano, scrive poesie in siciliano, in latino, in spagnolo, prose e composizioni in versi per gli archi di trionfo in onore dei vari viceré che s’installano a Palermo. Ma scrive anche satire contro gli stessi viceré, contro il potere politico, satire affisse sui muri. (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 26) La vita del Veneziano si rivela curiosamente speculare a quella di Cervantes (ricca come risulta di accuse malevole, assilli economici, disordini familiari, varie incarcerazioni). Ed è ad una di queste incarcerazioni, presumibilmente, che si deve l’incontro, o il re-incontro (forse, congettura Consolo, si 42 Giuliana Adamo erano incrociati anni prima a Palermo, ma questo resta da dimostrarsi), e la conseguente ammirazione reciproca, quasi amicizia, tra l’autore del Quijote e quello della Celia. Il Veneziano venne preso prigioniero sulla galea Sant’Angelo, al seguito di Don Carlo d’Aragona, dai corsari, al largo di Capri, il 25 aprile 1578. Quindi venne condotto come schiavo ad Algeri nel cui bagno penale incontrò Cervantes, a sua volta schiavo in quella città da più di tre anni. Anche la biografia di Cervantes, soprattutto in relazione alla sua prigionia algerina e ai suoi ben quattro tentativi di evasione, è ricostruita storicamente da Consolo sulla scia di scritti, documenti, testimonianze di autori vari, incluse quelle dello stesso Cervantes. Ecco, dunque, che è importante rilevare (e la lectio ce ne dà prova) come Consolo lavori col materiale che ha cercato, documentato, elaborato. Da un lato, quindi, vediamo emergere, l’importanza che ha per lo scrittore la Storia e il metodo usato nella sua ricerca di ricostruzione e ricomposizione del passato; dall’altro – e in maniera costitutivamente intrecciata – il lavoro creativo dello scrittore che intaglia una storia ricca di dettagli documentati in modo meno ufficiale dentro alla grande Storia, che lui avvertiva sempre come immobile e immutevole nelle sue prevaricazioni, nei suoi inganni, nelle sue menzogne, nelle sue ingiustizie, nei suoi silenzi, nelle sue esclusioni. Ed ecco – analogamente a quanto avviene nei suoi lavori storici, memori della lezione manzoniana ma prodotti nella sua lingua ‘rigogliosamente espressivistica’,9 plurivocale,10 pluridiscorsiva e pluristilistica – che Consolo si spinge a ricreare che cosa possano avere detto, fatto, provato insieme, ad Algeri, i due scrittori secenteschi: I due in carcere, ascoltano la cantilena in sabir, la lingua franca del Mediterraneo, che i ragazzi mori cantavano sotto le finestre dei bagni: Non rescatar, non fugir Don Juan no venir morir… cantilena riportata da Cervantes in Vita ad Algeri e ne I bagni di Algeri. Tutte e due avranno avuto catene alle caviglie e saranno stati vestiti allo stesso modo, il modo come Cervantes descrive il Prigioniero che entra con Zoraide nella locanda ‘il quale mostrava dagli abiti d’essere un cristiano giunto recentemente da terra di mori, perché era vestito d’una casacca di panno turchino, a falde corte, con mezze maniche e senza collo; anche i calzoni erano di tela turchina, e il berretto dello Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 43 stesso colore.’In quel carcere, con chissà che emozioni e sensazioni, scrivono l’uno la Celia (preso d’amore non si sa bene per chi fra i due possibili oggetti del suo amore: quello incestuoso per la nipote Eufemia o quello impossibile per la viceregina Felice Orsini Colonna, moglie di Marc’Antonio Colonna, comandante della flotta veneziana nella battaglia di Lepanto, nel 1571, allora viceré di Sicilia); l’altro presumibilmente Vita ad Algeri, le Ottave per Antonio Veneziano e comincia la stesura della Galatea. (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, pp. 30-31)11 I due protagonisti della lectio lasceranno Algeri, finalmente riscattati: il Veneziano nel 1579 (morirà nel 1593 nel carcere di Castellamare per lo scoppio doloso della polveriera), mentre Cervantes nel 1580 (per poi finire nel carcere di Siviglia o in quello di Castro del Rio dove nel 1592 concepisce il Quijote). In seguito, ricorda significativamente Consolo, Cervantes ritornerà sulla passata dolorosa esperienza: ‘[d]ice ancora il Prigioniero del Don Chisciotte: “Non c’è sulla terra, secondo il mio parere, gioia che eguagli quella di conseguire la libertà perduta”’ (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 33). A questo punto, da quel che emerge da una lectio così costituita possiamo cogliere un insieme di elementi che offrono una misura valida per farsi un’idea dei tratti essenziali che permeano tutta l’opera di Consolo: 1) L’ ineludibile necessità etica che lo spinse, da sempre, a studiare, indagare, scavare, scrivere – cercando di capire e di aiutare a fare capire – la complessità della vita, nel Cinquecento come nel 2000, che si svolgeva e svolge nell’area mediterranea, dove sono nate incontrandosi e/o scontrandosi le grandi civiltà della storia occidentale. 2) La necessità di mostrare che la Storia – se distaccata dalla storiografia ufficiale, sempre soggettiva e parziale, scritta dai vincitori e mai dai vinti – può emergere più contraddittoria, ma più completa, grazie al corale contributo delle voci di ‘più picciol affare’. In tal modo, la scrittura della storia diventa (con certa utopia) incrocio di punti di vista diversi: Storia, insomma, come una messa a fuoco plurima e dialettica della realtà. In Consolo il rapporto Storia-invenzione del romanzo storico classico è rovesciato: ‘ciò che lì era documento qui è racconto, universo opinabile, discorso retorico. Ciò che lì è veramente accaduto, qui è come realmente accaduto’, evidenzia finemente Nisticò a proposito, in particolare, de Il sorriso dell’ignoto marinaio. La critica operata da Consolo è volta alla Storia in quanto scrittura, nella sua ‘demistificazione permanente del mito 44 Giuliana Adamo dell’oggettività e della verità dei documenti e della tradizione storica’.12 Ed è su questo assunto che si è basata la sua intera attività di scrittore. 3) Il valore della scrittura qui esemplato dall’esperienza di due intellettuali che si trovano in mezzo a indicibili difficoltà oggettive e, di conseguenza, il ruolo salvifico della poesia che – nonostante tutto e tutti e nonostante i suoi stessi autori – è eternamente valida e, a differenza della Storia, super partes. 13 4) La metafora del presente che quell’antica, tormentata, feconda esperienza cinquecentesca è chiamata simbolicamente a rappresentare, in quanto per Consolo: ‘un testo è vivo quando è metafora, quando non parla solo di sé’.14 5) La fondante tensione metaforica resa attraverso uno stile che rende ragione del coro di voci e di lingue che scintillano in questo testo (come in tutti i suoi testi) intrecciandosi per ricordarci che quel che è successo succede ancora e che, e qui Consolo usa le parole, tragicamente attuali, che Fernand Braudel riferiva all’età di Filippo II: ‘In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli ‘universi concentrazionari’ (‘Due poeti prigionieri in Algeri’, p. 34). Rappresentativa della poetica di Consolo è questa lectio che ho voluto usare come microtesto per individuare le linee portanti del macrotesto consoliano: non autobiografica, se non per pulsioni spesso inconsce; storico-filologica; testimonianza del suo impegno di scrittore e di intellettuale contro soprusi e ingiustizie. Le attestazioni dell’inesausto agire civile di Consolo, oltre che in tutti i suoi libri e nei suoi saggi, anche sulle pagine dei quotidiani italiani storicamente più schierati a sinistra, come l’Unità e Il manifesto, che hanno accolto i suoi veementi articoli sui temi dell’immigrazione, dei migranti, delle angherie e degli abusi perpetrati ai loro danni, della micidiale miopia italica e dell’assenza di memoria di quel popolo di migranti che sono sempre stati gli italiani. Per Consolo etica e scrittura sono una cosa sola,15 la memoria individuale e la memoria storica consentono lo scavo nel passato per riflettere sul presente; la lingua del suo scrivere – con le lingue sottostanti che la nutrono storicamente e culturalmente – è una lingua storica e filologica e non la si capirebbe se la si alienasse dal fondamento del determinarsi storico e sociale dei linguaggi. La esibita letterarietà di Consolo, tanto sottolineata dai critici, per essere correttamente intesa va ricompresa in un progetto artistico che utilizza l’opacità e il peso della tradizione letteraria come strumenti di una più acuta e complessa lettura della realtà. Se, infatti, Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 45 pur nell’ambito di una insistita critica sociale mossa dalla prospettiva di una solidarietà coi ‘vinti’ e coi subalterni non possiamo sottrarci alla constatazione (è questa la critica mossa a Consolo) della preziosità erudita del suo linguaggio, delle sue notevoli densità e perspicuità letterarie, lo si deve soprattutto al suo tentativo di drammatizzare una contraddizione che da sociale diventa, performativamente, stilistica e retorica. Quello che in realtà è lo scontro tra isole di ricchezza e oceani di indigenza diventa, nelle strutture narrative di Consolo, lotta tra l’abbandono lirico di un linguaggio (spesso anche in veste parodica) che è esso stesso ‘cosa’ (strumento di gioco e di piacere) e il dover essere etico e razionale per garantire la narrazione. Prosa e poesia si fronteggiano, esibendo ciascuna le proprie ragioni. La sua narrativa usa a piene mani una lingua e dei moduli poetici non strettamente narrativi (ma lontanissimi dalla prosa d’arte da lui aborrita): il retablo, il cunto, l’opera teatrale, la metrica versificatoria, espedienti stilistico-retorici quali l’enumerazione e l’iperbato, il repentino mutamento dei registri, che con il loro andamento ipotattico frangono la paratassi del più generale impianto narrativo. Le apparenti dissimmetrie, che la lectio riflette, tra piano dell’espressione – iper-letteraria, barocca – e quello del contenuto – materialistico, progressivo – sono ricomprese ma non ricomposte o pacificate nella sua scrittura, a causa di una contradditorietà mai risolta: il conflitto (sociale e retorico) rimane la cifra estetica più propria nell’opera di Consolo.16 L’apprendistato E veniamo alla lectio di Meneghello ‘L’apprendistato’, quintessenzialmente meneghelliana: autobiografica, riflessiva, ironica, giocata sapientemente sui diversi registri retorici che, come sempre nella sua scrittura, sono capaci di suscitare, in chi legge uno spettro variegato di emozioni: dal riso alla commozione alla riflessione al disincanto. Dall’inizio emerge subito l’interesse primario di una vita, il motore di tutti i suoi libri: l’attenzione alle parole e alle cose che esse veicolano inquadrata, da subito, nel suo personale percorso di studente dialettofono italiano e di professore di italiano in Inghilterra. Le sue lingue di cultura (italiano, greco, latino, inglese) affiorano subito, nel primo lungo paragrafo della lectio laddove, in modo colto e ilare, racconta di quel che provoca in lui l’essere in procinto di diventare ‘filologo’ e cerca di definire che cosa sia la filologia. Risale all’origine greca del termine dovuto a Eratostene, nel III secolo a.C., ‘matematico, ma bravo anche come 46 Giuliana Adamo astronomo, geografo, filosofo, storico, e altro ancora’ (‘L’apprendistato’, p. 37), che ‘[d]oveva essere un personaggio straordinario, molto più di Tagliavini’ (ibid., p. 36) – maestro di Glottologia di Meneghello a Padova che aveva scommesso coi propri alunni di ricostruire, partendo da una mezza pagina, nello spazio di un’ora, la grammatica (morfologia e sintassi) di una lingua sconosciuta. Meneghello si sofferma sulla definizione antica di Eratostene che pare fosse chiamato dai colleghi ‘pèntathlos’ come a dire ‘pentatloneta’, per segnalare questa versatilità, e forse per denigrarla. […] In inglese uno che riesce bene in molte cose […] è un all-rounder: dove io non ci sento sottointeso ‘[bravo in tutto] e dunque non supremo in nulla’. Ma ad Alessandria pare proprio che il sottointeso ci sia stato. (‘L’apprendistato’, p. 36) Alle ipotesi sulla filologia come versatilità di conoscenze e applicazione delle stesse, seguono le considerazioni sul lavoro filologico svolto da Eratostene nella sua qualità di direttore, a suo tempo, della Biblioteca di Alessandria ‘editore, recensore e emendatore di testi letterari’ (‘L’apprendistato’, p. 37). Tuttavia permane l’ambiguità del termine con cui si definiva ‘filologo’. Termine ombrello, per Meneghello, che accoglie almeno tre significati: 1) espressione legata al gusto del discorrere; 2) amante del lógos, ovvero più estensivamente ‘dotto’, ‘studioso’; 3) più specificamente e circoscrittamente ‘studioso delle parole […] insomma un linguista’ (ibid.). Le diverse facce della filologia che affascinano Meneghello lo portano ad uno dei suoi tipici scarti logici in conclusione della prima parte del suo testo: Contro le mie tendenze, mi si affaccia l’idea che anche per la filologia ‘it takes all sorts to make a world’, ci vuole gente di ogni risma per fare un mondo, vale a dire il mondo così com’è. Ma nei riposti ventricoli del mio sentimento non ci ho mai creduto del tutto. (‘L’apprendistato’, p. 38) Passa, quindi, ad una riflessione, brillantemente argomentata, sul suo rapporto con la linguistica (‘non mi considero un linguista’, ibid.), soffermandosi sulla sua lingua nativa, non materna (la mamma, friulana, non aveva latte) ma della balia maladense. Il dialetto di Malo è percepito da Meneghello quale ‘lingua del genere umano, gli esseri umani parlavano così, e i loro modi entravano in me, davano forma alle strutture interne (preesistenti, penso) della mia competenza, creavamo circuiti indistruttibili’ (‘L’apprendistato’, p. 38) lingua parlata, pre-logica, del cui apprendimento non aveva coscienza. Accanto, parallelamente, si innesca il processo Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 47 di apprendimento di una sorta di lingua seconda: l’italiano, di origine più artificiosa e innaturale appreso a scuola e sui libri, prevalentemente attraverso la lettura. Una lingua, sia ben chiaro, tutt’altro che nitida e netta a proposito della quale Meneghello si sente in dovere di precisare: veramente c’erano due filoni, quasi due matasse di viscoso tiramolla, schiaffate una sull’altra e annodate in una specie di doppia elica, come si vedeva fare nelle sagre di paese: il filone ufficiale, di stampo aulico e di derivazione letteraria, e il filone reale dell’italiano regionale. Quest’ultimo aleggiava attorno a noi, imparavamo noi stessi a servircene – quando si cercava di parlare in chicchera – e a mano a mano a scriverlo: certamente non ci rendevamo conto che fosse ‘italiano regionale’, la nozione non si era ancora formata o diffusa, e la cosa non sarebbe parsa allora una variante legittima della lingua nazionale. (‘L’apprendistato’, p. 38) La complessità di queste esperienze per lungo tempo non ha dato luogo ad un sistema articolato di idee sulla lingua, questo è potuto avvenire molto più tardi, grazie all’influenza di amici e colleghi incontrati in Inghilterra, parecchi dei quali a Reading, e la menzione silenziosa a Giulio Lepschy in particolare è connotativa del modo in cui Meneghello – si pensi soprattutto ai volumi delle Carte – alluda spesso a persone della sua realtà biografica evitando di farne i nomi, cifra tipica della sua scrittura zibaldonica.17 L’incontro e il confronto con il nuovo mondo culturale inglese, portano Meneghello a riconsiderare la sua precedente visione del proprio rapporto con le lingue: la struttura delle lingue ha subito un rivolgimento radicale, le vecchie impostazioni abolite e cancellate. Questa del nuovo che sopravviene e soppianta l’antico, pare uno schema ricorrente nella mia vita mentale. (‘L’apprendistato’, p. 39) Il punto cruciale della lectio, che lo avvicina pur nella loro diversità a Consolo, è dedicato a sottolineare che il suo vivo interesse per le lingue non riguarda l’analisi teorica delle loro strutture, ma ‘ciò che le lingue che frequentavo recavano con sé, un’immagine intensificata delle cose del mondo’ (ibid.), e questo si verifica soprattutto nella poesia: i poeti lirici in particolare, antichi e moderni, nelle lingue in cui li leggevo, latini, italiani, francesi, e per frammenti anche tedeschi e spagnoli (non inglesi, in principio: quelli sono venuti in seguito, nella mia tarda gioventù, in Inghilterra, ed è stata un po’ una gran 48 Giuliana Adamo mareggiata poetica). In queste scritture percepivo gli effetti di una forza oscura che mi sprofondava nel cuore della realtà: e non pareva rilevante, e nemmeno pertinente, che si trattasse davvero di lingue diverse, era come se fosse una lingua sola. (‘L’apprendistato’, p. 39) La lingua ha risorse infinite per sondare la realtà e Meneghello usa, per fare questo, l’unica lingua che conosce davvero: l’Alto Vicentino, o meglio, la lingua di Malo. Alludendo a Libera nos a malo sottolinea: Si formava in me scrivendo, il quadro naturale di queste varianti, ero in grado di distinguere con spontanea precisione tra questi diversi usi, e intravederne a sprazzi le separate capacità di esplorare, trivellando in profondo il reale. (‘L’apprendistato’, p. 39)18 Nell’ultimo scorcio del testo evoca uno dei temi a lui più cari, quello del lungo apprendistato che lo ha reso in grado di portare ‘ciò che scrivo a pareggiare la potenza di quell’antica esperienza, nei vari settori della vita che mi è capitato di attraversare’ (ibid.). Di grande efficacia retorica, e commovente, è la chiusa della lectio in cui, con un procedimento analogo a quello esperito da Seamus Heaney in ‘Digging’ nella raccolta Death of a Naturalist del 1966, laddove evoca la mano contadina del padre che afferra la vanga per scavare e la propria che impugna la penna per fare altrettanto (vv. 1-5): Between my finger and my thumb The squat pen rests: snug as a gun. Under my window, a clean rasping sound When the spade sinks into gravely ground: My father, digging. I look down per, quindi concludere (vv. 29-31): Between my finger and my thumb The squat pen rests. I’ll dig with it. si istituice un parallelo tra l’apprendistato di Luigi Meneghello scrittore e quello di Cleto Meneghello, suo padre, tornitore: Aveva imparato a tornire da ragazzo a Marano […]. Sui vent’anni era andato a Verona a fare il suo Capolavoro. […] Il capolavoro che gli diedero da fare era una vite senza fine; preparò il pezzo, misurò, ci fece i segnetti che bisogna farci per tornire una vite senza fine, e a Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 49 questo punto il capo che lo stava a guardare aveva già capito che era bravo e disse: ‘Basta così’. (‘L’apprendistato’, p. 40) Segue l’explicit, profetico, dell’ultimo discorso pubblico di Meneghello: Vorrei poter fare anche io così, se ne avrò il tempo, scrivere qualcosa di veramente conclusivo, magari solo una paginetta, o un paio, ma da scrittore finalmente maturo. E che voi, come già a mio padre i suoi esaminatori, mi diceste: ‘Ok, basta così’. (ibid.) Quanto emerso da questa lectio permette di ravvisarvi, analogamente a quanto visto nel caso di Consolo, le trame costitutive dell’intera opera di Meneghello: 1) La prima lingua innata e l’incontro con le altre lingue apprese che ha determinato la sua attività di vita e di scrittura. 2) Il ricordo di Malo – oggetto del suo continuo nóstos – eternato nelle sue opere. 3) La sua vita di perenne apprendista. Tutti elementi che convivono simultaneamente nella sua ultima lectio e in tutti i suoi libri. Cosa, dunque, hanno in comune Consolo (nato nel 1933 a Sant’Agata di Militello, in Sicilia, provincia di Messina e morto a Milano nel Gennaio del 2012) e Meneghello lo scrittore di Malo (nato nel 1922 a Malo, in Veneto, provincia di Vicenza e morto nel 2007 nella vicina Thiene)? Alcune cose più ‘esteriori’ furono indicate dallo stesso Consolo nel ricordo dedicato allo scrittore maladense, suo contributo alla Biografia per immagini su Meneghello, curata da Pietro De Marchi e da chi scrive. Lo riporto qui di seguito: La laurea honoris causa in Filologia moderna, a noi due insieme, a Meneghello e a me, quel giorno di giugno del 2007, là nell’aula magna del Rettorato di Palazzo Steri, in quel trecentesco palazzo che tante ne aveva viste (fu abitato dall’illustre famiglia dei Chiaramonte che l’aveva fatto costruire, fu poi sede vicereale, sede del Santo Uffizio, del tribunale e del carcere della terribile Santa Inquisizione). La laurea, dunque, insieme, a Meneghello e a me. E a me sembrava quel giorno, in quella magnifica aula, davanti al senato accademico e al vasto pubblico, di usurpare il posto di Licisco Magagnato, il Franco di Bausète, che si laureò a Padova nello stesso giorno insieme a Meneghello ed ebbero, i due laureati, insieme un solo ‘papiro’ di laurea ‘a due teste’. Però, quel giorno, mi rassicurava il fatto che Meneghello ed io eravamo gemelli, voglio dire che eravamo nati scrittori nello stesso anno, nel 1963, lui col suo Libera nos a malo ed io con il mio La ferita dell’aprile; e tutti e due ancora con uguale assillo linguistico, 50 Giuliana Adamo l’intrusione, nell’italiano, del vicentino, o meglio della lingua di Malo, ed io del siciliano, vale a dire di tutte le antiche lingue che giacevano nel siciliano. E poi… E poi, eravamo due dispatriati, il Meneghello in Inghilterra, a Reading, ed io nella Milano dei Verri, di Beccaria, di Manzoni, di Verga, di Vittorini… Dispatriati, noi due insomma, in due diverse ‘patrie immaginarie’. Cosa univa ancora, Meneghello e me? A guardare le immagini di quella cerimonia, l’autoironia dipinta sui nostri due volti. Ah, caro Meneghello, che incontro è stato quello con te a Palermo! Primo e ultimo incontro, perché subito, tornato a Thiene, tu sei partito per quel viaggio dal quale non si ritorna più. Ed io ti rimpiango. Tutti ti rimpiangiamo, ma ci confortano però i tuoi libri, tutti i tuoi magnifici libri. Quelli, sì, resteranno sempre con noi.. (Luigi Meneghello. Biografia per immagini, pp. 172-173) L’ironia, tratto assoluto dell’intelligenza, unisce di certo i due scrittori, ed il distacco anche geografico con il conseguente, lungamente reiterato, rispettivo nóstos. Così come il loro essere sempre stati fuori dal coro, spesso a remare contro le patrie tendenze critiche e letterarie (ricordo, per esempio, l’insofferenza di Meneghello per Quasimodo e Ungaretti e pure per Moravia, nonché quella di Consolo nei confronti del – per lui – letterariamente troppo tradizionalista Tomasi da Lampedusa, per l’avanguardista Gruppo 63, e per la maggior parte della nuova narrativa italiana, tra cui spiccava l’avversione per il dialetto posticcio e folklorico di Camilleri). Entrambi fuori, per loro (e nostra) fortuna, dalla logica aberrante del mercato editoriale. Pur in modi diversi entrambi voci contro nel panorama letterario italiano del secondo Novecento. E questo vale, ovviamente e ancor di più, per il problema della ricerca e della definizione della propria lingua di espressione letteraria a cui entrambi hanno dedicato il meglio della loro sapienza e della loro perizia, del loro talento e della loro passione. Tratti questi che li accomunano anche nel loro amore totale per la poesia, per la sua funzione e per la sua libertà espressiva. A questo punto, forzandolo in qualche modo ai fini del mio discorso, vorrei citare Wittgenstein che, nel 1929, in una sua lezione a Cambridge sostiene: ‘So far as facts and propositions are concerned there is only relative value and relative good, relative right’ e ancora: I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 51 This running against the walls of our cage is perfectly absolutely hopeless.19 Meneghello e Consolo si scontrano con lo stesso problema: in che lingua esprimere il mondo ‘possibile’ del proprio narrare? Dal canto suo Meneghello, che si è sempre misurato con la sostanza non univoca dell’esperienza umana cercando di darle una forma espressiva che il più possibile si avvicinasse al vero – anzi che fosse ‘più vera del vero’ – ammette: ‘Con le parole è impossibile essere precisi: non dico difficile, impossibile’ (Le carte III, p. 95). Eppure occorre narrare per capire il mondo, ma come? Risponde: con ‘la lingua nativa che illumina l’andamento delle cose’ (Le carte III, p. 99). Consolo, a sua volta, e analogamente dal suo punto di vista storicofilologico, si confronta con una realtà sfaccettata, plurivoca, composita, contraddittoria – si ricordi la sua visione e il suo tentativo di una resa plurima e dialettica della Storia – e per esprimerla, ritenendo ormai insufficiente e superata la lingua razionale-geometrica-comunicativa di Sciascia e Calvino, crea una lingua espressiva, dove la poesia evoca quello che la lingua italiana ormai ‘massificata’ e fatta scadere dall’abuso dei massmedia non è più in grado di comunicare. Una pulsione analoga muove i due scrittori. I risultati? Sorprendenti in ambo i casi. Sulla lingua di Meneghello critici e linguisti hanno detto tante cose e tra tutte si stagliano le perfette analisi di Giulio Lepschy che in un saggio del 1983,20 a proposito di Libera nos a malo, individua le tre lingue del libro quali: ‘italiano prezioso, italiano popolare, dialetto’, segnalando che ‘il dialetto è usato più per il suo valore espressivo o per la sua crudezza, che per la sua normalità o spontaneità’.21 E alla domanda ‘in che lingua?’ è scritto il libro, Lepschy, in sedi diverse, risponde senza indugi:22 In italiano. Libera nos a malo è un libro ‘italiano’, scritto ‘in italiano’, che appartiene alla cultura italiana (e attraverso ad essa a quella europea e internazionale), e insieme la arricchisce di elementi nuovi e originali.23 Un italiano reso più leggero e antiretorico grazie a quanto imparato nell’apprendistato inglese. Consolo, a cui potrebbero attagliarsi le parole di Lepschy su Meneghello (e a garantirne l’appartenza alla cultura internazionale, basterebbe la lista delle traduzioni delle opere di Consolo in quasi tutte le lingue romanze e in inglese, tedesco, olandese) arriva a forgiarsi una lingua espressiva, barocca (nel senso migliore del termine), 52 Giuliana Adamo ricchissima di citazioni – echi – rimandi che vanno dalla sfera erudita a quella più bassa. Lingua in cui convergono le lingue mediterranee: greco, latino, arabo, spagnolo, le varie parlate siciliane, incluse le lingue delle isole linguistiche (tra cui spicca il dialetto gallo-italico di san Fratello, paesino sui Nebrodi), italiano colto. La ricchezza linguistica consente la realizzazione della scrittura palinsestica di Consolo (per il quale sotto la superficie della propria scrittura ci devono essere i segni più importanti della letteratura di chi ci ha formato. E direi che su questo punto l’analogia con il ricchissimo tessuto narrativo di Meneghello è palese) e la messa a fuoco dell’irriducibile complessità del reale (da qui il suo preferito procedimento stilistico dell’amplificatio: l’accumulatio, soprattutto nominale), nello strenuo tentativo di rendere quello che è stato. La ricerca dei nomi di questo ‘archeologo della lingua’ non è semplice ricordo memoriale, ma attestazione del travaglio e del dolore di quella parola attraverso il male della storia. Rievocazione del tempo e dello spazio della Sicilia perduta attraverso i nomi che non sono segni di un’origine metafisica, ma della materialità del mondo prima della lacerazione, delle ferite, del dolore. Analogamente, Meneghello si è dedicato alla ricerca del recupero ‘archeologico’ di una società e di una cultura conosciute nell’infanzia e nella giovinezza e poi irrimediabilmente perdute. Non si tratta, però, di una rivisitazione della memoria percorsa dalla nostalgia e dalla retorica, ma di una vera e propria ricostruzione di ambienti, frammenti di vita e di cultura che mira a ridisegnare quella realtà attraverso una specie di ricerca antropologica, segnata sempre dal filo dell’ironia. E Consolo, in che lingua scrive? Non usava il dialetto: le espressioni, le parole dialettali sono sempre citazioni. Il suo linguaggio è l’italiano, ma l’italiano di Sicilia. Consolo, insomma, ripercorre la storia di Sicilia, dal Risorgimento all’ascesa del fascismo alla violenza mafiosa contemporanea, servendosi di un italiano costruito su ‘un fasto barocco e un ritmo musicale, con un gusto del dialettismo, del latinismo e dell’ispanismo, che contrastano espressionisticamente con i contenuti spesso tragici e con l’analisi, non sottolineata ma palesata e severa delle ragioni storiche’.24 Dice Consolo: Io non ho cercato di scrivere in siciliano assolutamente, ma vista la superficializzazione della lingua italiana e proprio per un’esigenza di memoria ho cercato la mia lingua che attingeva ai giacimenti linguistici della mia terra che erano affluiti nel dialetto siciliano, che io traducevo in italiano secondo la mia metrica della memoria.25 Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 53 Si potrebbero indicare molte altre aree di tangenza, vicinanza, analogia tra questi due scrittori che, pur diversi e geograficamente lontani, hanno dedicato la loro esistenza a mostrarci l’uno (Meneghello), più ‘antropologicamente’, che nella propria lingua nativa, innata e fondante, ‘le parole sono le cose’; l’altro (Consolo), con più impegno civile e utopia storica, che verrà un tempo in cui con parole nuove e, finalmente vere, perché riscattate dalla parzialità e dalle menzogne a senso univoco della Storia, ‘i nomi saranno riempiti interamente dalle cose.’26 È evidente che per entrambi il binomio etica e scrittura è indissolubile e che per entrambi scrivere sia una funzione del capire per avvicinarsi il più possibile alla realtà, all’unico ‘vero’ e, a questo proposito, grande è il debito nei confronti di Leopardi – di cui entrambi amano il poeta, il prosatore e il filosofo – contratto dai due scrittori. 27 Mi pare che la vicinanza più importante tra Consolo e Meneghello risieda in quella moralità che le parole di Franco Fortini definiscono come una forte e costante ‘tensione a una coerenza di valori e di comportamento’,28 espressa coerentemente e rispettivamente nella loro narrativa originale, coraggiosa, fieramente facente parte per sé stessa contro ogni tipo di omologante dittatura o partigianeria ideologica, letteraria, e del mercato editoriale. Trinity College Dublin Note 1 Ero presente a quella indimenticabile giornata palermitana sia per Consolo (su cui avevo appena finito di curare un volume di saggi), sia per Meneghello sulla cui opera stavo lavorando. Cfr. La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, con prefazione di Giulio Ferroni (San Cesario di Lecce: Manni, 2006) e Volta la carta la ze finia. Luigi Meneghello. Biografia per immagini, a cura di Giuliana Adamo e Pietro De Marchi con curatela iconografica di Giovanni Giovannetti (Milano: Effigie, 2008). 2 Giulio Lepschy, ‘Introduzione’, in Luigi Meneghello, Opere scelte, progetto editoriale e introduzione di Giulio Lepschy, a cura di Francesca Caputo (Milano: Arnoldo Mondadori, 2006), pp.xlv-lxxxiv (p.xlvii). 3 Cfr. Cesare Segre, ‘Libera nos a malo. L’ora del dialetto’, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, Atti del Convegno Internazionale di Studi In un semplice ghiribizzo (Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003), a cura di Giuseppe Barbieri e Francesca Caputo (Vicenza: Terra Ferma, 2005), pp. 23-27 (pp. 23-24). 4 Maria Attanasio, ‘Struttura-azione di poesia e narratività nella scrittura di Vincenzo Consolo’, Quaderns d’Italià, 10 (2005), 19-30 (p. 24). Ricordo, inoltre, che Consolo, nel solco di una discussione europea, negli anni del suo esordio letterario, circa il destino e la funzione del romanzo storico, ha ripudiato nella sua opera gli intrecci intrattenitori del romanzo tradizionale, ragione per cui, come non si è stancato di rimarcare nei suoi scritti e nei suoi 54 Giuliana Adamo interventi pubblici, scelse di spostare la scrittura dal ‘romanzo’ alla ‘narrazione’, secondo l’accezione datane da Walter Benjamin. Quanto al ripudio della lingua razionale e illuminista, lingua di una speranza ormai perduta irrimediabilmente, esso è motivato dalla mutazione antropologica avvenuta a seguito del boom industriale italiano nel corso degli anni ’50 del Novecento, su cui il Pasolini del saggio ‘Nuove questioni linguistiche’ (1964) ha scritto pagine fondamentali. La scelta poetico-espressiva della lingua letteraria di Consolo era in polemica con il linguaggio comunicativo, omologante, impoverito, tele-stupefacente determinato dall’avvento inarrestabile dei mass media. 5 Vincenzo Consolo, ‘Due poeti prigionieri in Algeri: Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano’ in Lectio Magistralis, documento ciclostilato (Palermo: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2007), pp. 23-34 (questo è il mio testo di riferimento): ora in La passion por la lengua: Vincenzo Consolo. Homenajes por sus 75 años, a cura di Irene Romera Pintor (Generalitat Valenciana: Universitat de Valencia, 2008), pp. 29-38. Luigi Meneghello, ‘L’apprendistato’, in Lectio Magistralis, documento ciclostilato (Palermo: Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2007), pp. 49-56; ora in Luigi Meneghello. Biografia per immagini, pp. 36-40 (è questa l’edizione a cui faccio riferimento). 6 Consolo alla p. 24 della sua lectio ricorda: ‘Nel 1894 la palermitana Società di Storia Patria pubblica il fascicolo dedicato ad Antonio Veneziano per il terzocentenario della sua morte’ e annota che il bibliotecario della Società era Giuseppe Lodi, a cui si devono le parole riportate nella citazione. 7 I romanzi di Vincenzo Consolo, di cui cito solo le prime edizioni: La ferita dell’aprile (Milano: Mondadori, 1963); Il sorriso dell’ignoto marinaio (Torino: Einaudi, 1976); Lunaria (Torino: Einaudi, 1985); Retablo (Palermo: Sellerio,1987); Nottetempo, casa per casa (Milano: Mondadori, 1992); Lo spasimo di Palermo (Milano: Mondadori, 1998). 8 Leonardo Sciascia, ‘Introduzione’ in Antonio Veneziano, Ottave (Torino: Einaudi, 1967), p. 7. 9 Enrico Testa, Lo stile semplice (Torino: Einaudi, 1997), p. 348. 10 Sulla plurivocità della lingua consoliana d’obbligo il riferimento al saggio di Cesare Segre, ‘La costruzione a chiocciola nel Sorriso dell’ignoto marinaio’, in Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento (Torino: Einaudi, 1991), pp. 71-86 (p. 83). 11 A proposito della descrizione riportata a testo, alludo di volata alla necessità visiva della scrittura di Consolo che – basti solo pensare a qualche suo titolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio (Antonello da Messina), Lo Spasimo di Palermo (Raffaello), Retablo etc. –, contrae un debito sostanziale e fondante con la pittura analogamente a Meneghello che notoriamente rimase folgorato, all’inizio del suo apprendistato inglese, dal metodo didattico del Warburg Institute su cui ha scritto pagine importanti e sui cui ha ampiamente basato il suo insegnamento e quello del dipartimento di Studi Italiani da lui fondato a Reading. Si veda, inoltre, quanto riportano Giuseppe Barbieri e Ernestina Pellegrini, rispettivamente, alle pp. 191 e pp. 197-202 di Luigi Meneghello. Biografia per immagini. 12 Renato Nisticò, ‘Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo’, Filologia antica e moderna, 4 (1993), 179-223 (p. 182). 13 Sulla salvezza della scrittura, da varie prospettive, si ricordino le parole di Meneghello: ‘la crisi di tutto il mio sistema di idee pre-inglesi, durata decenni, un lungo, interminabile periodo in cui ho dovuto tener duro, hold tight, come un naufrago su uno scoglio: usando ciò che potevo, aggrappandomi a ciò che avevo, per esempio, la prosa di Leopardi’: Luigi Meneghello, Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta, 3 voll. (Milano: Rizzoli, 2001), III, p. 185. E ancora: ‘“Scavi”. Estrarre “salvezza” dallo scrivere […]. È una specie di scavo continuo […]. Vado a scavare in tutto quello che mi è capitato: scavo, butto via e ricomincio, perché sono convinto che in qualche parte là sotto deve esserci quello che cerco, i nuclei del materiale effusivo e il luccichìo delle scorie vetrificate dove si Vincenzo Consolo e Luigi Meneghello 55 vede risplendere, che cosa di preciso? come dirlo?’ (ibid., p. 258). 14 Si confronti con quanto, analogamente, dichiara Meneghello, a proposito dell’autobiografia, nell’intervista concessa a Luca Bernasconi, in Luigi Meneghello. Biografia per immagini, p. 205: ‘Però tutto questo non è fondato sull’idea che ciò che è accaduto a me ha qualche importanza, anzi sono convinto che non ne ha praticamente nessuna per gli altri, se non per me. Ma dentro contiene qualche cosa che non appartiene solo a me e, scrivendo, qualche volta emerge. Quando emerge, allora va bene, ce l’abbiamo fatta; e l’autobiografia è diventata qualche cosa di più e di diverso.’ 15 A questo argomento nel 2002 è stato dedicato un convegno a Parigi, alla Sorbonne Nouvelle, i cui atti si possono leggere nel seguente volume: Vincenzo Consolo. Étique et Écriture a cura di Dominique Budor (Parigi: Presses Sorbonne Nouvelle, 2007). 16 Su questi aspetti si veda Nisticò, ‘Cochlìas legere. Letteratura e realtà nella narrativa di Vincenzo Consolo’. 17 Cfr. I seguenti volumi: Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta. Volume I: Anni Sessanta (Milano: Rizzoli, 1999); Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta. Volume II: Anni Settanta (Milano, Rizzoli, 2000). Per il volume III delle Carte si rimanda alla nota 13. 18 Si confrontino Meneghello e Consolo: le operazioni fatte sono diverse ma analoghe. Entrambi scavano nella propria lingua. Meneghello in quella parlata e non scritta del paese natale, nell’ambito storicamente ristretto alla propria esperienza biografica infantile e giovanile a Malo, nei due decenni degli anni ’20- ’40 del Novecento. Consolo, dal canto suo, scava storicamente e socialmente in un contesto storico millenario, secolare per: a) restituire la ricchezza linguistica del passato altrimenti destinata all’oblio; b) per rapportarsi sempre, metaforicamente, al presente. Meneghello: lingua della propria memoria biografica; Consolo: lingua della memoria storica collettiva. Ma la spinta etica a cercare di raccogliere nella loro lingua di espressione quanto di essenziale, di universale sia possibile reperire e tale da travalicare le proprie esperienze individuali è quello che li accomuna nel loro essere due ‘classici’ fuori dal coro. 19 Cfr. Ludwig Wittgenstein, ‘Lecture on Ethics: 1929- 1930’, ora in Ludwig Wittgenstein’s Lecture on Ethics. Introduction, Interpretation and Complete Text, a cura di Valentina Di Lascio, David Levy, Edoardo Zamuner (Macerata: Quodlibet, 2007), p. 42. 20 Sulle lingue di Meneghello, si vedano i lavori di Giulio Lepschy: ‘“dove si parla una lingua che non si scrive”’, in Su/Per Meneghello, a cura di Giulio Lepschy (Milano: Edizioni di Comunità, 1983), pp. 49- 60; ‘Le parole di Mino. Note sul lessico di Libera nos a malo’, in Luigi Meneghello, Il tremaio. Note sull’interazione tra lingua e dialetto nelle scritture letterarie (Bergamo: Lubrina Editore, 1987), pp. 75- 93. 21 Lepschy, ‘“dove si parla una lingua che non si scrive”’, p. 49 e p. 50. 22 Cfr. Giulio Lepschy, ‘In che lingua?’, in Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, pp. 15-22; ‘Introduzione’, pp.xliii-lxxxiv. 23 Lepschy, ‘In che lingua?’, p. 22 24 Cesare Segre, La letteratura italiana del Novecento (Roma-Bari: Laterza, 2004), p. 92. 25 Vincenzo Consolo, ‘I muri d’Europa’, Estudos Italianos em Portugal, Nova Série, numero a cura di Giovanna Schepisi, 3 (2008), 229-236 (p. 233). 26 Il sorriso dell’ignoto marinaio (Milano: Oscar Mondadori, 2004), p. 114. 27 Cfr. quanto Meneghello dice a proposito di Leopardi nella nota 13. 28 Franco Fortini, Attraverso Pasolini (Torino: Einaudi, 1993), p. 67
The Italianist (2012)
Per Vincenzo Consolo
24 gennaio 2012 • pubblicato da minimaetmoralia
Fabio Stassi ci regala un ritratto appassionato dello scrittore Vincenzo Consolo, scomparso qualche giorno fa. L’appendice che segue sono gli appunti che Stassi ha conservato di un passato Salon du livre di Parigi, dove Consolo fu ospite e parlò della sua ricerca stilistica e della sua poetica.
di Fabio Stassi
Ho conosciuto Vincenzo Consolo nella biblioteca di Storia contemporanea della Sapienza di Roma. Era un giorno di maggio del 1995. L’avevamo invitato a parlare delle biblioteche frequentate nella memoria e nel sogno. A quell’incontro con gli studenti avrebbe partecipato anche José Saramago, se il dipartimento non lo avesse ritenuto un personaggio ancora non “di chiara fama”. Consolo intervenne dopo l’inconfondibile barba bianca a due punte di Vittorio Emanuele Giuntella, uno studioso a cui volevo bene e che mi aveva insegnato tutto quello che so sull’età dell’illuminismo. Giuntella aveva scelto di raccontare le biblioteche dei lager nei quali era stato internato, e lo fece in maniera toccante. Consolo parlò invece dei libri della sua infanzia, della biblioteca di Lucio Piccolo, della scoperta della stella polare della letteratura. La sua voce era mite ma affabulatrice, capace di esprimere con la stessa forza sia la nostalgia che l’indignazione.
Fu uno dei primi scrittori che vedevo in carne e ossa, avevo letto tutti i suoi libri e lo consideravo l’ultimo esponente della tradizione del romanzo siciliano post-unitario[1]. Leonardo Sciascia era morto da qualche anno e con Gesualdo Bufalino ci avevo parlato solo per telefono (il Grande Sedentario non usciva mai dalla Sicilia: ci saremmo scritti, ma non l’avrei conosciuto perché rimandai troppo a lungo un viaggio a Comiso). Restava solo lui. Quella sera scegliemmo un piccolo ristorante, in centro, dove poter conversare in pace. E per me fu come andare a cena con la lezione umanizzata di Verga, De Roberto, Pirandello e Borgese, più la luce luttuosa di Brancati, più gli astratti furori di Vittorini e di Sciascia e l’eleganza formale di Tomasi e di Bufalino declinati tutti insieme in un espressionismo dolente. Prendemmo un gelato dietro al Pantheon. Ricordo che Consolo si arrabbiò per come cambiava la letteratura, per la sua spettacolarizzazione, e anche per l’incomprensibile sciatteria delle nostre canzoni e della musica commerciale.
Sull’esempio di chi lo aveva preceduto, il suo lavoro portava avanti quella coerente e quasi cromosomica riflessione sui fatti italiani che gli scrittori siciliani hanno sempre condotto, dalla delusione del Risorgimento e dell’unificazione sino all’omicidio dei giudici Falcone e Borsellino. Una riflessione che tra vicerè, vecchi e giovani, gattopardi, esercizi spirituali e olivastri selvatici suona come un recitativo all’inverso, una implacabile chiosa ai secolari malanni e guasti della nazione. La dominante è una dissonanza cronica: un cosmico e sgomentato discredito della storia. L’eccentrico barone Enrico Pirajno di Mandralisca, catalogatore di molluschi e collezionista d’arte, protagonista de Il sorriso di un ignoto marinaio (Einaudi, 1976), si chiede allo stesso modo dell’abate Vella del Consiglio d’Egitto di Sciascia[2]: “Cosa è stata sin qui la Storia, egregio amico?” La risposta è esemplare e definitiva: “Una scrittura continua di privilegiati.” Per lui il mondo aveva la forma di una chiocciola o di una lumaca: una spirale di ingiustizie e di soprusi, il ripetersi di una stessa mancata speranza.
Si potrebbe dire che il tema privilegiato della narrazione romanzesca, per Consolo come per Bufalino o per Sciascia, è “il tempo febbrile delle pesti”[3]. È lo stesso “mal contagioso” di cui scrive Manzoni, “il seme della peste”[4]. I personaggi che ne faranno esperienza, sono cronisti di epoche tristi e inferme, contemporanei di pestilenze ed esili che lasciano cambiati, per quanti oblii li seguiranno. È il “colera di Palermo”, la pandemia della mafia e quella nera del rimorso e del tragico senso di fallimento di una generazione che non ha saputo costruire dopo la guerra un’Italia civile e si ritrova ora a vivere in un paese franato, tra città stravolte, dove si cancellano memorie e nelle quali esala “un odore dolciastro di sangue e gelsomino”[5]. Segno che l’infezione, ancora, non è passata né che se ne potrà guarire.
Se Bufalino lavorò per decenni alla sua Diceria dell’untore, Consolo intitolò uno dei suoi ultimi libri con il nome dell’antico lazzaretto della città: Lo Spasimo di Palermo. Dalla valle “fetida, infetta” della Conca d’Oro, da questa Palermo immersa in “un sudario molle”, cielo lattiginoso e “mare d’un verdastro torbido”, e “fumi grassi” che s’alzano dalle spiagge, si può risalire fino alla Somalia del sergente di Ennio Flaiano in Tempo di uccidere o all’Algeria di Camus del dottor Bernard Rieux, che aveva proprio l’aria di un contadino siciliano. Lungo questa mappa delle metafore o cosmologia della peste, tutto ritorna all’uomo: la pena, e la rivolta, e il dovere della responsabilità e del bilancio.
Sarà un terremotato di Gibellina, emigrato nelle cave di Meirengen, vicino Basilea, a resocontare in L’olivo e l’olivastro il ritorno nell’isola odiosamata[6] ricoperta ora di gelsomini neri, un sudario di calce al posto del ricordo, una terra di massacro e una terra massacrata, dove di ciclopico è rimasta solo la demenza. Il suo viaggio, speculare a quello del Silvestro di Vittorini[7], è un dialogo con uomini e luoghi trapassati, con l’ansia divorante delle madri, un inoltrarsi nella rovina, un chiedersi cos’è successo, un sapere che si è destinati a ripartire… è l’ultimo mascheramento di Ulisse. Perché più vado avanti e più mi rendo conto che tutto quanto c’era da dire, scriverà in un altro piccolo libro Vincenzo Consolo, era già stato detto da Omero e dopo non si è fatto altro che ripetere: “l’Odissea è matrice di ogni racconto”[8].
Per qualche anno ci scambiammo solo dei biglietti, di tanto in tanto. Perché lo incontrassi nuovamente, il caso scelse un’occasione privilegiata: il cielo grigio di Parigi e il Salon du livre del 2001. Io ci partecipavo come bibliotecario: quell’anno l’Italia era il paese omaggiato. All’ingresso avevano esposto trentacinque enormi ritratti. In uno di questi, Vincenzo Consolo teneva in mano una lente d’ingrandimento che gli dilatava l’occhio e lo sguardo mentre Rigoni Stern camminava su un sentiero innevato di Asiago. Lessi che teneva una conferenza alla sala Victor Hugo: Une heure avec Vincenzo Consolo. Mi precipitai. La sala era accanto al Padiglione Italia. Una sala gialla, affollata. Dai vetri si vedeva la gente che passava. Entrai mentre un attore stava leggendo un brano di un suo libro. Presi posto e aprii il mio quaderno per gli appunti. Soltanto dopo un po’ mi accorsi che mi ero seduto accanto a Daniel Pennac.
La conferenza di Consolo fu ipnotica. Parlò di molte cose, della letteratura come metafora, delle sue scelte stilistiche, del Sud, di Omero, di Verga e del proverbio siciliano cu nesce arrinesce: chi esce, chi va via, riesce. Alla fine, Daniel Pennac si avvicinò al mio orecchio e mi disse sottovoce, con un gran sorriso entusiasta, che per lui Consolo era semplicemente magnifique. Ci alzammo e andammo ad abbracciarlo insieme.
Nel 2007 lo ritrovai a Siracusa, al Premio Vittorini. Era il presidente di giuria e furono le sue mani a benedire il mio primo romanzo. Ma l’ultima volta che l’ho visto fu a una serata tributo per Pino Veneziano, l’artista siciliano che un giorno dell’84 aveva cantato anche per Borges, commuovendolo. Consolo aveva firmato un appello per Selinunte e l’introduzione a un libretto dal titolo Di questa terra facciamone un giardino[9]. Prese la parola e tracciò un breve elogio della cultura orale. Me lo ricordo così, sotto la luce gialla che illuminava le colonne del tempio, piccolo e incanutito ma con gli occhi che non avevano mai smesso d’essere vivaci, un vecchio cantastorie in piedi tra i ruderi di un’acropoli.
APPENDICE
Un clandestino a Parigi : une journée avec Vincenzo Consolo
(dai miei appunti, Parigi, Salon du livre, 24 marzo 2001)
Sala Victor Hugo, ore 12
La letteratura è metafora. Nostalgia di un tempo e di una patria perduta, desiderio dei personaggi di tornare a un’Itaca che non esiste più. È la nostra condizione. Siamo degli ulissidi che anelano a raggiungere la patria perduta. La memoria di una patria. Io ho sempre avvertito nel mio lavoro di scrittore una discrepanza tra argomento e stile. Sin da quando iniziai a scrivere, nel 1963, capii che dovevo fare una scelta di campo dal punto di vista linguistico e stilistico. Non c’è innocenza in arte, bisogna avere consapevolezza di quello che si sta svolgendo. Io sapevo che gli scrittori della generazione appena precedente alla mia, avevano adottato un registro comunicativo, un codice linguistico comunicativo. Moravia, Calvino, Morante, Sciascia. Io penso che speravano che dopo la fine del fascismo sarebbe potuta nascere in Italia una società civile con la quale comunicare. E questa loro speranza risaliva all’utopia linguistica di Manzoni.
Ma quando cominciai a scrivere io, questa società non si era formata, non esisteva per me. Per questo ho adottato un codice non comunicativo, ma espressivo. Con questa scelta stilistica mi inserivo in una tradizione italiana che partiva da un mio conterraneo, Giovanni Verga. Lui aveva rivoluzionato il codice linguistico manzoniano. Sulla sua linea lo avevano seguito Gadda e Pasolini.
Avevano creato un controcodice espressivo.
In questo sono stato favorito dalla ricchezza della lingua della mia terra, da quel giacimento linguistico che con molta faciloneria viene chiamato dialetto. Nel siciliano sono presenti residui della lingua greca, araba, francese, spagnola e delle altre civiltà transitate dalla mia isola. Io ho utilizzato questo serbatoio, questi residui, per rompere il codice linguistico nazionale, organizzando la prosa in modo ritmico, lirico, più simile alla poesia. Per me non esisteva un rapporto tra testo letterario e contesto storico, situazionale, ma una rottura. L’esempio più efficace lo dà la tragedia greca. Il messaggero appare sulla scena e riferisce quello che è avvenuto in altro tempo e in altro luogo. Solo dopo che lui racconta i personaggi si muovono e il coro commenta. Così, attraverso il rito del teatro, si ottiene la liberazione dalla colpa, la catarsi. Il messaggero, l’anghelos, è lo scrittore. Appare e dice di una vicenda, e cerca di far immedesimare personaggio e lettore. Ma oggi la cavea è vuota. Non c’è più il pubblico. L’unica possibilità è quella di spostare la narrazione sul commento della tragedia che ci riguarda tutti.
Nei miei libri, in tutti i miei libri, ci sono queste parti corali, che i latini chiamavano cantica. Si interrompe il racconto e si alza il ritmo, attraverso l’uso insistito delle assonanze e delle rime. Come dice Bachtin, il romanzo è sempre utopico perché ipotizza un mondo migliore.
Questa è stata la mia ricerca stilistica, una ricerca archeologica e filologica. Noi non abbiamo la fortuna di voi francesi. Leopardi, in un’analisi delle due lingue cugine, l’italiano e il francese, dice che il francese, attraverso la creazione di uno stato e la sua storia unitaria, si è “geometrizzato”. L’italiano, invece, non è una sola lingua, ma tante lingue. Questa è la nostra risorsa ma anche la nostra dannazione, da Dante in poi.
La letteratura, per me, è soprattutto una memoria linguistica. Ho ricercato le radici e usato la tecnica dell’innesto. Ma non ci si deve confondere. Trovo ingiustificato e regressivo l’inserimento dell’elemento dialettale. Come ha scritto Pasolini, Verga usava un italiano irradiato di dialettalità, ma non era un dialetto, era un’altra lingua. Una lingua nuova.
Considero la ricerca stilistica un impegno nei confronti della storia. Capisco che i miei testi non sono di facile lettura. Ma c’è in me un’esigenza di praticare una “letteratura d’intervento” (così l’ha definita Roland Barthes) anche sui giornali. Sento il bisogno di esprimere il mio giudizio sulla situazione politica del mio paese, ma anche su quella internazionale. Domani, insieme ad altri scrittori che fanno parte del Parlamento internazionale degli scrittori, tra cui José Saramago, parto per Tel Aviv e per Ramallah, per portare un appello per la pace. In Francia, l’esempio dello scrittore militante è quello di Zola, che pur pagando di persona alla fine riuscì a far riaprire il processo Dreyfuss. Oggi, in Italia, c’è un ministro della cultura che accusa gli intellettuali di vigliaccheria. Di fronte a tanta volgarità non vale nemmeno la pena di rispondere. Voglio aggiungere che non volevo alcuna ipoteca da parte del governo italiano sulla mia partecipazione a questo Salone del libro. Dopo le nostre dichiarazioni, io, Camilleri e Tabucchi siamo stati cancellati dal catalogo. Non troverete né la nostra foto né la nostra biografia. Per il mio governo, qui sono un clandestino.
Sala Dante Alighieri, pomeriggio. Vincenzo Consolo discute insieme a Erri De Luca, Giuseppe Bonaviri e Raffaele La Capria. Qualcuno gli chiede perché ha lasciato la Sicilia…
Appartengo alla storia infinita di meridionali che hanno abbandonato questa estremità, questo limite, per raggiungere il centro. Alcuni vennero in Francia, nel vagheggiamento di un nord mitico. Il primo è stato Verga. Approda a Firenze, poi a Milano, nella Milano dei salotti e delle contesse. Trova invece un mondo in grande subbuglio. In quegli anni si avvia la Pirelli. Lui rimane spiazzato. E qui si toglie la maschera di scrittore borghese e compie una rivoluzione stilistica. Dopo di lui, a Milano ci piovono Vittorini e Quasimodo. Io ci ho studiato, poi sono tornato in Sicilia. Ho insegnato nelle scuole agrarie. Ma presto mi sono reso conto che la mia presenza nell’isola era un’assurdità. Il mondo che volevo descrivere, il mondo contadino, si stava frantumando. Era in atto un esodo di braccianti che partivano per il nord e diventavano operai. Si pensava ancora che Milano fosse diversa e opposta alla realtà siciliana. Questa mitologia era stata alimentata da Vittorini. Lì ho lavorato in quella che definisco una fabbrica di armi, ossia la televisione, la Rai. Progressivamente il mito di Milano mi si è infranto, stagione dopo stagione, prima con gli anni di piombo, poi col riflusso craxiano, infine con l’era di Berlusconi. Questa è la mia storia.
La sala è strapiena. Gente in piedi, gente seduta per terra. L’affluenza è davvero impressionante. Sembra quella di un concerto. De Luca e La Capria relazionano in francese. Consolo riprende il microfono per spiegare che per la sua isola i Vespri siciliani sono stati una sciagura, al contrario di quanto ha creduto Croce. Perché i francesi se ne sono andati a Napoli, “e oggi i relatori napoletani lo parlano correttamente, mentre da noi sono arrivati gli spagnoli e l’Inquisizione, ma i siciliani non hanno imparato nemmeno lo spagnolo”. Suscita l’ilarità della sala. Poi pacatamente riprende il suo discorso sul recupero di una memoria linguistica, della memoria di un sud più profondo.
Il canale di Sicilia era un canale di grande comunicazione. I pescatori trapanesi andavano a pescare nelle acque del Mahgreb. Poi, con l’inizio dell’età dei conflitti, il Mediterraneo divenne un confine, un luogo di miserie e di atrocità, come ha spiegato Braudel, un mercato di schiavi, il centro di guerre economiche mascherate da guerre di religione. Oggi, purtroppo, assistiamo al ritorno di questi massacri. Ma non bisogna dimenticare che la storia delle civiltà è sempre una storia di incroci e di migrazioni e anche voi francesi ne sapete qualcosa.
L’intensa giornata di Vincenzo Consolo termina la sera, allo stand di France culture. Attorniati dai microfoni e dai giornalisti della radio francese, siedono allo stesso tavolo i membri del Parlament International des Escrivains. Vicino a Consolo riconosco i premi nobel per la letteratura Wole Soynka e José Saramago. Soynka è un po’ invecchiato, con una montagna di capelli bianchi sulla testa. Saramago elegante e autorevole, come sempre. Accanto a loro siedono il sudafricano Breyten Breytenbach, il cinese Bei Dao, Juan Goytisolo per la Spagna e Russel Banks per gli Usa. Con voce ferma e sicura, insieme consegnano a Parigi e al mondo il loro messaggio di pace.
[1] Un sommario elenco delle opere che hanno edificato questa linea siciliana del nostro romanzo comprende: I malavoglia (1881) e la novella Libertà (1882) di Verga, I vicerè (1894) di De Roberto, I vecchi e i giovani (1913) di Pirandello, Rubè (1921) di Borgese, Il gattopardo (1958) di Tomasi, Il Consiglio d’Egitto (1963) e il racconto Il quarantotto (Gli zii di Sicilia, 1958) di Sciascia. Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976) di Consolo è l’estremo tassello di questa antistoria del Risorgimento, un discorso che si protrae da oltre un secolo. Ma, estendendo la riflessione al fascismo, al dopoguerra e al cinquantennio democristiano, bisogna annotare almeno Conversazione in Sicilia (1941) di Vittorini, Il bell’Antonio (1949) di Brancati, Il contesto (1971) e Todo Modo (1974) di Sciascia, Diceria dell’untore (1981) di Bufalino, L’olivo e l’olivastro (1994) e Lo spasimo di Palermo (1998) di Consolo, a cui ora si possono aggiungere le opere e i nomi di Andrea Camilleri, di Giosué Calaciura e di Giorgio Vasta.
[2] L’abate Vella sosteneva “che il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un’impostura: e che c’era più merito ad inventarla, la storia, che a trascriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva più lavoro, ad inventarla: e dunque, onestamente, la loro fatica meritava più ingente compenso che quella di uno storico vero e proprio, di uno storiografo che godeva di qualifica, di stipendio, di prebende. «Tutta un’impostura. La storia non esiste. Forse che esistono le generazioni di foglie che sono andate via da quell’albero, un autunno appresso all’altro? Esiste l’albero, esistono le sue foglie nuove: poi anche queste foglie se ne andranno; e a un certo punto se ne andrà anche l’albero: in fumo, in cenere. La storia delle foglie, la storia dell’albero. Fesserie! Se ogni foglia scrivesse la sua storia, se quest’albero scrivesse la sua, allora diremmo: eh, sì, la storia… Vostro nonno ha scritto la sua storia? E vostro padre? E il mio? E i nostri avoli e trisavoli?… Sono discesi a marcire nella terra né più né meno che come foglie, senza lasciare storia… C’è ancora l’albero, sì, ci siamo noi come foglie nuove… E ce ne andremo anche noi… L’albero che resterà, se resterà, può anch’essere segato ramo a ramo: i re, i viceré, i papi, i capitani; i grandi, insomma… Facciamone un po’ di fuoco, un po’ di fumo: ad illudere i popoli, le nazioni, l’umanità vivente…. La storia. E mio padre? E vostro padre? E il gorgoglio delle loro viscere vuote? E la voce alta della loro fame? Credete che si sentirà nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà orecchio talmente fino da sentirlo?»” in L. Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, Milano, Adelphi, 1989, p. 59-60.
[3] V. Consolo, Lo Spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, 1998, p. 113.
[4] Così suona, in francese, il titolo della Diceria dell’untore.
[5] V. Consolo, Lo Spasimo di Palermo, cit., p. 115.
[6] Consolo aveva già individuato in un piccolo paese nell’entroterra della Sicilia, Caltagirone, l’epicentro di una epidemia e l’emblema di una nazione, “della vecchia Italia che ha generato dopo i disastri del fascismo, nei cinquant’anni di potere, il regime democristiano, la trista, alienata, feroce nuova Italia del massacro della memoria, dell’identità, della decenza e della civiltà, l’Italia corrotta, imbarbarita, del saccheggio, delle speculazioni, della mafia, delle stragi, della droga, delle macchine, del calcio, della televisione e delle lotterie, del chiasso e dei veleni. Il plastico dell’Italia che creerà altri orrori, altre mostruosità, altre ciclopiche demenze.” (L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori, 1994, p. 71).
In un altro libro di Gesualdo Bufalino, il Guerrin Meschino, il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 cala addirittura il sipario, si chiude per lutto. L’Oprante, il puparo si ferma, smonta il teatrino, ripone con cura i legni e, alla fine, rompe la noce del collo al più derelitto degli eroi, al desdichado di cui stava raccontando le avventure: è un tempo, ormai, dove nemmeno per finta, nemmeno per gioco, “il buono vive e il maganzese muore”.
[7] Silvetro Ferrauto è il protagonista di Conversazione in Sicilia.
[8] Vincenzo Consolo e Mario Nicolao, Il viaggio di Odisseo, introduzione di Maria Corti, Milano, Bompiani, 1999.
[9] Di questa terra facciamone un giardino. Tributo a Pino Veneziano, con CD audio, a cura di Rocco Pollina e Umberto Leone, Trapani, Coppola editore, 2009.
“AMOR SACRO”CRONACA DI UN ROMANZO MAI NATO
di Sergio Buonadonna
Dopo dieci anni di silenzio Vincenzo Consolo torna al romanzo. Considerato l’erede di Vittorini e Sciascia, ma dai più accostato a Gadda per la sua scrittura espressiva, il grande narratore siciliano (78 anni, più di quaranta vissuti a Milano, “il luogo dell’emigrazione come fu per Verga”) si ripropone con una metafora storico-sociale e una scrittura palinsestica (cioè scrittura su altre scritture) come nella sua famosa trilogia: “Il sorriso dell’ignoto marinaio” tema il Risorgimento, “Nottetempo casa per casa” (il fascismo), “Lo Spasimo di Palermo” (la contemporaneità fino alle stragi Falcone e Borsellino). Al grande ritorno sta accudendo da anni, ne è segno la fitta libreria d’epoca accumulata accanto al suo tavolo da lavoro che domina l’ampio studio carico di volumi, quadri e disegni tra cui quelli a lui carissimi di Guttuso e Pasolini. Racconta Consolo: “Il titolo di questo romanzo storico, lo dico con molto pudore, è Amor Sacro, è un processo d’Inquisizione di cui ho trovato i documenti all’Archivio di Madrid: una storia che si svolge in Sicilia. La vicenda riguarda un monaco e quindi Amor sacro direi che è appropriato. Ma non voglio aggiungere altro ché sarebbe impudico. Il secolo è la fine del Seicento, tempo, luogo e stagione di furori e misteri. Tuttavia non dico come Arbasino: sapesse signora mia la mia vita è un romanzo. I miei libri sono sempre storico-metaforici. Spero”. Si parla del passato per dire del presente? “Sans doute, come dicono i francesi. Senza dubbio”. Sicché – pubblicato questo libro tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 – dovremmo vedere finalmente il Meridiano che raccoglierà la tua opera?“ Tutta l’opera completa, questo è l’accordo con Mondadori anche se devo chiarire che ho atteso a lungo perché il mio contratto iniziale era con Arnoldo Mondadori. Berlusconi è arrivato dopo e come si sa io non ho molto piacere di lavorare per il cavaliere. Ma rispetterò i patti. Nel Meridiano ci saranno anche i miei scritti giovanili. Giorni fa è venuto a trovarmi un professore dell’Università di Gerona, bravissimo, che sta curando tutti i miei racconti. Il primo risale al 1952”.È giusto definire un tuo libro romanzo o narrazione? Ne “Lo Spasimo di Palermo” appare infatti il tuo manifesto letterario quando avverti: ‘il romanzo è un genere scaduto, corrotto, impraticabile…’“Quando negli anni Sessanta ho cominciato a scrivere il mio primo libro, ho visto cos’era accaduto nel nostro Paese soprattutto dal punto di vista linguistico, ma anche in campo letterario, politico, civile. C’era stata una forte mutazione, l’esodo dei contadini del sud, la ricerca di una lingua altra che non fosse quell’italiano che – come dice Leopardi – aveva l’infinito in sé. La lingua italiana l’aveva perso, s’era orizzontalizzata perciò il mio scrupolo è stato reperire dei preziosi giacimenti linguistici che ci sono in Sicilia, dove sono passate tante civilizzazioni, recuperare vocaboli immettendoli nel codice italiano. In Sicilia questi giacimenti linguistici significano greco, latino, spagnolo, arabo, tante parole che riportavo in superficie. Un giorno un dialettologo dell’Università di Catania mi chiese dove hai preso la parola “calasía” perché nei vocabolari siciliani non c’è? Gli risposi: viene dal greco kalós che vuol dire bello. Nella mia zona tra le province di Messina e Palermo, che è greco-bizantina si dice che calasía, che bellezza”. Insisto. Che cosa distingue il romanzo dalla narrazione? “È la distinzione che fa Walter Benjamin. Nella tragedia greca c’era l’anghelos, il messaggero che arrivava in scena, si rivolgeva al pubblico della cavea e narrava quello che era successo altrove in un altro momento. Oggi io dico che la cavea è vuota, non ci sono più i lettori. Quindi non sai a chi rivolgerti e perciò l’anghelos non appare in scena. Sono i lettori che scelgono l’autore”. Tu in Sicilia avevi scelto Lucio Piccolo e Sciascia. Come si collocano nella tua formazione? “Per me Piccolo e Sciascia erano due riferimenti fondamentali. Quando ho pubblicato “La ferita dell’aprile” l’ho mandato con una missiva a Leonardo Sciascia e lui mi ha risposto con una bellissima lettera invitandomi ad andarlo a trovare a Caltanissetta. È nato un rapporto di amicizia, quando ci incontravamo le nostre conversazioni sulla Sicilia erano davvero intense e avvincenti. Dall’altra parte c’era Lucio Piccolo, che era di Capo d’Orlando, stava nella villa in campagna con il fratello Casimiro, un esoterico, e la sorella Giovanna una botanica, Lucio poeta era cugino di Tomasi di Lampedusa col quale aveva un antagonismo incredibile. Quando andavo da Piccolo lui mi diceva salutami il caro Sciascia e quando andavo da Sciascia, Leonardo mi diceva salutami Piccolo. Poi ho fatto in modo di farli incontrare. Piccolo, che stava quasi sempre chiuso nella sua magione, quando arrivavano ospiti dava il meglio di sé. Era di una cultura infinita. Anni dopo Sciascia dichiarò che i due personaggi che più l’avevano colpito nella sua vita erano stati Borges e Lucio Piccolo. Poi è esploso il fenomeno del Gattopardo. In un’altra circostanza ho saputo che in un alberghetto di campagna vicino al mio paese c’era Salvatore Quasimodo con un’amica che presentava come figlia, sono andato a scovarlo e ho fatto in modo di accompagnarlo per fargli conoscere Lucio Piccolo, ma siccome questi era stato scoperto da Montale, acerrimo nemico di Quasimodo, allora il Nobel, uscendo dalla villa, mi fa: questo piccolo poeta”. Al nord stringi invece intensi rapporti con Pasolini e Calvino. Che cosa succede nella cultura italiana perché oggi sia così difficile trovare dei riferimenti che segnano veramente il tempo e la cultura? “Non voglio essere profeta di sventure ma credo che la letteratura italiana ormai sia al grado zero. Mi arrivano parecchi libri di esordienti. Leggo le prime pagine e rimango allibito dalla banalità della scrittura, delle storie, tutti che guardano il proprio ombelico, la propria infanzia, il papino, la mammina, le vicende personali, familiari, sessuali, non c’è uno sguardo nella storia nostra. La società è assente e ci si chiede ma ‘sta letteratura dov’è andata a finire? Negli anni Sessanta, dopo un’infelice esperienza alla Rai, che mi aveva cacciato perché mi ero rifiutato di mandare in onda un’autointervista su Cavour dell’allora direttore generale Italo De Feo (suocero di Emilio Fede), grazie a Calvino sono stato per più di dieci anni consulente della casa editrice Einaudi. Quando arrivavano i dattiloscritti, io dovevo essere il primo a leggerli, fare la relazione scritta e leggerla alla riunione del famoso mercoledì. Se io approvavo il libro, passava a Calvino. Quindi se lui l’approvava passava a Natalia Ginzburg per il giudizio conclusivo. Oggi basta andare alla televisione a sculettare o a fare il cantante, si scrive il romanzo e subito diventa best-seller. Questa è la letteratura italiana attuale”. La letteratura può far paura perché non è dominabile? “Senz’altro. La letteratura vera non è dominabile, se poi invece aspetti l’applauso e il successo sei dominabilissimo. Fai la volontà del padrone”. La Sicilia è sempre il cuore delle tue storie anche quando racconti il male di vivere, in certo modo l’inutilità di stare in Sicilia. “Diceva Verga che non ci si può mai allontanare dai luoghi della propria memoria. Lui l’ha fatto per parecchio tempo, i cosiddetti romanzi mondani quand’era a Milano, poi c’è stata la famosa conversione quando comincia il ciclo del verismo, ma anche Pirandello ha scritto che noi siamo i primi anni della nostra vita, cioè che quei segni sono incancellabili”. La distanza ti ha consentito una messa a fuoco migliore della realtà siciliana?“ Anche questo diceva Verga, e Capuana scriveva che la lontananza serviva a vedere più obiettivamente il luogo in cui si era nati e vissuti, il luogo della memoria”. E l’infinito presente del nostro tempo che cosa ci sta rubando? “Sia la memoria del passato che la visione di quel che può essere l’immediato futuro. Viviamo in questo infinito presente”. 
Giuseppe Tornatore fotografo Vincenzo Consolo
*
Bisogna subito dire di Bagheria, paese dove è nato e cresciuto Giuseppe Tornatore, questo regista della seconda generazione dei grandi registi italiani del secondo dopoguerra. Dire di Bagheria e di Giuseppe Tornatore fotografo, della sua fotografia come telemachia, prima educazione artistica, primo passo verso il mondo delle immagini, verso il cinema.
Bagheria, singolare paese, rispetto agli altri paesi di Sicilia per il motivo e per il modo in cui esso è nato, si è formato. “Bagheria – latino, Bayharia – Siciliano, Baaria (Val di Mazara). Estesissima ed amena campagna, ad oriente del territorio di Palermo, adorna all’ultima eleganza di casine suburbane di signori; lungo sarebbe descriverle, dirò tuttavia delle primarie. E prima occorre l’amplissima villa del principe Butera (…) Sovrastà ad una altura, a mezzogiorno di quella terra, al villa Valguarnera, dove nulla desideri che tenda alla delizia dell’animo; magnifica altresì quella di Aragona né quella di Cattolica, Filingeri, Palagonìa, Lardaria, sottostanno per fabbriche, ornamenti e disegno; sono palazzi degni tutti di grande città”. Così scrive Vito Amico nel suo Lexicon Siculum (1757), tradotto dal latino e postillato da Gioacchino di Marzo (Dizionario Topografico della Sicilia, 1858). E partiamo dunque dal primo che fece costruire la sua villa in quella “estesissima e amena campagna”, il principe Butera. Un emistichio del Tasso, O corte a dio, e una quartina in lingua spagnola faceva incidere sul primo e sul secondo arco di ingresso alla sua villa a Bagheria don Giuseppe Branciforti, conte di Mazzarino e principe di Butera. A capo di una congiura contro il re di Spagna, Filippo IV, e contro i viceré di Sicilia, don Giovanni d’Austria, l’eroe di Lepanto, nel sogno di divenire re di una Sicilia indipendente, tradito e traditore – la sua delazione, insieme a quella del poeta Simone Rao, costò la vita a sei congiurati – il Butera si ritirò in quel sobborgo di Palermo, tra la fenicia Soluto e la greca Imera, si chiuse dentro quella sua dimora che era fortezza, castello, tomba non di libri e di salme come l’Escorial, ma di orgoglio umiliato e di rimorso.
Ya la esperanza es perdita
Y un solo ben me consuela
Que el tempo que pasa y buela
Lleverà presto al vida.
Congiuravano contro il re di Spagna, i nobili di Sicilia, ma frequentavano i poeti spagnoli. Epigrafava la sua villa, il principe di Butera, con versi tratti dalla Galatea di Miguel de Cervantes. Dopo il Butera, come ci dice l’Amico, costruirono ville nell’amena plaga molti altri nobili, tra di loro in gara di delizia, di sfarzo, fino al rovesciamento nel delirio del barocco, nell’allucinazione pietrificata, nel capriccio goyesco della villa dei Mostri del principe Palagonìa, da cui Goethe, in cerca in Sicilia di una Ellade di luce e d’armonia, si sarebbe allontanato inorridito. Scrive nel suo Viaggio in Italia: “Palermo, lunedì 9 aprile 1787. Abbiamo sciupato tutta la giornata d’oggi dietro le pazzie del principe di Palagonia. (…) Quando il padre del principe attuale costruì la villa, (…) ha concesso libero sfogo al suo capriccio e alla predilezione per il deforme e per il mostruoso”. Certo, per un Goethe che viaggiavo in Sicilia con il metro di Winckelmann in tasca, quella villa Palagonìa non poteva che suscitargli orrore.Le ville di Bagheria. “Di ville, di ville!…di principesche ville” avrebbe esclamato con ironia Gonzalo – Carlo Emilio Gadda, riferendosi a quelle di Lukones, vale a dire della Brianza, ne La cognizione de dolore. Le ville di Bagheria non le hanno certo costruite con le loro mani i nobili, i Gattopardi di Sicilia, il loro progetto villesco, nella loro gara di sfarzo, di lusso, oltre agli architetti, ha attirato là, da Palermo e da altre zone della Sicilia, masse di murifabbri, scalpellini, falegnami, manovali e artigiani, oltre a braccianti, a contadini, per lavorare negli estesi giardini. Gli abitanti di Bagheria, abitanti al di qua delle ville cinte di gran mura come fortezze, erano, ci dice il Di Marzo, nel 1852 quasi diecimila. E oggi sono più di quarantamila. Al di qua delle alte mura delle ville i cui padroni, i famosi “leoni e i gattopardi” lampedusiani sono per la maggior parte tramontati, finiti per isolamento, dissennatezza o alienazione, al di qua sono nati e cresciuti a Bagheria, tra quello che si chiamava il popolo, gli spiriti più acuti, più intelligenti, gli artisti e gli intellettuali più dotati. Facciamo per tutti tre nomi: il poeta Ignazio Buttitta, il pittore Renato Guttuso e il fotografo-regista Giuseppe Tornatore. E qui vogliamo dire, dell’autore di famosi films, come Nuovo Cinema Paradiso, Stanno tutti bene, L’uomo delle stelle, La sconosciuta, e altri, e, in fase di produzione, l’ancora inedito Baarìa, di cui qui compaiono immagini delle riprese. La Baaria funestata oggi da quella mala pianta che si chiama mafia, da quelle “iene e sciacalletti” che sono subentrati ai principi e ai baroni delle famose ville. Giuseppe, anzi Peppuccio Tornatore, muove dunque i primi passi per le strade di Bagheria con una macchina fotografica in mano. La Sibilai, le città e i paesi siciliani, per la loro profondità storica, sono stati da sempre interessanti e “urgenti” per i viaggiatori stranieri, per gli incisori prima, incisori come Houel e Saint-Non, e quindi, con l’avvento della fotografia, è divenuta interessante e “urgente” per fotografi stranieri e per gli stessi siciliani. Ai primordi, verso la fine dell’Ottocento, vale a dire, otografano la Sicilia l’inglese Samuel Butler, l’eccentrico autore de L’autrice dell’Odissea, la grande triade quindi dei veristi siciliani, Capuana, Verga, De Roberto, che nella fotografia vedevano confermate le loro tesi letterarie. E ancora i fratelli Alinari, Giacomo Brogi, l’esteta von Gloeden, Giorgio Sommer. Robert Capa, poi, sbarcato nel ’43 con gli Americani in Sicilia, fotografò la Sicilia di quel momento della Liberazione. Vi fu poi la scuola di fotografi palermitani, da Interguglielmi a Giusto e Nicola Scafidi a Enzo Sellerio, a Ferdinando Scianna, a Melo Minnella. A questa scuola e a questa tradizione ha appartenuto il giovane fotografo Peppuccio Tornatore. Scrive Tornatore nel libro Giuseppe Tornatore fotografo in Siberia: “Dopo mesi e mesi vissuti in moviola, al buio, gli occhi eternamente puntati a vedere, rivedere…Ero in questo limbo dell’immaginazione, mentre mi avviavo a concludere il montaggio di La leggenda del pianista sull’oceano, quando un bel giorno, inaspettatamente, la voce nordica e gentile di Alberto Meomartini giunge a insinuarsi come una nota stonata nel quotidiano coro telefonico: “So che da ragazzo lei è stato fotografo. Se la sentirebbe di tornare a fare fotografie?”. Il Meomartini lo invita dunque ad andare in Siberia con la sua Rolleicord. Sono quelle fotografie di una Siberia innevata, quasi desolata, una terra di Dostoevskij o Solzenicyn, ma sono anche foto di bimbi, di donne, di uomini di grande dignità. E poi, in giro per la Russia, Tornatore ha fotografato Mosca, e in giro per il mondo, la Cina, il Giappone, l’America, la Tunisia. Sono foto che in parte compaiono in questa mostra. Ma a chi qui scrive, da siciliano e sicilianista, senza nessuna ombra di regionalismo, interessa molto il fotografo che “da ragazzo” fotografava la Sicilia, fotografava la sua Baaria, Porticello, Palermo, Portella della Ginestra…Sono fotografie degli anni Sessanta-Settanta di una Baaria ancora povera, contadina, ancora non mutata antropologicamente, fuori ancora crediamo dalla contaminazione corleonese: una Baaria priva di ville, ma nobile, ricca di umanità.
Indiscrezioni
Giuseppe Tornatore fotografie
Edizioni Fratelli Alinari 2008
Giuseppe Tornatore e Vincenzo Consolo a Venezia
foto di Giovanni Giovannetti

Ma la luna, la luna… Vincenzo Consolo
Si apre lo Zibaldone di Leopardi con questi versi: “Era la luna nel cortile, un lato Tutto ne illuminava, e discendea Sopra il contiguo lato obliquo un raggio…”1 . E quindi, ancora nello Zibaldone (3 ottobre 1828) Leopardi riporta un brano del Voyage d’Orenbourg à Boukhara, fait en 1820 del barone de Meyendorff, il quale parla dei Kirkisi e dice: “Plusieurs d’entre eux passent la nuit assis sur une pierre à regarder la lune, et à improviser des paroles assez tristes sur des airs qui ne le sont pas moins”2 . Si sa che da questo brano di Meyendorff, dei Kirkisi che intonano tristi canti guardando la luna, prende spunto Leopardi, per scrivere il suo Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: “Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, Silenziosa luna?”3 . chiede il pastore errante, e si chiede: “Dico fra me pensando: A che tante facelle? Che fa l’aria infinita, e quel profondo Infinito seren? (…) (…) ed io che sono? Così meco ragiono…”4 .
1 LEOPARDI, G. (1970: 474): Canti con una scelta di prose, a cura di Francesco Flora [diciottesima edizione], Verona: Edizioni Scolastiche Mondadori. 2 Cfr. LEOPARDI, G. (1970: 281). 3 LEOPARDI, G. (1970: 281, vv. 1-2). 4 LEOPARDI, G. (1970: 288, vv. 85-90).
Ci sembra che questo pastore del deserto asiatico si faccia filosofo, che, sotto quel profondo infinito sereno, sotto quella luna venga posseduto dallo spirito socratico. Così come Euripide, ci dice Friedrich Nietzsche ne La nascita della tragedia, inaugura la tragedia moderna per l’irruzione nelle sue opere di quello stesso spirito socratico: vale a dire dello spegnersi del canto, del canto corale come in Eschilo e in Sofocle, e dello sgorgare del pensiero, del ragionamento, dell’assillante e paralizzante argomentazione. “Ed io che sono?” si chiede il pastore asiatico. “Io sono” afferma invece con energia un altro errante, il nomade della valle dell’Indo o del deserto egiziano che percorre il Maghreb, giunge in Spagna, in Sicilia, nel Napoletano. Diciamo del gitano posseduto dal lorchiano duende, il gitano che distoglie lo sguardo dalla luna, dal cielo, per appuntarlo sulla terra. Del gitano che ritrova la misura umana, la finita geografia della sua esistenza, e questa afferma, con forza: con il canto, il cante jondo, il movimento, la danza, canto e movimento come quelli dei coreuti della antica tragedia greca. Ma rivolgiamo ancora lo sguardo alla luna, alla luna dei poeti, di Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, rivolgiamo lo sguardo alla luna di Leopardi. Quasi tutti i Canti del poeta di Recanati sono illuminati dalla tenera luce dell’astro notturno, dell’ “eterna peregrina”, da La sera del dì di festa, a Alla luna, a La vita solitaria, a Il tramonto della luna. Dice in quest’ultima: “Dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno Nell’infinito seno Scende la luna; e si scolora il mondo…”5 . E in altri, in altri Canti ancora balugina la luna. E quando non è la luna, sono le “vaghe stelle dell’Orsa” o il “fiammeggiar delle stelle” sopra la desolata coltre di lava de La ginestra. Ma la luna, la leopardiana luna, si stacca dal cielo e cade sulla terra nell’idillio intitolato Spavento notturno o Il sogno. E così Alceta narra il suo sogno a Melisso:
5 LEOPARDI, G. (1970: 370, vv. 10-12).
“(…) Io me ne stava Alla finestra che risponde al prato, Guardando in alto: ed ecco all’improvviso Distaccasi la luna; e mi parea Che quanto nel cader s’approssimava, Tanto crescesse al guardo; infin che venne A dar di colpo in mezzo al prato (…) Allor mirando in ciel, vidi rimaso Come un barlume, o un’orma, anzi una nicchia, Ond’ella fosse svelta; in cotal guisa, Ch’io n’agghiacciava; e ancor non m’assicuro…”6 . Nel sogno di Alceta, di Leopardi, la spaventevole caduta della luna fa scolorire il mondo. Ma ci sono poi altri poeti che la rimettono in cielo, nel cielo della poesia. Lorca, ad esempio, gioiosamente, con un gioco quasi di fanciullo: “Alta va la luna bajo corre el viento (…) luna sobre el agua. Luna bajo el viento”7 . E ancora, “La quilla de la luna Rompe nubes moradas”8 . “Los niños se comen la luna Como si fuera una cereza”9 . “La luna está muerta, muerta; Pero resucita en la primavera”10. Risuscita la luna in Montale, Caproni, Luzi. E luminosamente in Andrea Zanzotto così:
6 LEOPARDI, G. (1970: 398-399, vv. 3-9 e 17-20). 7 Cfr. GARCÍA LORCA, F. (1921-1924): Canciones, “Nocturnos de la ventana [A la memoria de José de Ciria y Escalonte, Poeta (1)]”. 8 Cfr. GARCÍA LORCA, F. (1921): Poema del cante jondo, “Poema de la Saeta: A Francisco Iglesias [Madrugada]”. 9 Cfr. GARCÍA LORCA, F. (1921-1924): Canciones, “Teorías [Tío-vivo]”. 10 Cfr. GARCÍA LORCA, F. (1921-1924): Canciones, “Canciones de luna [Dos lunas de tarde: A Laurita, amiga de mi hermana]”.
“Luna puella pallidulla Luna flora eremitica, Luna unica selenitica, distonia vita traviata, atonia vita evitata…11”. E la luna infine, la luna che profuma d’oriente, di Lucio Piccolo: “La luna porta il mese e il mese porta il gelsomino”12. Ma è una luna, quella di Piccolo, che, come nel sogno di Alceta del leopardiano Spavento notturno, si frantuma, cade sulla terra e mai più risuscita. Lucio Piccolo di Calanovella. E bisogna purtroppo dire ogni volta di questo grande poeta scoperto da Montale, dell’autore di Gioco a nascondere e Canti barocchi, Plumelia, La seta, Il raggio verde, bisogna dire, per la fama planetaria che raggiunse l’autore de Il Gattopardo, che Lucio Piccolo era cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era del Capo d’Orlando ma veniva sempre al mio paese, prima in landò, dal tempo screpolato, e poi in macchina. Correva sempre, correva, il volto chiuso in una sua gioia incomprensibile. M’accadeva d’incontrarlo spesso, e allora mi fermavo e lo seguivo con gli occhi finchè spariva. Un giorno, dopo anni, il barone Piccolo me lo trovai davanti nella carto-libreria-legatoria dei fratelli Zuccarello, titolari anche della tipografia Progresso. Entra, seguito dall’autista don Peppino. “Ecco qua” dice Piccolo. “Queste sono le poesie” e consegna dei fogli dattiloscritti, con un sorriso tra imbarazzato e divertito. Discussero di carta, di caratteri, di copertina, di numero di copie. Poi gli occhi di Piccolo si appuntarono sui miei libri che
11 Cfr. ZANZOTTO, A., 13 settembre 1959 (Variante), in IX Ecloghe (1962), in ZANZOTTO, A. (1999): Le poesie e prose scelte, Stefano Dal Bianco, Gian Mario Villalta (ed.), Milano: Mondadori. 12 Poesia dal titolo “La luna porta il mese”, in PICCOLO, L. (1956: 62): Canti barocchi e altre liriche, prefazione di Eugenio Montale, collana «I poeti dello Specchio», Milano: Mondadori.
avevo portato là per farli rilegare, vecchi libri che scovavo sulle bancarelle: almanacchi, guide, storie locali. Disse: “M’accorgo di non essere il solo ad amare questi libri. Sì, le guide, gli almanacchi, sono pieni di insospettabile poesia”. E aggiunse: “Ho una intera biblioteca di questi vecchi libri. Venga, venga a trovarmi a Capo d’Orlando. Al chilometro 109 c’è una stradina che arriva fino alla casa”. Questo fu verso la fine del ‘53: era morto Stalin, i Rosemberg erano stati assassinati, le acque avevano sommerso la Calabria e in Sicilia una Madonna di gesso piangeva al capezzale di un operaio comunista. Quel libretto stampato dalla tipografia Progresso, intitolato 9 liriche, venne inviato a Montale, e quando poi, nel 1956 Mondadori pubblicò Canti barocchi, Montale ne scrisse la prefazione. Scrisse: “(…) mi colpì in queste liriche un afflato, un raptus che mi facevano pensare alle migliori pagine di Dino Campana. Il lessico è spesso ricercato, ma la parola ha poco peso, l’armonia è quella di un moderno compositore politonale”. E ancora: “Lucio Piccolo ha letto tous les livres nella solitudine delle sue terre di Capo d’Orlando (…) Un uomo molto singolare, un uomo sempre in fuga, per certi aspetti affine a Carlo Emilio Gadda, un uomo che la crisi del nostro tempo ha buttato fuori del tempo”13. Quest’uomo io ho frequentato per anni, da lui ho appreso cos’è la cultura, cos’è la poesia. Il 17 febbraio del 1967 pubblicavo su L’Ora di Palermo un lungo articolo su Lucio Piccolo dal titolo “Il barone magico”. In quell’articolo davo l’anticipazione di una prosa, intitolata L’esequie della luna che il poeta stava componendo. Scrivevo: “L’esequie della luna è un balletto in tre tempi. Lo si chiama balletto per convenzione, ma potrebbe bene esso creare una nuova categoria letteraria. Pomposo, Fantastico e Pastorale ne formano i tre tempi. Il racconto è questo. La luna, fanciulla che s’ammala, cade sfaldandosi (il simbolo è palese): ne vediamo gli effetti alla corte di un viceré, in un convento di trepide suore e in campa
13 Libretto “9 Liriche” stampato nello Stabilimento tipografico di Sant’Agata senza data. Montale nella prefazione pubblicata in Canti barocchi e altre liriche, (cit.), dice di aver ricevuto il libretto il giorno 8. 4. 1954 – La prefazione di Montale è da p. 9 a 19.
gna, dove infine la Luna, fanciulla ricomposta in un’urna, viene sepolta presso le acque” 14. Nel settembre del 1967, Piccolo così communicava allo scrittore Corrado Stajano: “Intanto ho scritto una sorte di narrazione-fantasia, volutamente barocca e ingenuamente romantica, L’esequie della luna, opera più che altro nostalgica…”15. E ancora a Stajano, nell’ottobre dello stesso anno, scriveva: “Ho scritto recentemente una sorta di racconto fantastico (al quale già pensavo da lungo) in cui le parole dovrebbero essere rappresentative come le figure di un balletto. Clima dei Canti barocchi. È un canto estremamente nostalgico verso la Palermo di quando ero bambino proiettata sopra un immaginario Seicento dove opera o meglio non opera il burattinesco Viceré. La caduta del satellite significa appunto l’estinguersi dei residui del romanticismo-barocco (…). il quale fatto coincide pure con la crisi della nostra epoca (…) Comunque i resti vengono portati al riposo vicino le acque (notare questo riferimento ricorrente del simbolismo equoreo-eracliteo!) delle piccole comunità rurali, le quali sono le sole ancora ad intravedere barbagli, lucori zodiacali ecc…”16. Nel dicembre del 1967, la rivista Nuovi Argomenti, diretta da Carrocci, Moravia e Pasolini, pubblicava L’esequie della luna di Lucio Piccolo. In quello stesso numero appariva una parte de Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante e Pilade di Pier Paolo Pasolini. Il Pasolini che già nel 1964 aveva scritto il saggio Nuove questioni linguistiche in cui diceva della mutazione della lingua italiana dovuta al cosiddetto “miracolo economico”, al neo-industrialesimo e alla correlata espansione dei mezzi di comunicazione di massa. Il Pasolini che diceva della fine del mondo contadino in Italia, della sua plurimillenaria cultura e
14 Consolo, V. (1967): “Il barone magico. Quattro inediti di Lucio Piccolo, il poeta siciliano dei Canti barocchi, presentati da Vincenzo Consolo”, en L’Ora, Libri, Venerdì 17 febbraio, p. 9. 15 Lettera del 12 settembre 1967, in “Galleria”, Anno XXIX, n. 3-4 maggio-agosto 1979, p. 99 (Salvatore Sciascia Editore Caltanissetta). 16 Lettera ottobre 1967, stessa rivista “Galleria” come sopra pp. 99-100.
dell’avvento della cultura di massa, del neo-capitalismo e della cultura piccolo-borghese. Lo stesso Pasolini poi che nel febbraio del 1975, pochi mesi prima della sua atroce morte, scriveva l’articolo sulla scomparsa delle lucciole. Leopardi, Pasolini, Piccolo: è pur vero che i poeti sono vati, sono “entusiasti”, vale a dire en theòs, vale a dire vaticinanti. Ed è pur vero che la vera scrittura è una scrittura palinsestica, una scrittura che scrive su altre scritture. Piccolo, nel 1967, aveva, con L’esequie della luna, aveva sì voluto rappresentare il tramonto di una cultura, che egli chiama “romantico-barocca”, ma aveva come presagito ciò che sarebbe successo da lì a qualche anno, la caduta del mito della luna appunto, della profanazione dell’astro dei poeti. Il 21 luglio 1969, l’astronave americana di nome Apollo -il fratello gemello di Diana approda sulla superficie dell’astro e degli uomini vi danzarono sopra con i loro scarponi di metallo. Nel romanzo incompiuto Un’isola nella luna William Blake ci dice che in quell’isola si parlava il linguaggio del nonsense. Ma un bel preciso e incisivo senso hanno quelle orme lasciate dall’astronauta sulla superficie della luna. Orma che è segno di violazione, di possesso. Scrive Sergio Perosa in L’isola la donna il ritratto: “La metafora principe del possessso è quella dell’orma, del footprint. Si può pensare per un momento (…) all’orma che lascia l’astronauta Armstrong sulla luna alla prima discesa della storia”17. Piccolo muore in quello stesso anno, il 1969. L’editore Vanni Scheiwiller racconta che Piccolo avrebbe voluto far musicare il suo L’esequie della luna da Gianfrancesco Malipiero e che avrebbe voluto, per la scenografia e i costumi, i disegni del pittore Fabrizio Clerici. Il desiderio di Piccolo non si è poi avverato, L’esequie della luna è rimasta solo una prosa da leggere. Nel 1969 io ero emigrato già da un anno a Milano. M’ero portato nel bagaglio l’idea o il progetto di un romanzo storico, apparso poi nel 1976 presso Einaudi col titolo Il sorriso dell’ignoto marinaio.
17 PEROSA, S. (1996: 48): L’isola la donna il ritratto, Torino: Bollati Boringhieri.
Nel 1985, ancora presso Einaudi, apparve il mio Lunaria. La dedica, nel libro, è questa: “A Lucio Piccolo, primo ispiratore, con L’esequie della Luna. Ai poeti lunari. Ai poeti”18. Dicevo sopra che la vera scrittura è per me quella palinsestica, la scrittura vale a dire che scrive su altre scritture, la scrittura che poggia sulla memoria letteraria soprattutto. Il mio Lunaria era esplicitamente scritto su Leopardi e su Piccolo, ma anche su tanti altri poeti e scrittori. Partivo dunque da Leopardi e da Piccolo per rovesciarne l’assunto. La mia luna, sì, come dice Lorca “está muerta, muerta; / Pero resucita en la primavera19”. Risuscita in una contrada senza nome, una contrada che prenderà il nome di Lunaria. Credo sia chiara la metafora: la luna, sì, è caduta nel nostro contesto, nella nostra cultura occidentale, è caduta qui da noi la poesia. In luoghi ignoti, in contrade senza nome, in quelli che noi chiamiamo terzi, quarti o quinti mondi, in quei luoghi, pur afflitti di povertà e malattie, in quelle primavere della storia l’umanità sa creare ancora la poesia. Dice il mio Viceré Casimiro: “Se ora è caduta per il mondo, se il teatro s’è distrutto, se qui è rinata, nella vostra Contrada senza nome, è segno che voi conservate la memoria, l’antica lingua, i gesti essenziali, il bisogno dell’inganno, del sogno che lenisce e che consola”20. Il terrifico sogno dell’Alceta leopardiano si è dunque mutato nel sogno necessario, nel sogno che lenisce e che consola: il sogno della poesia. Cesare Segre, in Intrecci di voci, nel capitolo intitolato Teatro e racconto su frammenti di luna, mette a confronto e analizza L’esequie della luna e Lunaria. Scrive: “In Consolo, la figura del Viceré, dopo l’iniziale scena, comica, d’ignavia, si rivela progressivamente la coscienza della vicenda. Se ricordiamo che il Viceré scopre alla fine la sua natura di attore che impersona il Viceré, potremmo dire che quando egli pencola verso il comico è il
18 Consolo, V. (1985): Lunaria, «Nuovi Coralli 365», Torino: Einaudi. 19 Cfr. GARCÍA LORCA, F. (1921-1924): Canciones, “Canciones de luna [Dos lunas de tarde…]”, cit. 20 Consolo, V. (1985: 62).
Viceré, quando è serio e meditativo è l’attore, distaccato tanto dal personaggio quanto dalla vicenda 21”. E trova consonanza e ulteriore sviluppo, l’affermazione di Segre, con quanto nota Irene Romera Pintor, l’autrice della magnifica traduzione in castigliano di Lunaria. Scrive: “Cierto, la sombra de La vida es sueño planea sobre las melancólicas ensoñaciones del Virrey, que ya no cree en su poder ni sabe siquiera quién es. Pero ningún crítico hasta ahora ha señalado la relación que sobre todo tiene Lunaria con El Gran Teatro del Mundo”22. E io ringrazio Irene Romera Pintor per questa rivelazione di un così alto rimando. La ringrazio per tutto il suo generoso lavoro su Lunaria.
Milano, 22 ottobre 2005
21 Cfr. SEGRE, C. (1991): “Teatro e racconto su frammenti di luna”, in ID., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, “Einaudi Paperbacks 214”, Torino: Einaudi, pp. 87-102 (cfr. in particolare p. 93). 22 Cfr. CONSOLO, V. (2003): Lunaria, edizione, introduzione, traduzione e note a cura di I. Romera Pintor, Madrid: Centro de Lingüística Aplicada Atenea (cfr. in particolare p. 12). 
Vincenzo Consolo : l’alchimie du logos
Chroniques italiennes n. 73/74 (2-3 2004), M. GIACOMO-MARCELLESI
Vincenzo Consolo : l’alchimie du logos
Femmine, che sono sti lamenti e queste grida con la schiuma in bocca ?
La transposition narrative du monde de Vincenzo Consolo, ce « Finistère » dont les frontières sont sans cesse repoussées dans l’espace et dans le temps, comporte une telle force dans les évocations langagière, qu’on a parfois l’impression de ne pas pouvoir comprendre le texte si on ne le lit pas à voix haute.
Il est sans doute difficile de trouver une production littéraire où la voix humaine aux mille parlers occupe autant de place que dans cet univers dont la dimension chorale exprime l’infinitude de la souffrance humaine. L’extrême richesse de la narration se développe dans la cristallisation métaphorique des mots, expressions, formules nées de la mémoire individuelle de l’écrivain qui renvoient à une culture populaire et savante, ainsi qu’à une sensibilité et une éthique forgées dans ce contexte.
Consolo définit lui-même la genèse de son oeuvre littéraire comme le projet d’une écriture de type sociologique, à la Carlo Levi, qui s’est inscrite dans la perspective d’une écriture expressive ou sentimentale quand il a compris que l’esthétique littéraire généralement qualifiée de néo-réalisme était dépassée. Son choix se porte donc sur cette écriture expressive, dont il voit l’archétype en Giovanni Verga, « il primo grande rivoluzionario stilistico nella letteratura moderna ».
Le critique Enzo Papa signale enfin une autre influence invoquée par Consolo, celle du groupe allemand ’47:
Vi resistono an cora gli echi della poetica neorealistica, già in congedo… ma vi appare evidente la lezione del tedesco gruppo ‘47, di quegli scrittori tedeschi che Consolo definisce analisti, come anche quella delle sperimentazioni linguistiche di Gadda e di Pasolini. 1
Dans cette lignée, Consolo manifeste dès son premier ouvrage La ferita dell’aprile ( bien qu’il ait fallu attendre Il sorriso dell’ignoto marinaio pour que la critique s’en aperçoive) une maîtrise des ressources de la langue et une originalité de style qui permettent de le reconnaître dès la première lecture, ad apertura di pagina, dit un critique2.
Nous verrons comment les voix populaires résonnent dans l’oeuvre de Vincenzo Consolo, les mots, les dialogues, mais aussi les interjections, les murmures, les balbutiements, les bruits. Il n’est pas jusqu’aux cris et au silence qui ne prennent une signification métaphorique dans cet univers.
1.Langue(s) et dialecte(s) :
1.1 La musique de l’inflexion dialectale:
La langue italienne dans ses inflexions dialectales diverses est évoquée avec émotion par l’écrivain Giacchino Martinez, héros du roman Lo Spasimo di Palermo (en partie autobiographique) quand il l’entend résonner dans le train, au retour d’un exil de plusieurs années : les voyageurs descendent à Florence et à Rome relayés par d’autres qui montent, le couloir est envahi par les soldats en permission qui hurlent, s’interpellent, se moquent les uns des autres d’un bout à l’autre du wagon dans un joyeux brouhaha, la baraonda : l’intellectuel se complaît à entendre résonner ces parlers qui ne sont plus le dialecte mais ne sont pas encore « la terrible nouvelle langue nationale que le malheureux Pasolini avait prophétisé pour le pays.
1 Enzo Papa, « Vincenzo Consolo : », in Id., « Ritratti critici di contemporanei», in: Belfagor, Firenze, Olschki, marzo 2003, LVIII, n.2, p. 179-198 : « on y trouve encore les échos de la poétique néoréaliste, …mais déjà apparaît en pleine évidence l’influence des écrivains du groupe allemand ’47…de ces écrivains que Consolo définit comme analystes, et aussi celle des expériences linguistiques de Gadda et de Pasolini ».
N.B. Cette traduction, comme toutes celles qui suivront, en note ou dans le texte, sauf mention spécifique, a été établie par l’auteure de la présente étude.
2 Gianni Turchetta, « Introduction » in : Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori, 1988, p. V-XII
Vincenzo Consolo : l’alchimie du logos 199
Oltre l’eterna melodia napoletana, cercava di distinguere i suoni di Calabria, quello aspro dei monti e quello piano di Vibo e di Lamezia. Nelle parlate poi della sua isola, indovinava facilmente, nelle sue varianti, le città e i paesi da cui i ragazzi provenivano. Sentiva l’incolore e aggirante messinese, il rotondo e iattante palermitano, l’allusivo e cantilenante catanese, il pietroso e aspirato agrigentino, e l’antico lombardo di Piazza, Nicosia o San Fratello3.
1.2 Le sicilien
Le premier roman La ferita dell’aprile4, propose, dès 1963, une langue de ce type, italienne souvent fortement infléchie par le dialecte tandis que le dernier roman (à ce jour), Lo spasimo di Palermo, sépare la langue italienne académique des énoncés en sicilien qui sont le plus souvent des noms de lieux ou des proverbes. Il sorriso dell’ignoto marinaio5 et Retablo6 se rapprochent plutôt de cette deuxième solution, tandis que Le pietre di Pantalica7 accorde une place beaucoup plus importante au dialecte puisque ce livre évoque l’occupation des terres par les journaliers agricoles, I braccianti. Enfin le livre consacré au Baroque en Sicile présente de longs passages en sicilien, les récits de témoins du tremblement de terre d’Acireale et de celui qui a détruit Syracuse en 16938.
Le sicilien proprement dit résonne à travers les dialogues, les proverbes, les rituels des travaux des champs, les insultes, les slogans politiques, les joutes poétiques de la vie quotidienne, les chansons du « folklore », et de nombreux textes sont eux-mêmes en dialecte.
Les caractéristiques phonologiques et morphologiques du sicilien sont présentes aussi bien dans La ferita dell’aprile que dans d’autres teste de Consolo.
– Vocalisme : l’absence de diphtongue dans le suffixe –ère « -ièri » (cavalere « cavaliere » sciarmère, « mèi « miei », sui « suoi »), -les voyelles fermées en syllabe tonique (chisti « questi », sunno « sono », signuri « signore », vui « voi »), les voyelles semi-ouvertes en syllabe atone (sicolo « siculo », scoltori « scultori »)
– Consonantisme : le rhotacisme (Arcamo « Alcamo », ascortate « Ascoltate »), la séquence –nn- correspondant à la séquence italienne –nd- : (monno « mondo », granne « grande »), l’absence de l’élément labio-vélaire (chisti « questi »), la présence de la fricative palatale dans la séquence consonantique –str- (nosctro « nostro »), la non-assimilation du groupe –ntpour l’italien –tt- (pintori « pittori »)
En revanche, la morphosyntaxe du sicilien est plus particulièrement présente dans la prose italienne de La ferita dell’aprile, qui reprend le rythme de la langue dialectale, sicilienne mais aussi plus généralement méridionale : emploi systématique du passato remoto là où la langue emploie le passato prossimo, postposition systématique du verbe, soli restammo, cavaliere è, essa fu, io sono, etc., emploi systématique de l’indicatif dans des subordonnée introduites par des verbes exprimant
Le lexique sicilien apparaît dans La ferita dell’aprile, certains mots connus comme caruso, picciotto, d’autres moins répandus dans la péninsule : il dubotti (due colpi en italien, (« deux coups » en français ), d‘autres enfin si obscurs qu’ils sont éludés dans les traductions françaises, comme le balate9, « les roches lisses qui donnent un accès facile à la mer », « les dalles ».
3 Vincenzo Consolo, La spasimo di Palermo, Milano, Mondadori, 1998, p.94-95 :Au-delà de l’étzrnelle mélodie du napolitain, ilessayait de discerner les sons de Calabre, l’âpre calabrais des monts et de la plaine de Vibo et de Lamezia. Dans les parlers de son île, il devinait facilement, à travers ses diverses variantes, les cités et les bourgs dont provenaient les jeunes gens. Il entendait l’incolore et insinuant parler de Messine, le palermitain sonore e glapissant, le parler de Catania comme une cantilène discrète, le parler âpre et pierreux d’Agrigente, et l’ancien lombard de Piazza, Nicosia ou San Fratello. »
4 Id., La ferita dell’aprile, Torino, Einaudi, 1963
5 Id., Il sorriso dell’ignoto marinaio, Milano, Mondadori, 1976
6 Id., Retablo, Torino, Einaudi, 1998
7 Id., Le pietre di Pantalica, 1988
8 Id., Il barocco in Sicilia : la rinascita del Val di Noto, Milano, Bompiani, 1991
9 Id., La ferita dell’aprile, p. 122
- 3 La différence linguistique comme vécu:
Cette expérience est autobiographique. Vincenzo Consolo tout en assumant son destin de grand intellectuel européen n’en finit pas de donner à entendre la différence linguistique qu’il a vécue dès son enfance. Comme le jeune héros de La ferita dell’aprile il est né dans un bourg en province de Messine, où on parle, aujourd’hui encore, un idiome « gallo-italique » qu’il appelle antico lombardo, qui s’est rapproché au cours des siècles du sicilien, tout en gardant de nombreux traits spécifiques. L’enfant prend conscience de cette singularité quand sa mère l’emmène vivre dans une autre localité, où la population le traite, lui et les siens, comme des étrangers, zanglé, zerabuini, « anglais », « arabes », êtres possédés du diable, affligés de tous les vices que même Mussolini n’avait pu convertir au christianisme. Alors que le paysage qu’il voit de l’institut où il est scolarisé lui donne l’impression rassurante de se rapprocher de son village, les collines entrevues comme un lion protecteur au repos, l’enfant se trouve confronté aux moqueries de ses camarades, pour sa différence de langue, celle d’un bourg « vieux comme le monde, où on parle d’une façon telle que personne ne nous comprend, et les illettrés, quand ils parlent, semblent être originaires du Nord » :
Don Sergio me lo chiese, un giorno che dicevo la lezione.- Di’ un po’ : non sarai mica settentrionale ?
– E le risate di que’ stronzi mi fecero affocare. Glielo dissero che ero uno zanglé, che avevo una lingua speciale. Don Sergio volle sapere e fece la scoperta che poteva esse colonia francese, che zanglé storpiava lesanglé, non inglesi, ma normanno.
Ma non sono neanche uno zanglé, un civile di casino, facce smorte e pertiche di faggio, zarabuino, se ci tiene tanto.
-Zarabuini sono gli arabi, disse don Sergio.10
L’altercation donne lieu à une leçon d’instruction civique empirique, une leçon de tolérance et de respect de l’autre « étranger ». Don Sergio se risque à une analyse hasardeuse de la différence entre « les arabes zarabuini et les normands, deux races, deux classes bien distinctes » dit-il, « la seconde s’étant imposée sur la première provoquant une fracture nette qui dure encore aujourd’hui ». Puis il propose à l’enfant un échange métalinguistique qui montre les correspondances entre les deux idiomes, pen « il pane », mer « il mare », travai « il lavoro » et d’où il ressort que la différence n’est pas un problème :
Vedete, vedete ! Che c’è da vergognarsi, è storia, storia.11
Le camarade de classe Mùstica devient alors un ami, lui qui avait été le premier à l’appeler zanglé , et il reconnaît à son tour « que chacun est fils de son père, un point c’est tout, et que tous nous sortons du même terrier ». Un des prêtres de l’institut, Don Baraglio lui suggère fort judicieusement d’opposer des insultes de sa propre langue à ceux qui l’appellent zanglé.
La coexistence de plusieurs idiomes dans la narration est illustrée notamment par le récit de l’arrivée du voyageur lombard, le peintre Fabrizio Clerici, à la cour princière de Alcamo :
« Venisse, venisse… » soggiunse, facendo segno d’ascendere alla loggia.
« Ben vinuto, ben vinuto ad Arcamo ! » disse quando gli fui di fronte, e m’abbracciò e mi baciò sulle guance.
« L’amici di Sepporta sunno amici mèi. E chisti » disse quando gli fui di fronte presentandomi gli altri ch’avea s ‘intorno « sunno mèi amici, e dunca vosctri. »
« Vino, vino al cavalère di Milano ! » gridò il Soldano. E mi si offrì nel cristallo una bevanda spessa e giulebbosa che dopo il primo assaggio, rifiutai
10 Id., La ferita dell’aprile, Torino, Einaudi, 1963, p. 25-26 : « Don Sergio me le demanda, un jour où je récitais la leçon. –Dis-moi un peu, tu ne serais pas septentrional, par hasard ?. – Les éclats de rires de ces cons ont failli me faire suffoquer. Ils lui ont dit que j’étais un zanglé, que j’avais une langue spéciale. Don Sergio voulut en savoir davantage et il découvrit que c’était peut-être une colonie française, que zanglé était une déformation de lesanglé, non pas des anglais, mais des normands. Mais je ne suis pas non plus un zanglé, un clients de bordel, avec un visage livide et des cannes de hêtre, plutôt zarabuini, si vous y tenez tant à anglé – Zarabuini, ce sont les arabes, dit Don Sergio. »
11 Id., Ibid. p. 26 : Vous voyez, vous voyez ! De quoi avoir honte, c’est de l’histoire, de l’histoire. »
« si contrstava…se sia opportuno, nel poetare o pure rivolgere al sicolo idioma tragedia antiqua oppur poema, sia opportuno dicimo per nui nativi d’Arcamo , patria del primo e granne, onore de la cosca de’poeto e luce di cinnàca, di Ciullo intenno, chiaro al monno intero, e surtuto per nui de l’Academia ardente che al nome suo s’impenne, far crescere la cima sicola da ràdica toscana o puramente far sbocciare in aura toscana la semente sicola. Giudicate vui, vah, giudicate vui »
« Ma veramente, » balbettai vergognoso « mi so nient di lingua e di poesia»
« Checchecchè ? ! »fece il Soldano.
« Non m’intendo, non m’intendo » dissi allungando le braccia » 12
Cet épisode prend toute sa signification si on donne une valeur anaphorique à un paragraphe postérieur où l’auteur évoque avec soulagement, et même une allégresse qui n’est pas due seulement à la limpidité de l’aube et de l’ora antelucana, son départ de la cour d’Alcamo. Cette évocation confirme qu’il s’agit bien de Frédéric II:
Gai giannetti e novi letticari, nell’aere lieve dell’ora antelucana, presto ci portarono lontani dalle mura turrite del paese d’Alcamo, madre di lingua e cuna di poesia, dal grasso amante d’ogni lusso e arte, il castellano e ospite Soldano, dal protervo satiro suo figlio, dalla corte de’bardi, scoltori, pintori e teatranti servi, sciarmèri e questuanti13.
L’ensemble de la rencontre illustre en fait, de façon parodique, le ontraste entre l’apparence orientale et mauresque du Sultan et l’identité du souverain d’origine anglo-saxonne, germanique par son père Henri fils de Frédéric Barberousse, et normande par sa mère Constance de Lecce. L’intérêt de Frédéric II pour les langues, sa maîtrise de la langue arabe, sapassion pour l’astronomie e plus généralement, pour une experimentation scientifique linguistique mais aussi biologique, qui ne recule pas devant la cruauté, sont suggérés ici dans un anachronisme parodique. Le sicilien est utilisé dans une dimension caricaturale, mais il présente des traits intrinsèques, vocaliques, consonantiques, morphologiques, presents également chez les protagonistes populaires du roman.
En contraste avec la générosité princière et linguistiquement sicilienne du Sultan, la formule lombarde mi non so nient exprime l’émotion du peintre lombard Fabrizio Clerici, déjà fortement éprouvé par la dégustation forcée de fruits artificiels, surtout par la vue des foetus monstrueux macérant dans de bocaux, et terrorisé à la perspective de la nouvelle épreuve.
Le même effet comique et parodique naît du plurilinguisme qui se dégage également des allocutions des deux bardes en « contraste », nouvelle allusion aux joutes poétiques médiévales en usage à la cour de Sicile comme dans d’autres régions de Méditerranée où elles sont encore vivantes. Le premier barde, Don Emilio Chinigò, in Accademia inteso Abelio Zenòdotto, s’exprime sans doute dans l’idiome gallo-italique des anciennes coloniespiémontaises :
12 Id., Ibid., p. 40 : « Venez, venez », suggérait-il en nous faisant signe de monter dans la loggia. Bienvenu, bienvenu, » dit-il quand je fus en face de lui, et il me serra contre lui et m’embrassa sur les joues. –« Les amis de Sepporta sont mes amis. Et ceux-ci, dit-il quand je fus en face de lui, en me présentant ceux qui l’entouraient, ce sont mes amis et donc les vôtres.- Du vin, du vin pour le chevalier de Milan ! » cria le Sultan. Et il m’offrit dans un verre de cristal une boisson épaisse que je repoussai dès la première gorgée. – Nous débattions, pour savoir s’il est opportun de rédiger une poésie ou une tragédie en sicilien, pour nous natifs d’Alcamo, patrie du premier, le grand, l’orgueil de la compagnie des poète, je veux parler de Ciullo, célèbre dans le monde entier, et surtout pour nous de l’Académie ardente, faut-il cultiver les sommets siciliens avec une racine toscane, ou bien faire s’épanouir dans l’atmosphère toscane la semence sicilienne. Donnez votre jugement, allez, donnez votre jugement. – « Mais vraiment, balbutiais-je, plein de honte, – je ne sais rien en langue et en poésie.- Quoi, quoi, fit le Sultan. – Je n’y connais rien, je n’y connais rien, » dis-je en allongeant les bras.
13 Id., Ibid., p. 53 :De joyeux guides et de nouveaux jeunes porteurs nous emmenèrent, dans l’air léger de l’aube, loin des remparts crénelés de la ville d’Alcamo, mère de la langue et berceau de la poésie, loin de l’amant de tous les luxes et de tous les arts, le châtelain notre hôte, le Sultan, et loin de son arrogant satire de fils, loin de la cour des bardes, des sculpteurs, des peintres, des comédiens, des jongleurs et des mendiants.
Esultante quindi l’accademico, con voce forte, chiara, si mise a recitare versi oscuri, incomprensibili a me, a voi, a chicchessia, mi credo, non fusse nato in Alcamo, che rumorosi applausi si ebbero, e numerosi brindisi, di tutta l’adunanza14.
Le second barde, padre don Getulio Camàro, in Accademia Aristeo Apollonio, use d’une langue artificielle et ampoulée, peut-être celle du trobar clus et des poètes définis comme siculo-toscans :
Poscia seguì il prete, grevio, untuoso, che pur poetando nel più cercato e prezioso italico linguaggio, tanto dolz e pien di sghiribizz, di pess, e pazz, e pozz, e puzz, e pizz, come ridendo dice il nostro Maggi, erano i versi suoi gonfi di metafore e di immagini e di concetti sùi peregrini e falsi, e manierato il tono, e il ritmo artefatto…15
Dans la diversité des langues, il faut inclure l’argot, il gergo, gergo adolescenziale revendiqué par Consolo, l’emploi des mots fottere, minchione, etc.
Certains mots sont difficiles à comprendre parce qu’ils correspondent à une époque où se situe le roman, ainsi serraglio e mentòla pour les cigarettes « légères »
D’autres idiomes sont conviés, grec, arabe, espagnol, français, anglais, allemand, et même une langue inconnue, dans une comptine que le prêtre fait chanter aux enfants pour exorciser leur peur pendant les bombardements16 Ces idiomes apparaissent à travers des répliques ou mots isolés, souvent des toponymes, qui sont « la dent et la griffe de l’histoire dans la langue » comme disait un illustre géographe. Ces insertions prennent une valeur symbolique dans le déroulement de la narration que nous nous proposons d’évoquer plus longuement dans la troisième partie de notre étude.
- Le choix du genre : roman, poème narratif ?
A travers la série d’interviews organisées à Rome, le 25 juin 1993, par l’Imes, l’Istituto meridionale di storia e scienze meridionali, et publiées dans le recueil Fuga dall’Etna17, Vincenzo Consolo affirme un point de vue selon lequel, dans les conditions actuelles de l’Italie, la fonction de l’écrivain connaît une grave mutation. Cette situation est due à l’absence d’ancrage national des intellectuels italiens, à la rupture du rapport entre la société et les intellectuels :
Gli scrittori italiani hanno sempre dovuto andare all’estero per poter scrivere in prosa, da Manzoni a Calvino, a Sciascia, mutuare cioè la loro dalla prosa francese, o adottare una sorta di koiné funzionale di tipo transnazionale come Pirandello o Morzavi18.
Cette analyse correspond, de manière significative, aux remarques d’Antonio Gramsci sur le clivage entre les intellectuels italiens et le peuple, leur éloignement de la vie « nationale-populaire »19. C’est dans le vide de cette relation entre la société et les intellectuels que s’est installé, selon Consolo, un type de communication qui est, en fait, une véritable imposture.
14 Id., Ibid. p. 41 : « Exultant, l’académicien se mit d’une voix forte et claire, à réciter des vers obscurs et incompréhensibles pour vous, pour moi, pour qui que ce soit croyez-moi, qui ne serait pas né à Alcamo, et il recueillit bon nombre d’applaudissements et de toasts »
15 Id., Ibid. p.41 : Puis le prêtre, d’une contenance grave et onctueuse, débitza des poesies dans le plus précieux et recherché des idiomes italiques, tout en dolz et plein de sghiribizz, de pess, de pazz, de pozz, et puzz, et pizz comme dit en riant notre Maggi, et ses vers étaient gonflés de métaphores , d’images , d’idées étranges et fausses, le ton maniéré, le rythme artificiel .»
16 Id., Lo spasimo di Palermo : p. 14
17 Fuga dall’Etna (La Sicilia e Milano, la memoria e la storia) Roma, Donzelli, 1993.
18 Ibid., p. 53-54 : « Les écrivains italiens ont toujours du se rendre à l’étranger pour pouvoir écrire en prose, de Manzoni à Calvino et à Sciascia, changer leur prose avec la prose française ou bien adopter une sorte de koiné fonctionnelle, de type transversal, comme Pirandello ou Moravia. ».
19 Gramsci Antonio, Quaderni del Carcere, Torino, Einaudi, 1975, 4 vol. , plus particulièrement, dans le volume II, le cahier 8, « Note sparse e appunti per una storia degli intellettuali » , p. 922 et suivantes.
Il explique avoir adhéré au Manifesto per la difesa della lingua italiana parce qu’il estime que la langue italienne est menacée par la langue du pouvoir, langue « absolument horizontale », un pouvoir qui n’est pas seulement politique, mais aussi économique et technologique avec le développement d’une communication de masse dominée par Internet et Monsieur Gates. Seule la pratique de codes linguistiques qui plongent dans les couches profondes de la langue italienne, « le langage vertical » – dit-il- , peut sauver la langue italienne. Dans la même logique, il revendique le choix d’une forme d’écriture qui s’inscrit dans le refus de la forme romanesque, refus affirmé au cours de son itinéraire intellectuel et porté à l’extrême par son dernier ouvrage, Lo Spasimo di Palermo, tandis que l’ouvrage précédent, Il Sorriso dell’ignoto Marinaio, accueilli triomphalement par la critique, témoignant d’un langage prodigieusement inventif, mêlant étroitement langue et dialecte, tradition cultivée et tradition populaire, avait été classé comme « poème narratif ».
Voglio essere radicale per una volta, credo che nel nostro contesto non si possa più praticare questa forma narrativa che è stata di nobilissima tradizione in Europa20
Pourtant, Vincenzo Consolo écrira de nouveau au moins un roman, sa dernière oeuvre jusqu’à présent. Il y exprime quelques justifications par rapport à son impossibilité d’écrire quand son fils lui reproche son silence et lui donne en exemple « le castor ligure, l’indifférent romain, son ami l’amer sicilien », et le père écrivain répond ceci :
Hanno la forza, loro, della ragione, la chiarità, la geometria civile dei francesi. Meno, meno talento, e poi mi perdo nel ristagno dell’affetto, l’opacità del lessico, la vanità del suono21
et dans les entretiens de 1999-2001 avec Fabio Gambaro, il rapproche les deux formes, roman et poème narratif et il développe de façon encore plus nette sa position par rapport aux deux lignées d’écrivains italiens.
Ainsi, le résultat final rappelle souvent le poème narratif. A ce propos, il faut rappeler que nous n’avons jamais eu de langue unitaire de communication, les particularismes ayant toujours gagné à tous les niveaux. Par conséquent, les écrivains ont toujours dû se poser la question de la langue et s’inventer un langage pour leurs ouvrages. D’un coté, certains écrivains – de Manzoni à Moravia, de Calvino à Sciascia- ont choisi une langue rationnelle et communicative, qui exprimait l’espoir de la naissance d’une société plus civilisée. D’autres écrivains ont préféré s’exprimer dans une langue que j’appelle « du désespoir », une langue très expressionniste. De Verga jusqu’à Gadda, en passant par Pasolini, Meneghello ou d’Arrigo, les écrivains qui ont choisi cette option forment une tradition à laquelle je suis heureux d’appartenir.22
C’est la lecture de Retablo qui a imposé à l’auteure de la présente étude le sentiment d’une étonnante solution narrative symbolisée par la métaphore de l’ « alchimie », impliquant à la fois la relation entre la langue et le monde qu’elle représente, et la fusion entre langue(s) et dialecte(s), expression employée lorsque l‘auteure a interrogé sur ce mystère23.
Vincenzo Consolo qui a alors récusé l’étiquette « dialecte », indigne de cette noble langue qu’est le sicilien24. Il a évoqué, en revanche, le processus de ré-appropriation des mots qu’il avait, enfant, entendu prononcer par sa mère et dont il a découvert, à l’âge adulte, qu’ils remontaient souvent au grec, ou à l’arabe, ou à l’espagnol. Le travail sur le matériau sonore des premières années de la vie convoque la recherche étymologique, mais il suppose aussi un rapport vivant, émotionnel avec la langue maternelle, opposée à « l’hypothétique code linguistique de la langue nationale ». Le parti pris d’écriture résulte d’un choix expérimental, intuitif et conscient à la fois, déjà à l’oeuvre dès son premier roman, La ferita dell’aprile :
20 Fuga dall’Etna, « Je veux être radical au moins une fois, je crois que dans le contexte qui est le nôtre, on ne peut plus pratiquer cette forme narrative qui relève de la plus noble tradition européenne. »
21 Id., Lo spasimodi Palermo, p. 88 : E ux, ils ont la force de la raison, la clarté, la géométrie civile des français. J’ai beaucoup moins de talent, et puis je me perds dans les eaux stagnantes de l’affection, l’opacité du lexique, la vanité du son. »
22 Fabio Gambaro, L’Italie par ses écrivains, Paris, Liana Levi, 2002
23 L’auteure de cette étude a posé à Vincenzo Consolo une question relative à ces problèmes de la présente étude au cours du débat au Colloque international qui lui a été consacré, organisé par Dominique Budor & Denis Ferraris, Ethique et écriture, 25-26 ottobre 2002, Sorbonne-Nouvelle-Paris III (Actes sous presse).
Mi ponevo con esso subito, un po’ consapevolmente, un po’ intuitivamente, sul crinale della sperimentazione, mettendo in campo una scrittura fortemente segnata dall’impatto linguistico, dal recupero non solo degli stilemi e del glossario popolari e dialettali, ma anche, dato l’argomento, di un certo gergo adolescenziale. Gergo quanto mai parodistico, sarcastico, quanto mai oppositivo ad un ipotetico codice linguistico nazionale, a una lingua paterna, comunicabile25 .
L’univers narratif de Vincenzo Consolo offre des solutions originales à l’ancienne interrogation qui hante l’histoire linguistique et culturelle de l’Italie : la questione della lingua, et la problématique de la mimesis, la résonance dans la trame du texte des voix populaires et dialectales C’est en tant qu’auteur du roman historique, pour la métaphore et non pour ses choix linguistiques, qu’Alessandro Manzoni est défini comme un auteur de référence 26 :
« La lezione del Manzoni è proprio la metafora. Ci siamo chiesto perché abbia ambientato il suo romanzo nel Seicento e non nell’Ottocento. Proprio per dare distanza alla sua inarrestabile metafora. L’Italia del Manzoni sembra davvero eterna, inestinguibile ».
Consolo évoque aussi comme référents Sciascia e Piccolo, qui représentent respectivement ses deux Siciles, la Sicile orientale et la Sicile occidentale.
Dalla mia Finisterra, potevo muovere verso il Centro del Caos, verso il Vulcano o verso lo iatto dello Stretto, verso le fate morgane e i terremoti o muovere verso l’occidente dei segni della storia profondi e affollati… E mi sembrò poi, questo movimento, questo partire ogni volta da lontano, dal profondo e approdare al presente alla superficie, l’essenza della narrativa : un ibrido, un incrocio di comunicazione ed espressione, di logico e di magico27.
Dans cet univers « hybride », entre logique et magie, les mots étrangers, les mots étranges, le « parole peregrine » contribuent au processus créatif de cette oeuvre.
- Le parole peregrine : le mystère des mots dans la métaphore:
La diversité des langues comme malédiction est évoquée par le spectacle que découvre le romancier à son retour à Palermo : ses livres ont été rangés par la vigoureuse et dynamique Michela, la fille des fidale Delfio et Cristina, en fonction de leur couleur (ils auraient pu l’être en fonction de leur taille !). Le babelico assemblaggio 28, insupportable pour un intellectuel qui utilise les livres en fonction de leur contenu et non en fonction de la couleur de la couverture, préfigure la tragédie finale puisque c’est le mari aussi mafieux que vulgaire de cette même Michela qui organise l’attentat contre le juge.
24 La même interrogation est formulée par le coordinateur de l’interview dans Fuga dall’Etna,. Après un assez long développement sur la mémoire historique et la mémoire personnelle, Renato Nicastò évoque le rôle du dialecte dans la mémoire personnelle et conclut par la question suivante : « Ecco, l’alchimia di tutto questo come succede, come nasce ? »
25 Vincenzo Consolo, Per una metrica della memoria, 1997.» Je me suis immédiatement situé sur la ligne de l’expérimentation, en mettant en oeuvre une écriture marquée par l’impact linguistique, par la récupération non seulement des stylèmes et des glossaires populaires et dialectaux, mais aussi, vu le thème de l’ouvrage, un certain argot d’adolescent. Un argot parodique, sarcastique, en contraste avec un hypothétique code linguistique national, et une langue paternelle, véhiculaire. »
26 Id . , Fuga dall’Etna, p. 46-47. « La leçon de Manzoni réside justement dans la métaphore. Nous nous sommes demandé pourquoi il a situé son roman au XVIIème siècle et non au XIXème. Justement pour donner une distance à l’incontournable métaphore. L’Italie de Manzoni est vraiment éternelle, indestructible. »
27 Id., Per una metrica della memoria: « De mon Finistère, je pouvais me déplacer vers le centre du Chaos, vers le Volcan et vers la fracture du Détroit, vers les fées Morgane et les tremblements de terre, ou avancer vers l’occident les signes profonds de l’histoire. Par la suite, ce mouvement, ce départ chaque fois renouvelé depuis l’éloignement, depuis la profondeur, jusqu’à la surface m’est apparu comme l’essence du récit : un hybride, un croisement dans la communication et l’expression, de la logique et de la magie. »
28 Id. Lo spasimo di Palermo, p. 102.
L’écriture de Consolo est profondément métaphorique, dans le sens où de nombreux mots, de nombreuses évocations ont une signification qui n’est pas liée au seul contexte immédiat, mais s’inscrit dans la relation anaphorique et cataphorique qu’un passage entretient avec l’ensemble du texte, parfois de façon très fugitive, de sorte que seules des relectures successives peuvent en révéler le mystère. Cet arrière-plan multiple s’inscrit dans la discrétion et le minimalisme chers à Consolo, et qui n’ont d’égal que l’extrême densité sémantique.
Dans La ferita dell’aprile, la « blessure » qui donne son titre au roman est évoquée, au détour du récit, à la fin du chapitre 10, presque à la fin de l’ouvrage qui en comporte 12 d’importance à peu près égale.
N’ammazzarono tanti in una piazza (c’erano madri e c’erano bambini) come pecore chiuse nel recinto, sprangata la porta. Girarono come pazzi in cerca di riparo ma li buttò buttò buttò riversi sulle pietre una rosa maligna nel petto e nella tempia : negli occhi un sole giallo di ginestra, un sole verde, un sole nero di polvere di lava, di deserto29.
Le récit pourrait être celui de bien des hécatombes passées ou des hécatombes à venir que prophétise, nouvelle Cassandre sicilienne, la vieille femme encore debout sur le lieu du massacre :
Femmine, che sono sti lamenti e queste grida con la schoiuma in bocca ? Non è la fine : sparagnate il fiato e la vestina per quella manica di morti che verranno appresso !30
Le véritable message est suggéré par la couleur du tissu du drapeau rouge, toujours plus rouge au fur et à mesure qu’il s’imprègne du sang des victimes :
La pezza s’inzuppò e rosso sopra rosso è un’illusione, ancore un’illusione31.
Le drapeau rouge, le « superbe drapeau rouge, rouge du sang des fusillés »32 retrouve sa signification réactualisée au moment où s’évanouissent les illusions sur la démocratie, une démocratie italienne don’t on sait aujourd’hui que son gouvernement a organisé le massacre d’une innocente, dans une mise en scène qui permet d’en imputer la responsabilità au populaire bandit Salvatore Giuliano. Cette signification ne peut être comprise que si on met en relation ce passage avec celui qui précède, les cris d’une manifestation populaire de 1er mai : « Con la bandiera rossa gridano, al Primo Maggio, ai Lavoratori evviva ! » mêlée à l’évocation statuaire d’un monument aux morts, un soldat qui s’élance pour la patrie de Piémont-Sardaigne, une liste de noms révoquant l’appel des recrues, etc.:
Vicino al fante verderame slanciato avanti, Savoja !, le balate e i nomi, presente !, scoloriti per il tempo che ci è passato sopra: le ruote grandi e i raggi neri mangiati dalla ruggine e i fusti dei cannoni, con la bandiera rossa gridano, al Primo Maggio, ai Lavoratori, evviva !33
La ruelle qui relie l’intérieur des terres à la mer, via Rotolo, dont le nom revient dans d’autres ouvrages, au bout de laquelle se trouve cette statue est elle-même précédée d’une description du paysage, voir comme un tableau de peintre à travers les yeux décillés d’un narrateur le héros luimême caruso, bastaso, devenu désormais jeune homme qui fume sa première cigarette en compagnie d’un jeune maçon, fixé dans la position du jeune désoeuvré qui « tient le mur » dans une attitude qui exprime l’ascendant qu’ont pu avoir les mafiosi sur la jeunesse34 (il ne faut pas oublier que mafioso est une appellation à l’origine positive, comme ‘ndrangheta ‘la société des hommes debout).
29 Id., La ferita dell’aprile, p. 122 : « Ils en ont tué beaucoup sur place (il y avait des mères et des enfants) comme des brebis enfermées dans l’enclos, la barrière fermée. Ils ont tourney comme des fous en quête d’un abri mais ils ont été jetés à la renverse sur les pierres, les uns après les autres, par une rose mauvaise qui les frappés à la poitrine et à la tempe : dans leurs yeux, un soleil jaune comme les genêts, un soleil vert, un soleil noir de poudre, de lave, de désert. ».
30 Id. Ibid. « Femmes, qu’est ce que ces lamentations et ces cris ? Epargnez votre souffle et votre robe en prévision des nombreux morts qui vont suivre ! »
31 Id., Ibid., « le tissu s’imbiba et rouge sur rouge c’est une illusion, encore une illusion .»
32 Chant de la Commune de Paris.
33 Id., Ibid., :: « Près du fantassin vert-de-gris qui s’élance, en avant, Savoie !, les balata, les noms, présent !, décolorés par le temps qui est passé dessus, les grandes roues et les rayons noirs rongés par la rouille ainsi quet les fûts des canons, avec le drapeau rouge, ils crient : vive le 1er mai, vive les Travailleurs ! »
Un nom étranger relie la signification immédiate que le mot prend dans le texte à d’autres significations, qui se superposent à elle dans le déroulement du texte. Nous ne donnons ici que quelques exemples :
-Il packet-boat :
L’insistance avec laquelle ce mot revient dans plusieurs ouvrages ne peut être fortuite, même s’il s’agit d’une façon sicilienne de désigner le navire. Les mots d’origine anglaise passé par le français, il packet-boat, symbolise l’éloignement de l’île, la distance qui le sépare du monde européen.
-Il marabutto :
Ce mot d’origine arabe est prononcé par le père de Gioacchino (Chino), en réponse à une question de son entourage, il dit où il va pour cacher un Polonais évadé de l’armée allemande. L’enfant ne peut s’empêcher de le ressortir quand les Allemands torturent Delfio pour le faire parler. Il occulte plus ou moins ce mot qui symbolise sa culpabilité pour n’avoir pas pu se taire, car son imprudence langagière a déterminé le destin tragique de ses parents, et peut-être celui de son propre fils, pense-t-il, car l’attitude rebelle celui-ci à l’égard de la société, à l’égard de son propre père incarne au-delà du problème oedipien, une punition pour la faute qu’il a commise enfant. Mais au-delà de cette névrose, c’est la signification même du mot que le romancier découvre à la fin du roman, puisqu’il apprend, au hasard de ses enquête sur l’histoire de la Sicile, que le mot marabutto est une adaptation du mot arabe qui signifie ermite, un religieux qui s’est luimême enfermé dans le silence.
-Il monello :
Bien que ce mot soit un mot italien, il est aussi significatif de la valeur métaphorique de la différence de langue. Ce nom est celui par lequel le film de Chaplin The Kid, est désigné en italien. Lorsque Gioacchino Martinez arrive dans son hôtel parisien, qui a été rénové sous le signe du cinéma, il voit immédiatement une affiche du film. Est-ce un hasard ? En français, le titre anglais n’est pas traduit. Or, le mot monello a une histoire significative : c’est à l’origine un mot d’argot, parola gergale, désignant celui qui doit être réprimandé35, fortement, un voyou, même, puis le mot a pris une signification moins forte, par euphémisme, celui qui n’est pas très sage et doit être grondé. Mais le rapport conflictuel entre le fils du romancier et la société, avec le père symbolisant la société, rapport difficile qui était déjà celui de Chino avec son propre père.
Les insultes en langue étrangère sont une forme de défense, que suggère un enseignant au jeune héros de La ferita dell’aprile et dans Lo spasimo di Palermo. Autre épisode significatif : Dans Lo spasimo di Palermo, pendant un bombardement, le prêtre propose aux enfants une comptine en langue inconnue, une arme contre la peur, mais aussi, peut-être symboliquement, l’arme des mots contre les armes de la guerre
« Fermi, fermi ! Tutti sotto le panche, le mani sulla testa » si mise a vociare il prete. E nella breve pausa, dopo le prime raffiche, ordinò di cantare l’aria con parole senza senso, ch’erano forse parodia, scherno d’una lingue :
Sukkerlain suttreklain
Kulì jutek ansamadain
Ma sei ni kuskei dublei
Kulì brudak mundai mundei
Suleik dindi moni dindindin
Suelik dindi moni dindindind36…
34 Id., Lo spasimo di Palermo
35 Gianfranco Folena, Semantica e Storia di « monello », in Lingua Nostra, XVII, 1956, p.
65-77, et Id., « Ancora maonello-famiglie », ibid., XVIII, p. 33-35
36 Id., Lo spasimo di Palermo : p. 14 : « « Arrêtez, arrêtez! Tous sous les bancs, les mains
sur la tête » se mit à crier le prêtre. Et dans la brève pause, a^rès les premières rafales, il
odronna de chanter l’air avec de sparoles dépourvues de sens, qui étaient peut-être une
parodie, la dérision d’une langue. – Sukkerlain suttrekalin… »
Le silence même suggère les cris, hurlements si terribles qu’ils sont muets, de toutes les victimes des catastrophes « naturelles » ou provoquées par la folie meurtrière des sociétés humaines, cris silencieux sortis de la bouche grande ouverte des victimes, dans un visage aux yeux exorbités par la peur que représentent tableaux, fresques et sculptures de l’art baroque :
Un cielo livido come nelle Crocefissioni di Antonello, piane colli monti privi d’ombre, sfumature, d’una insopportabile evidenza ; un tempo immobile, sospeso, e un silenzio attonito, rotto da ulular di cani, strider d’uccelli, nitriti di cavalli : un mondo che sembra attendere da un momento all’altro la sua fine : l’uomo, di consegnarsi ineluttibilmente all’ultima certezza. Il cui panico Michelangelo ha rappresentato nel Giudizio in un personaggio (in basso, sul lato dei dannati, un occhio reso cieco da una mano, l’altro sbarrato, con dentro lo sgomento)37.
Les cris se confondent avec les grondements terribles de la mer déchaînée et des ouragans en furie et des volcans et de la terre dans les éruptions et les secousses sismiques, sifflements des sirènes et des bombes, etc. A la fin du Spasimo di Palermo, est évoqué le tableau La montée au Calvaire, que Raphaël a peint à la demande des prêtres ulivetani, qui a ensuite été offert au roi d’Espagne de sorte qu’il est maintenant à l’Alcazar de Madrid38
La métaphorique, c’est aussi celle du cri muet de Munch, l’horreur de l’éruption du champignon atomique.
Mathée GIACOMO-MARCELLESI
,37 Id & Giuseppe Leone, Il barocco in Sicilia : l a rinascita del Val di Noto, Milano, Bompiani, 1991, p. v. : « Un ciel livide comme dans les crucifixions d’Antonello, platine collines montagnes sans ombre, sans nuances, d’une évidence insupportable ; un temps immobile, suspendu ; et un silence étouffé, interrompu par des hululements de chiens, des cris stridents d’oiseaux, des hennissements de chevaux ; un monde qui semble attendre d’un moment à l’autre sa propre fin ; l’homme qui semble attendre de pouvoir se confier inéluctablement à l’ultime certitude et dont la panique est représentée par Michelange, chez l’un des personnages de la fresque du Jugement, (en bas, du coté des damnés, un oeil obturé par une main, l’autre oeil exorbité reflétant l’effroi) ».
38 Id. La Spasimo, p.
Nel magma Italia: considerazioni su Consolo scrittore politico e sperimentale
di Massimo Onofri
Non saprei davvero che cosa attendermi, quanto allo studio delle nostre vicende letterarie, da quello che Machiavelli chiamava il «benefizio del tempo». La variante più ottimistica della teoria della ricezione su quel «benefizio» pare confidare molto: rileggetevi quel che scrive Hans Robert Jauss a proposito di due libri, apparsi a stampa lo stesso anno, entrambi incentrati sul tema dell’adulterio, come Fanny di Feydou e Madame Bovary di Flaubert. Secondo lo studioso, se il capolavoro di Flaubert fece fatica ad affermarsi per riuscire a creare poi un nuovo orizzonte d’attesa che l’avrebbe posto al centro del canone romanzesco moderno, il libro di Feydou, nonostante l’immediato e clamoroso successo, venne presto dimenticato, tanto che, se oggi ancora lo ricordiamo, lo facciamo per contestualizzare meglio l’opera flaubertiana. Ma le cose non sono così semplici: se persino La Divina Commedia, in non pochi momenti della sua lunghissima avventura ermeneutica, è stata violentemente espulsa dal canone. Prendiamo l’anno di grazia 1963. Se stiamo ai manuali scolastici d’uso corrente, quella resta ancora la data cui consegnare il Gruppo ’63, gli irresistibili fasti della neoavanguardia, magari in gloria d’una storia della letteratura ridotta a quella degli istituti linguistici. Se ci riportiamo invece alla generazione di critici cui appartengo, e dentro il cantiere aperto d’un giudizio storico in via di ridefinizione, non v’è dubbio che il 1963 sarà l’anno in cui, subito dopo Memoriale (1962) di Paolo Volponi, sono apparsi Nel magma di Mario Luzi, Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, Libera nos a malo di Luigi Meneghello, i racconti di Un caso di coscienza di Angelo Fiore, e, appunto, La ferita dell’aprile di Vincenzo Consolo. Per dire di libri tutti sicuramente inclinabili su un versante di notevole sperimentazione linguistica, ma nella precisa consapevolezza che il problema del linguaggio non potrà mai esaurire, in sé stesso, quello assai più complesso della verità letteraria. Ecco perché non credo che si faccia giustizia a Consolo quando lo si intruppa tra i nipotini di Gadda. Lo dico chiaro: quando tramonterà uno dei più eclatanti dogmi della teoria letteraria novecentesca, quello secondo cui la letteratura, parlando del mondo, non farebbe altro che continuare a parlare soltanto ed esclusivamente di sé stessa (il dogma che ha messo capo all’altrettanto tenace mito dell’intertestualità), tramonterà con quel dogma, inevitabilmente, anche la fama di molti atleti dello stile oggi celebratissimi, i cui libri sembrano confezionati a bella posta per confermare le teorie di critici allevati a batterie dentro falansteri, ove la religione di Jakobson è stata al massimo sostituita dal culto di Bachtin. Sicché: si parli pure di Consolo, magari sotto la stella del grande Contini, come del notevolissimo «romanziere plurivoco e pasticheur», si distingua anche, come fa legittimamente Cesare Segre, tra «plurilinguismo» e «plurivocità», ma senza mai dimenticare che un’analisi linguistica, anche la più strenua e raffinata, dell’intero corpus di questo vitalissimo e sorprendente scrittore non potrà non arrestarsi ai soli preliminari. Consolo, in effetti, se non è un realista, è uno scrittore della realtà: uno scrittore preoccupato del mondo e delle verità che sul mondo possiamo pronunciare, ma anche dell’eventuale retorica della sua manutenzione, intendo la manutenzione del mondo, quella che possiamo identificare con il termine “ideologia”, una parola oggi tabuizzata, che però non lo spaventa affatto, semmai lo provoca, come dimostra in modo assai eloquente l’ultimo suo libro importante, Di qua dal faro (1999). Consolo, ecco il punto, è un miracoloso scrittore politico: laddove il miracolo sta nel fatto che la politica gli si eserciti sulla pagina per via di un’oltranza di stile. Lo sappiamo tutti: Consolo discende prima di tutto da Vittorini, per quella forte tensione in direzione d’una parola-giustizia che resti agonistica, sganciata da ogni facile comunicazione e prossima agli ardui approdi della poesia. Eppure, lo spazio letterario entro cui s’accampa, come scrittore, conosce due grandi poli di tensione: Sciascia e Piccolo. Sciascia: e cioè una deontologia della ragione, una ragione prismaticamente capace di rifrangere tutte le ambiguità della Storia e della Vita. Piccolo: ovvero un’insopprimibile vocazione al canto, ed un rapporto con la verità che possa essere guadagnato attraverso le ragioni della poesia. Se ho parlato insomma di disposizione alla politica, dovrò dunque aggiungere che tale disposizione passa inevitabilmente per la singolare alleanza tra razionalità e prosodia. Non vorrei dimenticare, mentre lo sto impiegando, ciò che il sostantivo “politica”, unitamente a quello di “impegno”, ha significato nella storia di questo martoriato Paese: a cominciare dalla celeberrima polemica tra Vittorini e Togliatti. Sicché non credo sarà inutile un veloce chiarimento preliminare. E allora: in che senso cultura e politica, letteratura ed ideologia possono intersecarsi, senza che per questo la dimensione estetica si neghi a sé stessa, risolvendosi in pedagogia sociale ed oratoria? Non ho dubbi in proposito: la grandezza (e la tenuta storica) di certi romanzi non potrebbe avere altro fondamento che politico, di una politicità che, per essere più rigorosi, chiamerei trascendentale: ad indicare semplicemente una delle precondizioni attraverso cui la letteratura sperimenta i suoi peculiari modi d’accesso alla conoscenza del mondo. Prendete I vecchi e i giovani di Pirandello, che è stato quasi sempre liquidato come un prodotto epigonale del naturalismo: si tratta invece d’uno straordinario romanzo politico, sull’Italia e sugli italiani, sul Risorgimento ed il sicilianismo, come Croce aveva capito subito, anche se per sospingerlo al di fuori delle siderali regioni della poesia. Dirò di più: talvolta quello ideologico e politico può risultare addirittura come l’unico criterio possibile per sanzionare la debolezza o la forza d’un testo, per misurne la sua peculiare qualità gnoseologica. Mi spiego: nessuno potrebbe dubitare dell’alta fattura linguistica d’un libro come Figurine di Faldella, soprattutto dopo che Contini, da par suo, ne ha garantito l’importanza all’interno del suo canone espressionistico. Ma quando si passa da un approccio formalistico ad uno storico-ideologico, dal dogma dell’autonomia del significante (con la conseguente svalutazione della referenza della letteratura) alla fede in una letteratura dialetticamente aperta alla società, la pochezza e l’inanità di un’opera come Figurine appare in tutta la sua evidenza: affollata com’è di bravi giovanotti dell’industrioso nord che si sposano la figlia del padrone, facili sostenitori delle sorti magnifiche e progressive del Paese, stucchevolmente ottimisti e, come si direbbe oggi, politicamente corretti. Un’opera conformistica e persino apologetica Figurine, che, se rapportata ad un romanzo di grande lucidità e ferocia politica come I Viceré di De Roberto, rischierebbe addirittura di scomparire. Proprio quel De Roberto, si badi, cui il sommo stilista Contini è stato del tutto sordo. Bisogna invece affermare che Consolo è stato uno dei pochi intellettuali italiani ad avere avvertito l’importanza di questa specialissima modalità del romanzo, nella convinzione che ciò non implicasse alcuna deroga dalle fondamentali funzioni della scrittura letteraria. In questo senso, certe sue dichiarazioni sono molto chiare, come quando, in conclusione del libro-intervista Fuga dall’Etna (1993), afferma: «Mi sono sempre sforzato di essere laico, di sfuggire, nella vita, nell’opera, ai miti. La letteratura per me, ripeto ancora, è il romanzo storico-metaforico. E poiché la storia è ideologia, come insegna Edward Carr, credo nel romanzo ideologico -anche quelli che scrivono di Dio o di miti fanno ideologia, coscientemente o no-, cioè nel romanzo critico. La mia ideologia o se volete la mia utopia consiste nell’oppormi al potere, nel combattere con l’arma della scrittura, che è come la fionda di David, o meglio come la lancia di Don Chisciotte, le ingiustizie, le sopraffazioni, le violenze, i mali e gli orrori del nostro tempo». Si tratta di parole perentorie dov’è ribadita, non senza implicazioni latamente marxiste, l’attitudine critica e demistificatrice del genere romanzesco -attitudine, lo sottolineo, potenziata, se non addirittura realizzata, attraverso una radicale disposizione metaforica (e, dunque, supremamente connotativa) della scrittura- proprio negli anni in cui il ritorno al mito, al suo potere incantatorio, quando non alcinesco, stava già trapassando dall’antropologia culturale alla letteratura. Il fatto più interessante è che questa rivendicazione del carattere ideologico della propria scrittura creativa passi attraverso una decisa presa di distanza da un altro e pernicioso mito, quello, appunto, dell’intellettuale engagé. Si veda quella fondamentale pagina di Nottetempo, casa per casa in cui il protagonista Petro Marano, personaggio vicario dello stesso Consolo, ormai esule della storia e della vita, si lascia alle spalle un’idea della rivoluzione quale quella propugnata dall’anarchico Paolo Schicchi, gettando in mare il libro del poeta Rapisardi, che lo stesso Schicchi gli aveva affidato come invito alla lotta e come viatico: «Cominciava il giorno, il primo per Petro in Tunisia. Si ritrovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare. Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata la calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore». Lasciamo stare quel che effettivamente potrebbe risultare da una lettura ravvicinata dei versi di Rapisardi: qualche pagina imprescindibile, e non certo a discredito del vate siciliano, ce l’ha già data un giovanissimo Luigi Baldacci nei due volumi ricciardiani dei Poeti minori dell’Ottocento (1958-1963). In Nottetempo, in effetti, Rapisardi non vale tanto in sé, e nella sua concreta vicenda umana, quanto come idolo polemico, nei modi d’un topos già codificato, nella storia della letteratura siciliana, da un sarcastico e brillante Brancati il quale, appunto, aveva opposto al facondo poeta catanese gli strenui silenzi e la severa moralità di Verga. Un idolo polemico, s’è detto e lo si sottolinea: a ricapitolare in sé tutti i tratti d’una poesia civile e politica per così dire ingaggiata, sempre sul punto di travalicare nell’orazione. Siamo dunque ad un primo risultato importante: Consolo è e resta scrittore politico proprio in quanto, nel contempo, elabora una sua implacabile condanna della retorica dell’impegno. Se le cose stanno così, ciò significa che la disposizione politica della scrittura di Consolo si giuoca prima di tutto sul piano della forma che su quello dei contenuti: secondo modalità che si dispongono, come s’accennava già, sul livello della connotazione. Non è davvero un caso se Petro Marano, una volta gettato in mare il libro di Rapisardi, si volge al suo privatissimo quaderno, quello su cui ha appuntato idee e sentimenti, sogni ed utopie, maturandoli nel segno d’una tradizione che da Dante conduce a Leopardi. Né mi pare casuale che la sua scommessa di scrittore, quella propriamente politica appunto -ma d’una politica che dovrà involgere tutta intera l’esistenza-, consisterà nell’allestimento d’un «racconto», dove, insieme alle parole, conteranno soprattutto «il tono, la cadenza». Risulterà chiaro, adesso, che cosa s’intendesse quando s’è parlato di quel miracoloso fatto per cui, sulla pagina, la politica venga effettivamente esercitata attraverso un’oltranza di stile, e non mediante uno scandalo dei contenuti: ragione, questa, che approssima Consolo, prima ancora che a qualche romanziere (ma si potrebbe fare il nome dell’altrettanto politico Volponi), ad un poeta civilissimo, seppur dissimulato nelle sue fibrillazioni d’eremita della lingua, come Andrea Zanzotto, l’unico che, guarda caso, Giocchino Martinez, l’alter ego di Consolo dello Spasimo di Palermo (1998), invidi tra i letterati suoi contemporanei: un poeta appunto, non un romanziere. Ho detto Zanzotto: per dire d’un poeta di precisa e strenua consapevolezza ideologica, di un’ideologia che si esplicita nel linguaggio, e abituto a lavorare sull’ideologia per alchimie sintattiche, fermentazione lessicale, combustioni prosodiche. Ma le alchimie della sintassi, la fermentazione del lessico, la sovraeccitazione prosodica, dentro una più complessa «metrica della memoria», non rappresentano le stesse strategie cui ricorre il narratore Consolo, senza più compromessi, nel segno di un singolare estremismo della verità? Strategie che sono state poi il suo speciale modo di constatare il fatto che, quanto alla scrittura, il problema del come scrivere va ad inglobare inevitabilmente ed a riscaldare, a temperature quasi insostenibili, quello del che cosa scrivere, per una letteratura che, in un’accezione tutt’altro che formalistica, ha fatto della forma una questione di sostanza. Ma torniamo al personaggio Martinez, che pare avere esattissima percezione dei termini del problema. Si veda quanto scrive al figlio, esule a Parigi perché implicato in un’inchiesta sul terrorismo, ad avviare un processo di chiarificazione non più procrastinabile: «Rimaneva in me il bisogno della rivolta in altro ambito, nella scrittura. Il bisogno di trasferire sulla carta -come avviene credo a chi è vocato a scrivere- il mio parricidio, di compierlo con logico progetto, o metodo nella follia, come dice il grande Tizio, per mezzo d’una lingua che fosse contraria a ogni logica, fiduciosamente comunicativa, di padri o fratelli -confrères- più anziani, involontari complici pensavo dei responsabili del disastro sociale». Sia detto per inciso: è stato questo, dentro un’Italia che s’apprestava a decomporsi nelle sue istituzioni, a liquefarsi in magma, il grande assillo degli ultimi anni di Pasolini, il quale s’era attrezzato lucidamente a fronteggiare l’informe e l’irreale per restituirci il suo romanzo più irrealistico ed informale, il suo capolavoro, il postumo Petrolio. Quel Pasolini, si badi, che, già a partire dagli anni Sessanta, aveva teorizzato l’assoluta omologia tra le trasformazioni della lingua italiana ed i processi di ricomposizione neocapitalistica della società. Ma torniamo a Petro Marano, al suo proposito di trovare le parole, il tono, la cadenza per un racconto che avrebbe dovuto sciogliergli il grumo di dolore che si sentiva dentro. Si tratta d’un impegno di canto che da Marano passerà a Martinez, ma dentro un diverso e forse più degradato contesto storico: gli anni pseudodemocratici dell’attentato al giudice Borsellino che si sono sostituiti a quelli dell’incipiente fascismo, pur se sempre contemplati dalla specola siciliana. Martinez -la moglie morta dentro il precipizio della follia, il figlio ricercato dalla polizia- è tornato da Milano a Palermo, ripercorrendo a ritroso il viaggio che è stato dello stesso Consolo: ma si tratta di due città ormai omologate nell’orrore, che patiscono una medesima catastrofe civile. A differenza di Marano, che vive un clima culturale il cui massimo problema è D’Annunzio, Martinez ha alle spalle gli estenuati dibattiti sulla morte del romanzo degli anni Sessanta ed è approdato ad un’assoluta mancanza di fiducia nei confronti d’una lingua comunicativa, razionale e consequenziale, quella di venerati maestri su cui pure s’’è formato come Sciascia e Calvino, che ora rischiano di apparirgli, come abbiamo visto, «complici involontari» dell’apocalisse civile. Martinez aspira ad una parola ieratica e percussiva, che sia all’altezza della tragedia edipica, d’un edipo sociale e personale, che gli è toccato vivere: è assillato, per così dire, dall’utopia di un’antilingua, quella di chi ha letto tutti i libri di Foucault, sapendo bene che proprio il linguaggio, la retorica del discorso, sono i luoghi privilegiati entro cui si costituisce la sintassi del Potere, ecco perché quell’antilingua dovrà valere come il suo contropotere. Ma è incalzato, se non tentato, dal rischio dell’afasia. Vorrei subito sgombrare il campo da un equivoco, quello di chi troppo facilmente sovrappone all’autore Consolo il personaggio Martinez: ravvisando nell’esito dell’afasia un approdo di tipo esistenziale. Non sono certo un fanatico d’un altro mito novecentesco, quello dell’autonomia del significante e della morte dell’autore, rivendico anzi l’importanza delle biografie intellettuali e dello studio delle poetiche: ma ritengo che la distinzione proustiana tra l’«io che vive» e l’«io che scrive» rappresenti un punto di non ritorno nel dibattito teorico sulla letteratura. So altrettanto bene che questo grande tema dell’afasia ci potrebbe condurre ad un’altra ineludibile questione: quella che mette in campo una riflessione di tipo metaletterario sull’irreversibile crisi del romanzo. Una questione che implica la distinzione, in Consolo, tra scrivere e narrare, su cui Giuseppe Traina ha scritto qualche pagina risolutiva nella sua monografia pubblicata per Cadmo nel 2001. A noi interessa qui il Consolo scrittore politico e sperimentale: l’afasia cui ci si riferisce non ha né una valenza psicologica, né estetica, ma solo storica ed antropologica. Anzi: è proprio a questo livello che la ricerca di Consolo e la sua storia di scrittore sembrano caricarsi di futuro. Ancora una precisazione, in conclusione di queste mie considerazioni solo preliminari: Attraverso tre opere strettamente connesse, Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976), Nottetempo, casa per casa, Lo Spasimo di Palermo, Consolo, in linea con una tradizione che comincia con la Sicilia della nuova Italia, ha tracciato tre capitoli di un’incandescente autobiografia della nazione, dal Risorgimento alla nostra contemporaneità. Entro tale quadro, l’afasia di Martinez pare l’unica via d’uscita possibile d’una scrittura politica che ha registrato, al suo massimo grado, l’astrazione e la stereotipizzazione dei linguaggi a fronte della combustione della realtà, d’una realtà che registra ormai il suo più alto livello di depauperizzazione della vita a contrasto d’una sempre più invadente virtualità. Non so quali alternative abbia ancora la letteratura nell’epoca della falsificazione e dell’implosione dei significati: Consolo se n’è trovata una e l’ha percorsa a rischio della consunzione. Proprio per questo resta uno dei pochi scrittori, in Italia, ancora all’altezza delle domande che i nostri tempi impongono.
‘Il dovere del racconto’
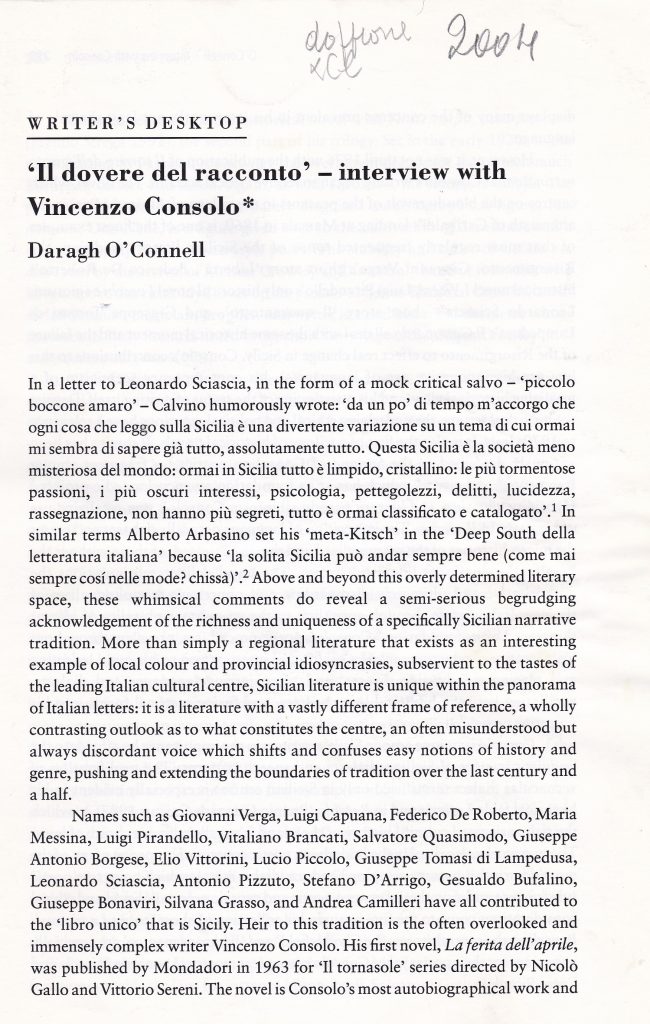
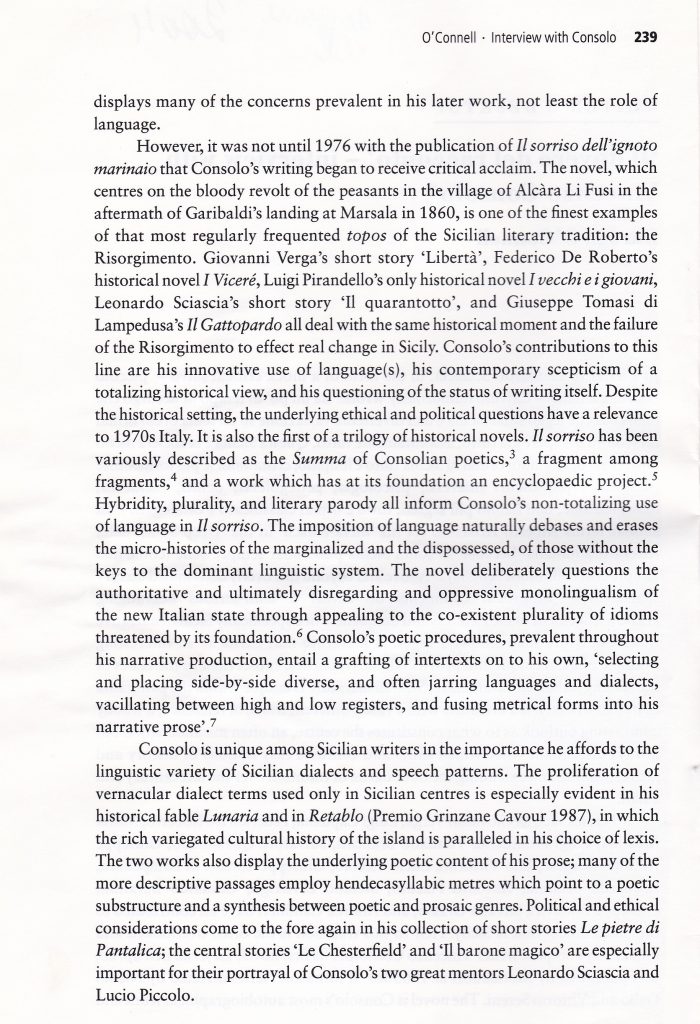
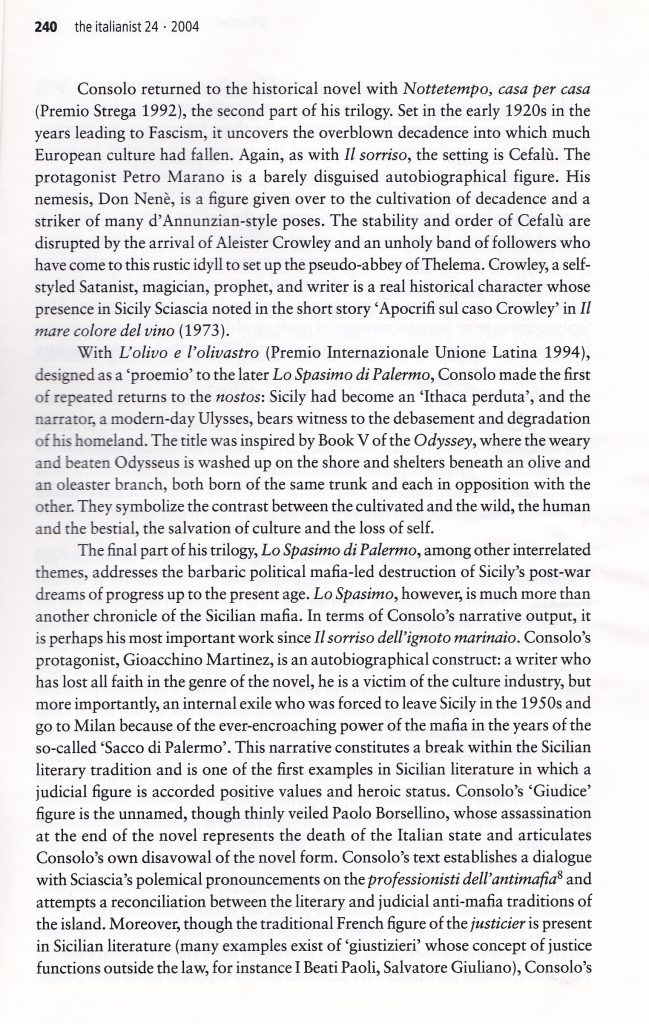
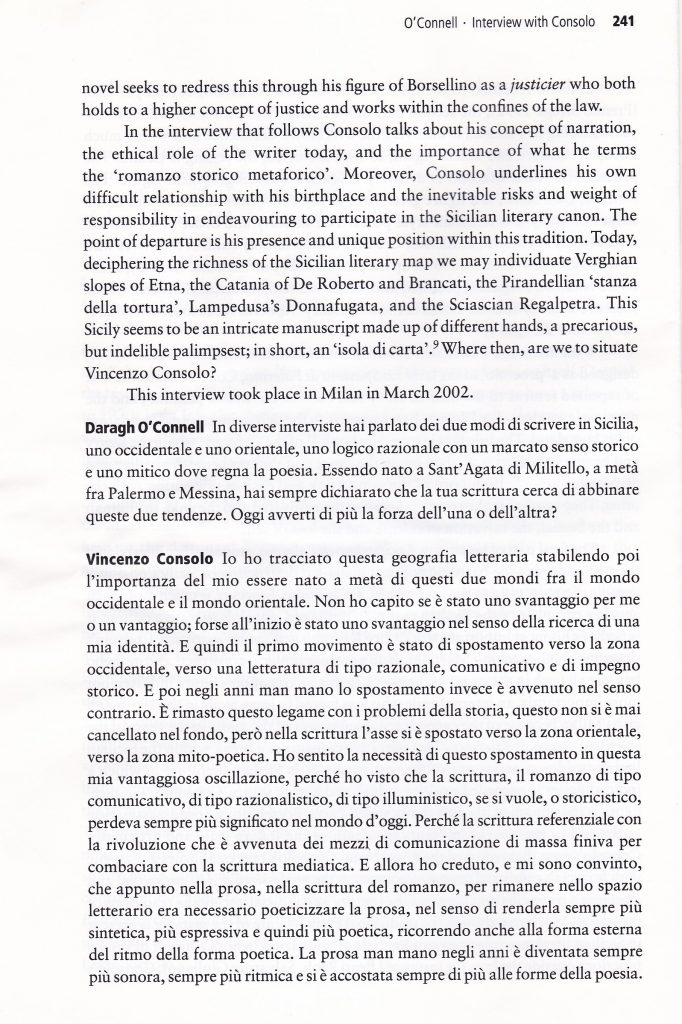
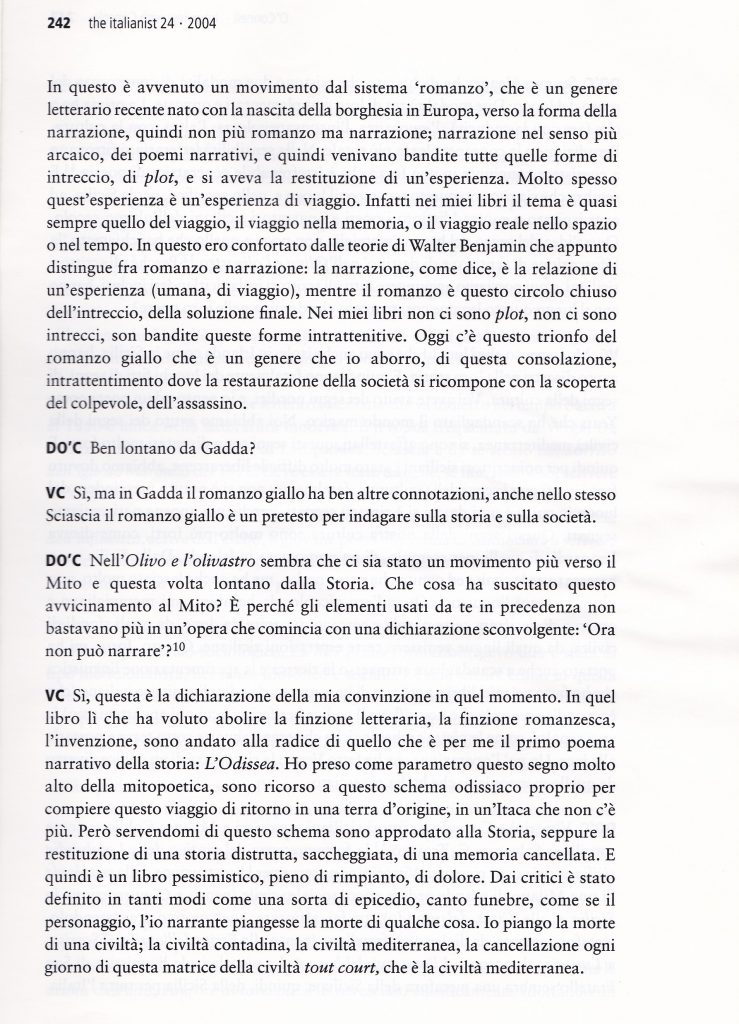
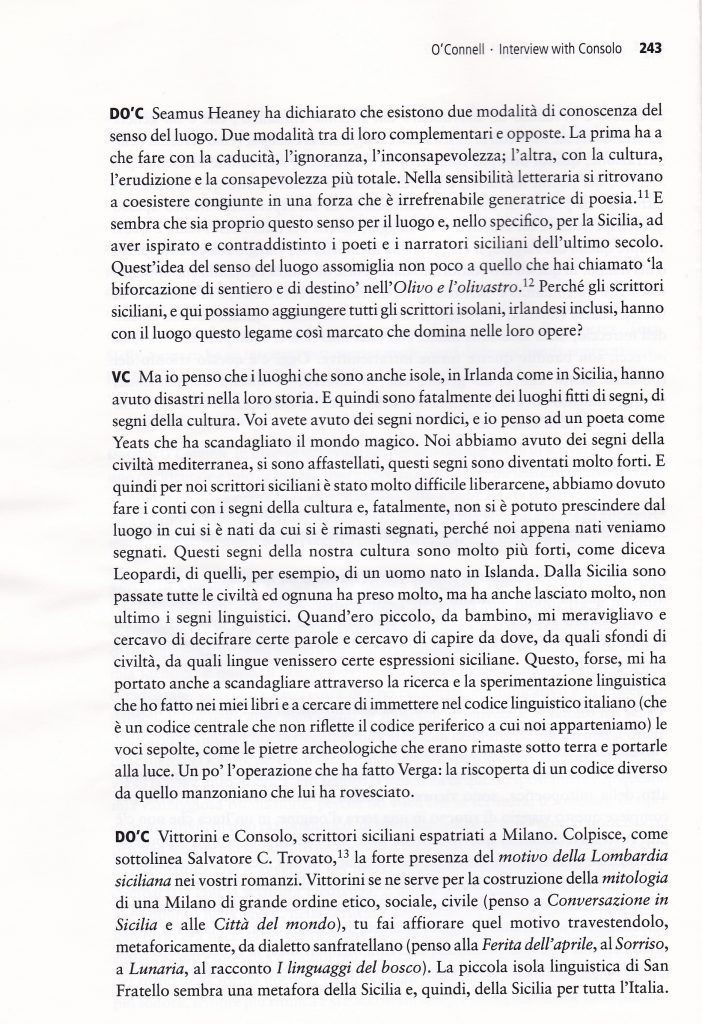
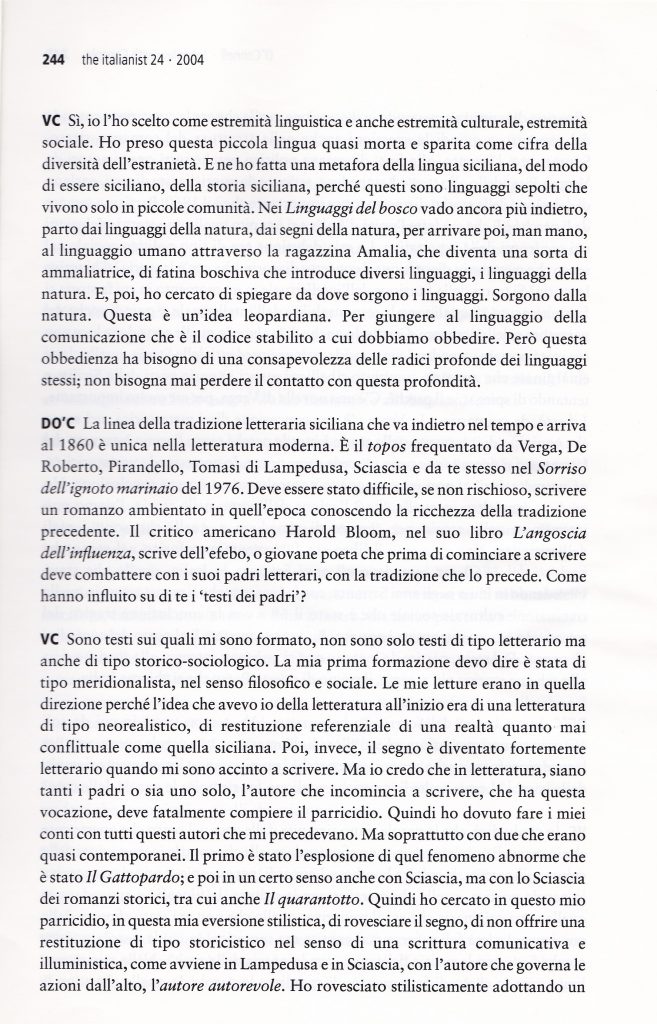
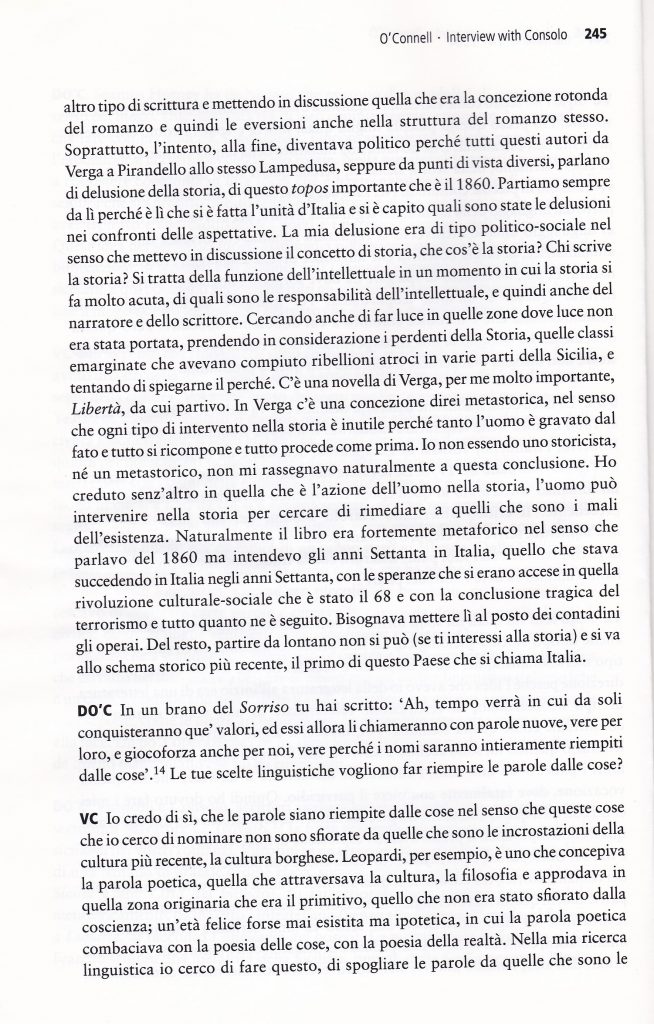
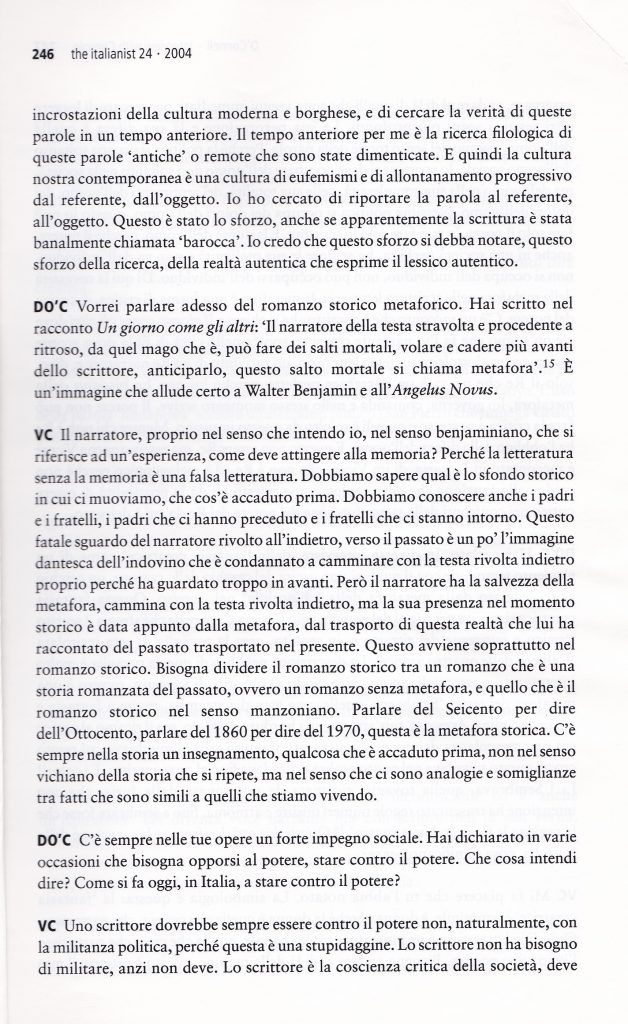
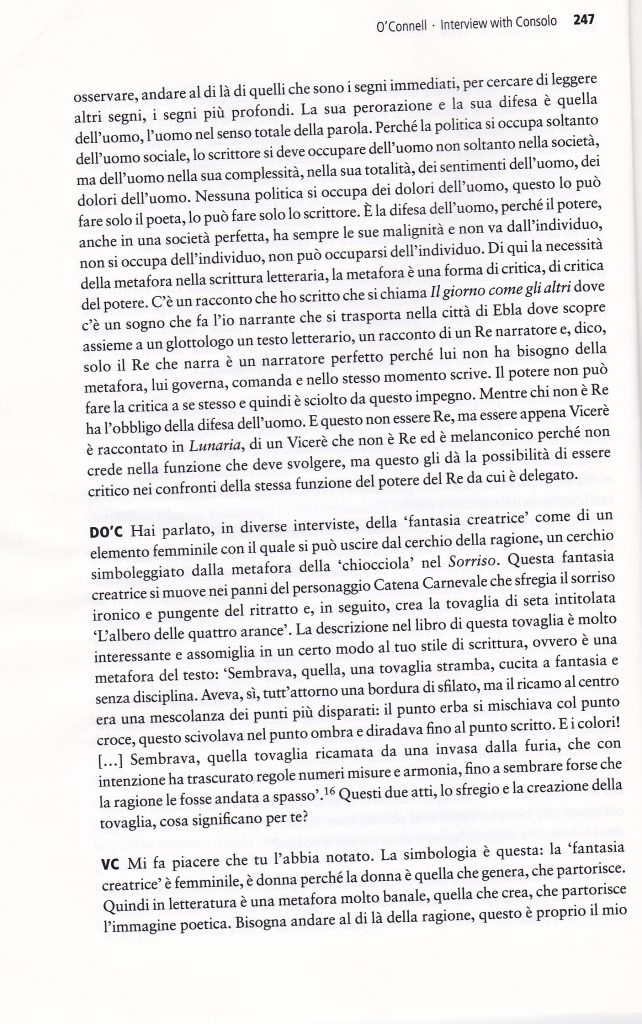
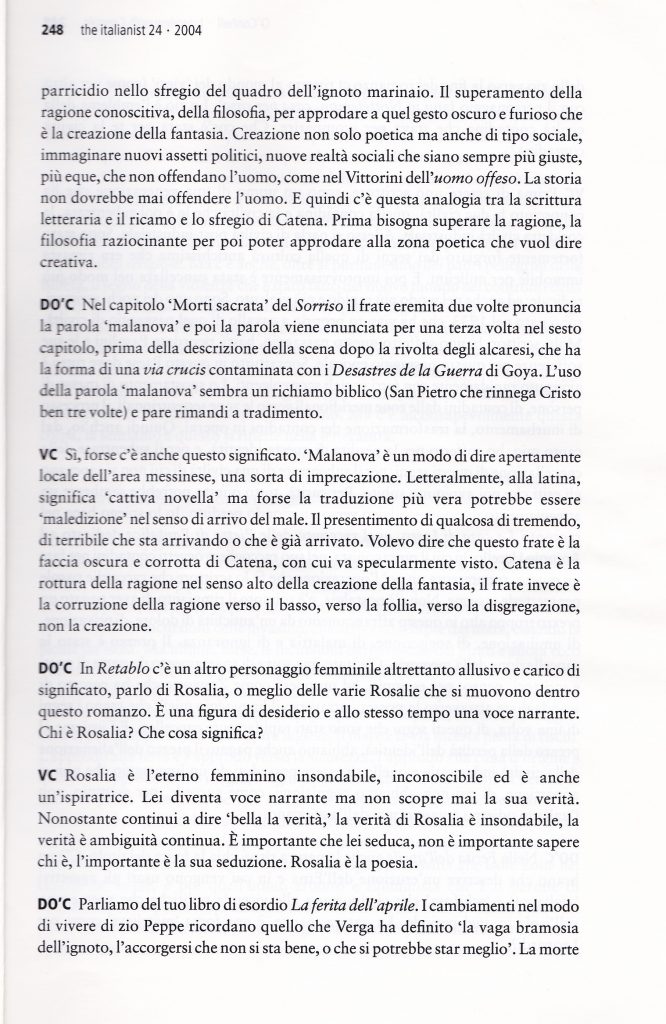
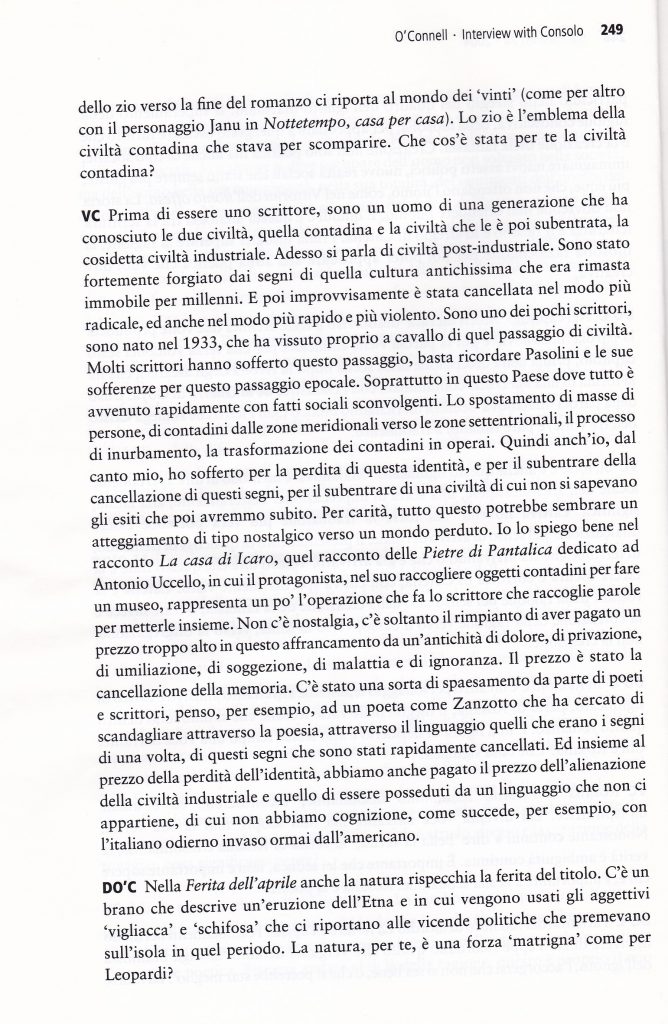
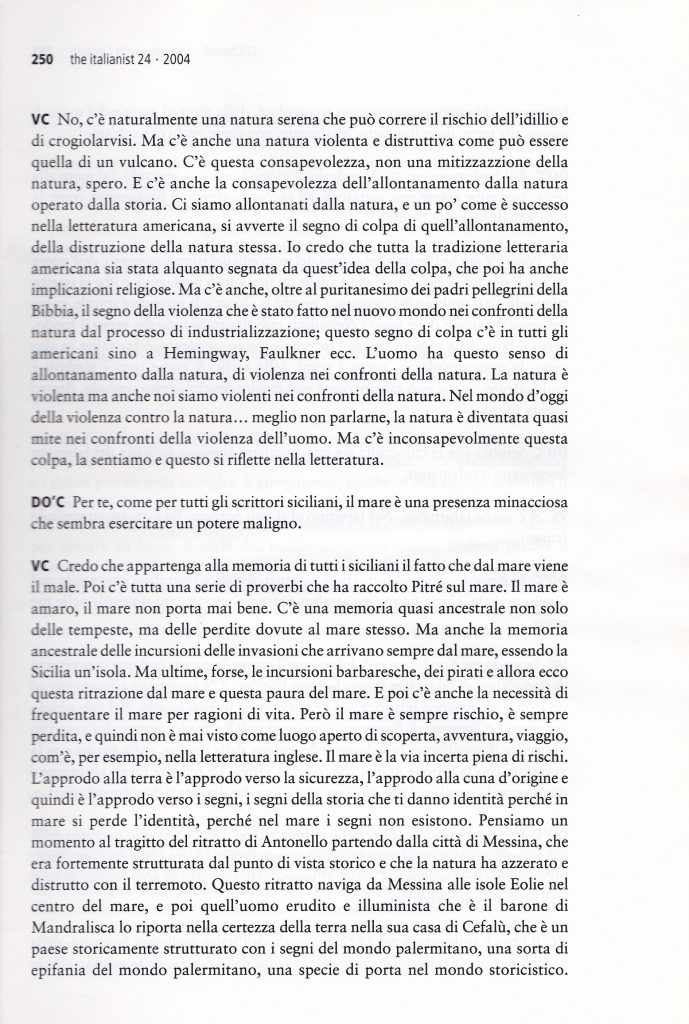
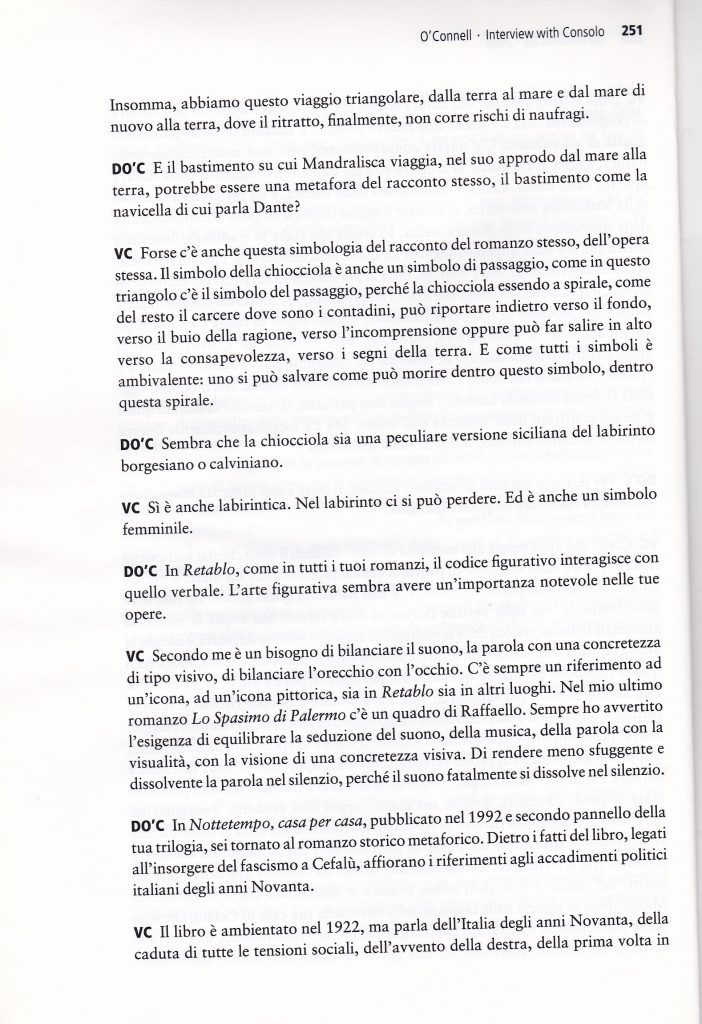
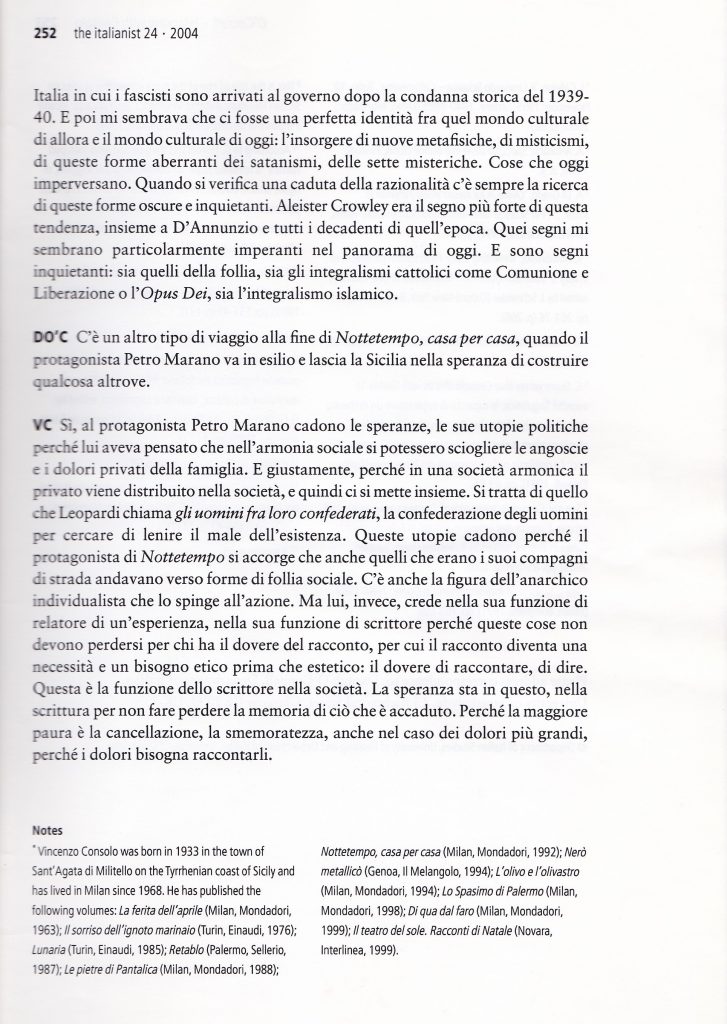
La nebbia gravava sulla città cancellando le guglie del Duomo
La nebbia gravava sulla città cancellando le guglie del Duomo, le cime imbandierate delle impalcature della Galleria, la cella campanaria di S. Ambrogio, la cupola di S. Maria delle Grazie, la sestiga sopra l’Arco della Pace; s’addensava tra gli ippocastani ed i tigli del Parco, e dai Giardini, scivolava le acque dei Navigli. Era una giornata di novembre del 1872, una di quelle giornate milanesi d’autunno in cui chi approda in città per la prima volta, chi approda dal Sud rimane meravigliato – guardando in alto – che il sole velato e docile possa essere fissato ad occhio nudo al pari di una rossastra luna notturna.
In quella giornata di novembre arrivava a Milano un Siciliano di nome Giovanni Verga. Aveva abbandonato da parecchio gli studi di giurisprudenza e aveva deciso, aiutato dalla madre Caterina Di Mauro, di trasferirsi in Continente per dedicarsi alla letteratura.
Certo, non è che la sua esclusiva professione di letterato, di scrittore, per uno che usciva da una famiglia borghese o di piccola nobiltà appena benestante, non fosse avventurosa; ma crediamo che la famiglia Verga avesse approvato la decisione del figlio perché c’era stato il precedente di Domenico Castorina, loro cugino, poeta e romanziere, mandato in altitalia a spese del comune di Catania per completare e pubblicare un poema in versi. C’era forse anche la suggestione del locale mito artistico per eccellenza, del “cigno di Catania” Vincenzo Bellini, che in Continente aveva raggiunto fama e gloria; e poi Giovanni, precoce come Bellini, aveva dato già buona prova del suo talento e della sua passione letteraria: aveva scritto a 15 anni il suo primo romanzo “Amore e Patria”, a 20 “ I carbonari della montagna”, a 23 “Sulla laguna”.
Milano non era la prima tappa a nord di Verga; c’era stato già un soggiorno di sei anni a Firenze dove si era trasferito nel 1865; Firenze, nuova capitale politica del Regno e vecchia capitale letteraria e linguistica d’Italia. In questa Firenze splendida e suggestiva per un giovane provinciale ambizioso e determinato, Verga abbandona i temi storici e patriottici dei primi romanzi per avventurarsi in quelli amorosi, passionali e mondani. A Firenze, sono ora infatti ambientate “Eva”, “Tigre reale” ed “Eros”. Ma subito, come punto dalla nostalgia, abbandonati i salotti, i concerti, le passeggiate in carrozza alle cascine, ritorna in Sicilia, a Vizzini, alla sua viva memoria di adolescente, al ricordo di una fanciulla timida, triste, malaticcia, chiusa in un convento come una capinera in gabbia, con il romanzo che gli darà la notorietà e gli farà da biglietto da visita per il suo ingresso nel mondo e nella mondanità milanese. La “Storia di una capinera” e l’esotismo del suo autore, giovane meridionale sottile ed elegante, olivastro e pallido, capelluto e baffuto, dall’occhio color della lava, romantico e fatale insomma, fanno subito di Verga un personaggio di spicco nei salotti: nel salotto della contessa Maffei, della Castiglione, Cima, Ravizza, Gargano. “La prima volta che lo vidi fu a causa della Maffei, una domenica sera, e le due salette erano piene di signore, tra cui sei o sette giovani e belle, e queste lo circondavano in tal modo che io non potei appressarmi a lui”; questo scrive Roberto Sacchetti. Il successo dello scrittore Siciliano con le donne scatenerà la gelosia feroce –oltre che a un certo razzismo- di Carducci, il quale temeva che anche la sua amante Lidia fosse caduta vittima del fascino del “bel tenebroso”: un uomo che mette una brutta corona baronale sulla sua carta da visita, che si lascia dare falsamente del cavaliere, e che scrive un romanzo epistolare, e con tutto questo è anche Siciliano, non può che essere altro che un vigliacco, ridicolo, “parvènu”. Ma contrariamente a quanto possa far credere quest’ira schiumosa del vate d’ Italia, e anche senza sposare la tesi di una misoginia verghiana sostenuta da Carlo Matrignani nell’introduzione a Giovanni Verga dei “Drammi intimi” di Sellerio, ora Verga non è un personaggio brancatiano, non è un “Paolo il caldo” che dissipa il suo tempo e il suo talento passando ossessivamente da una aventura amorosa ad un’altra, è un metodico e intransigente lavoratore che concede ai riti mondani solo le poche ore di libertà. Dalla sua prima dimora in piazza della Scala, e di qui alle sue successive dimore in via Principe Umberto e Corso Venezia, muoveva per andare al “Cova”, al “Biffi”, alla “Scala” per passare la serata in uno dei salotti alla moda, per fare le sue passeggiate per le vie del centro. Di una eleganza un po’ troppo puntigliosa nel suo “tight”, nella sua marsina, forse eccessivamente inamidata nella forma, non frequentava certo l’osteria del “Polpetta” di via Vivaio, il ritrovo degli “Scapigliati”, anche se con alcuni di questi aveva stretto rapporti di amicizia. Ma, come sempre capita agli immigrati, sono i conterranei che più frequenta il Verga: quella piccola colonia di Siciliani formata da Onofrio, Farina, Auteri, Navarro della Miraglia, Scontrino, Avellone, a cui si aggiungerà poi Capuana, che il Verga con incessanti lettere aveva convinto a trasferirsi a Milano: “Tu hai bisogno di vivere alla grand’aria come me, e per noialtri infermi di nervi e di mente la grand’aria è la vita di una grande città, le continue emozioni, il movimento, la lotta con noi e con gli altri, se vuoi, pur così…; tutto quello che senti ribollire dentro di te irromperà improvviso, vigoroso, fecondo, appena sarai in mezzo ai combattenti di tutte le passioni e di tutti i partiti; costà tu ti atrofizzi” così scrive nel ’ 74 Verga al suo più caro amico e confratello. Scrive così il Verga che certo vuole strappare dalla provincia il Capuana, sottrarlo alle divagazioni e dissipazioni che gli impegni politici e privati imponevano allo scrittore di Mineo; ma crediamo che, dopo due anni di soggiorno milanese, sente come il bisogno – di fronte a quella realtà, nell’affrontare quella vita che vertiginosamente cambiava sotto i suoi occhi – di un compagno di strada, di un amico fidato, con cui discutere per potere capire. “Si Milano è proprio bella, amico mio, e qualche volta c’è proprio bisogno d’una tenace volontà per resistere alle sue seduzioni e restare al lavoro”, aveva scritto al Capuana. Ma era soltanto della Milano quando Verga vi giunse nel ‘ 72?
Nel ’ 72 Milano contava 250.000 abitanti; era una città in pieno fermento industriale ed edilizio. Gli opifici della seta e dei latticini, della pasta, della gomma e di altri prodotti ammodernavano i propri impianti. La ditta Pirelli & C, fondata dal ventiquattrenne ingenier Giovanni Battista Pirelli, inaugurava la sua fabbrica per la produzione di oggetti in gomma plastica e guttaperca. Dalla nuova Stazione Centrale partivano le linee per il Veneto, il Piemonte, la Toscana, la Liguria, l’Emilia, il Lazio e giù fino alle Marche. La città in fermento aveva anche bisogno di ristrutturarsi e di espandersi: si sistema poi la piazza del Duomo; erano già stati iniziati i lavori per la Galleria la cui esecuzione, affidata ad una società inglese, era diretta dall’architetto Mengoni che in bombetta e spolverino si faceva fotografare sulle impalcature. Da quelle impalcature il povero Mengoni poi, accidentalmente precipiterà trovando la morte. Il duca Melza d’Eril offre al comune una vasta area per nuovi palazzi fuori Porta Nuova. A Porta Ticinese sorge una nuova stazione sussidiaria, e sorgono anche case operaie in via Solforino e Montebello. Il 4 settembre 1872 veniva inaugurato in piazza della Scala il monumento a Leonardo da Vinci. Nello stesso anno era stato aperto al pubblico il Teatro “Dal Verme”, quel teatro “Dal Verme” dove si darà poi la “prima” della Cavalleria rusticana. Sempre nel ‘ 72 si organizzano a Roma e Torino congressi di sezioni e federazioni operaie aderenti all’Internazionale dei Lavoratori.
Cominciavano tra il ‘ 75 e il ‘ 76 le inchieste in Sicilia promosse dal Parlamento e condotte da studiosi come Fianchetti e Sonnino, da giovani colti e disinteressati, come dice Capuana nel saggio “La Sicilia e il brigantaggio”. Dalla Sicilia arrivavano dalle delegazioni dei prefetti le notizie più preoccupanti sulla mafia, sulle condizioni dei contadini e degli zolfatari; dell’inchiesta Fianchetti e Sonnino, quello che aveva colpito di più la opinione pubblica era stato il capitolo supplementare dal titolo “Il lavoro dei fanciulli nelle zolfare Siciliane”; si alzava per la prima volta il velo su una terribile realtà pressoché sconosciuta, e l’Italia ne rimaneva inorridita. Anticipando quì in tanto un nostro assunto – di cui diremo più avanti – se “Nedda” del ‘ 75 può essere stata scritta dal Verga sulla spinta di un bisogno di un ritorno sentimentale in Sicilia, in una Sicilia contadina sepolta nella memoria, vista e conosciuta nella sua verità negli anni dell’adolescenza, possiamo ipotizzare che “Jeli il pastore” e “Rosso malpelo”e “Vita dei campi” dell’ 80 siano stati dettati dalla presa di coscienza di un’altra Sicilia, attraverso lo specchio delle sopradette inchieste? Presa coscienza dell’assoluta naturalità dell’intatto mondo ultraliminare, presociale del tredicenne guardiano di cavalli di Tepidi e di Jeli, della disumana, terrifica, quasi onirica, quasi metafisica condizione cunicolare, labirintica del capomonte Malpelo; l’una e l’altra tanto simili alle condizioni dei contadini e dei “carusi” delle zolfare di Franchetti e Sonnino.
Ma andiamo con ordine; ritorniamo a Milano, ritorniamo alla profonda trasformazione, al fermento di innovazione in campo industriale, sociale, urbanistico di cui la società è preda a partire dal 1872, innovazione e trasformazione che trova il suo culmine e la sua massima espressione nell’Esposizione Nazionale dell’ 81. Quell’anno Verga abita in Corso Venezia, all’angolo dei Bastioni di Porta Manforte, e l’Esposizione si svolge vicino a casa sua da via Senato ai Bastioni di Porta Venezia, occupando il boschetto e i Giardini. Molti letterati che credono nel progresso inneggiano all’Esposizione: Boito tiene una conferenza nel padiglione delle arti; alla Scala, durante i giorni dell’Esposizione si rappresenta il “Ballo Excelsior”, l’opera Romualdo Marengo su libretto di Luigi Manzotti. I temi dei vari quadri del balletto sono: l’Oscurantismo, la Luce, il Primo battello a vapore, i Prodigi dell’invenzione, il Genio dell’elettricismo, e via di queste immagini; il balletto si conclude con l’inno alla Scienza al Progresso, alla Fratellanza, all’Amore. Scrive Manzotti nella prefazione al libretto: ”Vidi il monumento innalzato a Torino in gloria del portentoso traforo del Cenisio, e immaginai la presente composizione coreografica, e la titanica lotta del progresso contro il regresso, che io presento a questo intelligente pubblico, e la grandezza della civiltà che vince, abbatte e distrugge per il bene dei popoli l’Antico potere dell’Oscurantismo che li teneva nelle tenebre del servaggio e dell’ignominia”: ce n’era abbastanza… E anche se il simbolismo retorico dell’ “Excelsior”, il suo ingenuo declamatorio ottimismo in un progresso al ritmo di mazurca non sono da paragonare alle “magnifiche sorti e progressive” del Mariani, o al “migliore dei mondi possibili” del Leibniz, avranno sicuramente suscitato nell’animo di Verga reazioni o sentimenti simili a quelli espressi nel leopardiano pessimismo cosmico della “Ginestra”, o nel volterriano scetticismo rappresentato con sprizzante ironia dal Candido. E non certo il solo, leggero Ballo Excelsior (ammesso che Verga l’abbia visto rappresentato alla Scala), ma tutto quanto avveniva sotto i suoi occhi, l’affacciarsi alla ribalta e prendere direzione e potere economico di una nuova intraprendente borghesia imprenditoriale, da una parte, dall’altra, un organizzarsi e prendere parola di una plebe che si fa popolo, si fa mondo del lavoro e che antagonisticamente reclama e difende i suoi diritti. Non a Firenze ma a Milano gli si rivela tutto questo, nella Milano industriosa e laboriosa, capitale della scienza e della tecnica, gli si rivelano due mondi in movimento, due realtà insieme complementari e in conflitto, che dai salotti nobiliari, dalle strade del lusso, dai luoghi conclamati dell’arte difficilmente si potevano scorgere; e neanche si intravedevano dalle crepuscolari patetiche portinerie, dai bastioni, dai viali, dalle gallerie, dai veglioni alla Scala, dalle osterie, da tutti i luoghi frequentati da dimesse e rassegnate sartine, commesse, doganieri, servette, soldati, ballerine, da tutte le persone che “non sbraitano, non stampano giornali, non si mettono in prima fila nelle dimostrazioni” (questo è un brano tratto da “Per le vie”, un racconto intitolato “Piazza della Scala” di Verga). A Milano si rivelano al Verga delle nuove storie, gli si rivela una nuova storia di cui non ha cognizione, memoria, linguaggio e di fronte alla quale si ritrae sbigottito, si ritrae da questo capitalismo inventivo e intraprendente per rifugiarsi nell’arcaico capitalismo terriero e feudale della sua Sicilia.
Nasce a questo punto nello scrittore il bisogno di risalire alle origini e risuscitare le memorie pure della sua infanzia e riprendere contatto con la sua terra, alla quale egli ritornava con l’animo del figliol prodigo, come all’unico bene che ancora gli rimanesse intatto e solido dopo tanta dissipazione.
Ben vicino e tangibile, eppure indecifrabile e remoto come un miraggio, come l’ideale oggetto di una suprema e già disperata nostalgia” scrive Natalino Sapegno. Un mondo intatto e solido fuori dalla storia, e in contrasto, nel suo movimento circolarmente chiuso, con l’illusione del cammino progressivo della storia. Recupera quindi il suo mondo, Verga, memorialmente e soprattutto linguisticamente, con una lingua che appartiene al mondo narrato e anche al soggetto narrante, che poi significa – per la teoria dell’impersonalità di Verga – al mondo che si narra da sé. Una lingua che non è matericamente e naturalisticamente la sua lingua dialettale, ma un italiano irradiato di sentimento e di ideologia dialettale, una lingua periferica in conflitto con la lingua centrale: conflitto da cui nasce la poesia, come dici Luigi Russo. Non finiremo mai di ringraziare gli ingegneri e gli industriali milanesi che, con il loro attivismo ed il loro progressismo, ci hanno restituito uno scrittore della grandezza del Verga; gli stessi ingegneri e industriali, la stessa borghesia milanese, che in anni più recenti, ci darà uno scrittore come Carlo Emilio Gadda.
L’81, storica data dell’Esposizione Nazionale e della pubblicazione dei “Malavoglia”, non è l’anno della caduta di Verga da cavallo sulla via di Damasco, o sui viali del parco di Monza; la conversione naturalmente ha radici più profonde, comincia a serpeggiare da epoche remote, dal ’74 almeno, dall’anno di pubblicazione di “Nedda”, e ancora dal ’75, quando Verga pubblica sull’Illustrazione Universale di Emilio Treves, in quattro puntate, una strana novella, un racconto gotico, nero: “Storie del Castello di Trezza”; quel racconto è affatto giovanile, primitivo, è vecchio di già; “è un mio vecchio peccato di gioventù, quella novella” scriverà Verga al suo traduttore Edoardo Rod e aveva a quell’epoca 35 anni e una solida fama di scrittore; in quella brutta novella Verga si scopre a guardare giù da sopra gli spalti del Castello di Trezza, il mare ed il paese di Acitrezza; guarda attraverso Donna Violante, uno dei personaggi del racconto: “il mare era levigato e lucente, i pescatori sparsi per la riva o aggruppati davanti agli usci delle loro casupole chiacchieravano della pesca e del tonno e della salatura delle acciughe; lontano lontano, perduto fra la bruma distesa, si udiva a intervalli un canto monotono e orientale; e sorprese sé stesa, lei così in alto nella fama dorata di quella dimora signorile, ad ascoltare con singolare interesse i discorsi di quella gente posta così in basso, ai piedi delle sue torri; poi guardò il vano nero di quei poveri usci, il fiammeggiare del focolare, il fumo che svolgevasi lento lento dal tetto.” Siamo qui ad una vera propria epifania, ad un “introibo”, e qui forse bisognerebbe – dopo aver raffrontato questo Castello di Trezza con la torre di Sandycove sulla spiaggia all’apertura dell’Ulisse di Joyce, da cui parte l’Odissea linguistica di Stephen Dedalus: “introibo ad altare Dei” incomincia con sarcastica solennità il suo amico Mulligan-Cristostomo – soffermarsi sulla posizione così in alto da cui si guarda al mondo degli umili e scoprire che Verga, nonostante la scientificità e l’obiettività del suo punto di vista, nonostante l’impersonalità del risultato, non sfugge a quanto Natalino Sapegno dice dei veristi: “Il verista italiano rimane in sostanza il gentiluomo che si piega a contemplare con pietà sincera ma un tantino condiscendente la miseria materiale e morale in cui le plebi sembrano immerse senza speranza in un prossimo futuro”; sono insomma, i veristi italiani secondo Sapegno, tutti afflitti dal complesso del “signor Marchese con… asterischi” del XXVIII capitolo dei Promessi Sposi, l’erede di don Rodrigo che serve a tavola Renzo, Lucia, Agnese e la mercantessa, ma che non si abbassa a mangiare insieme a quella buona gente.
E’ un serpeggiare, quello della conversione, con “Nedda” e con “Storie del Castello di Trezza”, sotterraneo e subcoscenziale; ma dopo il suo sgorgare alla superficie con “Cavalleria Rusticana” e con “La Lupa”, ancora intrise nel loro impeto di pietre dialettali e di terriccio toscano, ecco che con “Fantasticheria” siamo alla piena coscienza, siamo come al manifesto della nuova poetica, alla dichiarazione d’intenti del suo futuro lavoro il quale raggiungerà da lì a poco le vette di “Jeli il pastore” e “Rosso Malpelo” e si dispiegherà nei due grandi poemi dei “Malavoglia” e di “Mastro don Gesualdo”
Con l’abbandono di Milano, col ritorno a Catania in quella sua casa di via S. Anna, tutto denunzia la volontà dello scrittore di rimanere chiuso nella prigione di una rigorosa solitudine. Risalendo dal limite estremo della spiaggia, dai faraglioni del mare di Acitrezza, su verso le chiuse e le masserie di Vizzini, fino alle soglie dei palazzi nobiliari di Palermo, ripercorrendo tutti i livelli linguistici a noi noti, da quelli dei pescatori e dei contadini a quelli dei proprietari terrieri Siciliani, Verga sarà incapace di andare oltre. Dalla frase musicale d’attacco del primo romanzo del ciclo dei vinti “Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza”, all’ultima tragica frase del Mastro don Gesualdo che si spezza in un crescendo come in un’opera di Wagner “tutto! Pigliatevi tutto! Lasciatemi stare! L’Alia, la Canziria! Lasciatemi stare!” Verga non sarà più capace di orchestrare, di modulare le frasi nei saloni del Palazzo palermitano del duca di Leira. Risentito e scontento, dissiperà così il suo tempo a Catania, tra la casa e il Circolo dell’Unione, la conduzione del giardino d’agrumi di Novaluccello, le beghe giudiziarie, la cura e l’amministrazione dei beni dei nipoti, la corrispondenza con Tina di Serdevolo e i periodici viaggi in Lombardia e in Svizzera; e si chiuderà man mano in sé stesso, in una solitudine e in un’accidia senza rimedio. Dice sempre di lavorare alacremente alla “Duchessa di Leira”, ma pubblica i due bozzetti teatrali “Caccia al Lupo” e “Caccia alla Volpe” e pubblica anche, forse sulla spinta delle rivolte socialiste del ’93 di contadini e zolfatari, in opposizione ad esse, “Dal tuo al mio”, un dramma teatrale che poi diventerà romanzo: il 2 settembre 1920 si rifiuterà di presenziare, al Teatro Massimo di Catania, ai festeggiamenti in suo onore per l’ottantesimo compleanno. Pirandello, in quella occasione, leggerà il suo celebre saggio sul grande scrittore catanese, e Verga l’indomani andrà a trovarlo in albergo per dirgli: “perdonami, Luigi; a te tutta la mia gratitudine; ma dall’Italia ufficiale non voglio onoranze”. Diceva questo a quel Pirandello che, con precise disposizioni testamentarie, si sottrarrà a sua volta, morendo, alle manifestazioni ufficiali che il regime fascista gli avrebbe con certezza tributato.
Verga muore nel gennaio del 1922 nella sua casa di Catania. Lì si concludeva la vita di questo grande scrittore emigrato al Nord e ritornato nella terra da cui era partito, la vita del primo autore della letteratura Siciliana moderna che sente il bisogno di lasciare la periferia d’Italia, d’Europa, di lasciare l’Isola e approdare a Milano, al centro “ideale”, a quella che Salman Rushidie chiama la “patria immaginaria”. Dopo e insieme a Verga è il confrère Luigi Capuana che approderà a Milano nel 1887 e vi rimarrà fino al 1880. Verga “scrive” Milano nelle dodici novelle di Per le vie, e scrive in un libro collettivo dal titolo Milano nella sua vita, nell’arte, nei suoi costumi e nell’industria (1896) un testo, I dintorni; e Capuana, nello stesso volume, appare il brano In Galleria.
È Verga che terrorizza la necessità della ” distanza “, della lontananza dalla Sicilia per scrivere della Sicilia. In una lettera del 1878 scrive a Capuana: “… da lontano, in questo genere di lavori, l’ottica qualche volta, quasi sempre, è più efficace d’artistica, se non più giusta, e da vicino i colori sono troppo sbiaditi… “. Questa affermazione di Verga si può costare a un’altra di Nikolaj Gogol’: ” io posso scrivere della Russia stando a Roma. Solo da lì essa si erge dinanzi in tutta la sua interezza, in tutta la sua vastità “.
Nel 1918 arriva a Milano, proveniente da Roma, Giuseppe Antonio Borgese, arriva in una città tutta imbandierata per le celebrazioni della vittoria della Grande Guerra. E sulla prima guerra mondiale e sul dopoguerra, Borgese, già famoso per i suoi saggi letterari, scriverà il romanzo Rubè , che si svolge tra Milano, il Lago Maggiore, Roma e la Sicilia, la terra del protagonista Filippo Rubè. Scrive già da anni, Borgese, sul Corriere della Sera, e a Milano insegna alla Accademia Scientifico-Letteraria; nel ’26, sarà creata per lui, all’università, la cattedra di estetica. Nel 1931, lo scrittore abbandonerà Milano ed emigrerà in America per ragioni politiche, per opposizione al fascismo. E in America pubblicherà, nel 1935, il libro Golia, marcia del fascismo. E in Golia ritornerà a scrivere di Milano, delle ragioni culturali politiche per cui possa esser nato in questa città, nel paese un fenomeno come Mussolini, possa esser nato il fascismo. Racconta, fra l’altro, di una serata del gennaio del 1919 alla Scala, il cui il vecchio socialista Leonida Bissolati teneva una conferenza. Da un palco di proscenio, Mussolini insieme a Marinetti cominciò a rumoreggiare, a disturbare la conferenza. Bissolati si fermò e guardò verso quel palco e riconobbe Mussolini.
” Volse la testa verso gli amici che gli erano vicini e disse a bassa voce:’ Quell’uomo no!’. Quell’uomo invece da lì a tre anni, partendo da Milano, avrebbe compiuto la famosa marcia su Roma. Quell’uomo sarebbe stato accettato e osannato per vent’anni in questo nostro sciagurato Paese.
Nel 1933 Elio Vittorini è a Firenze, sua tappa, come quella di Verga, prima di trasferirsi a Milano, dove si stabilirà definitivamente nel dicembre di quello stesso anno.
” Sai che è la più bella città del mondo? Anzitutto è città: quando si è dentro si pensa che il mondo è coperto di case… ” Scrive all’anglista Lucia Rodocanadi. Il siracusano Vittorini ha, nei confronti dell’industriosa e industriale Milano, un atteggiamento opposto a quello di Verga, rifiutandosi il ripiegamento nella passività e rassegnazione di Verga, la sua visione metastorica, il suo “fatalismo”, l’arcaico mondo contadino Siciliano. Milano è per Vittorini la città degli Illuministi, di Manzoni e di Cattaneo, la città attiva, degli operai che hanno coscienza di “classe” e un atteggiamento attivo nei confronti della storia, la città dell’industria a misura d’uomo, il cui modello è rappresentato da un imprenditore come Adriano Olivetti. “Scrive” Milano, Vittorini, con Conversazioni in Sicilia, in cui il protagonista ed io narrante Silvestro, nel momento più buio e tragico del Paese, dell’Europa, nel tempo del fascismo della guerra, in preda ad “astratti furori”, lasciasi il suo lavoro di tipografo e compie, come Ulisse, il viaggio di ritorno, il nostos, nella terra natia, nella terra della madre, delle madri. Ma non rimane lì impigliato, li prigioniero, come il Don Giovanni in Sicilia di Brancati; dopo lo sprofondamento del luogo della memoria, ritorna ai suoi doveri di “compositore di parole”, di scrittore, ai suoi doveri di uomo, di cittadino. Scrive la Milano della ‘ 43, Vittorini, la Milano della guerra e della lotta antifascista con Uomini e no. E anche di società, di contesti democratici con La Garibaldina, Erica e i suoi fratelli, Il Sempione strizza l’occhio al Frejus, Le donne di Messina, Le città del mondo… E c’è ancora un altro grande Vittoriani “milanese”, l’intellettuale e operatore culturale, il direttore di Riviste letterarie e politiche come Il Politecnico e Il Menabò, il direttore di collane letterarie come la Medusa, la Corona, e i Gettoni…
Un anno dopo Vittorini, nel ’34, provenendo dalla Sardegna, si stabilisce a Milano il geometra del Genio civile, il poeta, cognato di Vittorini, Salvatore Quasimodo. Il lirico, il siculo-greco Quasimodo, è costretto anche lui, per l’orrore della guerra, a lasciare la “terra impareggiabile”, l’isola della memoria, per scrivere di Milano, scrivere le liriche di Giorno dopo Giorno.
“E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’uomo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillava arrivi al testamento”.
Così cantava con dolore e orrore il poeta civile Quasimodo. Cantava della Milano straziata dalla guerra, oltraggiata dal fascismo, della Milano”insudiciata”, come ha scritto Alberto Savinio, dalla distruzione e dalla morte.
“Invano cercai tra la polvere,
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del naviglio…”
( Milano, agosto 1943)
Milano 14 dicembre 2003
Finita la carrellata sugli scrittori siciliani a Milano, mi si perdoni se parlo anche di me.
Sono arrivato a Milano con l’idea di una città diversa da tutto il contesto italiano, la Milano dove abitavano Vittorini e Quasimodo, attratto dalla presenza di questi due scrittori.
C’era già allora una corrente di scrittori che migrava dalla Sicilia per approdare a Roma, io non pensavo a Roma perché era la città del potere politico, io pensavo che la mia necessità di lasciare l’estremità, di lasciare l’isola era naturalmente per Milano.
Sono arrivato nel ‘51 per studiare all’università, in una Milano con ancora tutte le ferite del secondo dopoguerra. Sono andato a studiare all’Università Cattolica, non per convinzioni di natura religiosa, ma perché il collegio universitario mi dava allora la possibilità di avere una stanza ed i pasti a 20mila lire al mese. C’erano molti meridionali che approdavano allora a questa università, c’erano molti che sarebbero diventati la futura classe dirigenziale italiana, c’erano i fratelli De Mita, Gerardo Bianco futuro onorevole democristiano,…
Io stavo molto “in periferia”: sono stato un anno al collegio universitario, quando andai a salutare il direttore del pensionato, mi chiese se ero stato lì da loro, infatti io ero stato sempre defilato, mi interessavano altre cose, mi interessava la Milano culturale, la Milano di Vittorini. Invidiavo il mio compagno di università Raffaele Crovi che era amico del figlio di Vittorini e frequentava casa Vittorini, io lo odiavo per questo suo privilegio e non osavo presentarmi in casa di Vittorini perché non avevo delle carte con cui presentarmi. Conobbi Vittorini poi molti anni dopo, nel ’63, quando arrivai a Milano per la pubblicazione del mio primo romanzo presso Mondadori. Vittorini allora aveva un ufficio presso quella casa editrice e fui presentato.
Dopo un anno di collegio mi trasferii nella pensione della signora Colombo che parlava solo in dialetto milanese, allora c’era molta popolarità e dialettalità milanese.
Osservavo in quegli anni la piazza Sant’Ambrogio che poi ho chiamato “la piazza dei destini incrociati” approdavano nella piazza schiere infinite portate dai tram senza numero dalla stazione centrale. Erano immigrati che arrivavano dal meridione, che approdavano in questa piazza perché c’era allora il “centro orientamento immigrati”. Io osservavo gli immigrati e mi ricordo quelli destinati alle miniere di carbone del Belgio, che dopo avere passato le visite mediche venivano già equipaggiati con il casco la cerata e la lanterna, credo che questi 200 minatori furono poi vittime della tragedia di Marcinelle. Altri venivano mandati in Francia in Svizzera e via discorrendo.
In questo edificio di piazza Sant’Ambrogio vi era anche una caserma della Celere, e quindi si incrociavano i destini: da una parte gli studentelli privilegiati, dall’altra i migranti, e poi i celerini dell’onorevole Scelba, ed ad uno studentello come me poteva capitare di incontrare un mio compaesano.Incontrai Giacomino, un ragazzo del mio paese, con la divisa di poliziotto ed il manganello in mano pur essendo un ragazzo molto mite. Capitava di incontrare quelli che sarebbero stati mandati alla scuola sociale di Bologna per diventare onorevoli e classe dirigente democristiana italiana.
Mi ero convinto in quegli anni di voler fare lo scrittore, i miei due vangeli erano stati “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi e “Conversazione in Sicilia” di Vittorini, erano due poli di attrazione. Mi ero convinto che dovevo fare lo scrittore e che non potevo farlo se non in Sicilia: errore gravissimo, sono stato lì 11 anni e poi ho capito che non c’era nulla da fare… Ho frequentato in quegli anni due personaggi antitetici per me entrambi molto importanti, uno era un poeta “puro” Lucio Piccolo di Calanovella, cugino di Lampedusa, poeta straordinario, barocco di tipo mistico e spagnolo con riferimenti quali San Giovanni della Croce, dall’altra parte Leonardo Sciascia. Viaggiavo fino a Caltanissetta dove allora abitava Sciascia e a Capo d’Orlando dove abitava Lucio Piccolo, che mi diceva “venga pure a fare conversazione”, ma per me la conversazione era una vera lezione di letteratura, che andavo a prendere da lui che era di una cultura sconfinata.
Nel ‘68 ho fatto le valige in un giorno emblematico per ritornare a quella che ho chiamato “la patria immaginaria”, ritornando a Milano il 1 gennaio del ’68. Mentre nel novembre del 52 avevo trovato la città piena di nebbia, quel primo di gennaio la trovai piena di neve, allora nevicava a Milano, adesso non nevica più… Dovevo presentarmi al lavoro, avevo vinto un concorso e quella era la ragione per cui mi trasferivo, avevo bisogno di lavorare. Ho vissuto questa città e mi sono sentito sempre milanese perché ho creduto in questa città diversa dal contesto italiano, diversa dalla mia Sicilia, ma anche da Roma e da qualsiasi città italiana.
L’ho vista trasformarsi negli anni, con molta pena. Era la città delle utopie e delle fantasie, che, come sempre, si frantumano contro gli scogli della realtà, sappiamo tutto quello che è successo in questa città e nel paese. Viviamo in una città che nessuno di noi riesce ad accettare, diventata il simbolo della regressione e del degrado del nostro paese.
Ho scritto un libro che si chiama “Retablo”, che descrive il desiderio ed il bisogno di allontanarsi da questa città attraverso un personaggio che si chiama Fabrizio Clerici. E’ un personaggio contemporaneo, ma con un cognome che già appariva nel libro di Savinio “Ascolta il tuo cuore città” che io ho trasferito nel Settecento. Fabrizio è un pittore innamorato di una signorina che si chiamava Teresa Blasco, figlia di uno spagnolo e di una siciliana. Teresa e una donna molto bella, corteggiata dai giovanotti illuministi milanesi, dal Beccaria e da tanti altri in quel di Gorgonzola, dove la famiglia Blasco aveva la villa.
Quindi Fabrizio Clerici, non corrisposto nella sua passione amorosa decide di compiere un viaggio nella terra della donna che lui ama, cioè nella Sicilia. Viaggio romantico alla ricognizione di una Sicilia ideale del Settecento, dove come tutti i viaggiatori romantici si cerca di vedere l’Arcadia, la Grecia, ma la Grecia non c’è più in Sicilia, esiste l’infelicità sociale, che esisteva anche nel Settecento, i conflitti, il banditismo, l’ignoranza, le malattie… Fabrizio apre gli occhi come uomo coscenziale e vede la realtà che non conosceva e rimane coinvolto, anche linguisticamente in questo suo viaggio attraverso la Sicilia classica.
Poi ho esplicitato il disamore e la disillusione nei confronti di Milano in un libro più recente che si chiama “Lo Spasimo di Palermo”, che rappresenta non solo lo spasimo di Palermo, ma lo spasimo anche di Milano e dell’intero paese. Il romanzo comincia con un flash back che dal secondo dopoguerra ci porta fino al 1992; il protagonista è uno scrittore che si chiama Gioachino Martinez, il quale aveva scelto Milano per sfuggire all’orrore e alla violenza siciliana, era approdato a Milano quale sua città ideale ed anche qui, dopo anni di consolazione, trova violenza e trova orrore, terrorismo e degrado culturale. Decide di tornare a Palermo dove ancora troverà violenza e morte. Il paese è ormai omologato e non c’è più una Itaca, un luogo dove tornare, per nessuno di noi in questa società. Le città ideali si sono frantumate sotto i nostri occhi e l’Itaca che abbiamo lasciato durante la nostra assenza è stata distrutta ed è stata conquistata dai Proci, oggi viviamo in un mondo di Proci, in un mondo di orrore dove niente più è accettabile.
Voglio ricordare una pagina di addio a Milano, sullo schema dell’addio manzoniano, dello scrittore Gioacchino Martinez:
“Nessuna pena no, nessun rimpianto a lasciare dopo anni quell’approdo della fuga, quell’ asilo della speranza, antitesi al marasma, cerchia del rigore, probità, orgoglio popolare, civile convivenza, magnanimità e umore, tolleranza. Illusione infranta, amara realtà, scacco pubblico e privato, castello rovinato, sommerso dall’acque infette, dalla melma dell’olona, dei navigli, giambellino e lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, scala del corrotto melodramma, palazzo della vergogna, duomo del profitto, basilica del fanatismo e dell’intolleranza, banca dell’avventura e dell’assassinio, fiera della sartoria mortuaria, teatro della calligrafia, stadio della merce e del messaggio, video dell’idiozia e della volgarità.
Città perduta, città irreale, d’ombre senz’ombra che vanno e vanno sopra ponti, banchine della darsena, mattatoi e scali, sesto e cinisello disertate, tecnologico ingranaggio, dallas dello svuotamento e del metallo. Addio.”
“Addio ai campanili in cotto, alla romanica penombra, a Chiaravalle, a Morimondo. Addio alla casa di Manzoni, a San Fedele, all’alto marmo nel centro del Famedio. Alle vie verghiane, alla gaddiana chiesa di san Sempliciano. Allo Sposalizio della Vergine, emblema saviniano della città chiusa di Milano, del suo equilibrio, e della sua utile mediocrità. Addio a Brera di Beccaria e Dossi, addio a Porta a Tessa Quasimodo Sereni, al Montale del respiro vasto della bufera, dei meriggi assorti, degli orti, dei muri di salino costretto nella depressione della pianura, nel dorato cannello dell’imbuto cittadino. Alla casa dei fervori e dei furori di Vittorini, delle utopie infrante e dei lirici abbandoni. Al rifugio in Solferino dove Sciascia patì la malattia, sua del corpo e insieme quella mortale del Paese. Addio alla Vetra, al Mora e al Piazza, alla Banca del tritolo e della strage, all’anarchico innocente steso a terra come il Cristo del Mantegna, ai marciapiedi insanguinati, alle vite straziate di giudici civili militari studenti giornalisti…Amaro a chi scompare. Qui è la babele, il chiasso, la caverna dell’inganno, il loto dell’oblio, l’Eea dei filtri della mutazione, del grugnito inverecondo…”
l’emigrazione impossibile. In leggere Milano collana dell’edizione unicopli Le città letterarie, dicembre 2006.
Conferenza tenutasi nell’aula magna dell’università statale di Milano il 4
dicembre del 2003.

