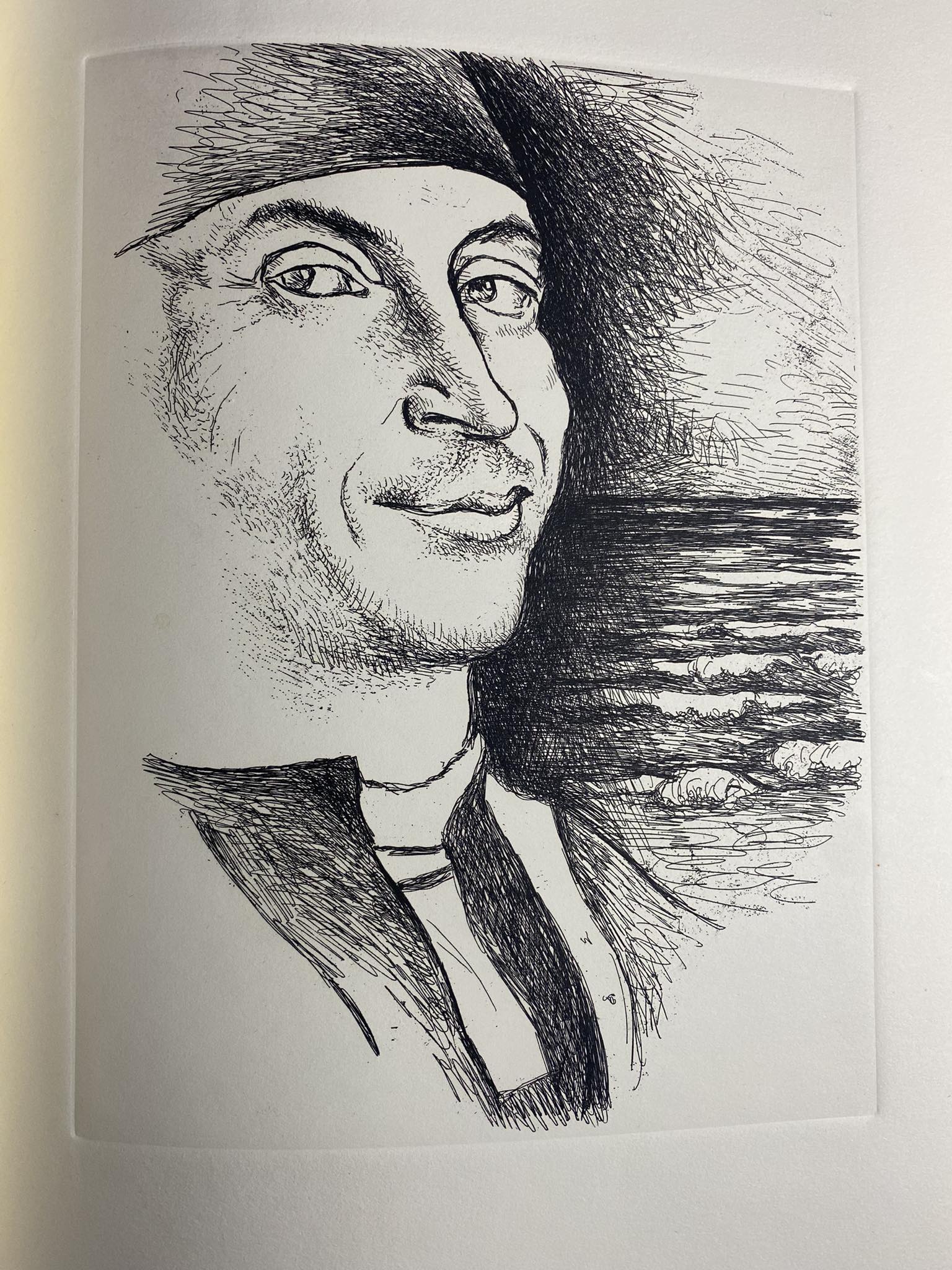Lunaria: il mondo salvato dalla Luna
In una Palermo di fine Settecento, una mattina il Viceré si sveglia madido e tremante: ha sognato che la Luna è caduta dal cielo e, una volta raggiunto il terreno, si è spenta, lasciando nel cielo un buco nero. La giornata del Viceré prosegue nella sala delle udienze dove egli acconsente svogliatamente alle richieste più svariate, tra cui spiccano quelle degli Inquisitori che chiedono la libera circolazione per gli officiali, i ministri e i familiari del Sant’Offizio, armati di qualsivoglia arma. A conclusione dell’udienza i ministri srotolano una mappa sulla quale sono indicati i possedimenti vicereali sul quale il Viceré fa scorrere il suo scettro che inspiegabilmente si impunta su una estrema Contrada senza nome.
A questo punto la scena si apre sulla Contrada senza nome, dove alcuni villani guardano sorpresi la Luna che sta per sorgere e che appare insolitamente grande e colorata, in parte, di rosso scarlatto. Dopo un po’ la Luna ritorna ad essere bianca e luminosa, ma comincia a creparsi e falde di luna cominciano a piovere a terra. Un Caporale ubriaco intima ai villani di raccogliere i cocci di Luna e di metterli in una giara, quindi ordina ad uno di loro, Mondo, di andare dal Viceré per riferire l’accaduto e chiedere istruzioni sul da farsi.
La scena torna quindi a Palazzo Reale, dove è riunita l’Accademia dei Platoni Redivivi per disputare circa la malattia, lo sfaldamento e la conseguente caduta sub specie pluviae della Luna. Tra loro arriva Mondo che racconta l’accaduto, portando con sé una falda di Luna come prova. Posto il coccio in uno scrigno, Mondo viene congedato e ciascuno degli accademici esprime la propria opinione sull’accaduto. Finita la disputa, nell’Accademia deserta dalle ante di un armadio esce il Teatro delle Bizzarríe: geni, fate, folletti, astri, pianeti, allegorie; quindi i personaggi fantastici spariscono a mano a mano, lasciando solo la Luna.
Nell’epilogo si torna nuovamente nella Contrada senza nome, dove uomini e donne vestiti di nero (che poi si dimostreranno essere i villani del paese) seppelliscono i resti della Luna nella fontana e, di lì a poco, assistono alla ricomparsa in cielo della Luna che, però, tra i due corni della falce mostra una macchia nera. Giunge allora il Caporale il quale, deluso di ritrovare la Luna al proprio posto, inveisce contro i villani; viene però interrotto dal sopraggiungere del Viceré, il quale sale una scala a pioli e incastra nella Luna il pezzo mancante, decretando che da allora in poi la Contrada senza nome si chiamerà “Lunaria”.
È questa per sommi capi la vicenda che Vincenzo Consolo racconta nell’opera Lunaria, pubblicata per i tipi di Einaudi nel 1985.
In essa si possono riconoscere gli elementi tipici della fiaba. Il ruolo dell’eroe è assunto dagli abitanti della Contrada senza nome e dal messaggero Mondo. Essi rappresentano simbolicamente coloro che vivono nell’amore nella fratellanza, privi di cultura ma generosi e umili, coloro che sono capaci di vivere la vita con pienezza e con poesia. Sono loro che, mossi da pietà, decidono di seppellire la luna morta, permettendone la resurrezione.
Il ruolo di antagonista è assunto dai rappresentanti del potere: innanzitutto quello religioso attraverso le figure degli Inquisitori, “simboli dichiarati di una concorrenza tra potere monarchico e potere ecclesiastico, ma anche di forze occulte e ricattatorie, che intralciano l’eventuale azione moderatrice dell’amministrazione civile” , e poi quello culturale con gli Accademici dei Platoni Redivivi. Questi ultimi, chiamati a consiglio per risolvere il problema della caduta della Luna, mostrano l’incapacità della cultura fine a se stessa di affrontare e risolvere i problemi della vita e di riconoscere che componente essenziale del mondo è la poesia. Essi sanno solo elucubrare freddamente, dilungarsi in lunghi discorsi sterili ai limiti dell’assurdo il cui unico fine è mostrare la propria supposta erudizione e non certo quello di essere utili all’umanità.
Anche il Dottor Elia, pur abitando nella Contrada senza nome, si dimostra sprezzante nei confronti dei suoi compaesani in nome della sua presunta superiorità culturale. Egli si rende ridicolo affermando che il rosso scarlatto che compare sulla Luna altro non è che un fiotto scivolato dal Sole rosso al momento del tramonto. A chi gli fa notare che i due astri percorrono traiettorie differenti, egli risponde con sguardi di compatimento, snocciolando un elenco di nomi illustri e meno illustri:
Tacete, pratico! Voi non avete letto – voi non sapete leggere – in libri autorevoli. Voi non conoscete Ippocrate, Galeno, Avicenna, Bellèo, Alàimo, Petronillo…
Il tema dell’intellettuale che non riesce a mettersi al servizio della vita vera, perdendosi invece in inutili speculazioni, richiama da vicino la tematica principale del romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio, in cui Consolo prendeva proprio in esame il ruolo dell’intellettuale nella società, attribuendogli il dovere, morale e civile, di contribuire attivamente al miglioramento della società.
Emblematico dell’incommensurabilità reciproca tra il mondo dei villani e quello dei dotti potenti è il momento – non privo di una gustosa comicità – in cui Mondo si pone al cospetto degli Accademici:
Tutti gli accademici ora si agitano, si turano le nari, smuovono l’aria con fazzoletti, pergamene, ventaglini. È per l’odore agreste, selvatico, che il villano emana dal suo corpo che disturba e sconcerta quei signori. Il Segretario chiama un valletto, il quale poi spruzza per aria e sul villano con una pompa essenze profumate. Il villano si agita, scalpita, si tura a sua volta le nari, dà segno di disdegno e di sconturbo.
Anche il potere politico, rappresentato dalla figura del Caporale, si pone come antagonista degli abitanti della Contrada senza nome. Questo non vale, però, per il Viceré, che assume invece il ruolo di aiutante.
Egli si presenta come un essere malinconico, lunare, disilluso dalla vita e simbolo consapevole di un potere fittizio; ricorda per certi versi il Principe di Salina del Gattopardo di Tomasi da Lampedusa, anche se la sua prima comparsa in scena, nel momento del suo risveglio, richiama da vicino quella del Giovin Signore del Giorno di Parini: anche il Viceré si sveglia piagnucolando contro il suo valletto, Porfirio, che ha scostato le cortine permettendo alla luce mattutina di inondare la sua camera :
No, no, no… Avverso giorno, spietata luce, abbaglio, città di fisso sole, isola incandescente…
In realtà il Viceré è molto diverso dal Giovin Signore e lo dimostra quando viene ad assumere, come si è detto, il ruolo di aiutante; in quel medesimo istante, però, il meccanismo del teatro nel teatro si disvela e il Viceré cessa di essere quello che è, tanto che esce di scena affermando:
Non sono più il Viceré. Io lo ho rappresentato solamente (depone lo scettro, si toglie la corona e il mantello). E anche voi avete recitato una felicità che non avete. Così Porfirio (Porfirio si spoglia della livrea, degli scarpini, del turbante), d’un mondo antico e nuovo, carico di memoria, invaso dall’oblìo […]. E’ finzione la vita, melanconico teatro, eterno mutamento. Unica salda la cangiante Terra, e quell’Astro immacolato là, cuore di chiara luce, serena anima, tenera face, allusione, segno, sipario dell’eterno.
Tra gli eroi e gli antagonisti è la Luna, ‘oggetto del desiderio’ ricco di valenze simboliche, sognata, contemplata, persa, rimpianta e infine riconquistata. Per Consolo la sua caduta “rappresenta l’allontanamento della poesia dal mondo” , poesia che è invece illusione necessaria contro la precarietà della storia e della vita (Scende la luna; e si scolora il mondo, aveva scritto Leopardi ne Il tramonto della Luna). Così lo scrittore ne ha parlato in una intervista:
[…] oggi più di ieri, credo che il narratore abbia bisogno di tornare alla poesia. In questo senso: questa scrittura laica che è la prosa si è enormemente impoverita e devitalizzata. I mezzi di comunicazione di massa ci spossessano sempre di più della lingua e, con la lingua, anche dei sentimenti. Ecco perché lo scrittore non può più praticare lo stesso tipo di prosa di una volta. […] Credo che l’accento della prosa debba spostarsi sempre più verso la poesia, in senso esterno e formale e in senso intimo, di contenuto.
La vicenda di Lunaria si apre con il Viceré che narra al valletto Porfirio il sogno appena fatto:
Ero in cima alla torre, sulla terrazza dell’Osservatorio dove l’Abate astronomo m’indicava Cerere e altre stelle intorno… Quand’ecco all’improvviso distaccarsi la Luna […]. Allora, guardando il cielo, vedo, dove lei s’era divelta, un’orma, una nicchia, un vano nero che m’attrae e dona nel contempo le vertigini…
Il tema è un esplicito richiamo a L’esequie della luna, opera in prosa dell’amico poeta Lucio Piccolo, il quale a sua volta aveva preso spunto dal frammento dialogato leopardiano Odi, Melisso , noto anche come Il sogno e Lo spavento notturno. In esso Alceta racconta a Melisso un sogno che ha fatto:
ALCETA
Odi, Melisso: io vo’ contarti un sogno
Di questa notte, che mi torna a mente
In riveder la luna. Io me ne stava
Alla finestra che risponde al prato,
Guardando in alto: ed ecco all’improvviso
Distaccasi la luna; e mi parea
Che quanto nel cader s’approssimava,
Tanto crescesse al guardo; infin che venne
A dar di colpo in mezzo al prato; ed era
Grande quanto una secchia, e di scintille
Vomitava una nebbia, che stridea
Sì forte come quando un carbon vivo
Nell’acqua immergi e spegni. Anzi a quel modo
La luna, come ho detto, in mezzo al prato
Si spegneva annerando a poco a poco,
E ne fumavan l’erbe intorno intorno.
Allor mirando in ciel, vidi rimaso
Come un barlume, o un’orma, anzi una nicchia,
Ond’ella fosse svelta; in cotal guisa,
Ch’io n’agghiacciava; e ancor non m’assicuro.
MELISSO
E ben hai che temer, che agevol cosa
Fora cader la luna in sul tuo campo.
ALCETA
Chi sa? non veggiam noi spesso di state
Cader le stelle?
MELISSO
Egli ci ha tante stelle,
Che picciol danno è cader l’una o l’altra
Di loro, e mille rimaner. Ma sola
Ha questa luna in ciel, che da nessuno
Cader fu vista mai se non in sogno.
Se Leopardi aveva sostenuto che la caduta della luna non può avvenire che in sogno, il sogno del Viceré si palesa però come premonizione, divinazione onirica; infatti, come si è visto, il giorno seguente la Luna cadrà veramente a terra frantumandosi in mille cocci.
Anche la prosa segue la dimensione del sogno, rivestendo di un alone magico i personaggi e le vicende. Siamo perciò di fronte ad un racconto caratterizzato dalla compresenza di componenti oniriche e magiche, fittamente intrecciate sia a livello contenutistico che di lingua: proprio da ciò scaturisce il fascino poetico in grado di ammaliare il lettore. Si può di conseguenza notare che la propensione al fantastico, che negli altri romanzi è espressa come scatto visionario, acquisisce in questo caso piena autonomia, impregnando di sé tutto il corso della vicenda.
Lunaria è stata definita dalla critica una “favola teatrale”. Questa affermazione è giustificata dalla struttura formale dell’opera, che consta di un Preludio, due Scenari separati da un Intermezzo e un Epilogo. A tal proposito Cesare Segre ha rilevato che nell’opera sono compresenti due forze opposte:
Alla tendenza centrifuga verso il teatro ne corrisponde una centripeta. Si tratta di quelle specie di teatro en abyme, istituito dal manichino del Re […]. Il manichino, richiamo simbolico all’opera dei pupi, sta in scena all’inizio del Primo scenario, e il Viceré, nascondendosi dietro ad esso, lo fa parlare e disquisire su Palermo, le sue malie e i suoi orrori. Un altro teatrino en abyme, magico e segreto, si rivela poi nel Secondo scenario, quando «Si aprono per incanto le ante di un armadio, che altro non è se non il Teatro delle Bizzarrie, e ne vengono fuori fantastici personaggi: monachini geni fate folletti lèmule» […].
La riflessione di Segre richiama alla mente molti precedenti, da Plauto a Goldoni, dall’Amleto di Shakespeare alla trilogia di Luigi Pirandello, nei cui drammi la metateatralità è pretesto per una riflessione sulle finzioni della realtà sensibile. E Lunaria varrà a Consolo il Premio Pirandello.
Nel dipanarsi delle azioni di sapore fiabesco emergono numerosi riferimenti storici, letterari, filosofici; emerge soprattutto un punto di vista malinconico sulla vita, impersonato dal Viceré che, nonostante si chiami Casimiro (nome che contiene le parole “fama” e “comandare”) soffre per il ruolo che riveste, è dedito spesso ad attacchi di malinconia, e a conclusione della vicenda declama:
Ma se malinconia è la storia, l’infinito, l’eterno sono ansia, vertigine, panico, terrore. Contro i quali costruimmo gli scenari, i teatri finiti e familiari, gli inganni, le illusioni, le barriere dell’angoscia. E il primo scenario fu la Luna, questa mite, visibile sembianza, questa vicina apparenza consolante, questo schermo pietoso, questa sommessa allegoria dell’eterno ritorno. Lei ci salvò e ci diede la parola, Lei schiarì la notte primordiale, fugò la dura tenebra finale […]. Se ora è caduta per il mondo, se il tetro s’è distrutto, se qui è rinata, nella vostra Contrada senza nome, è segno che voi conservate la memoria, l’antica lingua, i gesti essenziali, il bisogno dell’inganno, del sogno che lenisce e che consola. Lunaria da ora in poi si chiamerà questa contrada, Lunaria…
In Lunaria sono presenti reminiscenze letterarie sotto forma di riprese letterali, come quelle di versi leopardiani, talora conservati quasi senza mutamenti, o attraverso riferimenti espliciti, come quello al viaggio di Astolfo nel mondo della Luna, a cui segue un passo del XXXIV canto de L’Orlando Furioso di Ariosto:
Là, dove giunse Astolfo in groppa all’Ippogrifo per cercarvi il senno del folle Paladino, là, come canta il Poeta, è dammuso, catoio, pozzo nero di tutte le carenze, le pazzie, i sonni, gli oblii, gli errori della Terra.
Dall’apostolo santo fu condutto
in un vallon fra due montagne istretto,
ove mirabilmente era ridutto
ciò che si perde o per nostro difetto
o per colpa di tempo o di fortuna:
ciò che si perde qui, là si raguna.
Interi brani di poesia e versi “nascosti” compaiono in Lunaria. Lo stile si avvicina alla poesia come mai prima era avvenuto: il testo pullula di anafore, allitterazioni, rime interne. Si assiste così a una sorta di tendenza mimetica per cui al tema dell’intima necessità per il mondo della poesia (simboleggiata dalla Luna) corrisponde uno stile che si fa poesia. Il linguaggio si presenta talvolta oracolare, la forma espressiva risulta nervosa, essenziale: la parola si fa incantatrice e trascina il lettore nella “poesia” della vita. Aldo Maria Morace afferma che questo è il libro più barocco di Consolo.
Ne scaturisce una scrittura fortemente prosodica, assai ricca di assonanze e di propagginazioni foniche, governata dal richiamarsi di accenti acuti e gravi, posti in andamento ascendente e discendente […].
Esempi significativi di questo stile sono le cantilene che vengono recitate dagli abitanti della Contrada senza nome:
Luna nova, Luna nave,
su nel cielo a navigare.
Melograno e la lumía,
la parola di magía.
Consolo ha affermato di aver voluto, con questo racconto, allontanarsi da un romanzo storico che stava scrivendo, uscire dalla storia. Ma per uno scrittore che attraverso la propria opera vuole trasmettere un messaggio, e questo è il caso di Consolo, uscire dalla storia è impossibile. Infatti la storia è presente anche in questa che solo apparentemente è una favola. E’ storia di inquisitori, di dotti avulsi dal mondo, di poteri imposti e strumentalizzati, simbolo di un’umanità che non si riconosce più in se stessa. In questo senso il passo in cui si dichiara «Così è stato e così sempre sarà: rovinano potenze, tramontano imperi regni civiltà, cadono astri, si sfaldano, si spengono, uguale sorte hanno mitologie credenze religioni» è una chiara visione ciclica della storia, per cui tutto ritorna, come infatti farà la luna, ma avendo insegnato, almeno a qualcuno, quando inutile e melanconico sia un mondo senza poesia, senza illusione. Ed infatti una delle cantilene recitate dagli abitanti della Contrada senza nome, parlando della Luna, afferma:
Ma qui, nella remota
Contrada senza nome,
isola in cui dimora
frammento di parola,
qui ritorna ancora
in tutte le sue grazie,
nelle speranze, nel sogno
necessario, nella gioia
luminosa dell’inganno.
Dal punto di vista linguistico Lunaria accosta stili diversi: dal narrativo al dialogico, dal lirico-poetico al linguaggio scientifico o pseudo scientifico degli usato dagli Accademici. Nell’appendice all’opera denominata Notizie, vengono offerti al lettore confronti letterari, spunti di riflessione, riferimenti e riscontri storici; suggerisce echi e connessioni; stimola ricerche e approfondimenti.
Inoltre Lunaria, pur nella sua brevità, si configura come un crogiolo di lingue e dialetti. Sono facilmente riconoscibili l’uso dell’italiano nei suoi diversi registri: da quello accademico-scientifico, a quello visionario, mimetico, letterario, lirico, popolare; l’uso del siciliano, del dialetto gallo-italico, dello spagnolo di Doña Sol e degli inquisitori, del latino nonché di latinismi vari. Il Viceré «ricorre saltuariamente a tutti questi idiomi, compreso il dialetto gallo-romanzo» , ossia il sanfratellano, tanto che a Mondo risponde parlando nella sua stessa lingua. Ma dopo aver posto nella Luna il pezzo mancante, essersi posto dalla parte del popolo e non del potere che invece dovrebbe rappresentare, prima di affermare di non essere più il Viceré ammette significativamente:
Ah Mondo, Mondo, io non capisco più la vostra lingua, non sono più il sovrano poliglotta, il re della storia, il re che sogna…
C.Segre cit. pag. 98
Paola Baratter, Lunaria [di Vincenzo Consolo]: il mondo salvato dalla Luna, in “Microprovincia” (Stresa), n. 48 (2010), pp. 85-93.
 8
8