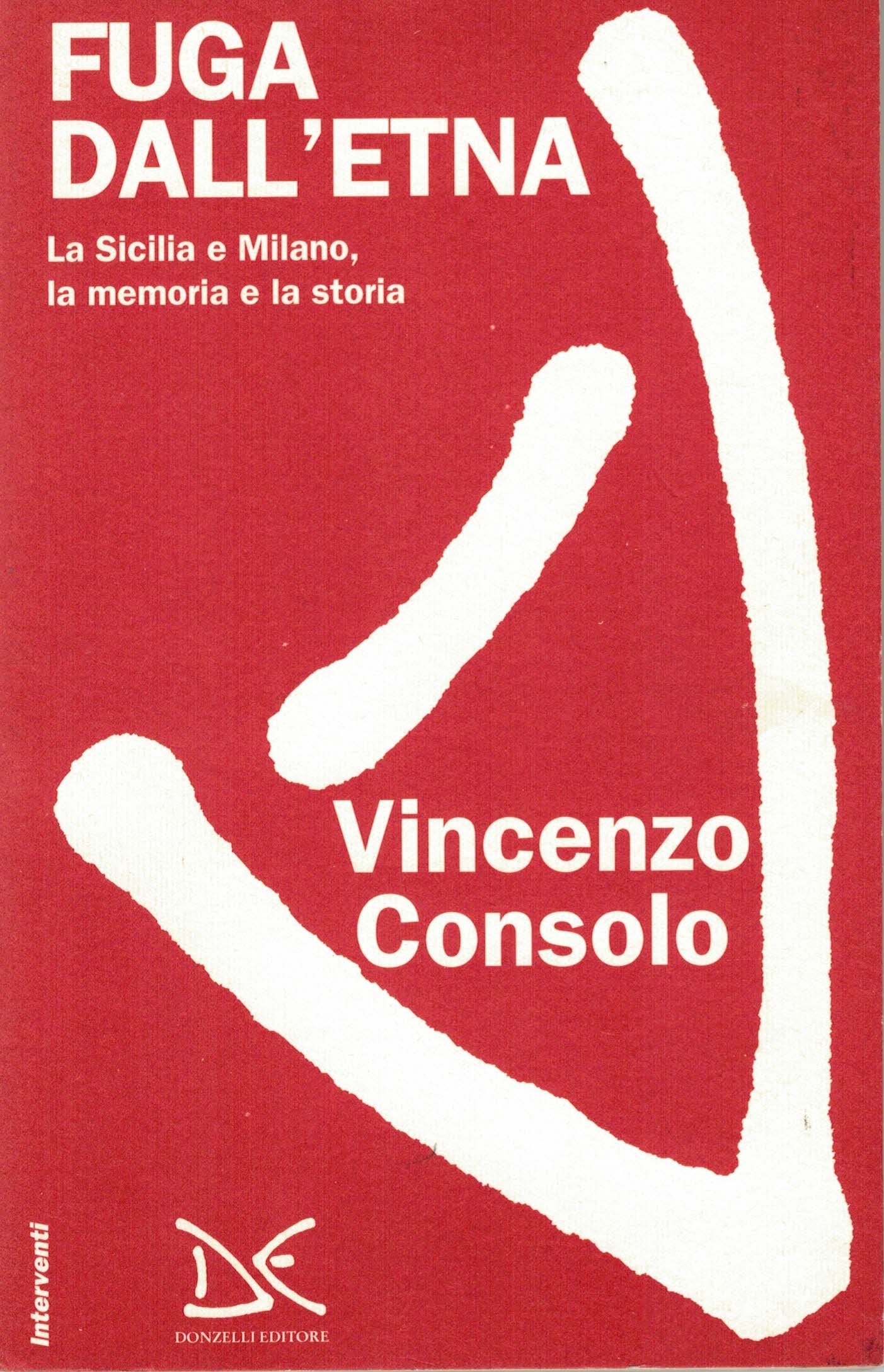Paola Villani
Sesto di otto figli, nacque a Sant’Agata di Militello (Messina) il 18 febbraio 1933, da Calogero (1898-1962) e Maria Giallombardo (1900-88).
Il padre, commerciante alimentare e poi piccolo imprenditore con la nascita della ditta ‘Fratelli Consolo Cereali’ nel 1939, trasmise al figlio i tratti di un’etica rigorosa, dimostrata anche contro la mafia, la quale nell’immediato dopoguerra veniva organizzando in tutta la Sicilia il controllo delle attività economiche.
Anche evocando il celebre testo di Luigi Pirandello sulla propria nascita nella contrada del Caos, Consolo ricordò i luoghi d’infanzia, le sue origini e la sua prima educazione nel romanzo d’esordio, La ferita dell’aprile (Milano 1963), dedicato «con pudore» a suo padre, scomparso proprio in quell’anno.
Iniziava una progressiva centralità della Sicilia nella sua personalità di uomo e di scrittore, di intellettuale al bivio tra saggistica e letteratura, in una contaminazione di ‘generi’ che ha sempre distinto le sue pagine e che trova in Leonardo Sciascia, maestro dell’ibridismo, un decisivo modello.
La sua terra di origine si rivela come presenza «ossessiva», con un forte valore identitario, storico ma anche simbolico, che segna in parte il destino di uno scrittore «anfibio», tra terra e mare, tra passato e presente. Sicilia come luogo, tema, personaggio, persino struttura narrativa; quasi ad annodare, in una profonda corrispondenza e circolarità, i fili dell’amplissimo e diversificato corpus letterario dello scrittore, da La ferita dell’aprile al postumo La mia isola è Las Vegas: «tutti i romanzi, se ordinati in base alla cronologia dei fatti descritti o allusi, compongono, per momenti decisivi, una storia della Sicilia degli ultimi duecentocinquant’anni» (C. Segre, Un profilo di V. C., in V. Consolo, L’opera completa, a cura di G. Turchetta, Milano, 2015, p. XIV). Questa sicilianità «ostinata» e «implacabile» (v. G. Turchetta, Da un luogo bellissimo e tremendo, ibid., pp. XXV-LXXIV, con partic. riferimento a p. XXV) emerge spesso nella declinazione, tematica e metaforica, del viaggio, che è spostamento fisico ma anche attraversamento di tempi e luoghi, sfida all’ignoto e continua tensione verso un altrove; nella duplice direzione della partenza e del nostos che richiama il grande archetipo omerico, l’Odissea, il «poema in cui per la prima volta si apre davanti ai nostri occhi lo spazio mediterraneo» (Lo spazio in letteratura, in Di qua dal faro, poi in L’opera completa, cit., p. 1239). Eppure, «nella modernità, le colpe non sono più soggettive, ma oggettive, sono della storia. I mostri non sorgono più dal mare, dalla profondità del subconscio, ma sono mostri concreti, reali, che tutti noi abbiamo creato […] Itaca non è più raggiungibile. Questo, secondo me, lo scrittore oggi ha il compito di dire, di narrare» (in V. Consolo – M. Nicolao, Il viaggio di Odisseo, introd. di M. Corti, Milano 1999, p. 22). Nel tragico confronto tra passato mitico e desolato presente, la sua terra gli appare aver perso tutti i connotati di un approdo. Si ripropone la sofferta diaspora, e il doloroso ritorno, degli scrittori meridionali; la «dolorosa saggezza» e la «disperata intelligenza» di cui Consolo ragiona ne Le pietre di Pantalica, come declinazione personale del paradigma della «intelligenza siciliana» di Vitaliano Brancati. Non è un caso se nel laboratorio della scrittura, oltre alla lezione di Italo Calvino o Cesare Pavese, affiora il realismo lirico-fantastico di Elio Vittorini o la prosa di cose di Giovanni Verga, Federico De Roberto, ma anche Pirandello.
Gli anni della guerra per il giovanissimo Vincenzo trascorsero relativamente tranquilli fino al 1943, quando gli americani, in preparazione dello sbarco, diedero avvio a massicci bombardamenti che coinvolsero la zona di Sant’Agata, sulla linea strategica Messina-Palermo, e che costrinsero la famiglia Consolo a ‘sfollare’ in campagna, nella contrada di Vallebruca. Dopo le scuole medie all’istituto salesiano Guglielmo Marconi, l’assenza di scuole pubbliche di grado secondario lo condusse nel 1947 al primo allontanamento da casa, per frequentare il liceo-ginnasio salesiano Luigi Valli a Barcellona Pozzo di Gotto, a ottanta chilometri da Sant’Agata. Era già chiara la sua passione per la lettura. Nelle pause scolastiche approfittava di un cugino del padre, Peppino Consolo, che possedeva una pur scarna biblioteca con alcuni classici della letteratura, da Manzoni a Hugo o Balzac, ai romanzieri russi.
Negli anni liceali si collocano i primi esercizi di scrittura, anche su suggestione di due letture che si rivelarono decisive: Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Iniziava allora una lunga ricerca sulle lingue, anche antiche. La sperimentazione di nuovi codici, registri e linguaggi si veniva costituendo in una «ideologia» precisa e insieme fluida e mai conclusa, tradotta in racconto con I linguaggi del bosco (in Le pietre di Pantalica, poi in L’opera completa, cit., pp. 606-612).
Nell’autunno del 1952 giunse il primo trasferimento, «traumatico», a Milano, per frequentare la facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica. Fu in quei primi anni universitari che conobbe Basilio Reale, l’amico Silo che lo introdusse alla casa editrice Mondadori (cfr. Sirene siciliane, Palermo 1986; poi in Di qua dal faro, cit.), e Lucio Piccolo, il «barone magico» delle Pietre di Pantalica: «grande poeta di sconfinata cultura, cugino e antagonista di Tomasi di Lampedusa. Fu lui a insegnarmi la vera letteratura, la poesia e, insieme, a farmi amare certi libri di erudizione provinciale, ottocentesca, storie, guide, cataloghi, ‘pieni di insospettabile poesia’ diceva, che furono miniere lessicali per me» (Fuga dall’Etna, Roma 1993, p. 18).
Costretto a interrompere gli studi per assolvere gli obblighi del servizio militare (dapprima a Orvieto e poi a Roma), riprese il percorso universitario nel 1957, stavolta a Messina, per laurearsi quindi nel 1960 discutendo una tesi in filosofia del diritto dal titolo «La crisi attuale di diritti della persona umana».
I PRIMI GRANDI ROMANZI
Il primo testo a stampa risale al 1957, Un sacco di magnolie, apparso a firma «Enzo Consolo» nella rivista La parrucca (poi in La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Milano 2012, pp. 8-10) che vantava collaboratori come Umberto Eco, Giorgio Manganelli o Edoardo Sanguineti. Il suo esordio come romanziere è invece La ferita dell’aprile (cit.) che, dopo lunga gestazione, apparve nel 1963 per Mondadori nella collana «Il Tornasole» di Niccolò Gallo e Vittorio Sereni, con l’assistenza redazionale di Raffaele Crovi: «Mi sono ritrovato fatalmente nel solco sperimentale di Gadda e Pasolini, di D’Arrigo e Mastronardi, anche. Non era ancora apparso all’orizzonte il Gruppo ’63, dal quale in ogni caso mi avrebbe tenuto ben lontano un forte senso di appartenenza alla tradizione letteraria» (Fuga dall’Etna, cit., p. 15). Forse anche per quella coincidenza cronologica con le spinte avanguardistiche, il romanzo quasi sfuggì all’attenzione di critica e di lettori. Suscitò invece l’interesse di Sciascia, al quale Consolo aveva inviato il libro allegando una lettera nella quale gli dichiarava il suo debito come scrittore. Era l’inizio di una salda e duratura amicizia, alla quale Consolo dedicò numerose pagine, molte delle quali raccolte nella sezione Intorno a Leonardo Sciascia del volume Di qua dal faro (cit., pp. 1161-1184).
La ferita dell’aprile, «poemetto narrativo» da leggersi anche come Bildungsroman autobiografico, costituisce un unicum nella carriera dello scrittore. Nel racconto della vita di un paese siciliano e delle lotte politiche del dopoguerra, la narrazione in prima persona (di cui Consolo non usufruì nei romanzi successivi) è impostata cronologicamente come diario di un anno scolastico e mette in scena i turbamenti dell’uscita dall’infanzia, nell’intreccio tra vicende personali dei protagonisti e storia d’Italia.
Sin dall’esordio emerge con forza, nella scrittura, quella centralità della parola che ha connotato fortemente l’intera sua produzione, fino a consacrarlo come ‘autore difficile’, ‘enigmatico’: «Mi ponevo […] sul crinale della sperimentazione, mettendo in campo una scrittura fortemente segnata dall’impasto linguistico» (in Adamo, 2006, p. 183).
L’attento lettore e saggista seguiva da vicino il dibattito sulla letteratura contemporanea. A segnare profondamente quella stagione fu anche la pubblicazione in Rinascita, del noto saggio di Pasolini, Nuove questioni linguistiche, apparso nel dicembre 1964, alla vigilia della pubblicazione del primo capitolo del Sorriso dell’ignoto marinaio, e anche della stesura di Il pane (1964), dei racconti Grandine come neve, Befana di novembre (1965) e Triangolo e Luna (1966), poi inclusi in La mia isola è Las Vegas (cit.).
Nel 1964 prese a scrivere per L’Ora di Palermo, giornale allora diretto da Vittorio Nisticò; era l’inizio di una lunga collaborazione che lo impegnò fino al 1975 e poi ancora dal 1977 al 1991, e che vide Consolo anche titolare di una rubrica di successo, «Fuori casa», inaugurata nel dicembre 1968. Nel racconto Per un po’ d’erba ai margini del feudo (in L’Ora, 16 aprile 1966, poi incluso da Sciascia nell’antologia Narratori siciliani curata per Mursia insieme con Salvatore Guglielmino), forte anche della lettura del fortunato saggio di Hans Magnus Enzensberger Letteratura come storiografia (in Il Menabò, 1966, n. 9), inaugurava un nuovo modo narrativo, fondato sull’intreccio tra fiction e storia, racconto e documenti, che avrebbe poi preso corpo nel suo maggiore romanzo.
Nello stesso 1966 si collocano per Consolo viaggi significativi: uno nella valle del Belice, che torna nel racconto del 1984, Il drappo rosso con le spighe d’oro, e la trasferta a Parigi con Sciascia, il quale nello stesso 1966 aveva dato vita al premio Brancati di Zafferana Etnea coinvolgendo, oltre ad Alberto Moravia, Dacia Maraini e Pier Paolo Pasolini, anche i siciliani Ignazio Buttitta, Lucio Piccolo e naturalmente Consolo.
Nel 1967, l’anno nel quale Pasolini pubblicava in Nuovi Argomenti la prosa poetica di Lucio Piccolo L’esequie della luna da cui nacque lo spunto per Lunaria, Consolo vinse un concorso per la RAI. Interruppe quindi l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado e, nel gennaio 1968, prese servizio presso la sede di Milano. Era un trasferimento destinato a essere definitivo, che segnò la vita e l’opera dello scrittore. Ad accoglierlo in azienda fu, tra gli altri, Caterina Pilenga, che aveva apprezzato il suo poco noto romanzo La ferita dell’aprile e che divenne compagna della vita, e moglie con rito civile dal 1986.
Quel trasferimento, in quel «momento di acuta storia», per l’acceso dibattito politico e culturale e per il duro conflitto sociale, fu una decisiva cesura, uno snodo sul quale spesso Consolo avrebbe riflettuto, non senza ripensamenti. Era una declinazione tragica del tema del contrasto di dimensione spazio-temporale, la sua protesta contro luoghi e tempi rispetto ai quali si sarebbe spesso sentito estraneo: la Milano di allora, l’«attiva, mercatora» città, e in particolare la RAI, «completamente ipotecata dal potere politico, dalla mafia partitica».
Pur mai rinunciando al suo carattere anarcoide, che lo portò non di rado ad aperte contestazioni, quella del servizio pubblico televisivo fu in effetti una postazione privilegiata per penetrare il paesaggio della letteratura contemporanea che Consolo lettore e critico ben conosceva; in una posizione insieme scomoda ma anche centrale di giornalista, che rivive nel personaggio Antonio Crisafi del racconto La pallottola in testa (poi in La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 157-162).
Stabilitosi a Milano, Consolo prese a frequentare la casa sui Navigli della compagna di Vittorini, Ginetta Varisco, un cenacolo culturale animato tra gli altri da Carlo Bo, Italo Calvino, Paolo Volponi e Salvatore Quasimodo. Intanto lesse, destinati a incidere il suo percorso di scrittura, Manifesto per un nuovo teatro di Pasolini, pubblicato in Nuovi Argomenti, e Appunti sulla narrativa come processo combinatorio di Calvino, apparso in ‘Nuova Corrente’.
In quel ‘caldo’ 1968 aveva anche inviato a Paragone, la rivista diretta da Roberto Longhi e Anna Banti, un racconto intitolato Il sorriso dell’ignoto marinaio: si trattava del primo capitolo del futuro capolavoro, che tuttavia non venne accolto dalla rivista e apparve in Nuovi Argomenti, per volontà di Enzo Siciliano, nell’ultimo numero della stessa annata.
Nel 1975, dopo il rallentamento subìto negli anni precedenti, l’attività giornalistica s’intensificò. Nell’autunno del 1976 Consolo iniziò a collaborare anche con La Stampa e Il Corriere di Sicilia; dal dicembre 1977 con il Corriere della sera e, dal 1980, col Messaggero. Era un lavoro che non solo non si interruppe ma che, attraverso l’impegno profuso in numerosi quotidiani e periodici, anche stranieri, si prospettò infine come possibile impegno esclusivo: «Ho cercato di lasciare Milano nel 1975, perché non volevo più scrivere, non volevo più fare lo scrittore […]. Mi sono detto ‘farò il giornalista a vita’, perché mi sembra importante fare il giornalista, soprattutto in una città di frontiera com’era Palermo a quell’epoca» (in Pintor, 2006, p. 252).
Era la vigilia dell’uscita del romanzo, che avrebbe fatto conoscere Consolo al grande pubblico. Nell’autunno del 1975, infatti, all’insaputa dell’autore, apparve l’edizione Manusè del Sorriso dell’ignoto marinaio, per interessamento della compagna Caterina e di Sciascia, con un’acquaforte di Renato Guttuso. Dopo diverse proposte editoriali, e con un crescente interesse di pubblico e di critica, il romanzo apparve in versione definitiva nel 1979 per Einaudi, la casa editrice con la quale collaborava dal 1976 su proposta dell’amica Elsa Morante e dello stesso Giulio Einaudi; mentre già si diffondevano le traduzioni e mentre la RAI commissionò un progetto (mai realizzato) di sceneggiatura allo stesso Consolo e al regista Salvatore Maira.
Il romanzo richiama nel titolo il sorriso enigmatico raffigurato nel Ritratto di ignoto di Antonello da Messina. L’intreccio prende corpo intorno a tre elementi, che si fanno nuclei narrativi: il fascino esercitato dalla preziosa tavoletta pittorica ammirata già nell’estate del 1949 presso la Casa-museo Mandralisca; l’interesse per la storia della rivolta contadina di Alcàra Li Fusi, innescata dall’arrivo di Garibaldi; l’inchiesta sui cavatori di pietra pomice delle isole Eolie ammalati di silicosi. Ne vien fuori una complessa architettura narrativa, più volte letta come anti-Gattopardo; pur con moduli espressivi e pur da postazioni ideologiche e artistiche molto differenti, al centro di entrambi i romanzi è la Sicilia percorsa dai moti risorgimentali, liberata (o occupata) dai Mille. In tale prospettiva, Il sorriso può intendersi come epigono della tradizione del racconto storico siciliano per ridisegnare l’epopea risorgimentale sullo sfondo del quadro storico-sociale negli anni dello sbarco garibaldino: una tradizione «sempre critica, antirisorgimentale», che da Verga, attraverso De Roberto e Pirandello, arrivava a Sciascia e Tomasi di Lampedusa. La complessità strutturale e stilistica giustifica la lunga gestazione del testo. La trasposizione del tempo storico all’immediato presente, la riflessione sulla lingua e la stessa tessitura linguistica, impastata di dialetti e gerghi tecnici, sembrano confermare la natura più autentica della narrativa di un autore che, sul modello di Zola, «abdica, per così dire, alla sua condizione di letterato per divenire intellettuale, ‘politico’» (Letteratura e potere, [1979], in Di qua dal faro, cit., p. 1168); la decisione di «non scrivere in italiano» era una forma di «ribellione alle norme» e alla storia, una «uccisione del padre» (in Sinibaldi, 1988, p. 12).
Nella contaminazione tra inserti documentari e narrazioni d’autore, in una costante sovrascrittura per la quale è stata richiamata la tecnica chirurgica del «trapianto» (O’ Connell, 2008, p. 165), il romanzo evoca le sperimentazioni novecentesche, il pastiche gaddiano o lo sperimentalismo pasoliniano, pur con una declinazione personalissima, a tratti neobarocca; in una raffinatezza strutturale, di carattere anche simbolico, che si rivela in una «costruzione a chiocciola», concentrica e labirintica, sulla quale ha insistito un fortunato saggio di Cesare Segre (Segre, 1987). A sostenere questo complesso impianto è, però, anche la grande tradizione del romanzo storico, e naturalmente il suo primo modello, il Manzoni dei Promessi sposi e della Storia della colonna infame.
Continuava intanto l’attività di scrittura come protesta e insieme documento, in quei caldi ‘anni di piombo’, di attentati e inchieste, che Consolo tradusse anche in racconto nel riuscito Un giorno come gli altri (1981) inserito poi da Enzo Siciliano nel «Meridiano» dei Racconti italiani del Novecento.
GLI ANNI OTTANTA E IL DITTICO BAROCCO DI LUNARIA E RETABLO
Anche sull’onda del successo del Sorriso, negli anni Ottanta Consolo intensificò l’attività di scrittura nella ricerca di nuove forme espressive, come mostra l’ampio ventaglio di progetti ai quali lavorò: un singolare romanzo giallo, Morte del giardiniere (1981); un libro saggistico sul Movimento indipendentista siciliano (1981); l’ipotesi di una sceneggiatura sulla vita di Giovanni Pascoli, alla quale si dedicò a Roma nel 1982 con Vincenzo Cerami per un film che avrebbe dovuto esser realizzato da Marco Bellocchio; il progetto di una inchiesta su una vicenda criminale degli anni Cinquanta (i frati estorsori di Mazzarino, primo nucleo narrativo di Le pietre di Pantalica); la traduzione, insieme con Dario Del Corno, di Ifigenia fra i Tauri di Euripide, che andò in scena nel 1982 al Teatro antico di Siracusa.
Nel novembre 1983 discusse con l’allora giovanissimo regista Roberto Andò il progetto di un testo teatrale tratto dal citato poemetto in prosa di Lucio Piccolo, Le esequie della luna; ne nacque invece Lunaria, favola teatrale ambientata nella Palermo settecentesca che apparve nei «Nuovi Coralli» di Einaudi (Torino 1985) e che gli valse il premio Pirandello.
La scrittura degli anni Ottanta sembra, almeno in parte, allontanarsi dalle ardite sperimentazioni formali e linguistiche del Sorriso. Tanto Lunaria (cit.) quanto Retablo (Palermo, 1987) sembrano aprirsi a forme più distese, costruite su vicende ambientate in un Settecento colmo di riferimenti storici e insieme estraneo a documentazioni rigorose, con una libertà di invenzione che mancava alle opere precedenti.
Nella profonda tensione etica, la scrittura si sarebbe liberata dallo scavo della realtà autobiografica e storica proprio con Lunaria, che può anche leggersi come semplice allegoria della solitudine dello scrittore. Nella Palermo settecentesca si muove il malinconico Viceré Casimiro, che sogna la caduta della luna, turbato da fantasmi di una diversa realtà, in una visione che si fa presagio che s’invera. Con un’apertura della prosa verso la poesia, quella poesia alla quale pure Consolo si dedicò (Accordi. Poesie inedite di V.C., a cura di F. Zuccarello – C. Massetta Milone, S. Agata di Militello 2015), ‘Lunaria’ vira decisamente in direzione del fantastico, ma anche del conte philosophique, che però attinge alla fortunata tradizione popolare del cuntu, come anche alle suggestioni del teatro barocco, Calderón de la Barca in testa (cfr. Di Legami, 1990, p. 28). Nel giugno 1986 l’opera andò per la prima volta in scena, a Roma, con la Cooperativa Quarta espressione, costituita da giovani diplomati dell’Accademia drammatica Silvio d’Amico.
Si moltiplicava, intanto, la rete di relazioni significative (da José Saramago ad Alberto Moravia), mentre proseguiva con Sciascia una salda amicizia, che lo spinse a pubblicare un articolo (Difficile mestiere scrivere da uomo libero, in Il Messaggero, 27 gennaio 1987), in difesa dello scrittore di Racalmuto travolto dalle polemiche suscitate da I professionisti dell’antimafia, apparso nel Corriere della sera il 10 gennaio 1987.
In seguito all’insistente invito di Elvira Sellerio, nell’estate del 1987 Consolo raggiunse Palermo per lavorare a Retablo, che apparve (dopo l’anticipazione di alcuni capitoli in la Repubblica) nell’ottobre 1987, con cinque disegni di Fabrizio Clerici. Retablo riscosse grande successo di pubblico e gli valse il premio Grinzane Cavour e il premio Racalmare. Nel 1997 Sebastiano Romano ne realizzò una lettura scenica a Milano, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, per la regia di Richi Ferrero e dello stesso Romano. Una versione teatrale, scritta da Ugo Ronfani, andò in scena nel 2001 al teatro stabile di Catania e poi a Milano.
L’opera segna per molti aspetti uno snodo all’interno della produzione di Consolo che, sensibile agli esiti della narrativa italiana e straniera (da Calvino a Manganelli, da Perec a Borges), pone al centro della narrazione romanzesca una stringente interrogazione sulla scrittura. Nella reiterata sovrapposizione tra storia e invenzione, persone e personaggi, Retablo, che richiama l’arte pittorica sin dal titolo, segue le vicende di un intellettuale e artista in fuga da Milano verso la Sicilia alla ricerca della matrice culturale e umana della donna che ama, Teresa Blasco (nella storia, la madre di Giulia Beccaria). Intorno al protagonista-pittore si dipana un intreccio tra letteratura e arti visive, ormai divenuto centrale nella scrittura di Consolo (Cuevas, Ut pictura: el imaginario iconografico en la obra de V. C., in Cuevas, 2005, pp. 63-77); fino a una immaginazione visiva che punta sulla centralità dei luoghi, in una personale geografia esistenziale. Retablo infatti è costruito sul modello odeporico, che richiama, per rinnovarla, la tradizione dei racconti del Grand Tour oltre che del modello classico del nostos, che utilizzò poi anche nelle narrazioni successive, nella opposizione geostorica Milano-Sicilia.
Il 1989 segnò per Consolo il ritorno alla forma tragica, con un testo redatto insieme con gli amici Gesualdo Bufalino e Leonardo Sciascia, Trittico appunto, andato in scena al teatro stabile di Catania il 3 novembre 1989 per la regia di Antonio Calenda (poi in volume, Catania 1989). L’atto unico di Consolo, Catarsi, si accompagnava a La panchina di Bufalino e a Quando non arrivarono i nostri, rielaborazione drammaturgica di una novella di Sciascia. 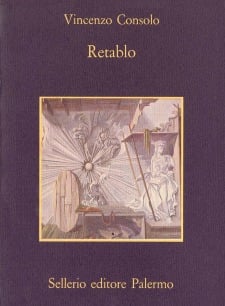
LA TRILOGIA DEGLI ANNI NOVANTA
La sincera passione civile, declinata spesso nel segno della protesta, non si tradusse mai nella partecipazione attiva alla politica – nonostante i ripetuti inviti a una sua candidatura avanzati dal Partito comunista italiano (PCI) di Achille Occhetto – ma certo animò la sua scrittura, nella battaglia ingaggiata tra le parole e le cose. All’indomani dell’assassinio del giudice Rosario Livatino, il 21 settembre 1990, in un acceso clima di rivendicazioni e polemiche, decise di dimettersi dalla giuria del premio Racalmare, che intanto era stato intitolato a Sciascia, scomparso l’anno precedente.
È nel segno di questa protesta che si inserisce anche lo studio e il racconto della Sicilia, che Consolo continuava a osservare e denunciare: l’isola tra mito e storia, la terra dalla quale idealmente non riuscì mai a separarsi, sul piano intellettuale e artistico, eppure nella quale non tornò mai a vivere. È in questa prospettiva che può leggersi quella che sembra configurarsi quasi come trilogia: Nottetempo, casa per casa (Milano 1992), L’olivo e l’olivastro (ibid. 1994) e Lo spasimo di Palermo (ibid. 1998), sotto il segno del definitivo tramonto dell’utopia, nell’accentuazione di una dimensione simbolica della storia e della realtà.
Dopo una serie di ritratti di scrittori lombardi realizzati in RAI nel 1991 con il titolo Tracciati (Piero Chiara, Carlo Emilio Gadda, Lucio Mastronardi, Ada Negri, Vittorio Sereni, Delio Tessa e Giovanni Testori), nel 1992 Nottetempo, casa per casa (cit.), che fu insignito con il Premio Strega, rappresentò un ritorno al romanzo storico, come già forse, in parte, Le pietre di Pantalica (Milano 1988), stratificato e multigenere, la cui struttura tripartita (Teatro, Persone, Eventi) rimandava ancora una volta al teatro.
Al progetto narrativo di Nottetempo Consolo lavorava almeno dalla fine degli anni Sessanta, quando aveva cominciato a raccogliere materiali e documenti sul risorgimento in Sicilia, sulla strage di Alcàra Li Fusi e sulla Cefalù degli anni Venti alle prese con il controverso caso del “santone” Aleister Crowley. L’opera sembra segnare il secondo tempo di una ideale lunga storia della Sicilia, una fase successiva al Risorgimento del Sorriso e precedente agli anni Novanta di Lo spasimo di Palermo (1998). «In Nottetempo ho voluto far vedere come il fascismo fosse figlio della follia, la follia privata del protagonista e quella pubblica della Storia, il ricorso al satanismo che voleva distruggere il cristianesimo di una società malata: tutti segni oscuri e premonitori, come quelli che vediamo oggi con il ritorno a queste ridicole forme di esorcismo, questi fondamentalismi, questi revanscismi» (in Parazzoli, 1998, p. 28).
Continuava la sua forte militanza civile: le proteste contro l’elezione di Formentini a sindaco di Milano, o le dimissioni, all’indomani della nomina, il 10 settembre 1993, dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del teatro stabile di Palermo, in polemica con il direttore artistico Pietro Carriglio, ritenuto «intellettuale organico alla DC di Salvo Lima».
Questa forte militanza proseguì con maggiore libertà dopo il suo collocamento in pensione dalla RAI, nel 1993. In seguito alla vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche, Consolo aderì al Forum Manifesto democratico 1994, promosso da Cesare Segre, Raffaele Fiengo e Corrado Stajano. Intanto, il 25 giugno di quell’anno partecipò a un dibattito coordinato da Renato Nisticò da cui sarebbe nato il testo Fuga dall’Etna (cit.), nuova testimonianza di una sicilianità che trovò riconoscimento anche nella cittadinanza onoraria di Cefalù, cui seguì, nel 1996, la stessa onorificenza da parte del Comune di Santo Stefano di Camastra. Ed è sempre la Sicilia al centro del volume del 1994, L’olivo e l’olivastro, che nel consueto superamento dei confini di ‘generi’ compiuto da Consolo, nell’intreccio tra poesia e prosa, narrazione e saggismo, che per alcuni richiama l’Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, si presenta come graffiante narrazione di viaggio. Il doloroso ritorno di Odisseo-Consolo verso l’Itaca-Sicilia è «un viaggio in verticale, una discesa negli abissi». Come Retablo, anche L’olivo e l’olivastro conduce il lettore attraverso la Sicilia di un presente degradato, che si confronta con il passato mitico.
Nel dicembre dello stesso 1994 ricevette per il complesso della sua opera narrativa e saggistica il premio internazionale Unione Latina da una giuria composta, tra gli altri, da José Saramago, Jorge Amado, Luigi Malerba.
In questi anni Novanta la presenza internazionale di Consolo si andò rafforzando. Nel 1995, su invito dell’allora presidente Salman Rushdie, divenne membro del Parlament international des écrivains (PIE) di Strasburgo. Tra dicembre 1995 e gennaio 1996 a Parigi andò in scena La crèche de Sicile, rappresentato anche a Palermo l’anno dopo. Il 15 febbraio 1996 il ministro della Cultura francese Philippe Douste-Blazy lo nominò chevalier dans l’Ordre des Arts et des lettres. Ormai anche socio onorario dell’Accademia di Brera, nel 1996 fu inoltre in Argentina con una delegazione di scrittori italiani, su invito dell’Università di Buenos Aires; seguirono quindi viaggi a Strasburgo, Santiago del Cile e nella Bosnia-Erzegovina della guerra.
Alla Sicilia continuano a essere dedicate anche le sue opere mature. Il 19 giugno 1998 venne eseguita al teatro Verdi di Firenze, l’Ape iblea. Elegia per Noto, musicata da Francesco Pennisi (poi, insieme con Catarsi, raccolto nel volume Oratorio, Lecce 2002). Pochi mesi dopo apparve il suo ultimo romanzo, Lo spasimo di Palermo (Milano 1998) che, riprendendo elementi de La ferita dell’aprile, segna come un ritorno all’autobiografismo. La vicenda si svolge nell’anno delle stragi di Capaci e via D’Amelio, i tragici fatti del 1992 ai quali Consolo aveva già dedicato un testo-adattamento della Messa di requiem di Verdi: Dies irae. Requiem da questa Palermo (poi Requiem per le vittime della mafia), eseguita con musiche di vari artisti nella Cattedrale di Palermo il 27 marzo 1993. La vicenda del protagonista-scrittore Gioacchino Martinez e del suo nostos ai luoghi dell’infanzia e giovinezza riscosse grande successo di pubblico e di critica (premio Monreale per la narrativa nel 1998; nonché, l’anno successivo, insignito con il premio Flaiano e il premio Brancati).
La Sicilia è ancora protagonista dell’ampia raccolta di saggi per la quale ipotizzava il titolo Pane di zolfo o Per nascente solfo, che apparve invece con il titolo Di qua dal faro (Milano 1999; premio Nino Martoglio e premio Feronia). Ed è ancora alla cultura popolare isolana che si consacra una sua riscrittura delle Fiabe siciliane raccolte nel 1868-69 dall’etnologa siculo-svizzera Laura Gonzenbach (Roma 1999).
IL SILENZIO DELLO SCRITTORE
Gli ultimi anni di vita sono segnati per Consolo da una dolorosa afasia artistica, che si manifesta come ulteriore declinazione dell’impegno, nella presenza-assenza al suo tempo e nella difficile condizione di un intellettuale «solo perché libero» (Letteratura e potere, cit., p. 1172). Nel marzo 2000 partecipò a una conferenza in difesa di Adriano Sofri, organizzata dal citato PIE con Christian Salmon, Jacques Derrida, Jacqueline Risset e Antonio Tabucchi. Il mese successivo firmò la sua adesione al Manifesto in difesa della lingua italiana promosso tra gli altri da Luigi Manconi, Aldo Masullo, Vittorio Sermonti, nella convinzione che l’Italia «ha perso memoria di sé, della sua storia, della sua identità», e che «l’italiano è divenuta un’orrenda lingua, un balbettio invaso di linguaggi che non esprimono altro che merce e consumo» (Il lungo sonno della lingua, in Il Corriere della sera, 6 giugno 2000).
Dopo esser stato in Francia ospite d’onore dell’Académie française al Prix Italiques, dove lesse la relazione La patria immaginaria, (poi con il titolo I Vespri, i paladini e la patria immaginaria, in Stilos, 1° maggio 2001), nel 2002 si trovò a esprimere per motivi politici – insieme con Umberto Eco e Antonio Tabucchi – il suo rifiuto alla partecipazione al Salon du livre di Parigi come componente della delegazione ufficiale italiana. Nello stesso anno si recò in Palestina con il PIE, per consegnare un appello di pace ad Arafat (cfr. Madre coraggio, poi in La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 195-200) e firmò anche un Manifesto contro la islamofobia, che sarebbe stato presentato poi alla Fundación de cultura islámica di Madrid il 30 gennaio 2007.
Intanto, era ascoltato, letto e studiato all’estero: nel 2002 tenne un ciclo di conferenze negli Stati Uniti, mentre si avvicendavano convegni e volumi a lui dedicati: Siracusa, Siviglia e tre convegni all’Università di Valencia per iniziativa di Irene Romera Pintor, traduttrice di opere consoliane. Con il convegno Éthique et écriture tenuto il 25 e 26 ottobre 2002, con la direzione di Dominique Budor (ed. in volume, Parigi 2007), l’Università Sorbonne di Parigi dedicava per la prima volta un convegno a uno scrittore vivente.
Nel 2003 l’Università di Roma «Tor Vergata» gli conferì la laurea honoris causa in lettere: pronunciò una lectio magistralis (La metrica della memoria) che riprendeva una fortunata relazione del 1996. Nello stesso anno, dal Ministère de la culture et de la communication francese, fu insignito del grado di officier dans l’Ordre des Arts et des lettres. Una seconda laurea honoris causa, in filologia moderna, gli venne conferita, insieme con Luigi Meneghello, da parte dell’Università di Palermo nel 2007.
Mentre proseguivano le edizioni di romanzi e raccolte di saggi in Europa, negli Stati Uniti e in Canada, a settembre 2004 Consolo iniziò a lavorare a una raccolta di racconti, che apparve postuma nel maggio 2012, a pochi mesi dalla morte, con il titolo La mia isola è Las Vegas, a cura di Nicolò Messina. Dichiarava intanto di lavorare al suo ultimo romanzo, Amor sacro e amor profano, del quale però nell’Archivio Consolo non sono state rinvenute carte.
Nel 2010 Consolo avrebbe dovuto introdurre un’opera di Roberto Saviano (La parola contro la camorra, DVD, Torino 2010) ma, risentito per alcune non condivise dichiarazioni letterarie e politiche del giovane autore, ritirò il suo testo.
Mentre dunque Consolo testimoniava la sua presenza nel segno della denuncia, e spesso del rifiuto, si moltiplicavano le trasposizioni delle sue opere letterarie. Erano transcodificazioni, da intendersi anche come viaggio dei testi, che rispondevano a specifici interessi di un intellettuale sempre attento ai diversi linguaggi artistici, in particolare alla pittura – che tanto attraversava la sua scrittura –, al teatro e soprattutto al cinema, consumato quest’ultimo come rito collettivo, come rievoca nel racconto-saggio scritto in occasione della proiezione di Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (Dal buio, la vita, in Di qua dal faro, cit., pp. 1179-1184). Mentre si arenava il progetto di una riduzione cinematografica dello Spasimo di Palermo, proseguivano adattamenti teatrali delle sue opere. Dopo la versione di Retablo al teatro stabile di Catania, per la stessa regia di Daniela Ardini, Ugo Ronfani scrisse nel luglio 2010 l’adattamento del Sorriso dell’ignoto marinaio, andato in scena a Genova. Al festival di Cannes dello stesso anno venne presentato il progetto cinematografico Vivre ou rien, di Maria Agnès Viala e Giorgio Arlorio, tratto da Lo spasimo di Palermo.
Il 5 giugno del 2011, nonostante fosse affetto da un tumore in stadio avanzato, Consolo si recò personalmente a Ostana (Cuneo) per ricevere il premio Lenga Maire, dedicato alle scritture in lingue minoritarie. Teneva molto al premio, che riconosceva il suo impegno per far rivivere lingue marginali e in via di estinzione.
Morì poco dopo, a Milano, il 21 gennaio 2012. Rifiutando cerimonie pubbliche in fede alla volontà dell’Autore, la moglie Caterina fece celebrare le esequie a Sant’Agata di Militello il 23 gennaio, dove fu seppellito nella cappella di famiglia.
OPERE
Gran parte dei volumi editi sono ora raccolti nel «Meridiano» L’opera completa, a cura di G. Turchetta con un profilo di C. Segre, Milano 2015, da cui si cita e cui si rimanda anche per una esaustiva bibliografia degli scritti (che include articoli, saggi in volume, traduzioni, riscritture e altri scritti sparsi), insieme con una dettagliata bibliografia critica.
Il volume comprende (nell’ordine delle prime edizioni): La ferita dell’aprile, Milano 1963; Il sorriso dell’ignoto marinaio, Torino 1976; Lunaria, ibid. 1985; Retablo, Palermo 1987; Le pietre di Pantalica, Milano 1988; Nottetempo, casa per casa, ibid. 1992; L’olivo e l’olivastro, ibid. 1994; Lo spasimo di Palermo, ibid. 1998; Di qua dal faro, ibid. 1999.
Ci si limita qui a segnalare i volumi non inclusi in quella edizione (anche postumi) e i saggi critici citati: Marina a Tindari. Poesie, Vercelli 1972; V. Consolo – N. Rubino, Fra contemplazione e Paradiso. Suggestioni dello Stretto, Messina 1988; Catarsi, in V. Consolo – G. Bufalino – L. Sciascia, Trittico, a cura di A. Di Grado – G. Lazzaro Damuso, Catania 1989; La Sicilia. Passeggiata, Torino 1991; Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma 1993; Neró metallicó, Genova 1994; V. Consolo – M. Nicolao, Il viaggio di Odisseo, introd. di M. Corti, Milano 1999; Il Teatro del Sole. Racconti di Natale, Novara 1999; V. Consolo – F. Cassano, Lo sguardo italiano. Rappresentare il Mediterraneo, Messina 2000; Oratorio, Lecce 2002; Isole dolci del Dio, Brescia 2002; Reading and writing the Mediterranean. Essays by V. C., a cura di N. Bouchard – M. Lollini, Toronto 2006; Il corteo di Dioniso, Roma 2009; Pio La Torre, orgoglio di Sicilia, Palermo 2009; L’attesa, Milano 2010; La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, ibid. 2012; Esercizi di cronaca, a cura di S. Grassia, Palermo 2013; Accordi. Poesie inedite di V. C., a cura di F. Zuccarello – C. Masetta Milone, S. Agata di Militello 2015.
FONTI E BIBLIOGRAFIA
M. Sinibaldi, La lingua ritrovata: V. C., in Leggere, II (1988), pp. 8-15; C. Segre, Introduzione a V. Consolo, Il Sorriso dell’ignoto marinaio, Milano 1987, pp. V-XVIII (poi in Id., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino 1991, pp. 71-86); F. Di Legami, V. C. La figura e l’opera, Marina di Patti 1990; V. C., Nuove Effemeridi, VIII (1995/I), 29 (n. monografico); P. Farinelli, Strategie compositive, motivi e istanze nelle opere di V. C., in Italienisch, XXXVII (1997), pp. 38-45; F. Parazzoli, Il gioco del mondo, dialoghi sulla vita, i sogni, le memorie, Cinisello Balsamo 1998, pp. 21-33; G. Traina, V. C., Fiesole 2001; E. Papa, V. C., in Belfagor, LVIII (2003), 2, pp. 179-198; Per V. C., Atti delle giornate di studio… 2003, a cura di E. Papa, San Cesario di Lecce 2004; Leggere V. C. – Llegir V. C., a cura di M.A. Cuevas, in Quaderns d’Italià, X (2005), pp. 5-132; «Lunaria» vent’anni dopo, a cura di I. Romera Pintor, Valencia 2006; La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di V. C., a cura di G. Adamo, San Cesario di Lecce 2006; V. C. Éthique et écriture, Atti del Convegno… 2002, a cura di D. Budor, Paris 2007; L. Terrusi, L’onomastica nel «Sorriso dell’ignoto marinaio» di V. C., in Il Nome del testo, XIV (2012), pp. 55-63.