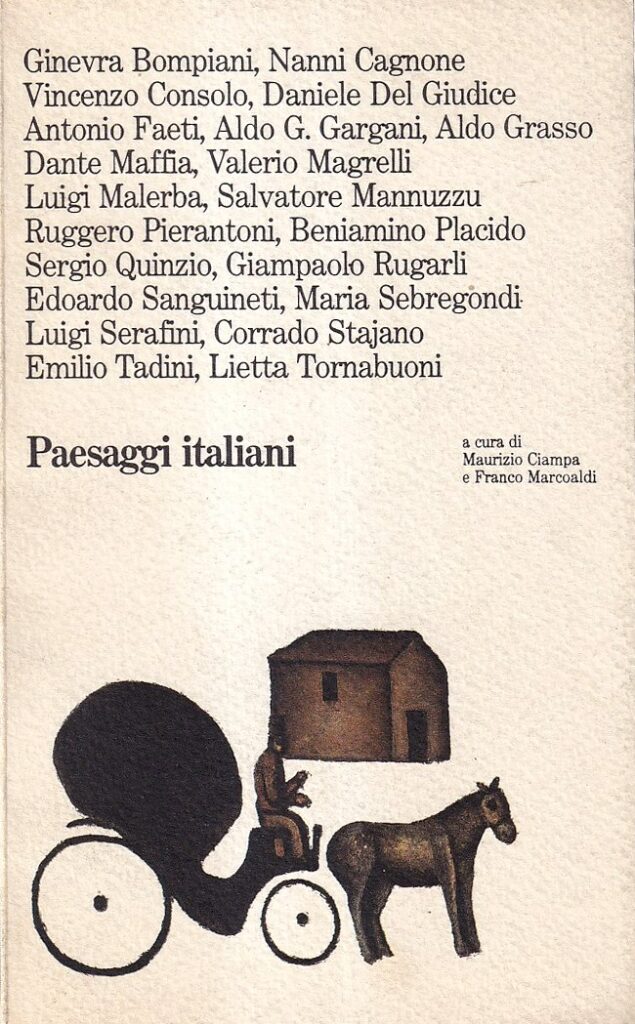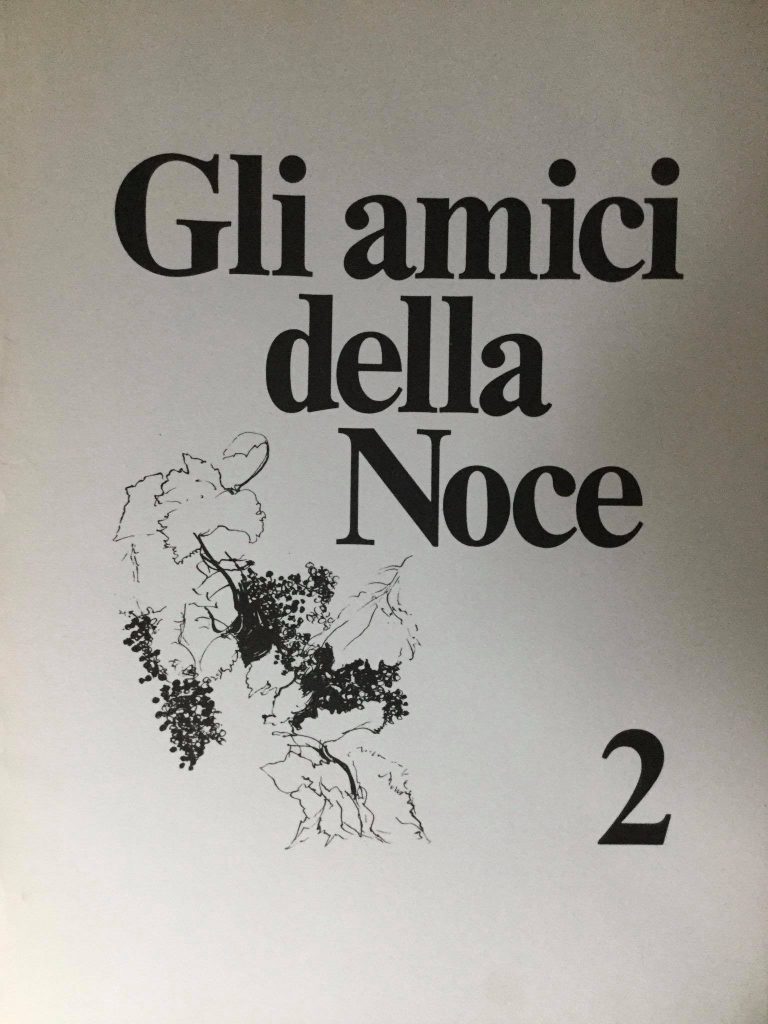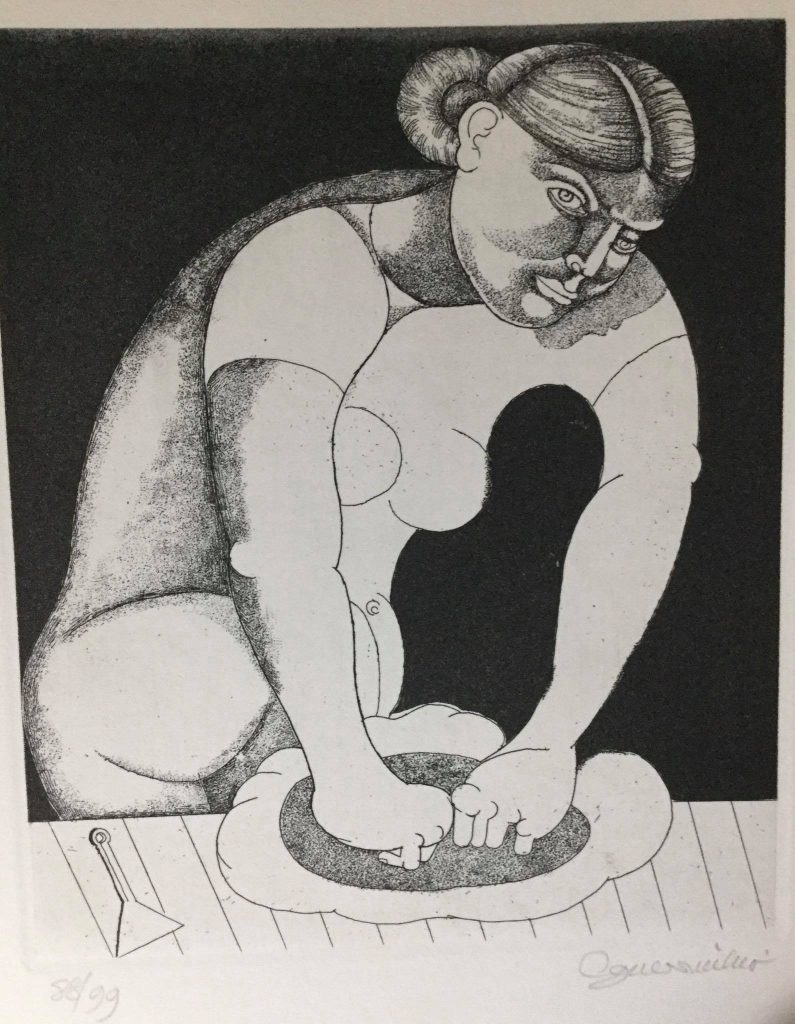Vincenzo Consolo – Far risalire l’uomo dal sottosuolo
Racalmuto, Regalpetra: la sua Yoknatapawpha, la sua Orano. La sua, di Leonardo Sciascia. Credo che non si possa capire questo straordinario uomo e questo grande scrittore, al di là o al di qua del più vasto teatro della Sicilia, dell’Italia o della civiltà mediterranea, senza questo piccolo mondo, questo suo piccolo paese di nascita e di formazione, sperduto nella profonda Sicilia. Un paese “diverso”, singolare.
Un paese del mondo dello zolfo. Qui, in questa zona del Girgentano, era avvenuta alla fine dell’800, una profonda, radicale rivoluzione culturale: al mondo della rassegnazione, dell’abbandono al fato immutabile, al mondo della passiva ripetizione di sentenze sapienziali, della inutile lotta di piccoli uomini come i Malavoglia e di disperati titani come Gesualdo Motta, votati comunque a una uguale sconfitta, questo mondo orizzontale ed eternamente circolare, scandito dalle chiuse, dai tumuli e dalle salme di terra che servono solo a seppellirvi chi accumula e possiede, era subentrato un mondo verticale, profondo e orrifico, dentro cui il contadino, già da una estrema condizione di insicurezza, di povertà, era precipitato: laggiù, dentro la miniera, spogliato d’ogni illusione, fantasia, spogliato nel corpo d’ogni riparo, avrebbe lottato contro la paura e la disperazione, contro la degradazione, l’annientamento. In quella condizione estrema d’una zona estrema, dalla spirale di quell’inferno sotterraneo, l’uomo poteva precipitare in basso o risalire verso la superficie. Ritrovando tutta la sua ragione, la sua volontà, la sua dignità. Regalpetra è formato da questa umanità: da zolfatari usciti dalla disperazione e dalla disgregazione della ragione, dalla stupefazione anche di fronte al paesaggio arso e pietroso attorno alla miniera, un paesaggio da Tebaide, da eliotiana “Terra desolata”: un mondo aspro, di ceneri e detriti, un’aria inacidita dai fiati dei “calcaroni”, incolore, sbiadito finanche nei vestiti delle donne, ma che tuttavia, la “peregrina della notte”, la luna può addolcire con la sua argentea luce e commuovere come in Ciáula che risorge dalle viscere della miniera.
E, fra le case del paese, nelle vie di Racalmuto, nei circoli, lo zolfataro racalmutese, deposta ogni rassegnazione al fato, ogni soggezione al padrone, ha imparato a ragionare, a parlare: un linguaggio nuovo, non più di proverbi, ma di sottile analisi, di conoscenza e comprensione della realtà; ha imparato a ragionare della realtà, della propria condizione umana e sociale, del suo stare e lavorare dentro un consorzio sociale. Di questa Racalmuto Sciascia è figlio, è uomo prima ancora che scrittore.
Dal cuore di questo pane giallo di zolfo è venuto fuori il cristallo limpido e tagliente della sua intelligenza, il calore della sua umanità; la pietà e il furore, la volontà e la tenacia. Da qui la sua lotta accanita, dura, disperata, contro le violenze della storia, del potere, contro la menzogna, l’impostura, l’ignoranza, la malafede, il fanatismo, la stupidità.
Da questo cuore profondo della miniera racalmutese è sgorgata la splendida metafora del mondo contenuta in ogni suo libro. “Tutti amiamo il luogo in cui siamo nati, e siamo portati ad esaltarlo. Ma Racalmuto è davvero un paese straordinario…di Racalmuto amo la vita quotidiana, che ha una dimensione un po’ folle. La gente è molto intelligente, tutti sono come personaggi in cerca d’autore” scrisse.
Il teatro di Racalmuto era dichiarato ed evidente nel suo primo passo letterario, che, ricordiamocelo, fu lirico, sentimentale, un libro di versi : La Sicilia, il suo cuore; e quindi, nella prosa più secca, lucida e denunciatoria, quel libro che conterrà tutti i suoi libri futuri: Le parrocchie di Regalpetra.
Solamente due volte infine Sciascia, nella sua inimitabile misura e pudore dei sentimenti privati, ha apposto una dedica ai suoi numerosi libri: a Morte dell’inquisitore, dedicato agli “uomini di tenace concetto” di Racalmuto; e a Occhio di capra, dedicato “Ai miei nipoti Fabrizio, Angela, Michele e Vito perché ricordino”. Occhio di capra è la raccolta estrema, di salvataggio, in questo nostro mondo di cancellazioni e di perdite, dei modi di dire, di proverbi racalmutesi.
Recita così uno di essi: “E il cucco disse ai suoi piccoli / al chiarchiàro ci rivedremo tutti. Per dire dell’appuntamento che tutti abbiamo con la morte”.
Ma questo luogo aspro e aguzzo che è oggi il mondo, questa Tauride disumana, questo chiarchiàro la scomparsa di Sciascia rende ora per noi più triste, più desolato.
(dal Corriere della Sera, 21 novembre 1989)
confluito in Nuove Effemeridi
Editori Guida anno III, n.9, 1990