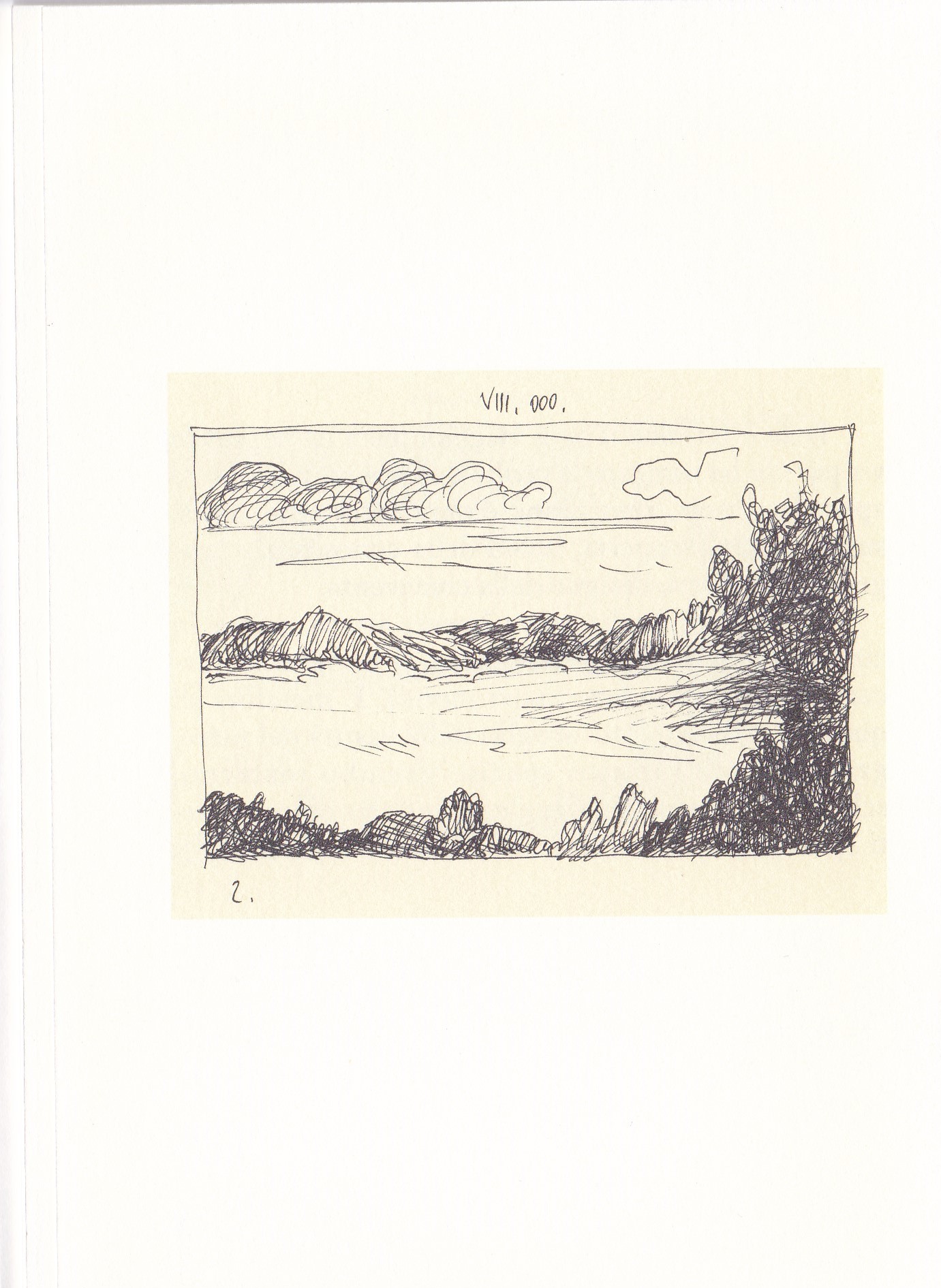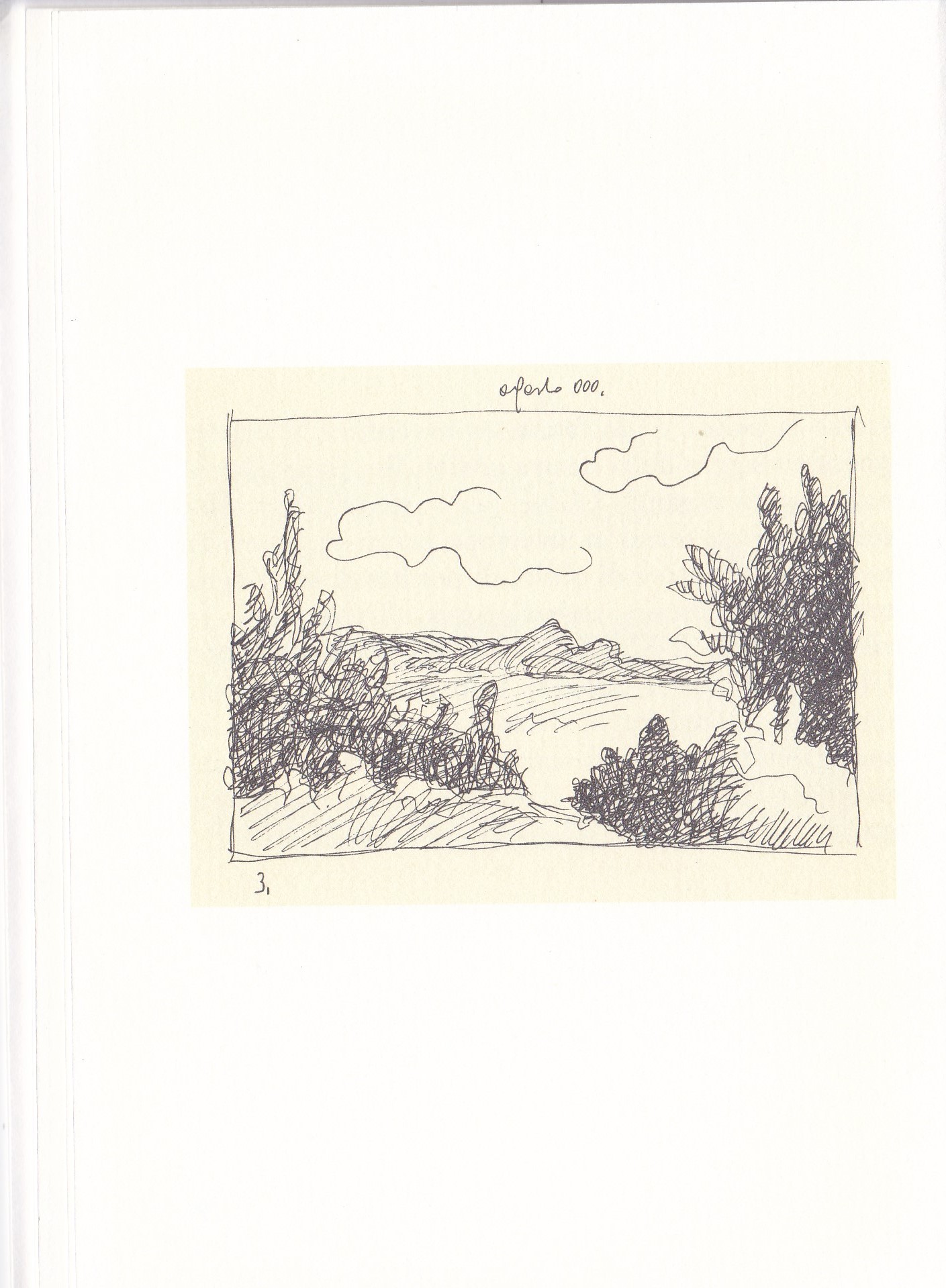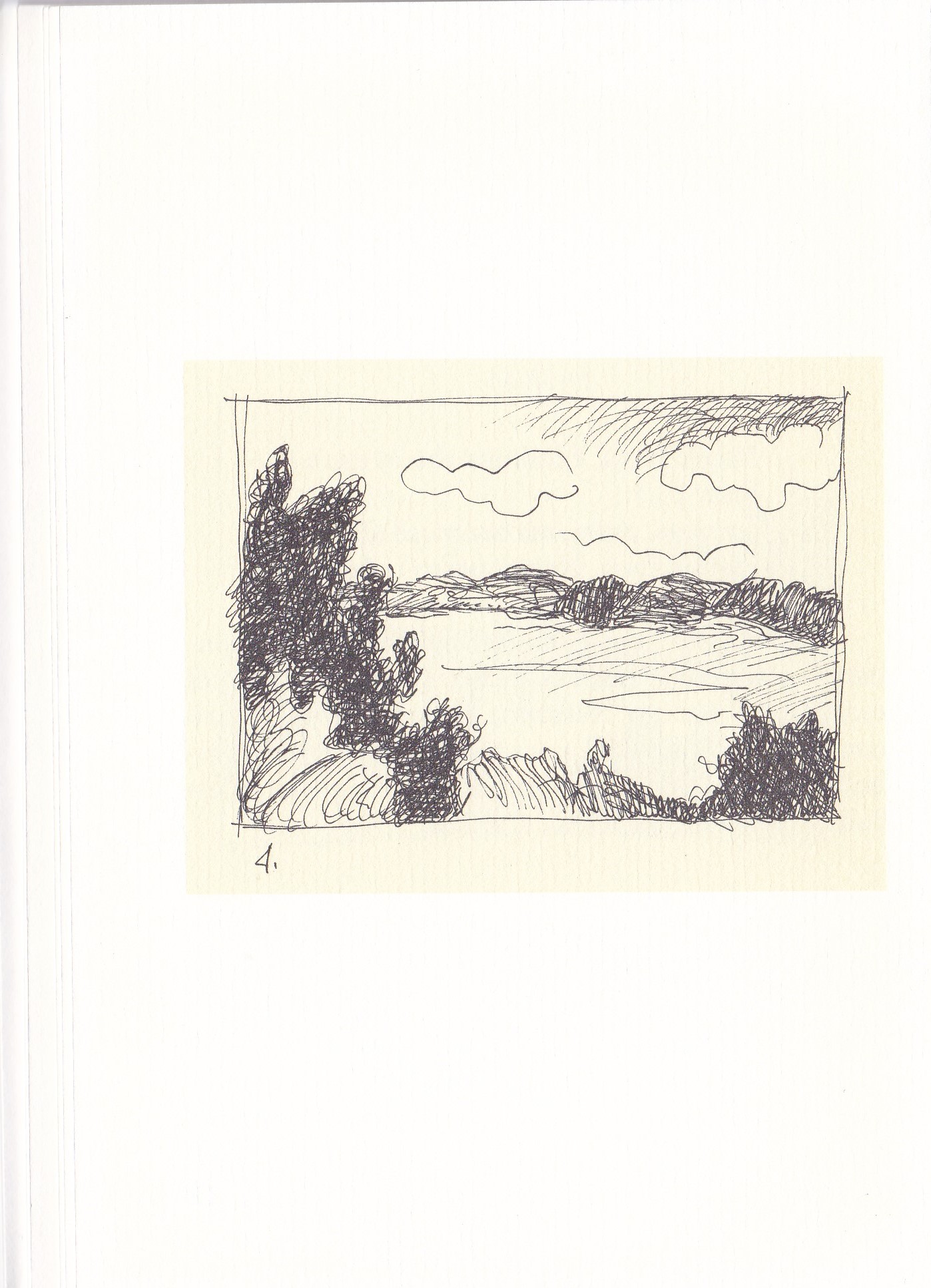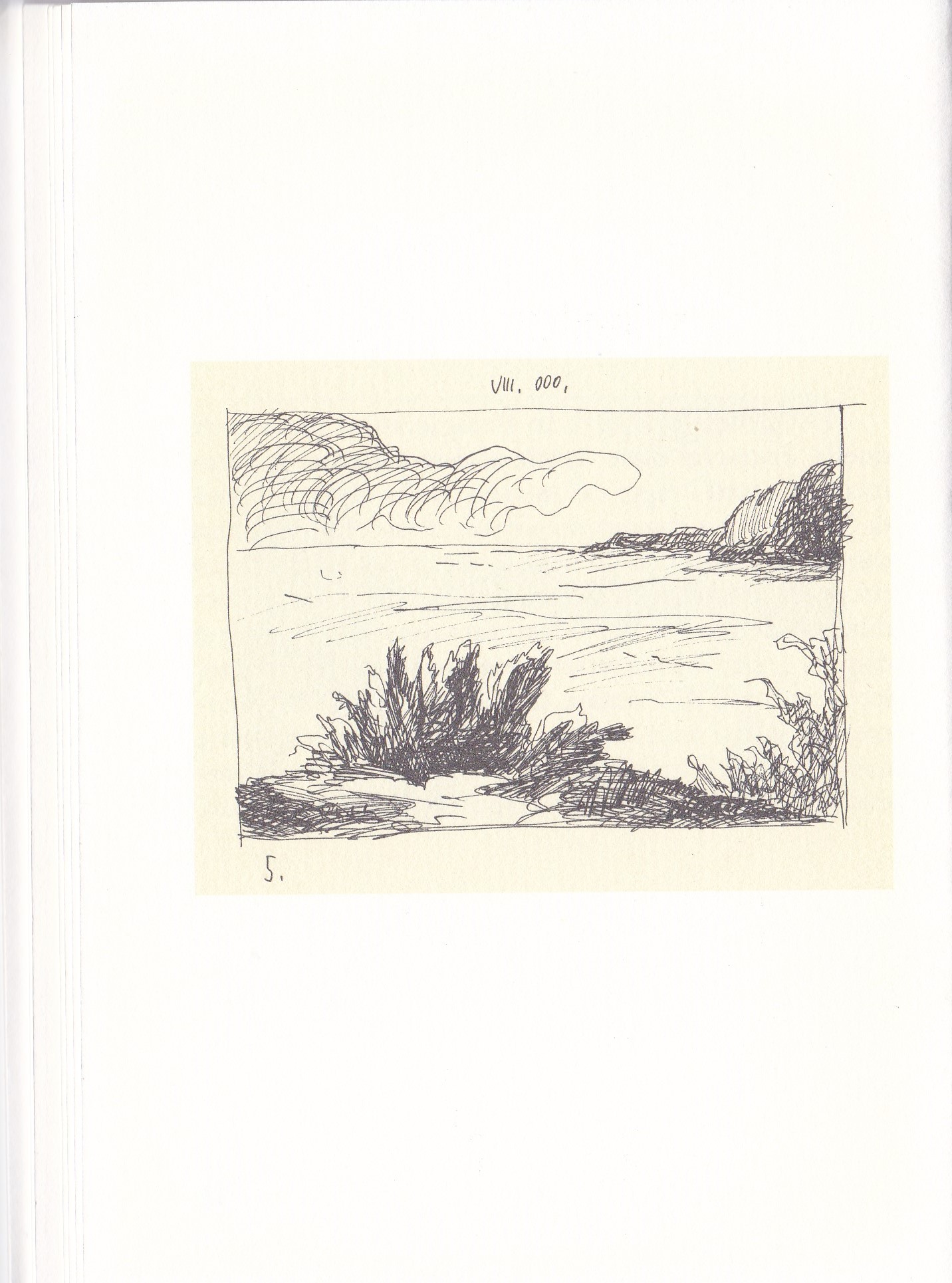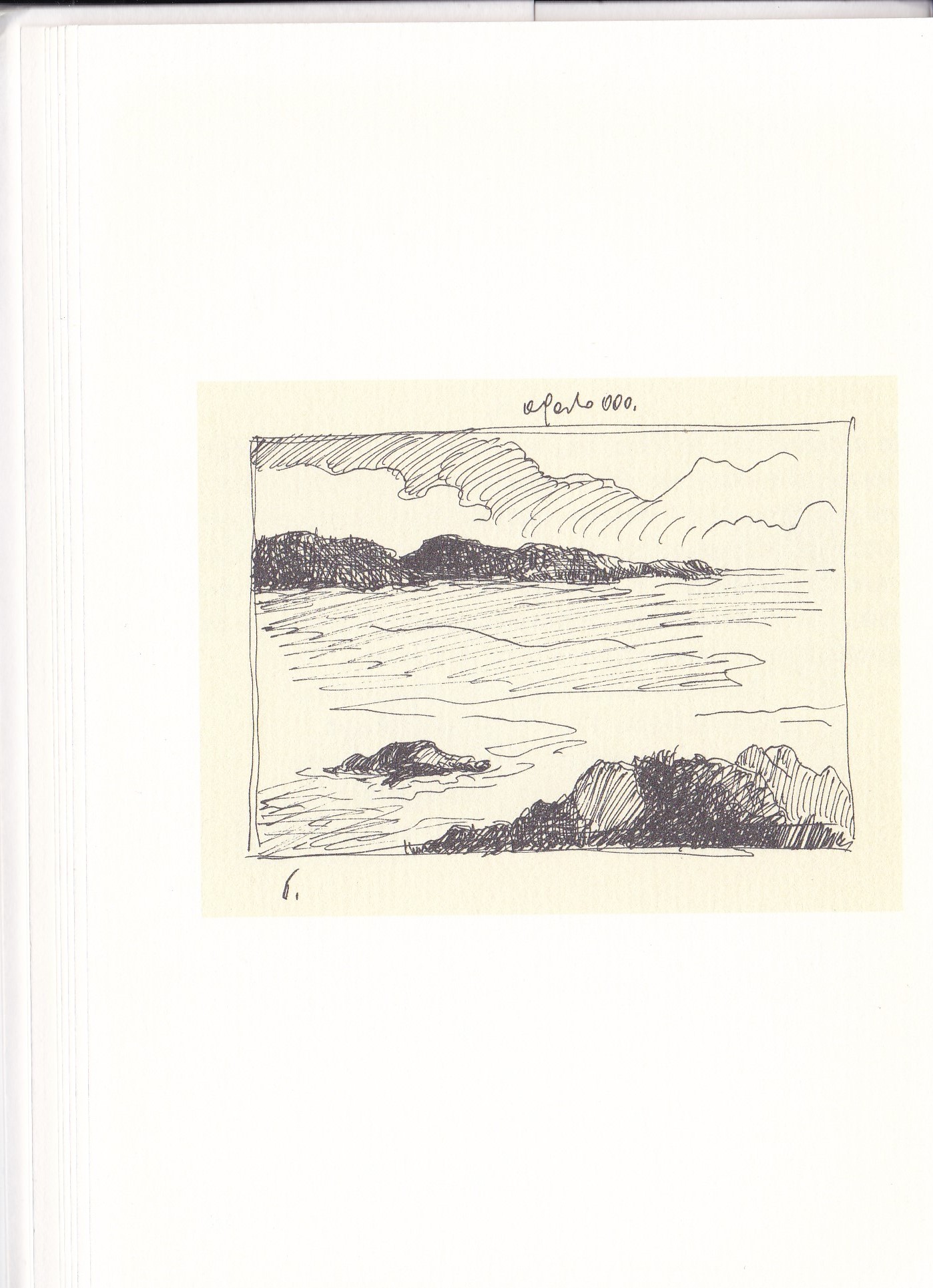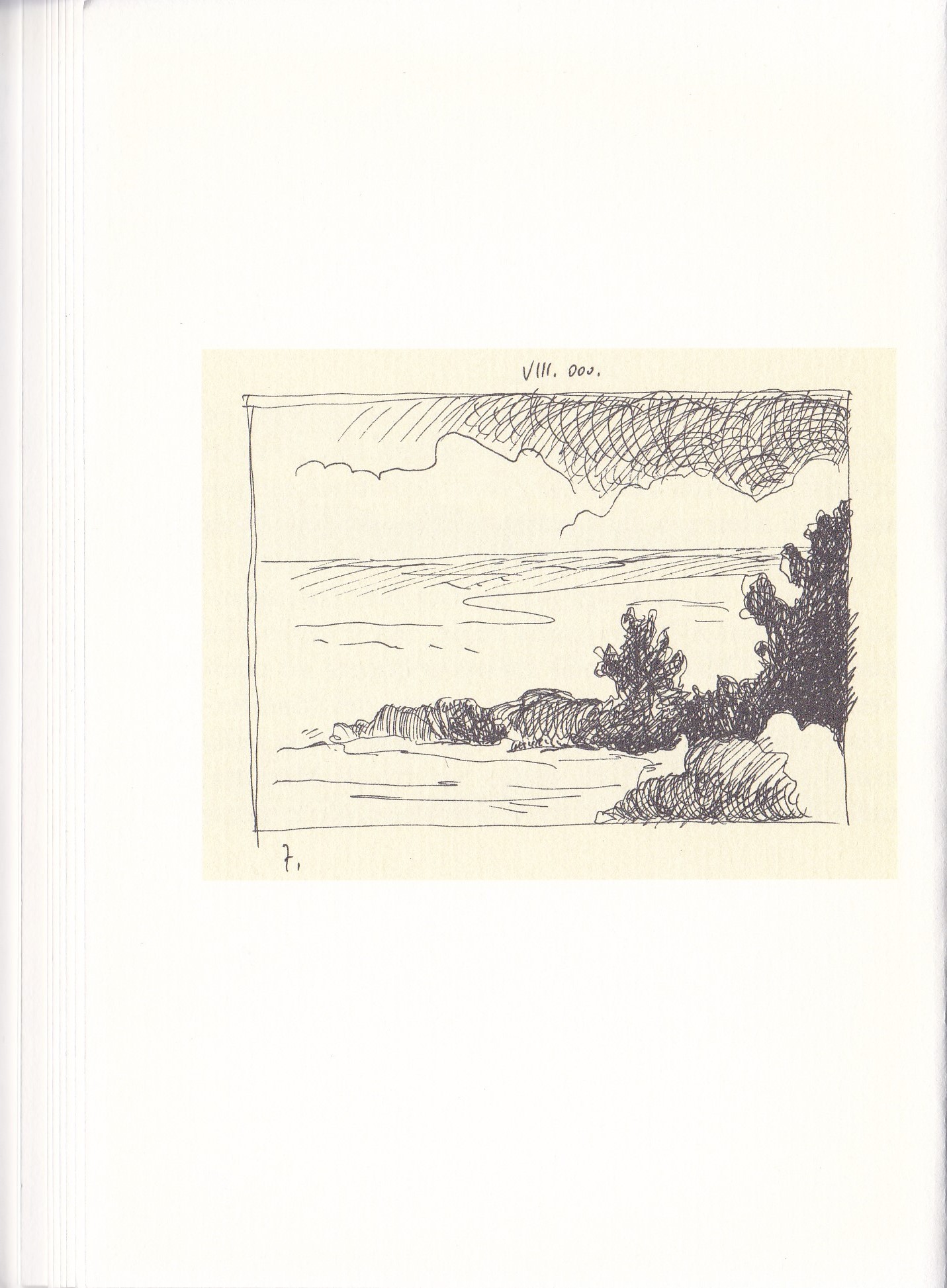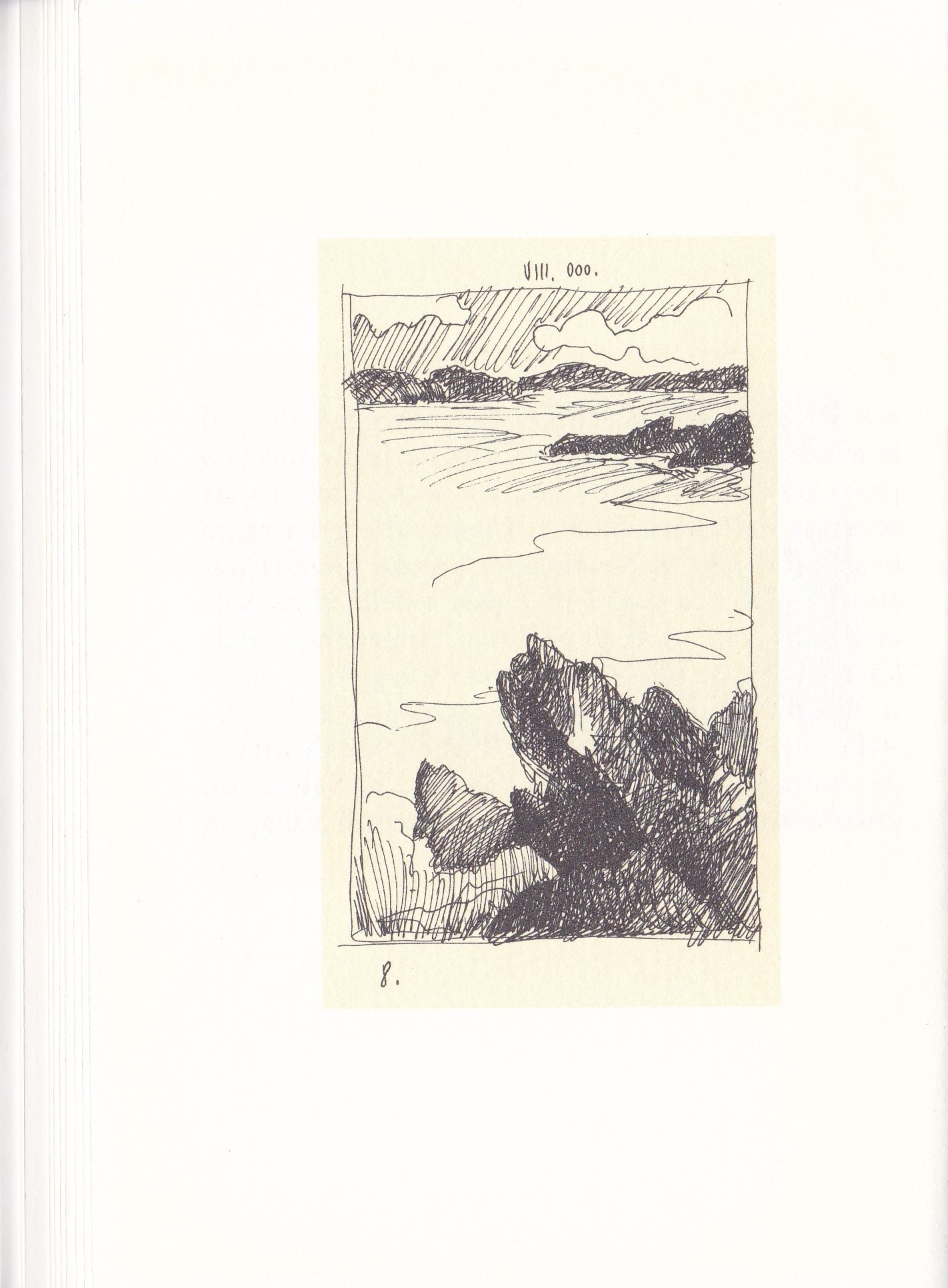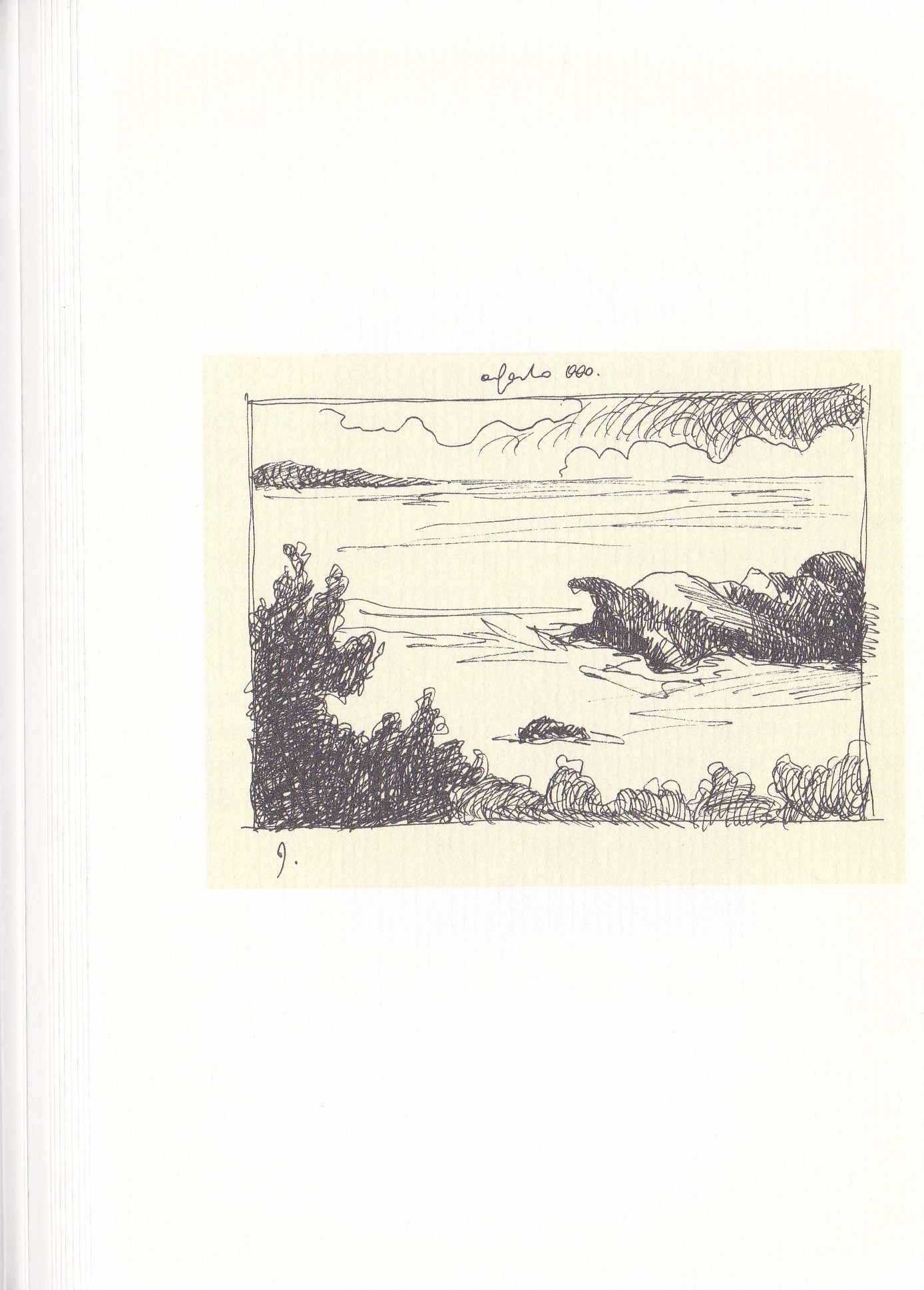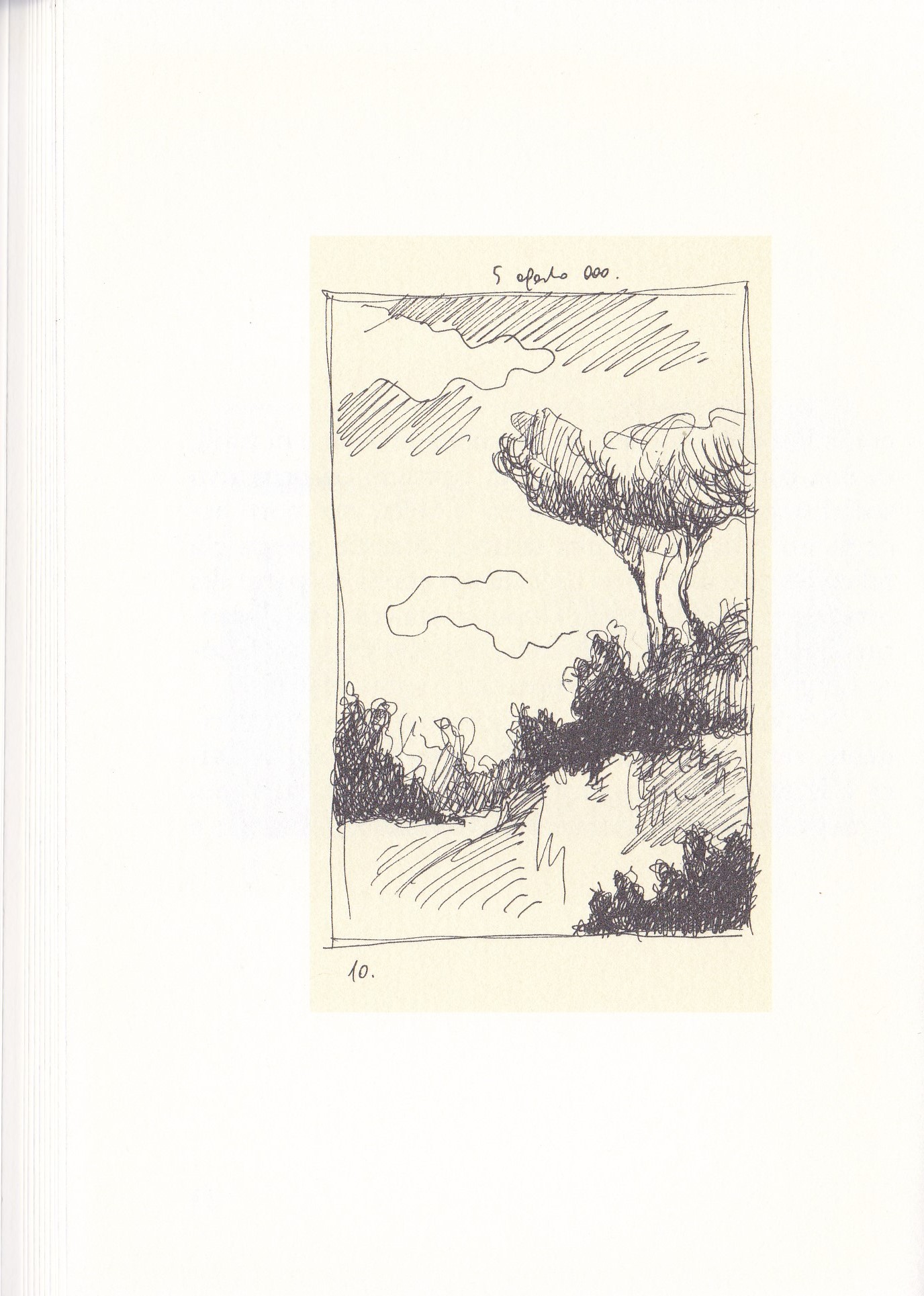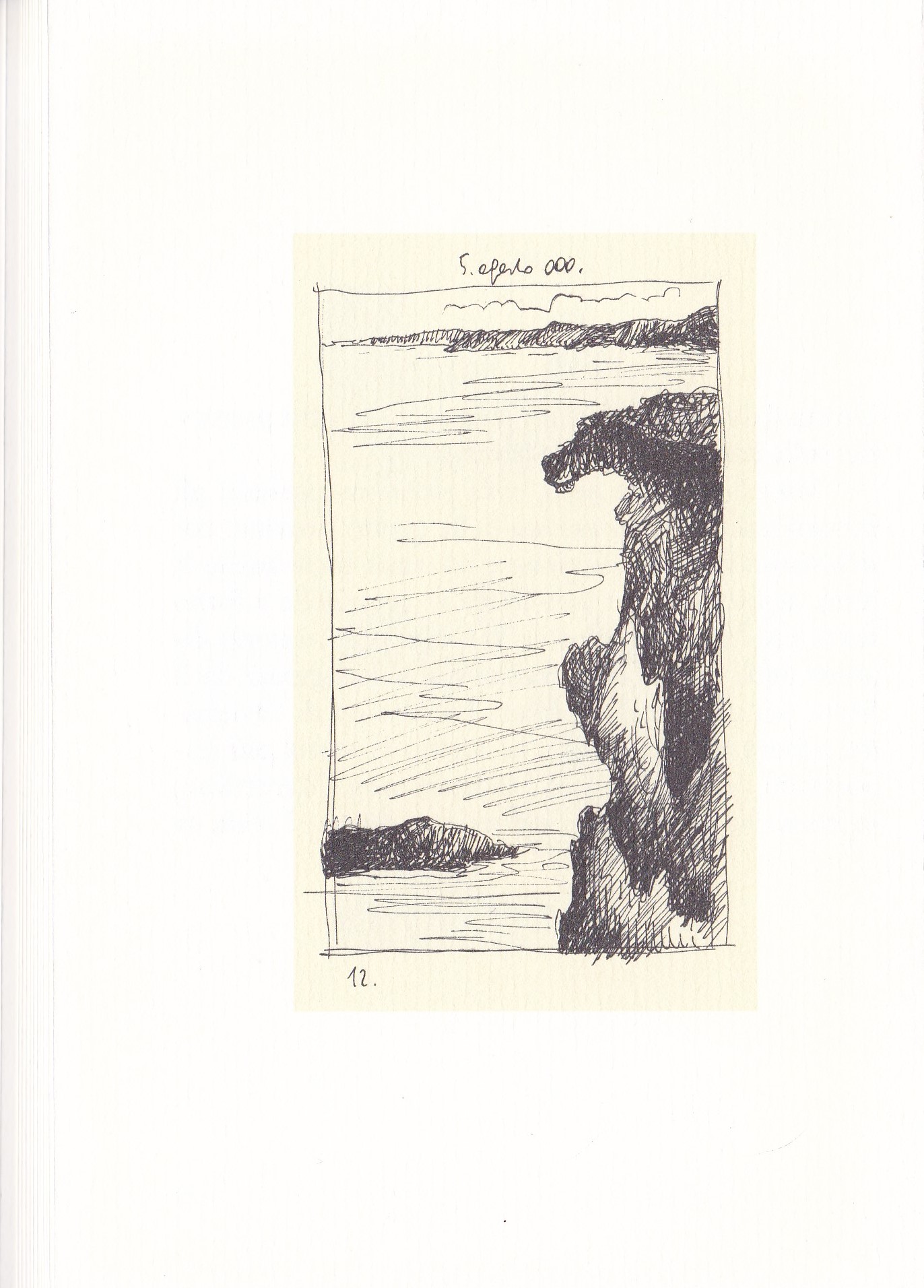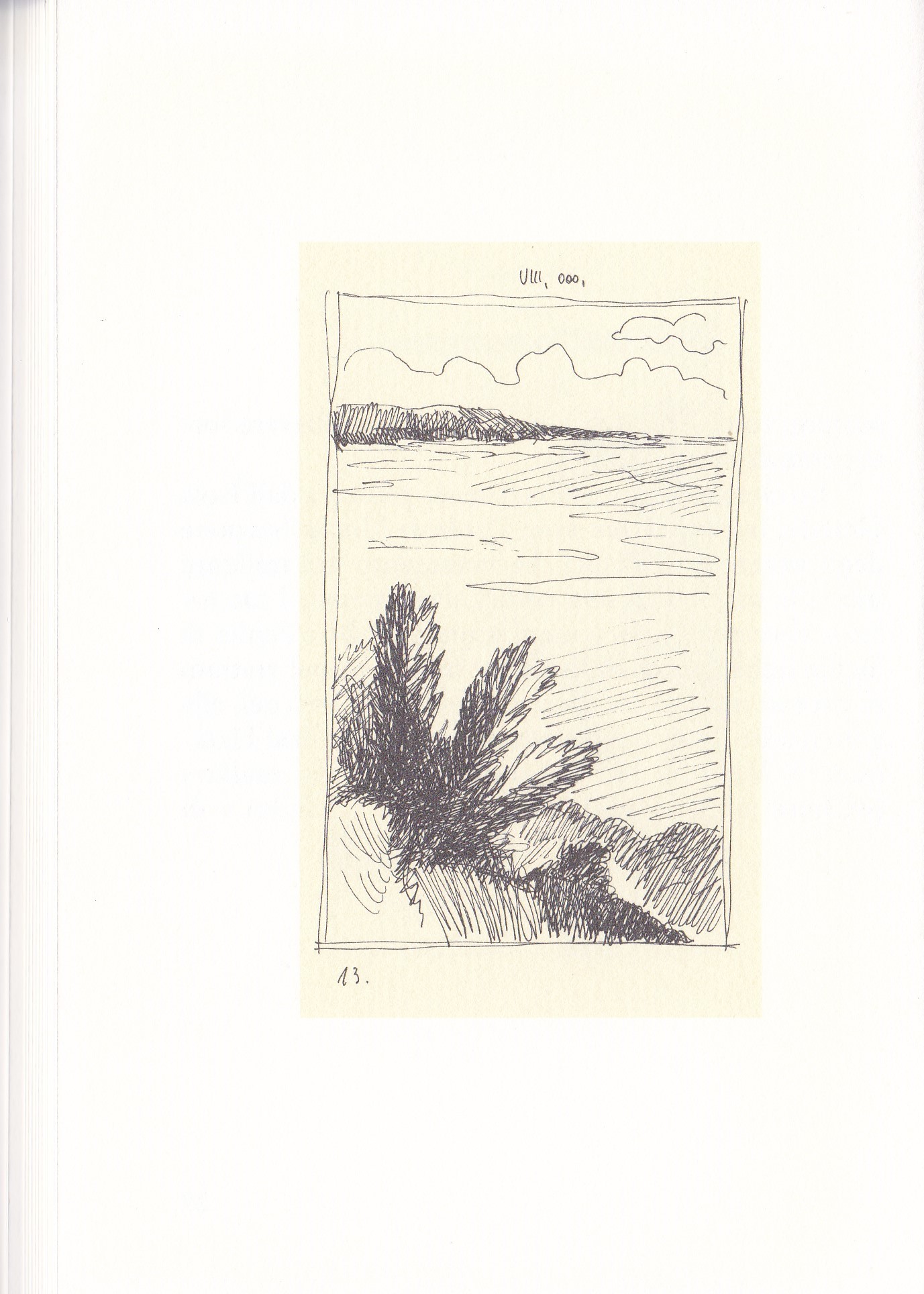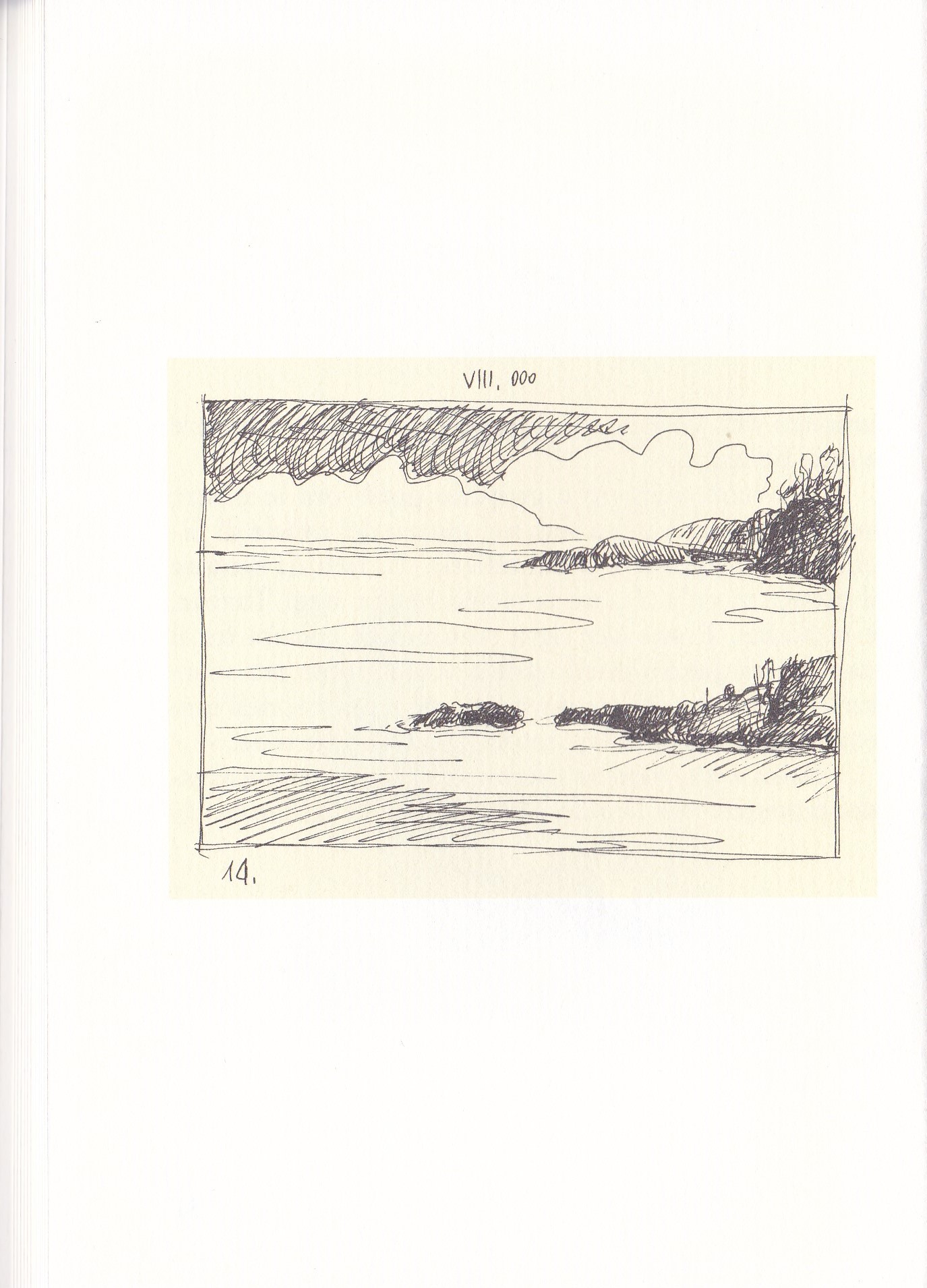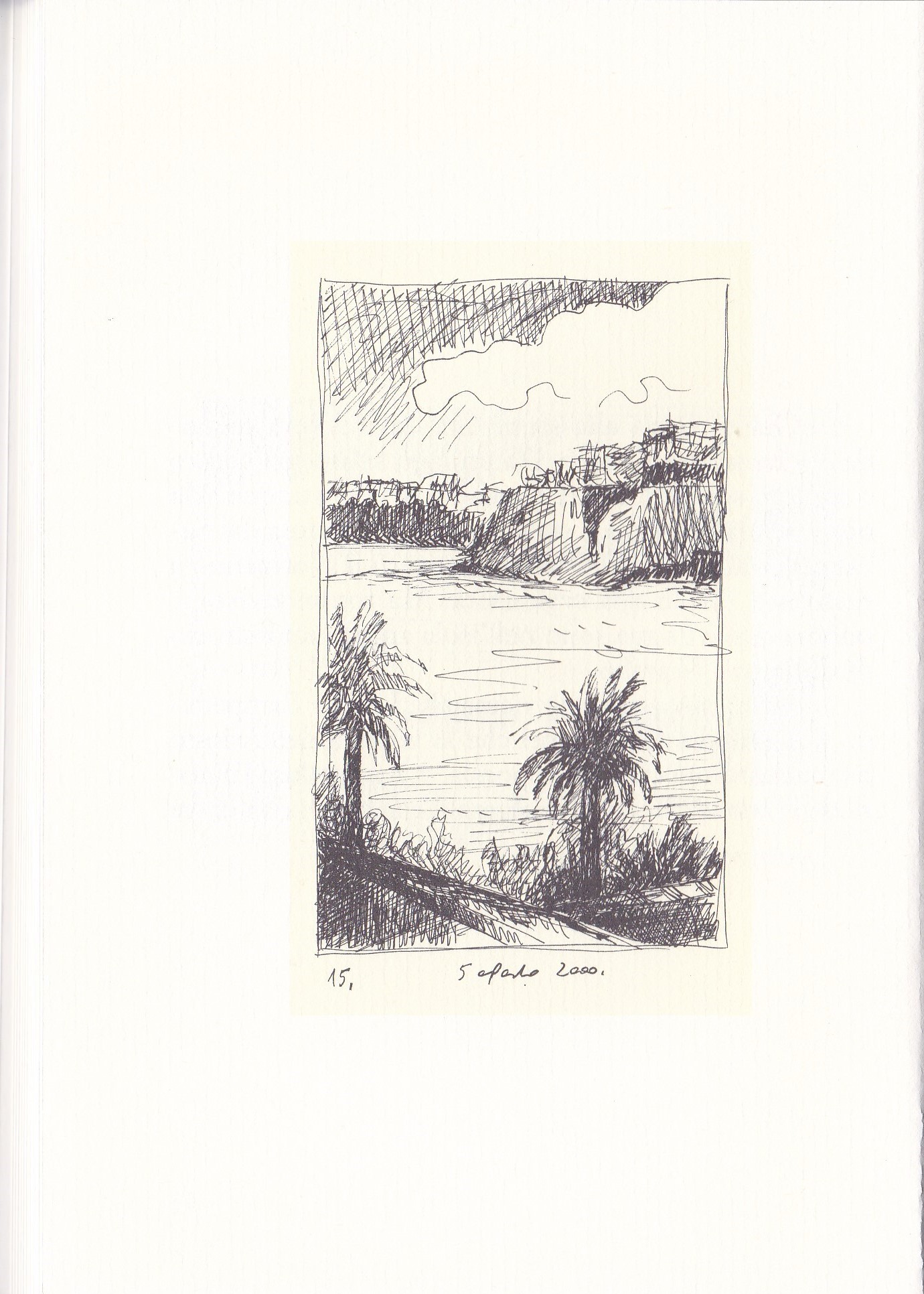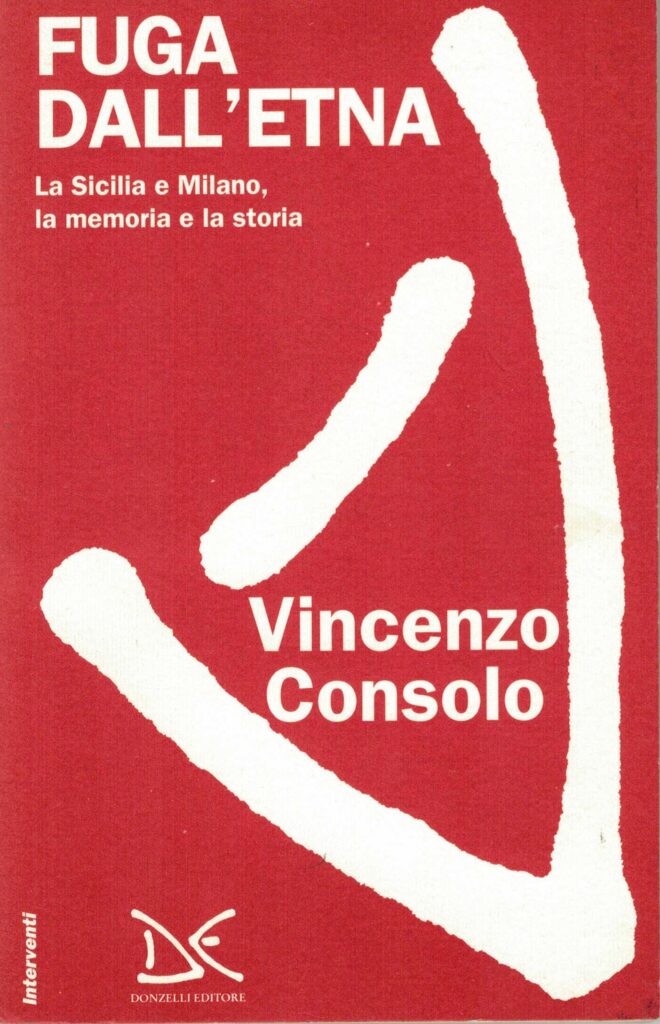*
Addolorata Bellanova
TRAGEDIE SICILIANE: LA TAURIDE DI VINCENZO CONSOLO
Nel 1982 viene rappresentata nel teatro di Siracusa, per la regia di Lamberto Puggelli, l’Ifigenia fra i Tauri.1 La traduzione della tragedia, commissionata dall’INDA, è frutto del lavoro di stretta collaborazione tra Vincenzo Consolo e Dario Del Corno: uno scrittore moderno e un filologo.2 Volendo perciò proporre delle osservazioni sulle modalità di lavoro del primo e sul suo specifico contributo al risultato finale si incorre inevitabilmente in più di una difficoltà. Si possono comunque individuare delle tracce significative del lavoro di Consolo e si può inoltre riflettere sulle conseguenze che questa traduzione ha avuto nella produzione dello scrittore. Intanto, alcune premesse. A fronte delle indiscutibili professionalità e competenza del filologo, già espresse nel confronto con vari testi dell’antichità classica e nello studio del teatro antico, quali competenze ha Consolo nella traduzione e, nello specifico, nella traduzione dalle lingue classiche? Quali competenze ha per affrontare il testo arduo della tragedia euripidea? Sarà meglio specificarlo subito: Consolo non è un traduttore e non è un grecista. Le sue nozioni di greco risalgono alla formazione ricevuta da ragazzo presso il liceo di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma l’incontro adolescenziale con la lingua e la letteratura antica deve essere stato per lui estremamente significativo. In particolare Consolo ama ricordare il fascino delle tragedie classiche messe in scena al teatro di Siracusa 3 e confessa una grande passione per Omero e per gli storici greci.4 Inoltre pur nell’imperfetta padronanza eitesti che il suo «grecuccio»5 gli permette, la frequentazione delle opere ricordate,oltre che la consapevolezza della sua identità siciliana e mediterranea,gli fa maturare una grande sensibilità nei confronti del mondo antico. Già prima di quest’opera di traduzione, Consolo ha ben chiaro quanto sia importante il legame tra la Sicilia e la cultura greca, nonché il valore fondante che la civiltà sorta nella Grecia antica ha avuto per l’intero Mediterraneo. Inoltre, anche se nelle prime opere mancano riferimenti espliciti al mondo antico, vi si può riconoscere già la spiccata propensione al plurilinguismo, la volontà di scavare e recuperare la memoria delle lingue mediterranee, quindi anche, in qualche modo, la memoria del greco, aspetto che caratterizzerà poi tutta la sua produzione. Queste osservazioni preliminari evidenziano il limite delle competenze tecniche di Consolo relativamente alla lingua del testo di partenza. Sottolineano però anche la sua spiccata sensibilità nei confronti della cultura greca e chiariscono la sua cifra stilistica, ovvero la grande ricchezza linguistica, in contrasto con la tendenza omologante contemporanea (in particolare bersaglio polemico è la lingua televisiva). Ciò ha il suo peso nel risultato finale della traduzione dell’Ifigenia, rappresenta cioè l’apporto propriamente consoliano al lavoro sul testo. 3 Consolo ha modo di conoscere la città e di innamorarsene proprio in occasione di una gita scolastica per le rappresentazioni teatrali, come racconta nell’articolo Siracusa, il mio primo talismano, in «L’Unità», 14 settembre 1989. 4 «E mi ricordai del tempo […] in cui per Omero, i tragici, per Erodoto, Diodoro, Tucidide, ero preso dalla passione per l’antico […]» (Vincenzo Consolo, Malophòros, in Id., Le pietre di Pantalica, Milano, Mondadori, 2012, pp. 83-94, a p. 91). Diverse le versioni dell’Odissea possedute e consultate da Consolo, come testimoniano le citazioni dalla traduzione di Giovanna Bemporad e da quella di Aurelio Privitera (ad esempio in Vincenzo Consolo, L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori, 2012, pp. 3, 14, 15, 17, 22, 34). 5 L’uso di questo termine lascia evincere la consapevolezza che l’autore ha delle sue limitate competenze nella comprensione del greco antico (Vincenzo Consolo, Le pietre di Pantalica, in Id., Le pietre di Pantalica, cit., pp. 125-138, a p. 127).
Qualche nota sulla traduzione Veniamo alla traduzione. Come si sa, alla versione del mito che racconta del sacrificio della figlia di Agamennone, necessario perché le navi achee salpino alla volta di Troia, la tragedia di cui l’autore si occupa insieme a Del Corno preferisce l’altra, altrettanto nota, secondo la quale Ifigenia non muore ed è trasferita dalla dea Artemide nella lontana terra dei Tauri, mentre sull’altare acheo viene sgozzata una cerva. Nonostante sia salva, la figlia del re dei re ha un destino tragico: è infatti condannata a vivere in un luogo inospitale. La Tauride è terra sconosciuta, il mare è tempestoso, gli abitanti uccidono esseri umani in onore degli dèi. La distanza di Ifigenia dalla popolazione locale è enfatizzata dal suo ruolo di sacerdotessa. Poca cosa è la compagnia delle schiave greche. Il dolore dell’essere lontana dalla propria patria – dove si stanno svolgendo eventi ignoti, forse sciagure – è complicato dall’arrivo di Oreste, fratello bambino nella memoria, ora cresciuto e perciò irriconoscibile, straniero e quindi vittima ideale sull’altare dei barbari. L’intreccio è risolto in maniera romanzesca con l’agnizione tra fratello e sorella e la partenza dalla terra selvaggia, mediante l’appoggio della dea Atena. A parte una diffusa tendenza a esplicitare i riferimenti del mito sostituendo epiteti, perifrasi o termini generici,6 colpisce nella versione di Consolo e Del Corno la volontà di realizzare una traduzione poetica, attraverso l’uso di una lingua non colloquiale, arcaizzante e ricca dal punto di vista retorico, a tratti anche più del testo di partenza, che enfatizza la solennità della tragedia. In particolare si nota un elevato numero di anastrofi, che conservano quelle euripidee o sono apporto originale della traduzione: ad esempio, all’ inizio del primo monologo di Ifigenia, «e Atreo generò» traduce ἐξ ἧς Ἀτρεὺς ἔβλαστεν, ovvero «da lei nacque Atreo» (v. 3);7 «Attento sto», nella prima battuta di Pilade, traduce ὁρῶ (v. 68) che poteva essere reso più letteralmente con «Sto attento», «guardo»;8 «gli altari, le bianche colonne dei templi / di sangue umano s’arrossano»9 introduce l’inversione nel testo 6 Ad esempio l’espressione «Ulisse» piuttosto che «figlio di Laerte» per la traduzione del 533 (Euripide, Ifigenia fra i Tauri, cit., p. 30); «Simplegadi» invece che «azzurre rupi» per il 746 (ivi, p. 43) o ancora «Alcione» per «uccello» al v. 1089 (ivi, p. 62). In questi riferimenti, come in quelli che seguono, segnalo la pagina per una più comoda consultazione del testo: nella traduzione di Consolo e Del Corno manca infatti l’indicazione dei versi. 7 Ivi, p. 7. 8 Ivi, p. 9. 9 Ivi, p. 23.
τέγγει / βωμοὺς καὶ περικίονας / ναοὺς αἷμα βρότειον (vv. 404-406) che alla lettera andrebbe reso con «sangue umano bagna gli altari e le colonne del tempio».10 Effetto arcaizzante ha anche l’introduzione dell’ipallage nella traduzione «quando poi si aprirà l’occhio scuro della notte»,11 assente nel testo greco (v. 110 ὅταν δὲ νυκτὸς ὄμμα λυγαίας μόληι, «quando si schiuderà l’occhio della notte scura»). Ci troviamo di fronte ad una traduzione che difficilmente può definirsi letterale e che a tratti trasforma decisamente la sintassi del testo di partenza. È forse abilità poetica piuttosto che acribia filologica quella che traduce i 201-202 σπεύδει δ’ ἀσπούδαστ’ / ἐπὶ σοὶ δαίμων con «Atroce zelo un demone / dimostra contro di te»,12 mentre con una maggiore fedeltà al testo greco il passo andrebbe reso «Un demone sollecita per te / eventi non desiderabili » oppure, come traduce Albini nell’edizione Garzanti, «un demone affretta contro di te / eventi cui vorresti sottrarti».13 In queste scelte si può riconoscere la penna di Consolo? In realtà, anche se la tentazione di ricondurle alla sua grande ricerca linguistica può avere un senso, non possiamo affermarlo con certezza.Lo stesso dicasi per la scelta di una serie di termini che afferiscono alla sfera semantica della pazzia e che possono essere conseguenza della sensibilità particolare che Consolo ha per il problema della malattia psichica. Ricordiamo che il tema sarà centrale negli ultimi romanzi (la famiglia del protagonista Petro Marano in Nottetempo, casa per casa, del 1992; la moglie di Chino Martinez ne Lo Spasimo di Palermo, uscito nel 1998). Per il v. 211 leggiamo «immolata alla follia del padre»14 ma è piuttosto «vergogna», «onta», e, solo raramente, «demenza», il significato di λώβαι. Anche nella traduzione dei vv. 932 e 933 (l’argomento è il tormento causato a Oreste dalle Erinni) la scelta dei termini «convulsioni» e «attacchi» non è scontata.15 Lo stesso dicasi per l’uso di «follia» al v. 991 (πόνων),16 o per «pazzia» al v. 1031 (ἀνίαις),17 che sono un rafforzamento del testo greco dove piuttosto si parla di «sofferenza, fatica». Va però ricordato che la figura di Oreste tormentato dalle 10 La traduzione proposta per un confronto è quella di Albini nell’edizione Garzanti: Euripide, Ifigenia in Tauride-Baccanti, trad. di U. Albini, Milano, Garzanti, 1989, p. 140. 11 Euripide, Ifigenia fra i Tauri, cit., p. 11. 12 Ivi, p. 14. 13 Ivi, p. 128. 14 Ivi, p. 14. 15 Ivi, p. 53. 16 Ivi, p. 56. 17 Ivi, p. 58. Erinni, a cui si riferiscono per lo più i passi ricordati, ha molto a che fare con la follia. Perciò, anche se c’è da parte di Consolo una spiccata attenzione per il tema, la scelta di termini che enfatizzano la pazzia può essere frutto di una decisione condivisa. Diverso è il caso di tre interventi singolari che innestano nella traduzione arcaizzante tracce piuttosto evidenti di sicilianità, rispondendo in maniera netta al proposito consoliano di recupero delle lingue perdute o a rischio. Il primo è nel lungo discorso di Ifigenia al coro. Dopo il sogno angosciante che le ha fatto presumere la morte di Oreste, sogno su cui quasi si apre la tragedia, la donna dichiara la sua intenzione di fare sacrifici per il fratello. I versi 159-166 sono resi in questo modo nella traduzione di Consolo e Del Corno: […] Per lui voglio bagnare la terra di offerte, versare dalla coppa dei morti il latte di brade giovenche, lo spesso vino di Bacco e il miele ambrato delle api: mistura consòlo dei morti.18 L’originale consòlo traduce θελκτήρια, che ha il significato letterale di «che mitiga, che lenisce» e si riferisce alle offerte liquide da versare per il fratello morto. Il termine non va inteso come italiano arcaico per ‘consolazione’, piuttosto vi si deve riconoscere un rimando all’uso funerario, tipico dell’Italia meridionale e quindi della Sicilia, dell’offerta di cibo alla famiglia di un morto. Ma al di là della traduzione non certo usuale, la scelta di consòlo fa pensare a una σφραγίς vera e propria per l’evidente evocazione del nome dell’autore. Netto contributo di Consolo è anche l’uso del termine nutríco, sicilianismo che traduce ἐπιμαστίδιον (v. 231)19 ovvero ‘lattante’ (anche in questo caso è Ifigenia che parla, ricordando il fratello ancora bambino). E neppure è casuale la preferenza della parola zagara («zagara sacra dell’ulivo d’argento »), al posto di un più letterale ‘virgulto’ o ‘germoglio’ (‘virgulto del glauco ulivo’, ‘fiore dell’ulivo azzurro’) per θαλλόν (v. 1101),20 scelta che si fonda su un uso raro, specialmente siciliano, del termine zagara, di solito riferito al fiore degli agrumi, anche per le infiorescenze degli alberi di olivo. 18 Ivi, p. 13. 19 Ivi, p. 15. 20 Ivi, p. 62.
- La forza dei nuclei tematici euripidei
Lungo sarebbe il discorso a proposito dell’influenza della tragedia antica sull’ideologia di Consolo,21 sempre più evidente con il passare degli anni. Ma in questo caso ci occupiamo specificamente degli effetti prodotti dalla meditazione profonda sul testo dell’Ifigenia fra i Tauri. L’esperienza vissuta con Del Corno è definita «vivificante» in Le pietre di Pantalica, testo eponimo della raccolta del 1988, che proprio con il racconto della rappresentazione dell’Ifigenia a Siracusa si apre. In più Consolo aggiunge: «Avevo provato una sensazione di ritorno, ritorno alla giovinezza, al grecuccio del liceo sepolto dentro di me, ritorno alla terra natale, alla cultura d’origine, all’origine della cultura».22 La traduzione di un testo antico dunque, e specificamente la traduzione dell’Ifigenia, acquista un grande significato per lo scrittore. In particolare sono i nuclei tematici dell’opera antica ad assumere un grande peso nell’ opera consoliana. Il lavoro di riflessione sui temi è già testimoniato dal breve testo Tradurre l’Ifigenia, scritto a quattro mani con Del Corno, per accompagnare la traduzione. Opponendosi alla definizione di tragedia a lieto fine, abbastanza ricorrente a proposito dei drammi euripidei (si veda l’intervento provvidenziale del deus ex machina), i due traduttori riconoscono piuttosto nell’Ifigenia fra i 21 Consolo valorizza la via lirica del coro tragico, perché ritiene che questa sia l’unica rimasta,venute meno le possibilità di comunicazione reale con il pubblico. A proposito si veda Per una metrica della memoria, relazione tenuta dall’autore nel gennaio del 1996 presso il Centro Studi sul Classicismo di San Gimignano, nel quadro delle attività accademiche dell’Istituto italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Il testo ha trovato varie collocazioni, ad esempio Vincenzo Consolo, Per una metrica della memoria, in «Cuadernos de Filología Italiana», iii (1996),249-259. Alla luce di questa considerazione del coro tragico, vanno interpretati gli “a parte”,frequenti soprattutto in Nottetempo, casa per casa e in Lo Spasimo di Palermo. Sulla questione è utile anche consultare Alessandro Di Prima, La strategia del coro. Intervista a Vincenzo Consolo,in «Versodove», iv (2001), 13, pp. 68-71. Gli ultimi romanzi adottano inoltre epigrafi da tragedie antiche (epigrafe dall’Antigone sofoclea al IV capitolo di Nottetempo, epigrafe iniziale dal Prometeo incatenato eschileo a Lo Spasimo di Palermo). Tragedia o metatragedia può dirsi poi Catarsi del 1989. La critica ha spesso accennato alla questione. Più specifici ad esempio Luca Canali, Che schiaffo la furia civile di Consolo, in «L’Unità», 7 ottobre 1998; Carla Riccardi, Inganni e follie della storia: lo stile liricotragico della narrativa di Consolo, in Atti delle giornate di studio in onore di Vincenzo Consolo, a cura di E. Papa, San Cesario di Lecce, Manni, 2004, pp. 81- 111; Domenico Calc
, Vincenzo Consolo. Le parole, il tono, la cadenza, Catania, Prova d’autore, 2007, pp. 65-66. 22 Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., p. 127. Tauri «una tragedia di personaggi senza futuro». Solo a «una vuota e immota sopravvivenza fisica» possono aspirare Ifigenia e Oreste, perché essi sono bloccati nella loro identità di esclusi: Ifigenia rimarrà per sempre incatenata al suo destino di vergine sacerdotessa:di esclusa, di diversa, di relegata, non importa se fra i selvaggi abitatori della Tauride, o sulle sacre terrazze di Brauron; Oreste infine liberato dagli spettri del matricidio – nel cui tormento e nel disperato movimento era tuttavia la sua grandezza – sarà impegnato forse solo a cancellare il ricordo del suo furore.23 E sono per di più ancorati al loro passato, all’attimo del sacrificio Ifigenia, a quello del delitto Oreste. Il loro esilio, che non è solo esilio nella Tauride,ma esilio dalla vita, è condiviso dalle donne del coro. Le ancelle, espulse dalla civiltà greca in una terra barbara, inospitale, rischiano la perdita della loro identità culturale. Per salvarsi ricorrono alla memoria. Da questa scaturisce il canto, ovvero l’alto lirismo corale, in netta contrapposizione alla lingua, al mondo dei barbari (Toante, il mandriano, la guardia). Nei confronti del testo tragico, e di ogni altra tragedia antica, i traduttori riconoscono un debito di cultura e civiltà da parte della cultura e della civiltà del presente. E non mancano di individuare l’attualità del tema dell’esilio e della perdita di identità:24 Che di tutto questo la traduzione sia riuscita a salvaguardare e ad evocare qualche accenno, è la speranza di chi ad essa ha lavorato, con amore: trovando in questo lavoro la soddisfazione di rileggere quel passato che ha orientato la nostra storia, e scoprendo la terribile attualità di questa, come di ogni altra tragedia. Il nostro è tempo di esuli da patrie e identità culturali perdute, di lingue cancellate; è tempo di immobilità e di futuri deserti, di rimpianto per le mancate realizzazioni.25
23 Vincenzo Consolo, Dario Del Corno, Tradurre l’Ifigenia, nel libretto di scena di Euripide, Ifigenia fra i Tauri. 24 Proprio alla comprensione dell’importanza di tale tema saranno da ascrivere alcune scelte di traduzione, che enfatizzano la condizione dell’esilio: ad esempio «terra estrema, desolata » invece che ‘ignota, inospitale’, più letterale ma meno forte nella connotazione della Tauride, per ἄγνωστον ἐς γῆν ἄξενον al v. 94 (Euripide, Ifigenia fra i Tauri, cit., p. 10); oppure «mare fatale agli stranieri» al posto di ‘mare inospitale’ per πόντον ἄξενον al v. 341 (ivi, 20). 25 Consolo, Del Corno, Tradurre l’Ifigenia, cit. In Le pietre di Pantalica, sull’esilio, Consolo aggiunge:mi era apparsa, questa, come la tragedia dell’emigrazione, dell’esilio. Esilio d’Ifigenia e delle donne del coro da una terra umana, civile, in una terra disumana, barbara; tragedia della regressione e dello smarrimento,della perdita della propria cultura e della propria lingua, della perdita dell’identità. E Ifigenia e le donne del coro non fanno che sciogliere canti di nostalgia per la patria perduta, di dolore per la condizione in cui sono cadute.
26 Questi sono, dunque, i nuclei di significato forti rintracciati nella tragedia antica. I personaggi euripidei e la terra straniera vengono accolti come simboli nell’opera di Consolo, e diventano uno strumento per parlare della contemporaneità. È prima di tutto l’autore a essere lontano dalla patria: lontano dalla Sicilia per la sua scelta di vivere al Nord, ma anche lontano da un altro tipo di patria, quella ideale della cultura e della civiltà, ormai negata dal presente. Ne scaturisce la condanna ad una Tauride senza speranza. Ma è anche in generale l’uomo contemporaneo a vivere l’esperienza dell’esilio in una realtà che snatura, che priva dell’identità negando i valori, la civiltà. Tauride, dunque, è la Milano della realtà, che ha tradito l’utopia ispirata negli anni della giovinezza da Vittorini e dagli altri scrittori emigrati: la città del Nord, che era parsa valida alternativa all’immobilismo dell’isola con la sua promessa di vitalità culturale, si è rivelata, agli occhi dell’intellettuale migrante, gretta, inospitale, luogo di perdita della memoria, campo fertile per l’attecchimento di ideologie razziste.27 La Sicilia a sua volta assume nella distanza i tratti di un’Argo del desiderio, sospirata, ma in cui sarebbe meglio non tornare mai: la tragedia euripidea, non a caso, si ferma alla fuga dalla terra straniera e tace sul ritorno, che non può che essere tragico, perché la reggia ha subito troppi lutti, ha visto troppi orrori e, perciò, tra le sue mura la ricomposizione dell’identità sarà impossibile. Il simbolo euripideo si sovrappone a quello omerico di Itaca, che è per antonomasia la patria della nostalgia. Ma se nel poema epico il ritorno di 26 Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., p. 127. 27 L’accostamento è esplicito in Id., Fuga dall’Etna. La Sicilia e Milano, la memoria e la storia, Roma, Donzelli, 1993, p. 62. Ma Consolo sottolinea lo straniamento generato dalla grande città del Nord in molte altre occasioni, in particolare nelle pagine di Retablo o de Lo Spasimo di Palermo. Ulisse è scandito dalle tappe rassicuranti del sostegno di Atena e dei fedeli,del riconoscimento della cicatrice, dell’intesa del talamo, fino alla sconfitta dei Proci, così non è per Consolo: la Sicilia può essere Itaca, come può essere Argo, solo nella distanza,28 quindi nel ricordo che idealizza e preserva l’immagine del passato; nel momento dell’approdo la patria si rivela diversa,stravolta, preda dei pretendenti, nuova terra d’esilio. È diventata Tauride, dunque, terra straniera, perché non esiste più la civiltà di un tempo: non è più possibile ricomporre l’identità nel ritorno perché tutto è orrendamente mutato. La violenza e la sopraffazione, il miracolo economico «indecente» 29 hanno cambiato il paesaggio, i rapporti umani, hanno annientato i segni di sapienza e cultura locali. Non si ritorna più nei luoghi da cui si è partiti, perché quelli non sono più i luoghi che noi abbiamo lasciato. Non si è più di nessun luogo.30 Le Itache non esistono, i luoghi del ritorno non esistono. Una volta che li si è abbandonati è impossibile tornare. Il nóstos non è un’esperienza semplice. Quando si va via, succede qualcosa nel tempo in cui si è lontani,e non si può mitizzare ciò che si è lasciato. E tornando si ritrova il peggio del peggio… I cambiamenti che ho trovato tornando in Sicilia, non sono certo miglioramenti. Quel libro [L’olivo e l’olivastro] vuole essere una registrazione del mio dolore per la perdita della Sicilia, per il processo generale di imbarbarimento… Io ho sempre desiderato di lavorare, magari in forma teatrale, intorno ad un personaggio, Ifigenia… Penso a questa donna, che il padre voleva uccidere, presa e portata in un luogo barbaro,lei che, figlia di un re, viene da Argo… E invece va a fare la sacerdotessa in Tauride dove deve compiere anche sacrifici umani. Per vent’anni ci rimane,subendo, proprio a livello culturale, una regressione terribile… E le resta quest’immagine di Argo, questa nostalgia… l’idea di coloro che ha 28 Si veda a proposito della forza di questo simbolo quanto afferma Jankélévitch in L’irreversible et la nostalgie (Vladimir Jankélévitch, L’irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, 1983, pp. 370-371). Secondo il filosofo, anche l’eroe omerico è deluso nell’approdo a Itaca, che pure ha tanto desiderato. Il suo dramma, lo stesso che appartiene a tutti coloro che vivono lontano dalla propria terra, consiste in un sentimento di nostalgia perenne,non sanabile, a causa del cambiamento che il tempo ha prodotto nella patria e nell’ individuo. L’Itaca in cui torna Ulisse, infatti, è diversa da quella che l’eroe ha abbandonato partendo per la guerra di Troia. A nulla serve che, stando a quello che il mito racconta, i nemici vengano sconfitti, il vincolo coniugale sia ribadito, l’equilibrio ristabilito: non si torna indietro. 29 L’espressione è di Consolo (Il miracolo indecente, in «L’Unità», 9 novembre 2003). 30 Id., Fuga dall’Etna…, cit., p. 69. lasciato. Quando torna però la madre è stata assassinata, il padre pure, e non trova nemmeno più i suoi ricordi… Secondo me niente si può ricucire una volta che è stato strappato… Il dolore del ritorno può essere insopportabile. Meglio star fuori.31
Tauride in Sicilia Cercherò di mostrare, attraverso esempi concreti tratti dall’opera di Consolo, quali esiti abbia avuto la traduzione della tragedia in termini di riuso dei simboli da essa veicolati. Mi riferisco in particolare a Argo e Tauride.Un primo caso è rintracciabile nel già citato Le pietre di Pantalica, che si apre con la rievocazione della messa in scena della tragedia Ifigenia fra i Tauri di Euripide all’interno del teatro di Siracusa32, e propone, alternando toni lirici e saggistici, una riflessione sulla forza simbolica degli elementi tragici per esprimere la contemporaneità, in particolare quella siciliana.La sacralità poetica dei versi euripidei in scena è esemplificata da Consolo attraverso la citazione di due passi: nel primo è Ifigenia che parla e rievoca il sacrificio voluto dal padre (vv. 361-371), il secondo invece è una delle manifestazioni di nostalgia del coro, che accompagna la decisione della sacerdotessa di fuggire con Oreste e Pilade (vv. 1094-1101).33 Il confronto tra la solennità dei versi antichi e la misera scenografia urbana genera amarezza e indignazione:31 Monica Gemelli, Felice Piemontese, Vincenzo Consolo (intervista), in L’invenzione della realtà. Conversazioni sulla letteratura e altro, Napoli, A. Guida, 1994, pp. 29-48, a p. 47. 32 Del teatro Consolo offre una descrizione suggestiva in apertura del testo (Le pietre di Pantalica, cit., p. 125). A proposito si veda Paola Capponi, Della luce e della visibilità. Considerazioni in margine all’opera di Vincenzo Consolo, in «Quaderns d’Italià», (2005), 10, pp. 49-61, a 57. 33 «No, no, quest’orrore mai potrò cancellarlo! / Quante volte protesi le mani al viso del padre, / alle ginocchia; e m’aggrappavo implorando. / “Padre, padre! Che nozze nefaste / apparecchi per me; e mentre mi uccidi, / la madre e le donne di Argo cantano per me / l’imeneo, e tutta la reggia risuona di flauti: / ma io muoio, e sei tu a darmi la morte. / Morte era dunque il mio sposo, non Achille Pelide, / che tu mi avevi promesso. E sul carro / a nozze di sangue mi hai tratta, snaturato!”»; «Io, alcione senz’ali, con te / gareggio nel lamento / di nostalgia per l’Ellade in festa, / per Artemide propizia ai parti / che sui pendii del Cinto ha dimora / presso la palma frondosa, / l’alloro splendente / e la zagara sacra dell’olivo d’argento ». I due passi sono citati in Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., p. 128. La traduzione è da Euripide, Ifigenia fra i Tauri, cit., pp. 21 e 62. in questi alti momenti e in altri, nel teatro greco di Siracusa era tutto un clamore di clacson di automobili, trombe di camion, fischi di treni, scoppiettio di motorette, sgommate, stridore di freni, grattare di marce, un sibilare acuto di sirene antifurto, un gracchiare d’altoparlante d’un vicino lunapark … Attorno al teatro, dietro la scena, dietro il fondale di pini e cipressi il paesaggio sonoro di Siracusa era orribile, inquinato, selvaggio, barbarico, in confronto al quale, il fragore del mare inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin.34 La Siracusa di un tempo, bellissima, emblema di sublime grazia, vera civiltà, città per lo più silenziosa in cui l’udito era sollecitato solo dai richiami dei venditori ambulanti, che per la sua luce e la sua compostezza ha fatto innamorare il giovane Consolo nel 1950, ora non esiste più. Al silenzio di un tempo si oppone lo squallore sonoro del presente,35 rispetto al quale «il fragore del mare inospitale contro gli scogli della Tauride era un notturno di Chopin». A ciò si aggiunge la miseria visiva: appena oltre il teatro, «strade, superstrade, tralicci, ciminiere serrano la città»36 e, ancora oltre, «un paesaggio di ferro e di fuoco, di maligni vapori, di pesanti caligini»,37 ovvero le raffinerie di petrolio e le industrie chimiche di Melilli e Priolo, mentre il centro storico, «la bellissima città medievale, rinascimentale e barocca, la città ottocentesca e quella dell’inizio del Novecento è completamente degradata: una città marcia, putrefatta»,38 e i luoghi più belli e unici sono andati perduti.39 Alla tragedia antica rappresentata, dunque, corrisponde un’altra tragedia, quella reale, che scaturisce dall’impero industriale e dalla trascuratezza moderna che colonizzano la Sicilia e imbarbariscono ciò che un tempo era modello di equilibrio e bellezza: è la tragedia della dissoluzione di una civiltà di cui la Siracusa del passato era simbolo. Il ritorno alla patria d’elezione – quella in cui Consolo aveva pensato di andare a vivere – è devastante, della scoperta che dell’immagine del ricordo non c’è più nulla. Siracusa 34 Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., pp. 128-129. 35 Fernando Gioviale, L’isola senza licantropi. ‘Regressione’ e ‘illuminazione’ nella scrittura di Vincenzo Consolo, in Scrivere la Sicilia. Vittorini ed oltre. Atti del Convegno di Siracusa 16-17 dicembre 1983, Siracusa, Ediprint, 1985, pp. 123-132, a p. 124. Sullo squallore che caratterizza persino Siracusa Consolo si esprime anche in Flauti di reggia o fischi di treno, in «Il Messaggero », 19 luglio 1982, testo riutilizzato con alcune variazioni in Le pietre di Pantalica. 36 Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., p. 129. 37 Ibidem. 38 Ibidem. 39 «Le Latomie non sono più che cave aride e polverose, l’Orecchio di Dionisio un insignificante cunicolo, la Fonte Aretusa una pozzanghera fetida, il Fiume Ciane un rigagnolo avvelenato dove il suo famoso papiro sta lentamente morendo…» (ibidem). è idealmente accostata all’Argo del sogno e della nostalgia di Ifigenia, un luogo che non esiste più perché stravolto dall’orrore dell’omicidio. La terra straniera è sicuramente luogo inospitale di sofferenze e di nostalgia, ma l’Argo è ancora più barbara della Tauride. Ah Ifigenia, ah Oreste, ah Pilade, ah ancelle della sacerdotessa d’Artemide, quale disinganno, quale altro dolore per voi che tanto avete bramato la patria lontana! V’auguro, mentre veleggiate felici verso la Grecia, che venti e tempeste vi sospingano altrove, che mai possiate vedere Argo, distrutta durante il vostro esilio, ridotta a rovine, a barbara terra, più barbara della Tauride che avete lasciato. Vi resti solo la parola, la parola d’Euripide, a mantenere intatta, nel ricordo, quella vostra città.40 L’apostrofe amara ai personaggi della tragedia è in realtà meditazione sulla propria vicenda personale. Vi si accompagna l’affermazione della sacralità della parola, della letteratura, della memoria, che è fonte di valori contro l’insipienza che avanza e che è forse l’unica opportunità di preservare ciò che sta irrimediabilmente svanendo.41 Una riflessione dai toni simili è in L’olivo e l’olivastro dove l’esule, ovvero lo stesso Consolo, che vuole cantare la perduta Siracusa afferma di cercare versi da parodo tragica che siano dotati del tono grave di Ungaretti e di tutti gli altri poeti che si sono confrontati con la città. «Calava a Siracusa senza luna la notte e l’acqua plumbea e ferma nel suo fosso riappariva, 40 Ivi, p. 130. 41 Si veda a proposito Mario Minarda, La lente bifocale. Itinerari stilistici e conoscitivi nell’opera di Vincenzo Consolo, Gioiosa Marea, Pungitopo, 2014, p. 106. All’affermazione del valore della poesia si accompagna, anche in virtù di un giudizio scettico e pessimista sulla realtà, il dubbio a proposito del senso della traduzione e della messa in scena di una tragedia antica oggi. Ciò lo porta persino a commentare le scelte registiche, in particolare la scelta di esibire nel finale la dea Atena, deus ex machina, in una gabbia appesa ad un’autogru: «Se proprio voleva essere attuale, perché il regista non ha fatto calare dal cielo, pendente da un elicottero d’argento, la dea Atena, perché non giungere, come il barone di Münchhausen, a cavallo di un missile, d’uno di quelli che stanno installando qui, nella vicina Comiso? E non si chiamano appunto, questi missili, missili di teatro, del teatro d’Europa?» (Consolo, Le pietre di Pantalica, cit., p. 26). L’amaro sarcasmo punta il dito non contro regista e trovata scenica in sé quanto piuttosto su una contemporaneità scottante. Così la tragedia antica e quella contemporanea finiscono con il sovrapporsi mentre Consolo richiama un’altra sciagura, quella della base missilistica di Comiso su cui si concentra poi in Comiso (Id., Comiso, in Id., Le pietre di Pantalica, cit., pp. 139-144). soli andavamo dentro la rovina, un cordaro si mosse dal remoto». Il tono scarno e grave, ermetico e dolente vorrebbe avere d’Ungaretti o tutti i doni degli innumerevoli poeti per sciogliere, muovendo il passo come in parodo sopra le lastre di una piccola piazza, contro il tufo chiaro delle case, in vista, oltre la balaustrata che cinge la fontana, il forte d’Aretusa, del porto Grande e del Plemmirio, della foce dell’Anapo e del Ciane, in vista del bianco tavolato degli Iblei, sciogliere un canto di nostalgia d’emigrato a questa città della memoria sua e collettiva, a questa patria d’ognuno ch’è Siracusa, ognuno che conserva cognizione dell’umano, della civiltà più vera, della cultura. Canto di nostalgia come quello delle compagne di Ifigenia, schiave nella Tauride di pietre e d’olivastri. Ché questa è oggi la condizione nostra, d’esiliati in una terra inospitale, cacciati da un’umana Siracusa, dalla città che continuamente si ritrae, scivola nel passato, si fa Atene e Argo, Costantinopoli e Alessandria, che ruota attorno alla storia, alla poesia, poesia che da essa muove, ad essa va, di poeti che si chiamano Pindaro Simonide Bacchilide Virgilio Ovidio Ibn Hamdis esule a Majorca.42 Il richiamo ai versi ungarettiani di Ultimi cori per la terra promessa, che non a caso erano scelti anche come epigrafe al testo di Le pietre di Pantalica («Soli andavamo dentro la rovina»), enfatizza l’amarezza delle immagini tragiche. In una ideale tragedia che abbia come scenografia i luoghi simbolo della città, la poesia ungarettiana può forse avere la forza di una parodo della nostalgia, può cioè descrivere una condizione di sofferenza certamente personale ma che riguarda tutti coloro che rimpiangono «la civiltà più vera, la cultura». L’espressione del dolore di quest’esilio richiama di nuovo i personaggi e le immagini euripidee e il modello della parodo è fornito dal coro di donne greche dell’Ifigenia fra i Tauri.43 La solitudine «dentro la rovina» dei versi di Ungaretti attualizza lo sradicamento della Tauride euripidea e la 42 Id., L’olivo e l’olivastro, cit., p. 74. Sul passo si veda Roberta Delli Priscoli, Il mare, l’isola, il viaggio negli ultimi libri di Vincenzo Consolo, in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVIII congresso dell’ADI, Padova 10-13 settembre 2014, a cura di G. Baldassari, V. Di Iasio, G. Ferroni, E. Pietrobon, Roma, Adi Editore, 2016, 1-10, alle pp. 3-5.43 Dopo il prologo e dopo l’uscita di scena di Oreste e Pilade, Ifigenia rientra accompagnata dal coro. Questa sezione rappresenta il nucleo centrale della prima parte della tragedia:Ifigenia è travolta dal lutto (pensa di aver perduto suo fratello) e prevede nuove sciagure, le schiave greche sono costrette a intonare canti barbari («Canto in risposta ai tuoi canti. / accompagnerò la mia padrona / con barbara cadenza in modo asiatico»; Euripide, Ifigenia fra i Tauri, cit., p. 14) ma sono solidali con lei, ne condividono la nostalgia e il lamento, deprecano l’inospitalità del mare della Tauride, ricordano con amarezza la patria che sono state costrette ad abbandonare.La meditazione si fa universale nell’accostamento ad altri luoghi del passato e del Mediterraneo mentre Siracusa incarna «la storia dell’umana civiltà e del suo tramonto».44 Qualche pagina più avanti la Tauride euripidea di nuovo viene utilizzata per parlare del degrado contemporaneo. Dalla meditazione sulla città di Siracusa scaturisce il racconto di una visita al di là del mare, lungo la costa africana. Tra i ricordi del passaggio alle rovine di Utica – «bassi muretti,pavimenti d’umili mosaici, qualche vasca, nudi ed esposti, in mezzo a tutta la vastità deserta intorno» –45 più del riferimento quasi inevitabile al Catone latino e a quello dantesco, colpisce la memoria delle piantine di un basilico profumatissimo che cresce in abbondanza tra le pietre e i mosaici e che viene poi offerto in dono da un vecchio arabo sorridente. Un particolare apparentemente senza importanza, che però, mentre riporta dall’aulico piano storico letterario a quello più concreto e tangibile degli usi e della gastronomia, definisce il prezioso patrimonio di piccole cose del Mediterraneo: Tra le pietre e i mosaici era un soave esalare di profumo di basilico riccio e fitto dentro vasche, vasi di terracotta. Era il profumo delle estati dei pomodori, delle cipolle, dei cetrioli, del basilico che i vecchi, uscendo per le strade sul tramonto, freschi e bianchi nelle camicie di cotone, mettevano all’orecchio; era di una intensità tale che si torceva nel profumo dolce e speziato della cannella.46 L’Utica di Consolo è rovine e basilico. Ma tutto il Mediterraneo in qualche modo è Utica. Tutto il Mediterraneo è fatto di «piccoli luoghi antichi e obliati» come Utica, in cui la natura si intreccia in maniera straordinaria con la memoria del passato.47 Proprio per questo, per la dimenticanza, per 44 Consolo, L’olivo e l’olivastro, cit., p. 73. Identica espressione in Id., La dimora degli Dei, in Vincenzo Consolo, Giuseppe Voza, Salvatore Russo, La terra di Archimede, con fotografie di M. Jodice, Palermo, Sellerio, 2001, pp. 3-16, a p. 14. Significativo in L’olivo e l’olivastro è l’accostamento della decadenza di Siracusa alla caduta di Costantinopoli: nel testo infatti è inserito un passo della Historia turco byzantina di Ducas (Consolo, L’olivo e l’olivastro, cit., p. 93) che contiene un lamento per la fine della città. Siracusa in preda al degrado dei moderni barbari dunque è come Costantinopoli in mano ai turchi. 45 Consolo, L’olivo e l’olivastro, cit., p. 91.46 Ivi, pp. 91-92.47 I mosaici e il basilico di Utica sono già ricordati in un passo di Malophòros, in un elenco di caratteristici e rapidi ritratti di piccoli luoghi carichi di passato, dalla Sicilia alla Grecia al Nord Africa: «Ci sono ormai posti remoti, intatti, non dissacrati, posti che smemorano del presente, che rapiscono nel passato? Io avevo provato questo rapimento a Tindari, affacciato alla balaustra della terrazza sul vertiginoso precipizio sotto cui si stende la spiaggia sinuosa l’incuria e l’anonimato di tanti tesori, la meditazione diventa amara: nell’enumerazione di antiche città, nell’anafora del verbo «ricordare», Consolo si trasforma in un «presbite di mente» tutto rivolto verso il passato, si trasforma in «infimo Casella» tutto proteso verso qualcosa che non c’è più: Ricordò i piccoli luoghi antichi e obliati, bagnati da quel Mediterraneo, ricordò Tindari, Solunto, Camarina, Eraclea, Mozia, Nora e Argo, Thuburdo Majius, Cirene, Leptis Magna, Tipaza… Ricordò la spianata delle moschee davanti al porto, il bagno d’Algeri […]. Pensò d’essere divenuto un confuso uomo, un presbite di mente che guarda al remoto ormai perduto, si ritrae in continuo dal presente, vecchio e scontento, di non essere in quel mondo che ombra, sagoma di nebbia, spirito lento, anima ancora carica di spoglia,nostalgia, infimo Casella smarrito sulla marina che arditamente intona versi alti, canta «Amor che ne la mente mi ragiona». No, non più. Odia ora. Odia la sua isola terribile, barbarica, la sua terra di massacro, d’assassinio, odia il suo paese piombato nella notte, l’Europa deserta di ragione. Odia questa Costantinopoli saccheggiata, questa Alessandria bruciata, quest’Atene, Tebe, Milano, Orano appestate, questa Messina, Lisbona terremotate, questa Conca d’oro coperta da un sudario di cemento, il giardino delle arance insanguinate. Odia questo teatro dov’è caduta la pietà, questa scena dov’è stata sgozzata Ifigenia, quest’Etna, questa Tauride di squadracce dove si consumano merci e vite, si svende onore, decenza, lingua, cultura, intelligenza…48 sa coi laghi marini, e sulla strada verso il teatro e il ginnasio, dove davanti alle casupole costruite coi blocchi di arenaria dei ruderi stavano vecchine, tutte nere e con bianchi fazzoletti damascati in testa, a filare come le Parche. L’avevo provato a Segesta, seduto sui gradini del tempio, in faccia all’orrido da cui saliva il gorgoglio delle acque del Kàggera; nel tragico silenzio di Micene, rotto dal suono di campani di greggi invisibili; nella sperduta piccola Utica, fra gli umili mosaici e il basilico che odorava di cannella; e qui a Selinunte, la prima volta che vi giunsi, in treno appunto, tantissimi anni avanti» (Id., Malophòros, cit., p. 89). Dello stesso tono la precedente osservazione sulle «stazioncine solitarie remote, di luoghi antichi,sacri, come quella di Segesta, di Cartaghe-Hannibal, di Pompei o di Olimpia» che sanno essere «commoventi, hanno ormai anche loro qualcosa di antico, di sacro» (ivi, p. 88). Omaggio ai «piccoli luoghi antichi e obliati» sono per lo più gli interventi apparsi su «L’Espresso» tra il 1981 e il 1982, dedicati a centri poco noti, come Miraglia, Valverde, Galati o Filosofiana. Il tono di questi articoli è però di solito quasi giocoso, un invito al godimento delle bellezze e delle ricchezze sconosciute. Come luogo antico e fuori dai soliti canali turistici è presentata anche Dion, stesa nella pianura ai piedi del Monte Olimpo (Id., Neró Metallicó, Roma, La lepre edizioni, 2009, pp. 31-32).48 Id., L’olivo e l’olivastro, cit., pp. 92-93. Il riferimento a Casella evidenzia il legame che Consolo sente con il passato, con ciò che non esiste più. Ma la sovrapposizione non è perfetta: il richiamo alla canzone Amor che ne la mente mi ragiona è immediatamente contraddetto dal «No, non più. Odia ora» e il canto non ha nulla della dolcezza
del regno del Purgatorio, ma piuttosto una rabbia infernale, un tono che pretenderebbe «rime aspre e chiocce».Dai toni nostalgici Consolo passa a quelli indignati di un coro antico e professa odio prima nei confronti della sua Sicilia, diventata «terribile, barbarica,terra di massacro», una Tauride percorsa da «squadracce», poi verso l’Europa e verso l’intero Mediterraneo. Il dramma in atto ha proporzioni gigantesche e il riferimento ai simboli della tragedia euripidea sancisce la gravità della speculazione edilizia, dell’azione mafiosa: sulla cavea è stata sgozzata Ifigenia, si è prodotto cioè il sacrificio dei sacrifici, la morte della sacerdotessa che Artemide aveva voluto salva, la morte dell’esiliata e, con lei, la morte di ogni forma di giustizia, cultura, rispetto. Il presente è una Tauride senza speranza. Ai simboli euripidei Consolo ricorre anche in L’ape iblea. Elegia per Noto,testo teatrale del 1998,49 in cui all’elogio nei confronti della città che seppe rialzarsi dal disastroso terremoto del 1693 con la prodigiosa fantasia del barocco si sostituisce l’amarezza di fronte al degrado contemporaneo. Proprio per evidenziare la decadenza, l’incuria, Consolo introduce il lamento in prima persona di una Ifigenia smarrita, prima esiliata «nel fragore industriale», che è quello del polo siracusano, quindi di ritorno ad un’Argo di arnie e miele dove però non trova né arnie né miele, ma una «città / perduta, ottenebrata», «una Sarajevo / di lenta erosione»,50 un luogo cioè in cui non è possibile la ricomposizione dell’identità: L’Atride snaturato, la sorte avversa,bandì lontano,in terra stranea inospitale, regno d’ogni crudezza, scialo.Nei recessi bui, nel fragore industriale,bramai ognor la casa,conca di memoria brace di speranza.49 Uscito nel 2002, nel volume Oratorio, insieme a Catarsi (Id., Oratorio, Lecce, Manni, 2002).50 Ivi, p. 57.Vergine indurita, torno ora in Argo, all’alta reggia, alla chiara pietra, all’arnia, al miele. Torno e, oh, cieca m’aggiro nella città perduta, - ottenebrata, chiese, conventi vacui, deserte, mute le piazze.51Il mito della figlia di un Agamennone snaturato evidenzia la tragedia di Noto. Il riferimento forza la tradizione nel descrivere il ritorno di Ifigenia che però nulla realizza della tanto sospirata speranza: se al polo industriale ben si adatta l’immagine di Tauride dell’esilio, gli Iblei di api e miele invece non possono più essere la patria del sogno, l’alveare della memoria, e sono piuttosto un’Argo deludente. Nella amara scoperta dell’involuzione della propria patria, alla tragedia di Ifigenia si sovrappone quella di Antigone. La mancanza di cura del patrimonio culturale si configura come un’azione sacrilega, empia, come l’atto di un «Creonte dissennato», che mette al di sopra delle leggi divine la sua autorità di despota.Chiusa nel mio nero,sola sulla scalea,piango per l’oltraggio,l’ingiustizia, l’empietà d’un Creonte dissennato.52 Quest’uso dei simboli tragici antichi per parlare di drammi siciliani ne testimonia la forza, intatta nonostante i secoli. Dell’esperienza “vivificante” della traduzione dell’Ifigenia fra i Tauri Consolo conserva figure e modelli, capaci di commentare il contemporaneo,53 in una prospettiva che privilegia 51 Ivi, pp. 57-58. 52 Ivi, p. 58. 53 La Di Legami (Flora Di Legami, Vincenzo Consolo, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, 48-49) sottolinea soprattutto che per Consolo la scelta della tragedia più romanzesca dell’antichità equivale ad un ripetuto interrogarsi sulla natura e sul significato del narrare. L’Ifigenia euripidea dunque sarebbe per l’autore anche metafora della condizione straniata dell’intellettuale a tu per tu con una parola sempre più svuotata di senso, in esilio come Ifigenia e Oreste. Si veda anche Minarda, La lente bifocale…, cit., pp. 104-106: il critico evidenzia i luoghi noti, quindi la Sicilia, Milano, il Mediterraneo, e che si allarga facilmente al mondo intero.Al di là dell’interesse tematico c’è il riconoscimento della grandezza formale della poesia antica, la ricchezza di una lingua perduta, in grado di veicolare un complesso di valori. Ciò spinge Consolo a usare i versi euripidei anche per commentare gli eventi di Palermo, la strage di via d’Amelio. Il buio della lunga notte dell’infelice paese, lo strazio per le esequie funebri delle vittime, richiama le parole della poesia vera, la sola che dia «luce e sollievo nei momenti più bui e insostenibili»,54 ovvero alcuni versi dall’Ifigenia fra i Tauri.Vorremmo usare parole alte, degne, essendo le nostre fatalmente povere,consunte, parole prese dai libri delle antiche religioni o dai poemi immortali,dalle tragedie greche, per poter commentare gli eventi di Palermo, lamentare lo strazio per le esequie funebri dei cinque uomini giusti dilaniati dal tritolo insieme a un giudice giusto, e non per infiorare pietosamente, come si fa con le corone, la realtà tremenda, ma perché le parole ispirate e pure dei salmi o dei grandi poeti ci sembrano quelle che al di sopra di tutte diano luce e sollievo nei momenti nostri più bui e insostenibili. «Strazio da strazio nasce, / poiché le alate cavalle volsero il corso / e il sole altrove sospinse / l’occhio sacro del giorno», recita un coro di Euripide.55 Le parole dell’Ifigenia commentano i fatti – lo strazio sorto dalle limitazioni in merito ai funerali per le vittime – e rappresentano l’ultimo baluardo possibile contro la perdita dell’identità. Ecco spiegato allora il senso della traduzione di una tragedia greca nel presente, quando il mondo antico muore e sembra che non debba restare «neanche una vuota, dorata carcassa, come quella della cicala scoppiata nella luce d’agosto».56 Come le donne greche del coro dell’Ifigenia fra i Tauri che cercano di salvare la loro identità attraverso la memoria, Consolo ricorre alla poesia antica contro la Tauride del presente: è la sua tragedia siciliana. come il dramma del riconoscimento identitario tra i fratelli diventi nell’opera di Consolo il dramma collettivo del riconoscersi a stento nei disagi del presente. 54 Vincenzo Consolo, La lunga notte di questo infelice paese, in «L’Unità», 23 luglio 1992, ora in Id., Cosa loro, a cura di N. Messina, Milano, Bompiani, 2017, pp. 117-120, a p. 117. 55 Ibidem. 56 Id., Le pietre di Pantalica, cit., p. 132.__ 1 Euripide, Ifigenia fra i Tauri, trad. di V. Consolo e D. Del Corno, Istituto Nazionale del Dramma Antico, XXVII ciclo di spettacoli classici (27 maggio-4 luglio 1982), Siracusa, INDA, Nello stesso libretto anche le Supplici di Eschilo, tradotte da Scevola Mariotti e Giuseppe Di Martino. 2 Secondo Giusto Monaco, allora direttore dell’INDA, il duplice contributo, con competenze e sensibilità differenti, è garanzia di un felice risultato: «Per ciò che riguarda le traduzioni, il felice risultato dell’esperimento fatto nel ciclo precedente ha suggerito di confermare il metodo dell’affidamento di ciascun dramma a due autori, un filologo e uno scrittore di teatro moderno», in Giusto Monaco, Tra rigore culturale e aperture sociali, breve articolo che accompagna il libretto con le tragedie. Già negli anni precedenti infatti la traduzione dell’opera messa in scena era stata il risultato della collaborazione di due professionalità differenti: nel 1980 Umberto Albini e Vico Faggi avevano tradotto le Trachinie di Sofocle, Vincenzo di Benedetto e Agostino Lombardo Le Baccanti di Euripide. La scelta viene confermata nel 1984 con il Filottete di Maricla Boggio e Agostino Massaracchia.Da Levia Gravia quaderni annuali (2018)