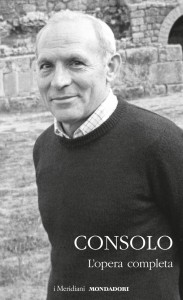clicca per aprire il pdf
E il sorriso si fece barocco
E il sorriso si fece barocco
01 febbraio 2015
A tre anni dalla morte, il Meridiano con l’opera completa e alcuni saggi critici lo colloca tra i maggiori del’ 900
di Salvatore Silvano Nigro
Domenica del Sole24ore
Quando si accinse a raccontare il “sorriso” nella pittura europea, Daniel Arasse si arrestò davanti a una scoperta imprevista. Dovette constatare che fu Leonardo da Vinci a inventare il «ritratto con il sorriso». Prima della Gioconda c’era stato sì l’«uomo che ride» di Antonello da Messina, misterioso nella sua bellezza senza biografia; ma l’increspatura dilatata delle labbra sortiva l’effetto, in quel ritratto conservato a Cefalù, di una smorfia se non proprio di un ghigno. L’anonimità del personaggio di Antonello aveva già acceso la fantasia di Vincenzo Consolo, che aveva raccolto nella trama di un romanzo la vibrazione arricciata, insopportabilmente ironica, che infettava di malizia il volto dipinto sulla tavoletta quattrocentesca. La «chiocciola», che andava allargandosi attorno alle labbra stirate dell’uomo ridente di Cefalù, aveva indirizzato e determinato la trama del romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio di Consolo: il percorso a spirale della storia, le linee spezzate di una narrazione che si sottrae alle continuità e agli slarghi della costruzione romanzesca e su se stessa si avvolge in un disegno di contrappunti o «riurti» e in un «giuoco delle somiglianze», le volute delle lumache studiate da un barone malacologo, l’architettura vorticante di un luogo di detenzione. L’opera, pubblicata nel 1976, è ambientata negli anni del Risorgimento in Sicilia. Racconta la rivolta contadina di Alcàra Li Fusi. E riprende la polemica contro le passioni politiche astratte e il tema dell’impostura storiografica, riportati all’attenzione dal Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia. Scrive Salvatore Grassia: «La macchinazione narrativa del Sorriso nacque … proprio da una costola delConsiglio d’Egitto. E tuttavia, se l’Ulisse di Joyce – come diceva paradossalmente Borges – era la fonte dell’Odissea, per il semplice fatto che il romanzo dello scrittore irlandese aveva cambiato il modo di leggere il poema greco, allo stesso modo si potrebbe affermare che il romanzo di Consolo ha “barocchizzato” la lettura dell’apologo sciasciano sull’impostura».
Il sorriso dell’ignoto marinaio si impose subito come libro epocale: il capolavoro riconosciuto di una generazione che aveva attraversato il Sessantotto e i movimenti degli anni Settanta ed era sensibile a una metanarratività impostata sulla responsabilità politica della scrittura letteraria. Piacquero la precisione a scalpello del lavoro linguistico, la musicalità splendida della prosa, la scrittura di immagini, gli effetti plastici delle tante voci in campo, assorbite nelle inflessioni poderose e ritmate come nell’oralità di un antico contastorie siciliano. In una densa conversazione con Silvio Perrella lo stesso Consolo ha sintetizzato il salto di generazione che lo aveva contraddistinto: «gli scrittori della generazione che mi ha preceduto, parlo di scrittori di tipo razionalistico, illuministico, come Moravia, come Calvino come Sciascia» scelsero una «lingua geometrizzata … cristallina, limpida … Io mi sono sempre chiesto perché questi scrittori che hanno vissuto il fascismo e la guerra abbiano optato per questo tipo di scrittura e di concezione illuministica del mondo. Perché speravano, perché la loro era una «scrittura di speranza». Speravano che finalmente in questo paese si formasse, dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, una società civile con la quale comunicare… Quelli della mia generazione, che hanno visto succedere al regime fascista un altro regime, quello democristiano, hanno dovuto prendere atto che questa società non era ancora nata, che la società civile alla quale lo scrittore poteva rivolgersi non esisteva, quindi la mia opzione non è stata più in senso razionalistico, ma in senso, diciamo, espressivo», barocco: plurilinguistico e pluriprospettico.
Scrivendo di un più tardo romanzo di Consolo, Retablo, che ha per protagonista il pittore novecentesco Fabrizio Clerici travestito da settecentesco «archeologo dei propri sogni barocchi», Giuseppe Traina ha applicato allo stile dello scrittore siciliano la definizione che Sciascia aveva dato delle Confessioni palermitane dipinte dal vero Clerici: «Un delirio barocco riflesso da uno specchio illuministico»; ovvero, «un barocco senza inganni e un illuminismo senza illusioni, giuste le lezioni di Leopardi e Pirandello (e di Sciascia)».
Il Meridiano dedicato a Consolo colloca lo scrittore tra i classici del Novecento. Nella premessa al volume, Cesare Segre esordisce lapidariamente: «Voglio subito enunciare un giudizio complessivo: Consolo è stato il maggiore scrittore italiano della sua generazione». Curata con passione da Gianni Turchetta, la raccolta di romanzi e saggi (e racconti; con la precisazione che Consolo si è sempre mosso ai confini dei generi letterari, praticando commistioni e ibridazioni), si apre con La ferita dell’aprile del 1963 e si chiude con Di qua dal faro del 1999. Include la «favola teatrale» Lunaria del 1985, Retablo del 1987 e, insieme a Le pietre di Pantalica del 1988, L’olivo e l’olivastro del 1994; allinea poi, lungo un percorso di intima tragicità che va dalla crisi delle illusioni all’ansia inquieta dell’afasia, la trilogia della storia: il Sorriso sul Risorgimento; Nottetempo, casa per casa, sull’avvento del fascismo; Lo spasimo di Palermo, sulla «collusione tra mafia e potere politico, con le stragi mafiose degli anni Novanta».
Nell’imponente apparato, il curatore segue la storia interna delle singole opere: il loro farsi e stratificarsi nel tempo, secondo la memoria che esse conservano del loro stesso costruirsi e grazie alle carte gelosamente ordinate e custodite nel vasto archivio privato. È un lavoro gigantesco, che fa i conti con la complessità di una scrittura letteraria che sin dall’inizio ha praticato citazioni, autocitazioni, evocazioni di reperti d’arte (dalle fotografie, alle pitture e sculture: dai quadri insospettabili di Turner, alle metope di Selinunte), rifacimenti di pagine di scrittori barocchi come Bartoli, e di scrittori più vicini come il Nabokov di Lolita; non senza la complicazione di più innesti nel corpo stesso di questa letteratura sulla letteratura, come ha documentato Grassia, individuando «le vele le vele» di Dino Campana che prendono vento dentro una pagina di Bartoli da Consolo rilavorata con l’aiuto del De Aetna di Bembo.
Turchetta rivede i testi. Corregge persino, e giustamente, qualche ipercorrettismo del curatore dell’edizione critica del Sorriso dell’ignoto marinaio. Io però non avrei accolto lo scioglimento di un’abbreviatura epigrafica contenuta in un cartiglio. Nella prima edizione del Sorriso, si legge «COEFALEDU SICILIAE URBS». Doveva essere «COEFALEDŪ». Chiaramente è caduto il segno abbreviativo, che va ripristinato. Lo scioglimento («COEFALEDUM») appanna il gusto arcaicizzante dello scrittore, la sua passione per l’immagine.
Corredano il volume un utile glossario, una dettagliatissima cronologia della vita, e una bibliografia esaustiva. Viene ricordato, a proposito del racconto Libertà di Verga presente al Consolo del Sorriso, anche il film di Vancini, Bronte: cronaca di un massacro. Sciascia collaborò alla sceneggiatura, fiancheggiato da Benedetto Benedetti da poco scomparso. E qui mi piace ricordare il vecchio film-maker, che un giorno, tanti anni fa, in tempi difficili, non esitò a improvvisarsi editore per pubblicare le poesie dialettali di Tonino Guerra.
I LIBRI DI CUI SI PARLA
Vincenzo Consolo, L’opera completa, a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre, I Meridiani, Mondadori, pagg. 1.564, € 80,00
Salvatore Grassia, La ricreazione della mente. Una lettura
del «Sorriso dell’ignoto marinaio», Sellerio, pagg. 78, € 12,00
Silvio Perrella, In fondo al mondo. Conversazione in Sicilia con Vincenzo Consolo, Mesogea, pagg.80,
€ 6,00
Giuseppe Traina, Siciliani ultimi? Tre studi su Sciascia, Bufalino, Consolo. E oltre, Mucchi Editore, pagg. 118, €15,00


E il sorriso si fece barocco
 E il sorriso si fece barocco
E il sorriso si fece barocco
1 feb 2015 Il Sole 24 Ore
Quando si accinse a raccontare il “sorriso” nella pittura europea, Daniel Arasse si arrestò davanti a una scoperta imprevista. Dovette constatare che fu Leonardo da Vinci a inventare il «ritratto con il sorriso». Prima della Gioconda c’era stato sì l’«uomo che ride» di Antonello da Messina, misterioso nella sua bellezza senza biografia; ma l’increspatura dilatata delle labbra sortiva l’effetto, in quel ritratto conservato a Cefalù, di una smorfia se non proprio di un ghigno. L’anonimità del personaggio di Antonello aveva già acceso la fantasia di Vincenzo Consolo, che aveva raccolto nella trama di un romanzo la vibrazione arricciata, insopportabilmente ironica, che infettava di malizia il volto dipinto sulla tavoletta quattrocentesca. La «chiocciola», che andava allargandosi attorno alle labbra stirate dell’uomo ridente di Cefalù, aveva indirizzato e determinato la trama del romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio di Consolo: il percorso a spirale della storia, le linee spezzate di una narrazione che si sottrae alle continuità e agli slarghi della costruzione romanzesca e su se stessa si avvolge in un disegno di contrappunti o «riurti» e in un «giuoco delle somiglianze», le volute delle lumache studiate da un barone malacologo, l’architettura vorticante di un luogo di detenzione. L’opera, pubblicata nel 1976, è ambientata negli anni del Risorgimento in Sicilia. Racconta la rivolta contadina di Alcàra Li Fusi. E riprende la polemica contro le passioni politiche astratte e il tema dell’impostura storiografica, riportati all’attenzione dal Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia. Scrive Salvatore Grassia: «La macchinazione narrativa del Sorriso nacque … proprio da una costola del Consiglio d’Egitto. E tuttavia, se l’Ulisse di Joyce – come diceva paradossalmente Borges – era la fonte dell’Odissea, per il semplice fatto che il romanzo dello scrittore irlandese aveva cambiato il modo di leggere il poema greco, allo stesso modo si potrebbe affermare che il romanzo di Consolo ha “barocchizzato” la lettura dell’apologo sciasciano sull’impostura».
Il sorriso dell’ignoto marinaio si impose subito come libro epocale: il capolavoro riconosciuto di una generazione che aveva attraversato il Sessantotto e i movimenti degli anni Settanta ed era sensibile a una metanarratività impostata sulla responsabilità politica della scrittura letteraria. Piacquero la precisione a scalpello del lavoro linguistico, la musicalità splendida della prosa, la scrittura di immagini, gli effetti plastici delle tante voci in campo, assorbite nelle inflessioni poderose e ritmate come nell’oralità di un antico contastorie siciliano. In una densa conversazione con Silvio Perrella lo stesso Consolo ha sintetizzato il salto di generazione che lo aveva contraddistinto: «gli scrittori della generazione che mi ha preceduto, parlo di scrittori di tipo razionalistico, illuministico, come Moravia, come Calvino come Sciascia» scelsero una «lingua geometrizzata … cristallina, limpida … Io mi sono sempre chiesto perché questi scrittori che hanno vissuto il fascismo e la guerra abbiano optato per questo tipo di scrittura e di concezione illuministica del mondo. Perché speravano, perché la loro era una «scrittura di speranza». Speravano che finalmente in questo paese si formasse, dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, una società civile con la quale comunicare… Quelli della mia generazione, che hanno visto succedere al regime fascista un altro regime, quello democristiano, hanno dovuto prendere atto che questa società non era ancora nata, che la società civile alla quale lo scrittore poteva rivolgersi non esisteva, quindi la mia opzione non è stata più in senso razionalistico, ma in senso, diciamo, espressivo», barocco: plurilinguistico e pluriprospettico.
crivendo di un più tardo romanzo di Consolo, Retablo, che ha per protagonista il pittore novecentesco Fabrizio Clerici travestito da settecentesco «archeologo dei propri sogni barocchi», Giuseppe Traina ha applicato allo stile dello scrittore siciliano la definizione che Sciascia aveva dato delle Confessioni palermitane dipinte dal vero Clerici: «Un delirio barocco riflesso da uno specchio illuministico»; ovvero, «un barocco senza inganni e un illuminismo senza illusioni, giuste le lezioni di Leopardi e Pirandello (e di Sciascia)».
Il Meridiano dedicato a Consolo colloca lo scrittore tra i classici del Novecento. Nella premessa al volume, Cesare Segre esordisce lapidariamente: «Voglio subito enunciare un giudizio complessivo: Consolo è stato il maggiore scrittore italiano della sua generazione». Curata con passione da Gianni Turchetta, la raccolta di romanzi e saggi (e racconti; con la precisazione che Consolo si è sempre mosso ai confini dei generi letterari, praticando commistioni e ibridazioni), si apre con La ferita dell’aprile del 1963 e si chiude con Di qua dal faro del 1999. Include la «favola teatrale» Lunaria del 1985, Retablo del 1987 e, insieme a Le pietre di Pantalica del 1988, L’olivo e l’olivastro del 1994; allinea poi, lungo un percorso di intima tragicità che va dalla crisi delle illusioni all’ansia inquieta dell’afasia, la trilogia della storia: il Sorriso sul Risorgimento; Nottetempo, casa per casa, sull’avvento del fascismo; Lo spasimo di Palermo, sulla «collusione tra mafia e potere politico, con le stragi mafiose degli anni Novanta».
Nell’imponente apparato, il curatore segue la storia interna delle singole opere: il loro farsi e stratificarsi nel tempo, secondo la memoria che esse conservano del loro stesso costruirsi e grazie alle carte gelosamente ordinate e custodite nel vasto archivio privato. È un lavoro gigantesco, che fa i conti con la complessità di una scrittura letteraria che sin dall’inizio ha praticato citazioni, autocitazioni, evocazioni di reperti d’arte (dalle fotografie, alle pitture e sculture: dai quadri insospettabili di Turner, alle metope di Selinunte), rifacimenti di pagine di scrittori barocchi come Bartoli, e di scrittori più vicini come il Nabokov di Lolita; non senza la complicazione di più innesti nel corpo stesso di questa letteratura sulla letteratura, come ha documentato Grassia, individuando «le vele le vele» di Dino Campana che prendono vento dentro una pagina di Bartoli da Consolo rilavorata con l’aiuto del De Aetna di Bembo.
Turchetta rivede i testi. Corregge persino, e giustamente, qualche ipercorrettismo del curatore dell’edizione critica del Sorriso dell’ignoto marinaio. Io però non avrei accolto lo scioglimento di un’abbreviatura epigrafica contenuta in un cartiglio. Nella prima edizione del Sorriso, si legge «COEFALEDU SICILIAE URBS». Doveva essere «COEFALED ». Chiaramente è caduto il segno abbreviativo, che va ripristinato. Lo scioglimento («COEFALEDUM») appanna il gusto arcaicizzante dello scrittore, la sua passione per l’immagine.
Corredano il volume un utile glossario, una dettagliatissima cronologia della vita, e una bibliografia esaustiva. Viene ricordato, a proposito del racconto Libertà di Verga presente al Consolo del Sorriso, anche il film di Vancini, Bronte: cronaca di un massacro. Sciascia collaborò alla sceneggiatura, fiancheggiato da Benedetto Benedetti da poco scomparso. E qui mi piace ricordare il vecchio film-maker, che un giorno, tanti anni fa, in tempi difficili, non esitò a improvvisarsi editore per pubblicare le poesie dialettali di Tonino Guerra.
L’ignoto Consolo marinaio di Sicilia
Lo scatto fantastico della letteratura come opposizione alle sconfitte della ragione
Ernesto Ferrero Tuttolibri 7 2 2015
Raccontava Vincenzo Consolo d’aver provato come una scossa, vedendo il ritratto d’ignoto di Antonello da Messina conservato al Museo Mandralisca di Cefalù. Gli sembrava qualcuno di famiglia, che parlava proprio a lui. Da quell’agnizione, carica di ghiotti misteri, prendeva forma quello che sarebbe rimasto il suo capolavoro, Il sorriso dell’ignoto marinaio, apparso a sorpresa da Einaudi nel 1976 dopo una gestione lunga e tormentata: un manufatto d’altissima oreficeria nel cuore degli anni di piombo.
L’ignoto (probabilmente un notabile liparitano) è quasi diventato un suo alter ego. Il suo sorriso ha qualcosa di sarcastico e beffardo, la malizia volpina di un mercante. Invece il sorriso d’incredulità e amarezza che stirava le labbra di Consolo ad ogni nuova notizia di violenze, sopraffazioni e furberie restava quello di un bambino ferito che non si rassegna alle ingiustizie del mondo proprio quando ne riceve un’ulteriore conferma. Di fronte a un degrado della Sicilia che trovava un puntuale riscontro nel resto del Paese, negli ultimi anni il suo sconforto era diventato quasi immedicabile, e tuttavia continuava ad alimentare in modo sempre più convinto l’oltranza dell’espressionismo cui restava fedele.
È stato sempre un pendolare, Consolo: tra la natìa Sant’Agata di Militello, nel messinese, dov’era nato nel 1933, e la Milano degli studi in legge e poi del lavoro; tra una storia da frugare proprio là dove era più trascurata, quella popolare, e le tensioni di un presente sempre meno progressivo; tra arte e vita, tra «ebbrezza stilistica e rigore argomentativo» (Cesare Segre). Cercava di conciliare in se stesso le passioni scientifiche del barone Mandralisca, collezionista erudito, e quelle politiche del cospiratore Interdonato.
Le delusioni hanno finito per rendere ancora più acceso, quasi parossistico, l’amore per la propria terra, per la sua storia e cultura. In lui lo scatto fantastico della letteratura, unica opposizione praticabile di fronte alle sconfitte della ragione che tanto angustiavano Leonardo Sciascia, amico e maestro, nasceva dal mite furore dell’indagine archeologica, storica, antropologica, linguistica. Tra Gadda e D’Annunzio, mirava a colmare il divario tra la realtà e le parole, restituite all’intensità originale del loro suono, per inseguire la bellezza assoluta del vero poetico. Più avvertiva i limiti intrinseci della letteratura, più le assegnava ambizioni e responsabilità. In una sorta di spasimo mai rassegnato.
Assume il valore di un definitivo risarcimento postumo il Meridiano che Gianni Turchetta ha curato con sapiente empatia critica, equipaggiandolo d’una fittissima cronologia, e di ben trecento pagine di note ai testi, glossario e bibliografia, per illuminare il backstage delle opere, la loro struttura calcolatissima, la complessità di intrecci, rimandi, assonanze, analogie, opposizioni. Si va dal romanzo di formazione La ferita dell’aprile (1963) ai saggi raccolti in Di qua dal faro (1999), passando per opere che sfuggono ad ogni etichetta di genere, come Lunaria e Retablo.
In un profilo posto in apertura del volume, Cesare Segre è esplicito: «Consolo è stato il maggiore scrittore italiano della sua generazione». Colui che ha cercato di fare manzonianamente i conti con il presente attraverso le metafore offerte da alcuni momenti-chiave della nostra storia: il 1860 e dintorni con le sanguinose rivolte contadine che seguono l’arrivo di Garibaldi; i primi anni venti in cui il fascismo trova in Sicilia un terreno fertile; la cupa Palermo delle stragi di mafia. Ma senza pagare pedaggio alla linearità del romanzo tradizionale, che tutto crede di organizzare e spiegare in una sorta di discorso illuministico, «geometrizzante», come diceva lui, citando Leopardi. Non si accontentava della facile comunicabilità del linguaggio medio. Ogni adescamento anche vagamente commerciale gli riusciva insopportabile. Non amava gli avanguardismi, lo sghignazzo di chi si fa beffe di quanto è stato prodotto prima di lui. Preferiva dirsi sperimentale (come lo era stato Verga), e dunque tentare una letteratura frattale, di rifrazioni, scomposizioni e ricomposizioni, intarsio di generi, modi, linguaggi, materiali anche diversissimi, fondato su una prosa che è stata a giusto titolo definita ritmica.
Alla narratività distesa e onnisciente preferiva i lampeggiamenti nervosi della poesia. Una musicalità costruita e goduta in ogni singola parola. Consolo è in primo luogo un poeta, sempre. Ogni sua pagina, tramata di endecasillabi, richiede il massimo impegno interpretativo del lettore chiamato ad eseguirla, come è particolarmente evidente nel virtuosistico Nottetempo casa per casa (1992).
Si potrebbe dire della sua opera quel che lui stesso ha scritto del barocco in Sicilia, nato dall’orgoglio di opporre alle distruzioni dei terremoti scenografie ardite, nate da sogni smisurati. Solo così la paura si può volgere in coraggio, «l’oscuro in luce, l’orrore in bellezza, l’irrazionale in fantasia creatrice, l’anarchia incontrollabile della natura nella leibniziana, illuministica anarchia creatrice; il caos in logos, infine». Troppe volte angustiato dai terremoti del Novecento, Consolo non ha mai rinunciato ad opporvi le sue sontuose polifonie, i raffinati collages in cui ha ricuperato i tesori di una Sicilia omerica e domestica, mitica e quotidiana, aristocratica e plebea, reale e araldica.
La luna e il faro, il Meridiano su Vincenzo Consolo
La luna e il faro, il Meridiano su Vincenzo Consolo
di Giuseppe Schillaci
É saturnina la Luna, atra, melanconica, sospesa nell’attesa infinita della fine che non arriva mai.
Ma se malinconia è la storia, l’infinito, l’eterno sono ansia, vertigine, panico, terrore.
Lei, la Luna, ci salvò e ci diede la parola.
Lei schiarì la notte primordiale, fugò la dura tenebra finale.
(Lunaria, Mondadori, 1985)
Il 21 gennaio 2012 è scomparso Vincenzo Consolo, uno dei più raffinati scrittori italiani, tra gli ultimi intellettuali europei della sua generazione, classe 1933, ad aver vissuto le luci e le ombre del Novecento. A tre anni dalla morte, Mondadori pubblica finalmente il Meridiano “L’opera completa” di Vincenzo Consolo, con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre. Il volume raccoglie i romanzi e i racconti, le scritture liriche e quelle d’intervento sociale, restituendo così l’immagine poliedrica di uno dei più grandi cesellatori della lingua italiana, le cui opere sono state tradotte in diversi Paesi e studiate nelle università di tutto il mondo.
Dello scrittore Vincenzo Consolo, collaboratore dell’Einaudi di Calvino e Ginzburg, m’impressionò, già da adolescente, l’originalità della voce: una lingua barocca ma schietta, appassionata, sempre in bilico tra contemplazione e denuncia, una scrittura legata profondamente alla sua terra. Consolo era ossessionato dalla Sicilia, così come tutti i grandi scrittori sono ossessionati dalla propria identità, dalla verità e dal divenire: la sua opera racconta un’isola visionaria e tragicamente reale, tra mito e storia, poesia e narrazione, alta letteratura e cultura popolare. A rileggere i suoi testi, oggi, si notano alcune figure che ritornano, ossessive, per tessere un mondo fragile e sublime, inquieto, in dissoluzione. Una di queste figure è il faro, presente anche nel titolo della raccolta di saggi Di qua dal faro (Mondadori, 1999): il faro per Consolo è un baluardo, la luce della ragione contro l’oscurantismo, una barriera contro il caos della notte.
La contrapposizione tra luce e oscurità si rivela poi, in tutta la sua potenza, nel romanzo di Consolo che più ho amato: Nottetempo, casa per casa, premio Strega nel 1992. Si tratta di una storia ambientata a Cefalù, in provincia di Palermo, ai tempi della nascita del Fascismo. Per Consolo, l’adozione del romanzo storico è sempre da intendersi in chiave metaforica rispetto al presente: gli anni Venti sono così un’epoca d’oscurantismo simile a quella che l’autore presagiva agli inizi degli Anni Novanta, all’alba del “nuovo ventennio”. La metafora storica era già presente nel romanzo sul Risorgimento tradito, Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato in pieni anni Settanta e etichettato come l’ « anti-Gattopardo », in cui Consolo racconta di un nobile siciliano illuminato che tenta di resistere al potere reazionario della nuova Italia, per parlare in realtà dell’Italia post-sessantottina, ipocrita e refrattaria a un reale cambiamento. Ma torniamo a Nottetempo, casa per casa. Qui, alla violenza fascista e alla perversione del potere fa eco un altro oscuramento della ragione, questa volta misterico, soprannaturale. Proprio nei primi anni Venti, infatti, si trasferiva a Cefalù Aleister Crowley, il mistico artista inglese che inneggiava alla libertà dei sensi e a un mondo esoterico che rasentava il delirio visionario. Alla ragione del faro si riflette e s’oppone così la poesia della luna, che è anche, irrimediabilmente, segno di follia e di dolore, come per il padre del protagonista Petro Marano, che corre rabbioso nelle notti di luna piena per quietare il suo male catubbo (la licantropia).
Ecco delinearsi il paradosso dello scrittore, la tensione irrisolvibile tra prosa e poesia, tra la storia oggettiva del faro, da un lato, e i mondi immaginari della luna, dall’altro. In questo orizzonte si muove la lingua musicale di Vincenzo Consolo, trovando nelle parole la propria salvezza. La vera sconfitta è l’afasia, l’impossibilità del racconto, il silenzio della morte. Così Consolo, come Petro Marano, cerca redenzione nel racconto, che sembra nascere da una nostalgia per l’unità perduta, da un’aderenza naturale tra le parole e le cose. Questa sorta di autenticità perduta, di bellezza primordiale, Consolo la insegue, ostinato, in tutta la sua opera, inventandosi una lingua che resuscita le voci greche, arabe, spagnolesche e francesi che hanno abitato, secoli fa, la Sicilia.
Vincenzo Consolo adorava la sua terra, e non solo perché rappresentava il teatro della sua infanzia, ma anche perché lo scrittore guardava alla Sicilia come centro del Mediterraneo, ricettacolo di culture d’oriente e d’occidente, porta d’Africa, culla della letteratura italiana e della civiltà europea. Ecco perché, negli ultimi anni della sua vita, intervenne spesso nel dibattito pubblico sull’emigrazione, allorché la Sicilia veniva considerata non più come porta, ma come muro d’Europa. Ma la Sicilia di Consolo è anche una terra del Sud, di un Sud d’Italia che è simile a tutti i Sud del mondo, e che è dunque terra tradita, ferita dalle storture del potere, schiacciata dalle meschinità umane, dalle mafie, dall’avidità, dall’ignoranza. Da emigrato al Nord Italia, a Milano, dove s’era trasferito già negli anni Sessanta, Consolo scrive di sradicamenti, di fughe, di un’Itaca a cui è impossibile ritornare.
Ho avuto l’onore di incontrare Vincenzo Consolo e il piacere di frequentarlo negli ultimi anni della sua vita, insieme alla compagna Caterina Pilenga, suo riferimento prezioso e costante. Durante quelle cene nelle osterie di provincia, restavo affascinato dai racconti d’un mondo quasi picaresco, che non esisteva più, e dai suoi aneddoti sui maestri della letteratura mondiale o sui personaggi leggendari del popolo siciliano, sempre dipinti con sagacia e profonda umanità; dagli occhi di quest’uomo minuto e fiero trasparivano le immagini delle sue opere, la loro complessa semplicità, l’ironia, la discrezione, la rivolta.
Vincenzo Consolo ci lascia un’opera densa, in cui ogni parola ha un peso e marca la propria estraneità al cicalio dei best-sellers contemporanei e dell’editoria mercenaria. La sua scrittura ci ricorda che la letteratura è una cosa seria, un tempio in cui entrare con rispetto, senza rinunciare però al contraddittorio e allo sberleffo, alla commedia dentro la tragedia, alla trivialità e al sorriso, alla speranza in un mondo diverso, nonostante la catastrofe. Consolo ha creduto sempre, caparbiamente, alla potenza della lingua e alla necessità della luce, forse proprio perché temeva con profonda angoscia il silenzio e le tenebre. La sua maestria letteraria abbracciava dunque ora la luna, ora il faro, e cercava di far proprie, allo stesso tempo, paradossalmente, la visionarietà del poeta Lucio Piccolo (la luna) e la tensione sociale di Leonardo Sciascia (il faro). Questo movimento torna sempre alla sua Sicilia, che è anche metafora dell’Italia, in una lotta appassionata, irrisolvibile e mai elusa, contro l’oscurantismo.
Da Milano, Consolo « scendeva » spesso in Sicilia, nella sua Sant’Agata di Militello, e lo faceva quasi fosse un dovere, una questione di principio. Proprio a Sant’Agata di Militello si tennero i suoi funerali, tre anni fa: una lunga processione silenziosa e commossa, lontano dai clamori dell’Italietta del 2012, agli antipodi d’un mondo che non lo capiva più, e da cui Consolo si teneva lontano. Lui, il razionale lunatico Vincenzo Consolo, si nutriva di disillusioni e continuava a scrivere, finché ne ebbe le forze. Quando lo interrogavano sul tempo presente o sull’avvenire di quest’Italia matrigna, Consolo amava citare un verso di un poeta spagnolo a cui era particolarmente affezionato, Antonio Machado; un verso semplice, tre parole: « desperados esperamos todavia ».
La luna e il faro, il Meridiano su Vincenzo Consolo
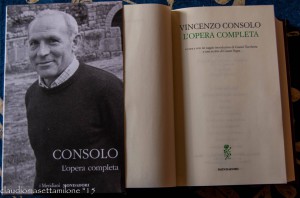
di Giuseppe Schillaci
É saturnina la Luna, atra, melanconica, sospesa nell’attesa infinita della fine che non arriva mai.
Ma se malinconia è la storia, l’infinito, l’eterno sono ansia, vertigine, panico, terrore.
Lei, la Luna, ci salvò e ci diede la parola.
Lei schiarì la notte primordiale, fugò la dura tenebra finale.
(Lunaria, Mondadori, 1985)
Il 21 gennaio 2012 è scomparso Vincenzo Consolo, uno dei più raffinati scrittori italiani, tra gli ultimi intellettuali europei della sua generazione, classe 1933, ad aver vissuto le luci e le ombre del Novecento. A tre anni dalla morte, Mondadori pubblica finalmente il Meridiano “L’opera completa” di Vincenzo Consolo, con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre. Il volume raccoglie i romanzi e i racconti, le scritture liriche e quelle d’intervento sociale, restituendo così l’immagine poliedrica di uno dei più grandi cesellatori della lingua italiana, le cui opere sono state tradotte in diversi Paesi e studiate nelle università di tutto il mondo.
Dello scrittore Vincenzo Consolo, collaboratore dell’Einaudi di Calvino e Ginzburg, m’impressionò, già da adolescente, l’originalità della voce: una lingua barocca ma schietta, appassionata, sempre in bilico tra contemplazione e denuncia, una scrittura legata profondamente alla sua terra. Consolo era ossessionato dalla Sicilia, così come tutti i grandi scrittori sono ossessionati dalla propria identità, dalla verità e dal divenire: la sua opera racconta un’isola visionaria e tragicamente reale, tra mito e storia, poesia e narrazione, alta letteratura e cultura popolare. A rileggere i suoi testi, oggi, si notano alcune figure che ritornano, ossessive, per tessere un mondo fragile e sublime, inquieto, in dissoluzione. Una di queste figure è il faro, presente anche nel titolo della raccolta di saggi Di qua dal faro (Mondadori, 1999): il faro per Consolo è un baluardo, la luce della ragione contro l’oscurantismo, una barriera contro il caos della notte.
La contrapposizione tra luce e oscurità si rivela poi, in tutta la sua potenza, nel romanzo di Consolo che più ho amato: Nottetempo, casa per casa, premio Strega nel 1992. Si tratta di una storia ambientata a Cefalù, in provincia di Palermo, ai tempi della nascita del Fascismo. Per Consolo, l’adozione del romanzo storico è sempre da intendersi in chiave metaforica rispetto al presente: gli anni Venti sono così un’epoca d’oscurantismo simile a quella che l’autore presagiva agli inizi degli Anni Novanta, all’alba del “nuovo ventennio”. La metafora storica era già presente nel romanzo sul Risorgimento tradito, Il sorriso dell’ignoto marinaio, pubblicato in pieni anni Settanta e etichettato come l’ « anti-Gattopardo », in cui Consolo racconta di un nobile siciliano illuminato che tenta di resistere al potere reazionario della nuova Italia, per parlare in realtà dell’Italia post-sessantottina, ipocrita e refrattaria a un reale cambiamento. Ma torniamo a Nottetempo, casa per casa. Qui, alla violenza fascista e alla perversione del potere fa eco un altro oscuramento della ragione, questa volta misterico, soprannaturale. Proprio nei primi anni Venti, infatti, si trasferiva a Cefalù Aleister Crowley, il mistico artista inglese che inneggiava alla libertà dei sensi e a un mondo esoterico che rasentava il delirio visionario. Alla ragione del faro si riflette e s’oppone così la poesia della luna, che è anche, irrimediabilmente, segno di follia e di dolore, come per il padre del protagonista Petro Marano, che corre rabbioso nelle notti di luna piena per quietare il suo male catubbo (la licantropia).
Ecco delinearsi il paradosso dello scrittore, la tensione irrisolvibile tra prosa e poesia, tra la storia oggettiva del faro, da un lato, e i mondi immaginari della luna, dall’altro. In questo orizzonte si muove la lingua musicale di Vincenzo Consolo, trovando nelle parole la propria salvezza. La vera sconfitta è l’afasia, l’impossibilità del racconto, il silenzio della morte. Così Consolo, come Petro Marano, cerca redenzione nel racconto, che sembra nascere da una nostalgia per l’unità perduta, da un’aderenza naturale tra le parole e le cose. Questa sorta di autenticità perduta, di bellezza primordiale, Consolo la insegue, ostinato, in tutta la sua opera, inventandosi una lingua che resuscita le voci greche, arabe, spagnolesche e francesi che hanno abitato, secoli fa, la Sicilia.
Vincenzo Consolo adorava la sua terra, e non solo perché rappresentava il teatro della sua infanzia, ma anche perché lo scrittore guardava alla Sicilia come centro del Mediterraneo, ricettacolo di culture d’oriente e d’occidente, porta d’Africa, culla della letteratura italiana e della civiltà europea. Ecco perché, negli ultimi anni della sua vita, intervenne spesso nel dibattito pubblico sull’emigrazione, allorché la Sicilia veniva considerata non più come porta, ma come muro d’Europa. Ma la Sicilia di Consolo è anche una terra del Sud, di un Sud d’Italia che è simile a tutti i Sud del mondo, e che è dunque terra tradita, ferita dalle storture del potere, schiacciata dalle meschinità umane, dalle mafie, dall’avidità, dall’ignoranza. Da emigrato al Nord Italia, a Milano, dove s’era trasferito già negli anni Sessanta, Consolo scrive di sradicamenti, di fughe, di un’Itaca a cui è impossibile ritornare.
Ho avuto l’onore di incontrare Vincenzo Consolo e il piacere di frequentarlo negli ultimi anni della sua vita, insieme alla compagna Caterina Pilenga, suo riferimento prezioso e costante. Durante quelle cene nelle osterie di provincia, restavo affascinato dai racconti d’un mondo quasi picaresco, che non esisteva più, e dai suoi aneddoti sui maestri della letteratura mondiale o sui personaggi leggendari del popolo siciliano, sempre dipinti con sagacia e profonda umanità; dagli occhi di quest’uomo minuto e fiero trasparivano le immagini delle sue opere, la loro complessa semplicità, l’ironia, la discrezione, la rivolta.
Vincenzo Consolo ci lascia un’opera densa, in cui ogni parola ha un peso e marca la propria estraneità al cicalio dei best-sellers contemporanei e dell’editoria mercenaria. La sua scrittura ci ricorda che la letteratura è una cosa seria, un tempio in cui entrare con rispetto, senza rinunciare però al contraddittorio e allo sberleffo, alla commedia dentro la tragedia, alla trivialità e al sorriso, alla speranza in un mondo diverso, nonostante la catastrofe. Consolo ha creduto sempre, caparbiamente, alla potenza della lingua e alla necessità della luce, forse proprio perché temeva con profonda angoscia il silenzio e le tenebre. La sua maestria letteraria abbracciava dunque ora la luna, ora il faro, e cercava di far proprie, allo stesso tempo, paradossalmente, la visionarietà del poeta Lucio Piccolo (la luna) e la tensione sociale di Leonardo Sciascia (il faro). Questo movimento torna sempre alla sua Sicilia, che è anche metafora dell’Italia, in una lotta appassionata, irrisolvibile e mai elusa, contro l’oscurantismo.
Da Milano, Consolo « scendeva » spesso in Sicilia, nella sua Sant’Agata di Militello, e lo faceva quasi fosse un dovere, una questione di principio. Proprio a Sant’Agata di Militello si tennero i suoi funerali, tre anni fa: una lunga processione silenziosa e commossa, lontano dai clamori dell’Italietta del 2012, agli antipodi d’un mondo che non lo capiva più, e da cui Consolo si teneva lontano. Lui, il razionale lunatico Vincenzo Consolo, si nutriva di disillusioni e continuava a scrivere, finché ne ebbe le forze. Quando lo interrogavano sul tempo presente o sull’avvenire di quest’Italia matrigna, Consolo amava citare un verso di un poeta spagnolo a cui era particolarmente affezionato, Antonio Machado; un verso semplice, tre parole: « desperados esperamos todavia ».
Mondo come lotta fra parole e storia
Le fughe e i ritorni di Vincenzo Consolo
Le fughe e i ritorni di Vincenzo Consolo. La Sicilia non è solo Gattopardo

Vincenzo Consolo (fonte: lettera43.it)
L’irrazionale e la storia s’incontrano, tra riti satanici, licantropia e leggende esoteriche. Allievo di Leonardo Sciascia, era agli antipodi rispetto a Tomasi di Lampedusa. La ribellione di Alcàra Li Fusi è seguita con una comprensione che diventa crescente orrore. Sul “Corriere della Sera”, l’ultimo intervento critico di Cesare Segre dedicato allo scrittore, di cui esce il Meridiano Mondadori
di CESARE SEGRE, “Corriere della Sera”, 19 gennaio 2015
Voglio subito enunciare un giudizio complessivo: Consolo è stato il maggiore scrittore italiano della sua generazione. La sua scomparsa ha turbato tutto il quadro della narrativa nel nostro Paese, rimasto senza un punto di riferimento alto e, per me, indubitabile. Il romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976, iniziato però intorno al 1969 e poi finito pochi mesi prima dell’uscita) fu una rivelazione. L’ignoto di una splendida tavoletta di Antonello da Messina nel museo Mandralisca di Cefalù divenne, con il suo sorriso, una specie di doppio di Vincenzo Consolo. Ma accanto alla vera immagine di Consolo sono spesso apparse altre due immagini: quella di Leonardo Sciascia e quella di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il primo, pur diversissimo nello stile, fu il maestro di Consolo per l’atteggiamento di fronte ai problemi e alle contraddizioni sempre piu laceranti della Sicilia. Il secondo ne fu l’antitesi: tanto è lontano il suo Gattopardo dal Sorriso dell’ignoto marinaio , anche se entrambi hanno come oggetto lo stesso momento storico della Sicilia, percorsa da moti risorgimentali, liberata (o occupata) dai Mille a nome dell’Italia da unire, bersaglio infine di jacqueries contadine confuse, dai contemporanei, con scoppi di banditismo. È comunque da questo confronto – si disse che Il sorriso era l’anti-Gattopardo – che si può partire per qualunque discorso su Consolo. Ma sarà intanto utile esporre lo schema del romanzo, e di quelli che seguirono. I primi due capitoli del Sorriso ci portano in mezzo agli aristocratici e ai borghesi illuminati, fra i quali si stanno diffondendo le idee liberali e mazziniane.
Essi odiano i monarchi borbonici e sono pronti ad affrontare, se occorre, l’esilio e la morte, come accadrà dopo la fallita rivolta di Cefalù del 1857. Gli altri capitoli, dal III al IX, sono ambientati pochi anni dopo, quando la Sicilia si prepara a passare sotto il governo dei piemontesi. Questi capitoli sono tutti dedicati ai prodromi, agli sviluppi e alla tragica conclusione della rivolta popolare di Alcàra Li Fusi, scoppiata alla vigilia dello sbarco di Garibaldi. Dietro Alcàra sta forse, per Consolo, il ricordo di Bronte e della spietata repressione di Nino Bixio, descritta da Verga nel racconto Libertà . Il barone Mandralisca, possessore del ritratto di Antonello, segue la rivolta con istintiva comprensione, ma, quando essa degenera, la vede con crescente orrore, e confessa la sua incapacità di comprendere e di giudicare. La narrazione d’autore si alterna a documenti ufficiali, brani di storici locali (come Francesco Guardione) o nazionali (come le Noterelle di uno dei Mille di Giuseppe Cesare Abba), che separano tra loro le varie parti d’invenzione.
Consolo aveva gia pubblicato un romanzo, La ferita dell’aprile (1963), che al momento sfuggì all’attenzione dei critici e dei lettori. Si tratta di un Bildungsroman autobiografico, un unicum nella carriera dello scrittore (che, per parte sua, lo definiva un «poemetto narrativo»). Il romanzo narra la vita nella Sicilia del dopoguerra, fino all’occupazione dei latifondi e alla repressione ad opera dei governi democristiani.Provando a completare il quadro dei romanzi di Consolo, siamo ben consapevoli di metterci in una posizione contraddittoria, dato che Consolo stesso ha più volte dichiarato che nel romanzo storico non credeva. Diciamo allora che, bypassando il problema, prendiamo in esame i suoi libri che esibiscono dei personaggi e una narrazione continuata.
Venne dunque Retablo (1987), con immagini di Fabrizio Clerici; il grande pittore, trasformato in personaggio settecentesco, appare nella seconda parte del romanzo, da milanese appassionato di antichità siciliane. È lui, che pure arde di un amore infelice per Teresa Blasco, la futura nonna siciliana di Manzoni, a tentar di risolvere i problemi del fraticello innamorato della prima parte della narrazione; ma intanto Consolo rende omaggio al mitico Illuminismo milanese, visto dal traguardo della contemporaneità: per esempio, dalla rivolta, che divenne poco dopo anche giudiziaria, contro il mostro della corruzione.
Si avvicina certo a un vero romanzo Nottetempo, casa per casa (1992). Il tema centrale potrebbe essere sintetizzato come «l’irrazionale e la storia», e fornirebbe argomenti alla negazione di principio del romanzo che Consolo ha fatto propria. Qui abbiamo, in singoli flash a luce radente, la ricostruzione dell’affermarsi del fascismo, negli anni Venti del secolo scorso, tra Cefalù e Palermo. Invece di raccontare questa vicenda, col rischio di ricadere nelle fauci dell’aborrito romanzo storico, Consolo evoca l’irruzione nell’isola di forme più o meno deliranti dell’irrazionale, dalla licantropia del padre di Petro, il protagonista, alle psicosi della sorella, alle esibizioni di un personaggio storico come l’inglese Aleister Crowley, inventore e officiante di riti satanici in cui alla promiscuità sessuale e alla droga si mescolano le invenzioni più stravaganti di religioni e leggende esoteriche.
Ma è più tardi Gioacchino Martinez, il protagonista di Lo spasimo di Palermo (1998) abbozzato in modo da risultare molto simile a Consolo stesso, a farci quasi toccare con mano, una ad una, tutte le disillusioni di un siciliano che, fuggito disdegnoso dalla sua isola, trova in Lombardia situazioni che generano in lui analoghi sentimenti di rifiuto e di condanna. Tutti i romanzi appena ricordati, se ordinati in base alla cronologia dei fatti descritti o allusi, compongono, per momenti decisivi, una storia della Sicilia degli ultimi 250 anni. Ma dalla mia grossolana rassegna tassonomico-cronologica resta fuori uno dei lavori più mirabili di Consolo, Lunaria (1985). In esso c’è un abbandono pieno all’invenzione. Invenzione tematica e invenzione formale. Il libro non è certo un romanzo, ma appartiene piuttosto a un «genere che non esiste», a un conato di teatralità divertita fra entremés alla spagnola e teatrino delle marionette. Si sa che molta elaborazione di Consolo è «letteratura sulla letteratura». Ebbene, in Lunaria la falsariga è costituita da un racconto di Lucio Piccolo, L’esequie della luna (1967), con cui Consolo si pone felicemente in gara, non dimenticando naturalmente Leopardi. Voglio evocare un aneddoto sintomatico. Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.Il mio percorso sembrerebbe aver trascurato i molti scritti di Consolo di carattere saggistico o polemico. Ma in fondo no, se pensiamo che molti o moltissimi dei suoi saggi (raccolti in volumi come L’olivo e l’olivastro , del 1994, Le pietre di Pantalica , del 1988, Di qua dal faro , del 1999) possono essere visti, per tornare a un’etichetta un tempo di gran moda, come i correlativi oggettivi dei suoi romanzi. Perché al centro dei saggi c’è sempre la Sicilia, le sue contraddizioni e i suoi mali visti con disperata frustrante insistenza, con passione e con sarcasmo da un siciliano che fugge e ritorna incessantemente: solo che qui lo stile, non gravato dalla necessità di reggere qualche complesso intreccio finzionale, può piegarsi a un’evocazione quasi impassibile delle bellezze naturali e delle ricchezze archeologiche e artistiche dell’isola, deva state forse irrimediabilmente.
Le fughe e i ritorni di Vincenzo Consolo
Le fughe e i ritorni di Vincenzo Consolo. La Sicilia non è solo Gattopardo

Vincenzo Consolo
L’irrazionale e la storia s’incontrano, tra riti satanici, licantropia e leggende esoteriche. Allievo di Leonardo Sciascia, era agli antipodi rispetto a Tomasi di Lampedusa. La ribellione di Alcàra Li Fusi è seguita con una comprensione che diventa crescente orrore. Sul “Corriere della Sera”, l’ultimo intervento critico di Cesare Segre dedicato allo scrittore, di cui esce il Meridiano Mondadori
di CESARE SEGRE, “Corriere della Sera”, 19 gennaio 2015
Voglio subito enunciare un giudizio complessivo: Consolo è stato il maggiore scrittore italiano della sua generazione. La sua scomparsa ha turbato tutto il quadro della narrativa nel nostro Paese, rimasto senza un punto di riferimento alto e, per me, indubitabile. Il romanzo Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976, iniziato però intorno al 1969 e poi finito pochi mesi prima dell’uscita) fu una rivelazione. L’ignoto di una splendida tavoletta di Antonello da Messina nel museo Mandralisca di Cefalù divenne, con il suo sorriso, una specie di doppio di Vincenzo Consolo. Ma accanto alla vera immagine di Consolo sono spesso apparse altre due immagini: quella di Leonardo Sciascia e quella di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il primo, pur diversissimo nello stile, fu il maestro di Consolo per l’atteggiamento di fronte ai problemi e alle contraddizioni sempre piu laceranti della Sicilia. Il secondo ne fu l’antitesi: tanto è lontano il suo Gattopardo dal Sorriso dell’ignoto marinaio , anche se entrambi hanno come oggetto lo stesso momento storico della Sicilia, percorsa da moti risorgimentali, liberata (o occupata) dai Mille a nome dell’Italia da unire, bersaglio infine di jacqueries contadine confuse, dai contemporanei, con scoppi di banditismo. È comunque da questo confronto – si disse che Il sorriso era l’anti-Gattopardo – che si può partire per qualunque discorso su Consolo. Ma sarà intanto utile esporre lo schema del romanzo, e di quelli che seguirono. I primi due capitoli del Sorriso ci portano in mezzo agli aristocratici e ai borghesi illuminati, fra i quali si stanno diffondendo le idee liberali e mazziniane.
Essi odiano i monarchi borbonici e sono pronti ad affrontare, se occorre, l’esilio e la morte, come accadrà dopo la fallita rivolta di Cefalù del 1857. Gli altri capitoli, dal III al IX, sono ambientati pochi anni dopo, quando la Sicilia si prepara a passare sotto il governo dei piemontesi. Questi capitoli sono tutti dedicati ai prodromi, agli sviluppi e alla tragica conclusione della rivolta popolare di Alcàra Li Fusi, scoppiata alla vigilia dello sbarco di Garibaldi. Dietro Alcàra sta forse, per Consolo, il ricordo di Bronte e della spietata repressione di Nino Bixio, descritta da Verga nel racconto Libertà . Il barone Mandralisca, possessore del ritratto di Antonello, segue la rivolta con istintiva comprensione, ma, quando essa degenera, la vede con crescente orrore, e confessa la sua incapacità di comprendere e di giudicare. La narrazione d’autore si alterna a documenti ufficiali, brani di storici locali (come Francesco Guardione) o nazionali (come le Noterelle di uno dei Mille di Giuseppe Cesare Abba), che separano tra loro le varie parti d’invenzione.
Consolo aveva gia pubblicato un romanzo, La ferita dell’aprile (1963), che al momento sfuggì all’attenzione dei critici e dei lettori. Si tratta di un Bildungsroman autobiografico, un unicum nella carriera dello scrittore (che, per parte sua, lo definiva un «poemetto narrativo»). Il romanzo narra la vita nella Sicilia del dopoguerra, fino all’occupazione dei latifondi e alla repressione ad opera dei governi democristiani.Provando a completare il quadro dei romanzi di Consolo, siamo ben consapevoli di metterci in una posizione contraddittoria, dato che Consolo stesso ha più volte dichiarato che nel romanzo storico non credeva. Diciamo allora che, bypassando il problema, prendiamo in esame i suoi libri che esibiscono dei personaggi e una narrazione continuata.
Venne dunque Retablo (1987), con immagini di Fabrizio Clerici; il grande pittore, trasformato in personaggio settecentesco, appare nella seconda parte del romanzo, da milanese appassionato di antichità siciliane. È lui, che pure arde di un amore infelice per Teresa Blasco, la futura nonna siciliana di Manzoni, a tentar di risolvere i problemi del fraticello innamorato della prima parte della narrazione; ma intanto Consolo rende omaggio al mitico Illuminismo milanese, visto dal traguardo della contemporaneità: per esempio, dalla rivolta, che divenne poco dopo anche giudiziaria, contro il mostro della corruzione.
Si avvicina certo a un vero romanzo Nottetempo, casa per casa (1992). Il tema centrale potrebbe essere sintetizzato come «l’irrazionale e la storia», e fornirebbe argomenti alla negazione di principio del romanzo che Consolo ha fatto propria. Qui abbiamo, in singoli flash a luce radente, la ricostruzione dell’affermarsi del fascismo, negli anni Venti del secolo scorso, tra Cefalù e Palermo. Invece di raccontare questa vicenda, col rischio di ricadere nelle fauci dell’aborrito romanzo storico, Consolo evoca l’irruzione nell’isola di forme più o meno deliranti dell’irrazionale, dalla licantropia del padre di Petro, il protagonista, alle psicosi della sorella, alle esibizioni di un personaggio storico come l’inglese Aleister Crowley, inventore e officiante di riti satanici in cui alla promiscuità sessuale e alla droga si mescolano le invenzioni più stravaganti di religioni e leggende esoteriche.
Ma è più tardi Gioacchino Martinez, il protagonista di Lo spasimo di Palermo (1998) abbozzato in modo da risultare molto simile a Consolo stesso, a farci quasi toccare con mano, una ad una, tutte le disillusioni di un siciliano che, fuggito disdegnoso dalla sua isola, trova in Lombardia situazioni che generano in lui analoghi sentimenti di rifiuto e di condanna. Tutti i romanzi appena ricordati, se ordinati in base alla cronologia dei fatti descritti o allusi, compongono, per momenti decisivi, una storia della Sicilia degli ultimi 250 anni. Ma dalla mia grossolana rassegna tassonomico-cronologica resta fuori uno dei lavori più mirabili di Consolo, Lunaria (1985). In esso c’è un abbandono pieno all’invenzione. Invenzione tematica e invenzione formale. Il libro non è certo un romanzo, ma appartiene piuttosto a un «genere che non esiste», a un conato di teatralità divertita fra entremés alla spagnola e teatrino delle marionette. Si sa che molta elaborazione di Consolo è «letteratura sulla letteratura». Ebbene, in Lunaria la falsariga è costituita da un racconto di Lucio Piccolo, L’esequie della luna (1967), con cui Consolo si pone felicemente in gara, non dimenticando naturalmente Leopardi. Voglio evocare un aneddoto sintomatico. Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procurò la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore.Il mio percorso sembrerebbe aver trascurato i molti scritti di Consolo di carattere saggistico o polemico. Ma in fondo no, se pensiamo che molti o moltissimi dei suoi saggi (raccolti in volumi come L’olivo e l’olivastro , del 1994, Le pietre di Pantalica , del 1988, Di qua dal faro , del 1999) possono essere visti, per tornare a un’etichetta un tempo di gran moda, come i correlativi oggettivi dei suoi romanzi. Perché al centro dei saggi c’è sempre la Sicilia, le sue contraddizioni e i suoi mali visti con disperata frustrante insistenza, con passione e con sarcasmo da un siciliano che fugge e ritorna incessantemente: solo che qui lo stile, non gravato dalla necessità di reggere qualche complesso intreccio finzionale, può piegarsi a un’evocazione quasi impassibile delle bellezze naturali e delle ricchezze archeologiche e artistiche dell’isola, deva state forse irrimediabilmente.
articolo disponibile sul sito del “Corriere della Sera”
© Riproduzione riservata
Vincenzo Consolo. Modernismo e meridionalismo
Le strategie linguistiche e strutturali mediante le quali Consolo costruisce la densità della propria parola letteraria, torcendola e caricandola nella sfida impossibile alla consistenza della realtà, e la stessa idea consoliana della parola, mettono capo a tensioni e aspirazioni solitamente rubricate sotto il segno della «poesia», nella costellazione, per intenderci, che si muove tra simbolismo e modernismo. La stessa ricorrente tentazione dell’afasia come esito della volontà di troppo dire è del resto segnale non dubbio di queste ascendenze. Non a caso già dal romanzo d’esordio, e fino alle ultime prove, T.S. Eliot è uno dei numi tutelari di Consolo. Allo stesso modo, per tutta la vita Consolo non ha smesso di sottolineare il proprio rifiuto radicale di appartenere alla tradizione propriamente romanzesca, sospetta perché troppo incline a cedere alle lusinghe di una facile leggibilità, ad usum commercii. Prove narrative le sue, quindi, ma protese verso la poesia. D’altro canto, non ci sono dubbi sulla necessità di accostare il suo progetto, letterario ma anche politico-culturale, alla tradizione meridionalistica, nel cui solco si forma, e che non ha mai smesso di operare, anche quando Consolo è andato prendendo strade assai diverse: come già negli anni Ottanta, con libri decisamente atipici come Lunaria e lo stesso Retablo, e sempre più negli anni Novanta. Stiamo così toccando l’altra questione di fondo: quella dell’ossessione della Sicilia. «Scrivo sempre di Sicilia perché non ci si può allontanare dagli anni della propria memoria» ha dichiarato lo scrittore: il che vuol dire, ed è un altro punto decisivo, che l’invenzione letteraria deve nascere dall’esperienza, con la quale entrerà in tensione, sforzandosi di esorcizzare i propri fatali limiti con l’accumulo e la pluralizzazione della forma.
Certo, Consolo parla di tutto sub specie Siciliae, tenendo insieme, in modo decisamente peculiare, la proiezione verso una dimensione di esemplarità e la messa a fuoco dettagliata di tratti storicamente identificati, ricostruiti con precisione maniacale. La sua sicilianità concede in questo senso abbastanza poco alla fuga per la tangente di una a-storica condizione universale, così caratteristica invece di altri autori siciliani, da Pirandello a Vittorini. In innumerevoli occasioni Consolo ha ricordato la sua ferma volontà di approdare alla metafora per via di storia, secondo il sempre attuale, magistrale modello manzoniano: «La lezione del Manzoni è proprio la metafora. Ci siamo sempre chiesti perché abbia ambientato il suo romanzo nel Seicento e non nell’Ottocento. Oltre che per il rovello per la giustizia, proprio per dare distanza alla sua inarrestabile metafora. L’Italia del Manzoni sembra davvero eterna, inestinguibile». L’esemplarità della Sicilia fa tutt’uno in Consolo con la sua peculiarità: che ci fa capire com’è l’Italia proprio perché è un caso estremo. Si potrebbe persino ipotizzare che, mutatis mutandis, a quello che egli scrive della Sicilia possa accadere in futuro qualcosa di simile a quanto già accaduto con la Lucania di Carlo Levi: ridiventata fruibile e attuale perché ricontestualizzata in «un quadro afroasiatico e latinoamericano». La Sicilia di Consolo vale come un’Italia estrema, e però anche come campione fin troppo vero di innumerevoli Sud del mondo. Per altri versi, la Sicilia di Consolo esibisce un cortocircuito di opposti, oscillando fra il vagheggiamento memoriale di un luogo che avrebbe potuto conciliare bellezza storica e naturale, vitalità e cultura, desiderio e conoscenza, e la constatazione, sempre più addolorata e indignata, dell’orrore reale, dell’ingiustizia perpetuata, della collusione eterna fra violenza criminale e violenza istituzionale. La Sicilia è un inferno, insomma, tanto quanto avrebbe potuto essere un paradiso. E la Sicilia è sempre solo la Sicilia: anzi no, è dappertutto.
Il progetto, ma forse dovremmo parlare piuttosto di dovere e di esigenza insopprimibile, di scrivere sempre di Sicilia coincide con la ferma convinzione che l’impresa della scrittura letteraria debba farsi portatrice di uno sguardo critico nei confronti della realtà, e implichi una dimensione etica, implicitamente o esplicitamente politica. Consolo ha infatti svolto per quasi cinquant’anni anche un’intensa attività giornalistica, della quale una larga percentuale è espressione di una diretta militanza civile. Restando però nell’ambito della scrittura letteraria, egli ha delineato, con un’originalità e un rigore teorico che hanno pochi termini di paragone in Italia, una possibile coincidenza fra espressività ed eticità, dove il permanente impegno civile deve identificarsi con la specificità della scrittura, cioè con l’impegno formale. Chiusa la stagione dell’engagement, per Consolo lo scrittore deve fare il proprio mestiere, fino in fondo, senza compromessi: solo così la scrittura può guadagnare lo spessore etico adeguato alle proprie aspirazioni, conoscitive non meno che estetiche. D’altro canto, chi scrive scrive, e dunque non può ignorare che scrivendo rinuncia al diretto impegno politico. Di conseguenza, i paradossi della parola letteraria, della sua pochezza e della sua titanica presunzione si rifrangono e ripetono nella compresenza costante di aperta politicità e senso di colpa dell’intellettuale, sempre abitato dalla sofferta consapevolezza della propria distanza dall’azione reale. Da questo punto di vista, Consolo ha molte cose in comune con Vittorio Sereni, e con lo stesso Franco Fortini, che del resto frequentava.
L’orgoglioso dovere della scrittura comporta così un permanente rimorso, che confina col senso d’inferiorità. Persino la dimensione utopica, pure evocata con tanta forza da Il sorriso dell’ignoto marinaio, non smette in realtà di mescolarsi con la cattiva coscienza, con un irriducibile senso di colpa. Ecco l’utopia del barone Mandralisca:
E gli altri, che mai hanno raggiunto i dritti più sacri e elementari, la terra e il pane, la salute e l’amore, la pace, la gioja e l’istruzione, questi dico, e sono la più parte, perché devono intender quelle parole a modo nostro? Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose. (SIM, qui alle pp. 216-7)
Questo sogno di un linguaggio che abolisca il divario fra le parole e le cose assomiglia molto alla permanente tensione di Consolo verso una parola portatrice di una densità tanto speciale da farla assomigliare a una cosa vera. Ma persino qui, dove tanto più la voce del personaggio pare confondersi con quella dell’autore, siamo obbligati a diffidare, e a prendere atto della permanente polifonia della scrittura consoliana; quel sogno infatti deve essere percepito come nobile, sì, ma impossibile, e persino mistificatore: «Quello non è il pensiero dell’autore, ma del Mandralisca, dell’intellettuale che cerca di scaricarsi la coscienza, di alleviare i sensi di colpa donando il suo patrimonio al popolo di Cefalù, nella speranza che le nuove generazioni “possano scrivere da sé la storia”. Certo, questa soluzione è ingenua, se non demagogica».
Il brano ritrovato
Con i paesani a Milano dove il sole si appanna nella muffa giallognola
Alla stazione Era frastornato da tutta quella confusione in mezzo ai treni tra vagoni, carrelli, passeggeri sotto il tetto di lamiere e vetro
«A rrivammo, arrivammo! urlò uno dentro lo scompartimento . Sveglia, sveglia!». Vito aprì gli occhi, scostò la testa di quello accanto che gli dormiva sopra la spalla, e guardò fuori attraverso il vetro del finestrino appannato dal fiato suo e dei suoi compagni. Vi sfregò sopra il dorso della mano, ma quell’appannatura era anche fuori, ‘na foschia che sfumava una pianura d’alberi scheletriti e case, di capannoni e ciminiere. Sentì ora, tornato fuori dal sonno alla coscienza, tutto il puzzo che ristagnava dentro il treno, di piedi, sigarette e di formaggio. Guardò il pavimento, e vide i suoi piedi e le caviglie gonfie dentro le calze verdi, le scarpe accanto, in mezzo a tutto quello zàccano che avevano combinato col mangiare, di scorze d’uova, d’arance, pezzi di pane, di carte unte d’olio. Una stalla sembrava, e loro cos’erano, lui e i suoi paesani, chiusi per un giorno e passa dentro quella stia, se non bestie, muli portati in una fiera. Il treno, dopo un poco, fece una frenata lunga, con stridore, ebbe un sussulto e si fermò. «Presto, ohu, arrivammo!», fece un altro, alzandosi per tirare giù la valigia. In quel momento scorse la porta, e l’accompagnatore dell’Ufficio Provinciale di Caltanissetta, gridò dentro: «Prepararsi, prepararsi, la prossima è Milano!».Vito guardò fuori, e vide ch’erano davanti a ‘na stazione, con la tettoia e le colonne di ghisa, ferrovieri e passeggeri lì di sotto, e la scritta MILANO LAMBRATE. Tirò giù allora la sua valigia, indossò la giacca, si mise in testa il tasco, s’avvolse il lungo collo d’uccello nella sciarpa.Cercarono di portarsi nel corridoio, ma il corridoio, come il giorno avanti, era affollato, di gente che lì accucciata, a terra o sopra le valigie, aveva viaggiato tutto il tempo.Il treno fischiò più volte e infine ripartì. Dopo breve marcia, fu finalmente alla stazione Centrale di Milano. Cominciò allora tutta la babilonia, tutto il bordello per scendere dal treno, di molti che vociavano, gridavano, scaricavano valigie e pacchi dai finestrini per far presto a prendere la coincidenza.Erano emigranti che si fermavano in Italia, che avevano parenti o conoscenti in Lombardia o Piemonte, a Varese o Vigevano, a Chivasso, Rivalta o Pinerolo. Napolitani, maggiormente, ma anche Lucani e Calabresi.Il funzionario del Lavoro, il signor Staìbbi, passando pel corridoio sopra uomini e valigie, gridò ancora dentro: «Scendete e aspettate tutti sopra il marciapiede. Non vi muovete da lì fino a quando non arrivo io».E così fecero,’na volta che poterono scendere dal treno, e Vito si tenne accosto ai suoi due compagni e paesani, a Turi Trubbia e Santo Brucculèri, ch’erano stati in guerra ed erano pratici di Continente e di cittadi.Era frastornato da tutta quella confusione fra mezzo ai treni, in quell’immensa stazione di Milano con quel tetto di lamiere e vetro come ‘na grande galleria, dentro cui s’ammassava muffa giallognola vagante. Sopra vagoni, carrelli, passeggeri, manifesti di reclame che Vito a stento riusciva a leggere, Calze Si-Si, Lame Bartali, Inverno Pirelli, Brillantina Vegetale Cubana.Giunse Staìbbi e li chiamò. S’unirono ad altri gruppi fermi sul marciapiede e formarono così ‘na compagnia, uno squadrone ben allineato, con Staìbbi accanto a loro che marciava come un capitano. Scesero le scale di quella stazione di marmi e mascheroni, dentro cui passi, voci e più l’altoparlante, rintronavano come dentro una grotta, e furono davanti alla cittade grande di Milano.Vito non sapeva dove guardare, giù per la spianata, pel vialone con binari, fili, alberi, macchine e camion con rimorchio che correvano, tram e filobus, e torno torno casoni altissimi che si perdevano in cima dentro a quella muffa. E sopra, sopra quelle case, in cielo, scorse un globo rossastro e appannato, come fosse dietro un vetro affumicato. Capì che era il sole, un sole che si poteva benissimo mirare senz?essere allucinati, come ‘na luna piena nella notte
Consolo Vincenzo
Pagina 31
(19 gennaio 2015) – Corriere della Sera