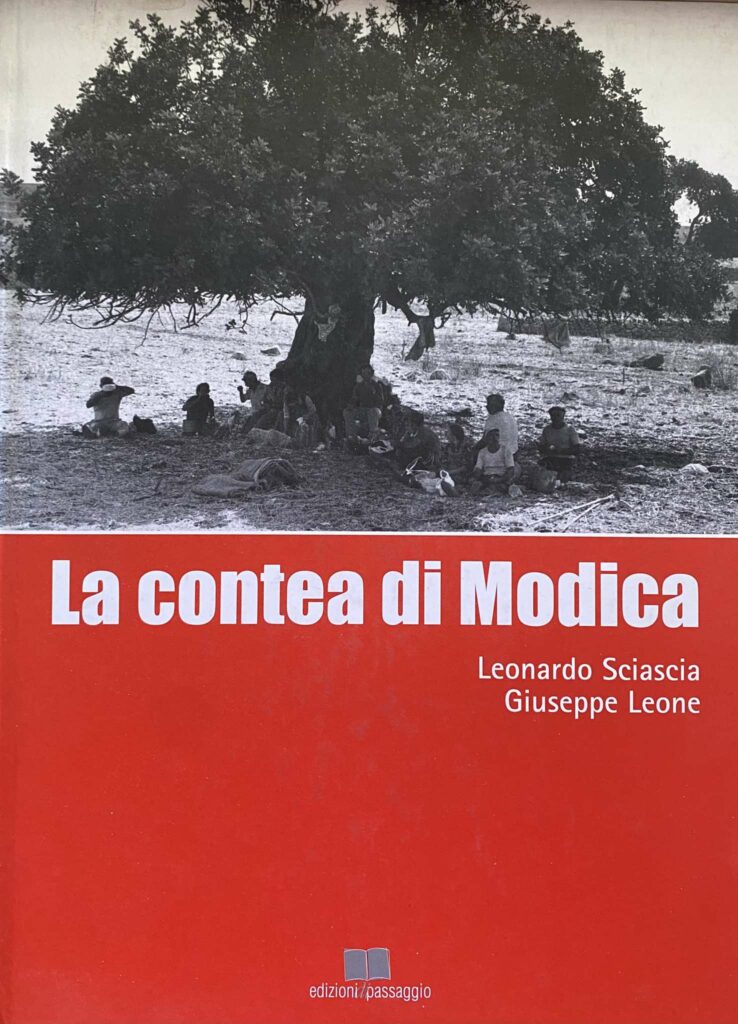«Il volto di un uomo misteriosamente invecchiato di colpo. Questo è l’ultimo ricordo di Consolo che conservo nella memoria». Il fotografo Giuseppe Leone, 85 anni, sta ultimando i preparativi per la mostra che ha dedicato al celebre scrittore di Sant’Agata di Militello. In occasione del decennale della scomparsa dell’autore di Retablo, l’università di Catania rende omaggio alla memoria di Vincenzo Consolo con una serie di eventi. La mostra di Giuseppe Leone si inaugurerà il 24 gennaio, alle ore 17.00, nei locali del Centro universitario teatrale di palazzo Sangiuliano a Catania. Il fotografo ragusano presenterà settanta ritratti, molti dei quali inediti.
Quando ha conosciuto Vincenzo Consolo?
«Nel 1980, ovviamente in contrada Noce, a casa di Leonardo Sciascia a Racalmuto. Dico ovviamente, perché quel luogo raccolto, modesto, lontano da ogni dove, è stato per anni l’ambasciata della cultura siciliana. Tutti gli artisti che operavano in Sicilia finivano per incrociare il loro cammino con la contrada Noce. Una mattina, mentre conversavo placidamente con Sciascia, giunse un’autovettura con a bordo una signora e un uomo. Vidi scendere e avanzare un uomo piccolo di statura. La prima impressione fu quella di avere di fronte un funzionario di una qualche casa editrice. Leonardo ci presentò e, nel corso del pranzo, ho avuto il piacere di scoprire l’eleganza dell’eloquio di Consolo e la sua grande cultura. Rimanemmo tutti incantati dalla sua personalità magnetica».
Come si è evoluto il vostro rapporto di collaborazione?
«Il primo lavoro nacque da un’intuizione proprio di Leonardo Sciascia. Il Sole 24 ore gli aveva conferito l’incarico di curare cinque pubblicazioni dedicate alla Sicilia. Affidò a me e a Vincenzo Consolo il volume sul barocco siciliano. Consolo venne a trovarmi e ci inoltrammo in una lunga perlustrazione tra le città di Ragusa, Noto e Palazzolo Acreide. Si instaurò subito una grande intesa che presto maturò in una grande e lunga amicizia. Era un uomo che amava e apprezzava la bellezza della vita in ogni sua forma. A dispetto dell’immagine stereotipata che si ha di lui, non era affatto un uomo ombroso. Certo, aveva le sue asperità e quando necessario attaccava a testa bassa, anche ferocemente. Ma era un artista autentico. Trovammo subito un’intesa. Lui scrisse “Anarchia equilibrata” uno dei testi più intensi che abbiamo mai accompagnato una mia pubblicazione. Nel corso degli anni, il rapporto di collaborazione si intensificò. Pubblicammo subito dopo un libro dedicato a Cefalù, la città che fa da naturale fondale a tre dei suoi più bei romanzi. Devo a lui la scoperta di angoli misteriosi di quella città. La stessa cosa avvenne quando decidemmo di pubblicare un libro fotografico dedicato ai Nebrodi, i luoghi dove era nato. Anche in quel caso, gli devo la scoperta di feste religiose, spazi sacrali, paesini affascinanti. Seguì poi un libro dedicato a Ortigia e Siracusa, città che lui amava e dove aveva comprato casa. Con lui ho firmato due dei libri più belli della mia produzione. Il primo, edito da Bompiani, ancora una volta dedicato al barocco siciliano, grazie al coinvolgimento del direttore editoriale Mario Andreose. Il secondo, decisamente un autentico capolavoro fu “Sicilia teatro del mondo”, commissionato dalle edizioni Eri, con un suo testo magistrale. Libro che è stato ripubblicato dalla casa editrice “Mimesis” proprio in occasione del decennale della sua scomparsa. Ma in verità, il nostro ultimo lavoro insieme è stata la copertina del suo ultimo libro, pubblicato postumo. La moglie, Caterina Pilenga, mi chiamò dopo la sua scomparsa per scegliere l’immagine che campeggia in copertina di “Al di qua del faro” pubblicato da Mondadori».
Ci racconta cosa c’è di vero della contrapposizione tra Consolo e Bufalino?
«Io li ho fotografati sorridenti e gioviali nella mia foto più celebre, quella che li ritrae in compagnia di Leonardo Sciascia. Ma diciamo la verità, senza infingimenti, tra i due non correva buon sangue. Erano due uomini totalmente diversi, con due modi opposti di intendere il ruolo dello scrittore. Senza partigianerie, bisogna riconoscere che Consolo ha incarnato, coraggiosamente e per tutta la vita, la figura dell’intellettuale contro, non è stato mai cortigiano. Una singolarità che ha duramente pagato, anche con la continua esclusione. Se posso azzardare un confronto, onestamente, bisogna riconoscere che il vero erede della scrittura civile e di impegno di Leonardo Sciascia è stato proprio Vincenzo Consolo. Una figura di artista e intellettuale contro che in Sicilia non abbiamo più. In questi anni è emersa una schiera di narratori che sembra vogliano accontentarsi di intrattenere il pubblico. Licenziano storie ben confezionate, pronte per essere consegnate alla successiva riduzione televisiva. Producono libri gradevoli, materni, avvolgenti. Mai però un impeto di denuncia civile come osava fare frequentemente Consolo dalle pagine dei giornali. Ecco siamo passati da Consolo ai consolatori».
Il suo ultimo ricordo?
«Pochi mesi prima della sua scomparsa a Ragusa Ibla. Era stato invitato dagli studenti della facoltà di Lingue. Fu un incontro misterioso. Appariva stanco. Ricordo l’ultimo scatto, guardava fisso l’obiettivo con un’espressione di totale disillusione. Era il volto di un uomo che, misteriosamente, era invecchiato di colpo».
Concetto Prestifilippo
La repubblica Sabato, 15 gennaio 2022 ediz. Palermo