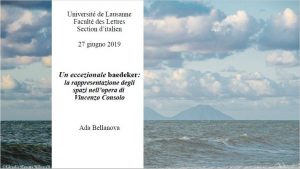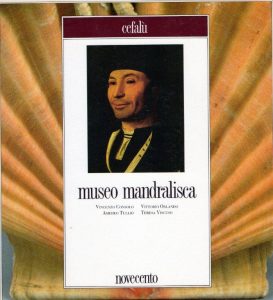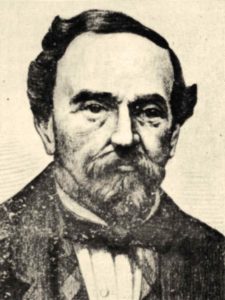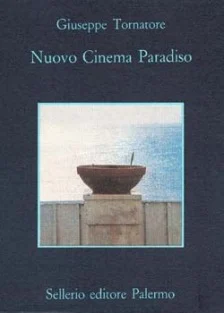Bellanova A.,
Un eccezionale baedeker. La rappresentazione degli spazi nell’opera
di Vincenzo Consolo, Université de Lausanne, 2019.
Il volume propone un’analisi geocentrata della produzione di Vincenzo Consolo, valutando un corpus di testi ampio e vario, che va dalle opere maggiori a articoli e testi sparsi. Osservando come,già a una lettura superficiale, gli spazi rappresentati si annuncino quali straordinari portatori di senso, ha dunque l’obiettivo, mediante uno studio delle modalità di costruzione dell’immagine
letteraria, di accendere l’attenzione non solo sugli spazi di cui l’autore parla direttamente, ma anche sulla nostra relazione con lo spazio. L’introduzione, oltre a portare esempi della ‘geograficità’ dell’opera di Consolo – indicazioni
spaziali, dettagli localizzativi e descrittivi, toponimi –, fa il punto sugli indirizzi di critica geocentrati, ovvero geocritica, geopoetica, geotematica e ecocritica.
La prima parte invece, partendo dalla scelta di un approccio che contamina più linee di indagine,dichiara anche la necessità degli strumenti della critica letteraria tradizionale, soprattutto in relazione alla pagina ‘palinsesto’ e alla polifonia che caratterizzano l’opera di Consolo. Individua dunque e passa in rassegna i modi più ricorrenti nella rappresentazione consoliana: il contributo della letteratura e dell’arte nella definizione degli spazi, il ruolo della Storia, i rimandi alle percezioni sensoriali, il legame tra spazio e lavoro dell’uomo. In particolare l’esplorazione della ‘palincestuosità’ in relazione all’immagine dei luoghi sortisce la valorizzazione di un’ampia serie di rimandi e aspetti, distinguendo tra interventi della letteratura suscitati dall’identità stessa dei realia oggetto di appresentazione (ad esempio il rimando a Scilla e Cariddi e all’Odissea per parlare dello Stretto di Messina, i numerosi riferimenti ai resoconti del Grand Tour, soprattutto in Retablo per la caratterizzazione dell’isola) e accostamenti con luoghi distanti, a loro volta oggetto di rappresentazione letteraria (come i luoghi manzoniani ne Il sorriso dell’ignoto marinaio). Importante l’attenzione riservata al ruolo dei classici greci e latini: non solo l’Odissea, referente d’eccezione ne L’olivo e l’olivastro o ne Lo Spasimo, ma anche l’Eneide in particolare nel finale di Nottetempo, casa per casa, la poesia arcadica, gli storici antichi ecc.Come i modi individuati si intreccino nella produzione dell’immagine dei luoghi più significativi è argomento della seconda parte che, muovendo da Sant’Agata di Militello, si allarga all’analisi
puntuale della rappresentazione di Cefalù, Palermo, Siracusa, grandi siti archeologici della Sicilia occidentale, Milano. Una terza parte invece, sulla base delle suggestioni e degli strumenti forniti dall’ecocritica, riflette sul tema ecologico nell’opera di Consolo, soffermandosi soprattutto sulla rappresentazione degli
spazi siciliani e mediterranei e sull’impegno etico che vi si accompagna. In particolare questa sezione si concentra sull’immagine letteraria degli effetti prodotti dal “miracolo indecente” (i casi dei poli industriali di Milazzo, area siracusana, Gela o la violenza della speculazione edilizia) a cui l’autore contrappone alcune isole di sopravvivenza, ovvero i Nebrodi e gli Iblei. ‘osservazione
dello spazio di carta e quindi la considerazione dei meccanismi rappresentativi impegnati ‒ ricca intertestualità, straniamento, notazioni percettive ‒ accompagnate dalla documentazione a proposito dei referenti geografici reali, consentono di comprendere la critica feroce all’industrializzazione e alla modernità, in quanto fautrici di una grave perdita in termini di biodiversità culturale: soffermandosi sulle rappresentazioni dei luoghi del passato e denunciando l’invadenza delle immagini distorte di quelli del presente, l’autore avvisa della necessità di ricordare, del bisogno di documentare un’identità a rischio. A questo aspetto si aggiunge inoltre l’analisi della descrizione dei danni causati da una natura violenta (eruzioni, terremoti) e, ancora più importante, della rappresentazione dei meccanismi di ricostruzione (lodevoli nel caso della Noto barocca, stranianti nel caso della Nuova Gibellina). Infine una quarta parte, incentrata sulla questione Mediterraneo. Mentre evidenzia la caratterizzazione del mare come spazio di molteplicità e migrazioni (significativo il motivo insistente della morte per acqua, con chiaro riferimento al personaggio eliotiano di Phlebas il Fenicio), lo studio rivela un’importante riflessione autoriale sulle emergenze della contemporaneità.
Dalle Conclusioni, pp. 366-367: «Il lettore [di Consolo] potrà, facendosi strada in uno spazio letterario labirintico, compilare mappe di senso e comprendere i luoghi dell’autore e il nesso esistente tra geografie di carta e geografie
reali? Se sì, forse sarà incoraggiato a scoprire la Sicilia, il Mediterraneo, chissà anche Milano. Ma, fatta salva la specificità dei luoghi chiamati in causa, si troverà inevitabilmente di fronte a una serie di riflessioni di più ampia portata, ciò che accade di fronte alla vera letteratura. Comprenderà che i luoghi non sono uno sfondo, non solo quelli della pagina scritta, ancor meno i loro referenti della
realtà: nessun luogo reale, infatti, è un semplice contenitore, uno scenario su cui sfilare. Mediterà allora sul proprio modo di percepire lo spazio, sulla relazione tra rappresentazione e realtà, sulla memoria e sul cortocircuito che si produce quando, nello scorrere del tempo, Itaca smette di essere Itaca mentre i ricordi restano fedeli al passato. Sarà costretto a pensare a quello che sta succedendo
al paesaggio, a tratti esteticamente splendido, a tratti deturpato, privato della sua identità. Ecco, si interrogherà sull’identità: se i luoghi non sono uno sfondo e smettono di essere quello che sono – fagocitati dall’omologazione, da interessi economici, dalla costruzione di barriere –, inevitabili e funeste sono le conseguenze anche sugli esseri umani. Così strettamente interrelate sono l’identità degli uomini e quella degli spazi. Ecco allora l’eccezionalità di baedeker dell’opera di Consolo: vi si può cogliere l’invito a scoprire alcuni angoli geografici, mediante il rilievo a proposito delle emergenze architettoniche o naturalistiche che attendono il lettore che voglia avventurarsi alla scoperta dello spazio reale, ma vi si troverà anche la presentazione dei deprecabili interventi che deturpano il paesaggio e la vita umana. Già questo basterebbe ad attestarne la particolarità, perché le guide di viaggio, anche quelle letterarie, si soffermano piuttosto sugli aspetti seducenti, evitando invece ciò che produrrebbe un’esperienza quanto meno sgradevole per il lettore-viaggiatore. Mentre, alternando la lente dello stupore e dell’idealizzazione a quella dell’indignazione, attrae e scoraggia,
il testo svela la complessità della nostra relazione con lo spazio, costringendo ad un’esperienza non sempre gratificante, e guida a una maggiore attenzione nei confronti dei luoghi, di tutti i luoghi, in quanto portatori di identità. Alla domanda che la contemporaneità continua a porsi “Come andare avanti adesso che la modernità è sfinita?” (F. Arminio, Geografia commossa dell’Italia interna,
Mondadori, Milano 2013), l’opera risponde affermando il valore di ciò che è rimasto, traccia di passato nel presente: solo nella conservazione, nella cura possiamo sperare di non perdere noi stessi,ma questo non può accadere senza consapevolezza. Consolo dichiara insomma che i luoghi non sono uno sfondo, ma ci appartengono profondamente e rileva l’intimo scambio che esiste sempre tra ambiente e essere umano.Mi piace pensare allora che nei versi di Accordi, con l’ignoto tu, l’autore alluda proprio a questo, ad un’identità sua e di tutti i figli del Mediterraneo, un’identità nata da una relazione vecchia di secoli con la terra, le piante, i muri a secco, con i paesaggi: tolto tutto ciò, cosa saremmo?
Sei nato dal carrubo
e dalla pietra
da madre ebrea
e da padre saraceno.
S’è indurita la tua carne
alle sabbie tempestose
del deserto,
affilate si sono le tue ossa
sui muri a secco
della masseria.
Brillano granatini
sul tuo palmo
per le punture
delle spinesante».