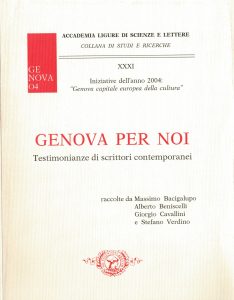LUNARIA LUNEDÌ 5 LUGLIO ORE 21.15 PIAZZA SAN MATTEO GENOVA
di Vincenzo Consolo
con Pietro Montandon tecnico luci e fonica Luca Nasciuti costumi Maria Angela Cerruti scene Giorgio Panni Giacomo Rigalza
regia Daniela Ardini
Lunaria Teatro Genova
Uno dei testi più ricchi di suggestione della drammaturgia contemporanea e insieme un capolavoro della letteratura del Novecento. Questo è Lunaria, favola scritta da Vincenzo Consolo, vincitrice nel 1985 del Premio Pirandello, realizzata in prima nazionale da Daniela Ardini e Giorgio Panni nel 1986 e successivamente realizzata in molte versioni in Italia e all’estero. La storia. In una Palermo di fine Settecento, una mattina il Viceré si sveglia madido e tremante: ha sognato che la Luna è caduta dal cielo e, una volta raggiunto il terreno, si è spenta, lasciando nel cielo un buco nero. La giornata del Viceré prosegue nella sala delle udienze dove arriva Messer Lunato, uno strambo viaggiatore in mongolfiera. A conclusione dell’udienza i ministri srotolano una mappa sulla quale sono indicati i possedimenti vicereali sul quale il Viceré fa scorrere il suo scettro che inspiegabilmente si impunta su una estrema Contrada senza nome. A questo punto la scena si apre sulla Contrada senza nome, dove alcuni villani guardano sorpresi la Luna che sta per sorgere e che appare insolitamente grande e colorata di rosso scarlatto. Dopo un po’ la Luna ritorna ad essere bianca e luminosa, ma comincia a creparsi e falde di luna cominciano a piovere a terra. Un Caporale ubriaco intima ai villani di raccogliere i cocci di Luna e di metterli in una giara, quindi ordina ad uno di loro, Mondo, di andare dal Viceré per riferire l’accaduto e chiedere istruzioni sul da farsi. La scena torna quindi a Palazzo Reale, dove è riunita l’Accademia dei Platoni Redivivi per disputare circa la malattia, lo sfaldamento e la conseguente caduta sub specie pluviae della Luna. Tra loro arriva Mondo che racconta l’accaduto, portando con se una falda di Luna come prova. Posto il coccio in uno scrigno, Mondo viene congedato e ciascuno degli accademici esprime la propria opinione sull’accaduto. Finita la disputa, nell’Accademia deserta dalle ante di un armadio esce il Teatro delle Bizzarrie: geni, fate, folletti, astri, pianeti, allegorie; quindi i personaggi fantastici spariscono a mano a mano, lasciando solo la Luna. Nell’epilogo si torna nuovamente nella Contrada senza nome, dove uomini e donne vestiti di nero seppelliscono i resti della Luna nella fontana e, di li a poco, assistono alla ricomparsa in cielo della Luna che, pero, tra i due corni della falce mostra una macchia nera. Giunge allora il Caporale il quale, deluso di ritrovare la Luna al proprio posto, inveisce contro i villani; viene pero interrotto dal sopraggiungere del Viceré, il quale sale una scala a pioli e incastra nella Luna il pezzo mancante, decretando che da allora in poi la Contrada senza nome si chiamerà “Lunaria”. La lingua e lo stile. Dal punto di vista linguistico Lunaria accosta stili diversi: dal narrativo al dialogico, dal lirico-poetico al linguaggio scientifico o pseudo scientifico degli usato dagli Accademici. Inoltre Lunaria, pur nella sua brevità, si configura come un crogiolo di lingue e dialetti. Sono facilmente riconoscibili l’uso dell’italiano nei suoi diversi registri: da quello accademico-scientifico, a quello visionario, mimetico, letterario, lirico, popolare; l’uso del siciliano, del dialetto gallo-italico, dello spagnolo di Dona Sol e degli inquisitori, del latino nonché di latinismi vari. Il Viceré e ricorre saltuariamente a tutti questi idiomi, compreso il dialetto gallo- romanzo, ossia il sanfratellano, tanto che a Mondo risponde parlando nella sua stessa lingua. Interi brani di poesia e versi “nascosti” compaiono in Lunaria. Lo stile si avvicina alla poesia come mai prima era avvenuto: il testo pullula di anafore, allitterazioni, rime interne. Si assiste cosi a una sorta di tendenza mimetica per cui al tema dell’intima necessita per il mondo della poesia (simboleggiata dalla Luna) corrisponde uno stile che si fa poesia. Il linguaggio si presenta talvolta oracolare, la forma espressiva risulta nervosa, essenziale: la parola si fa incantatrice e trascina il lettore nella “poesia” della vita. La critica letteraria. Cosi Cesare Segre: “Uno dei lavori più mirabili di Consolo, Lunaria (1985). In esso c’è un abbandono pieno all’invenzione. Invenzione tematica e invenzione formale. Il libro non è certo un romanzo, ma appartiene piuttosto a un “genere che non esiste”, a un conato di teatralità divertita fra entremes alla spagnola e teatrino delle marionette. Si sa che molta dell’elaborazione di Consolo è “letteratura sulla letteratura”. Ebbene, in Lunaria la falsariga è costituita da un racconto di Lucio Piccolo, L’esequie della luna(1967), con cui Consolo si pone felicemente in gara, non dimenticando naturalmente Leopardi. Voglio evocare un aneddoto sintomatico. Quando Consolo mi mise tra le mani il meraviglioso libretto, e io mostrai di riconoscerne alcune fonti, invece di chiudersi nell’enigma mi procuro la fotocopia dei testi cui più si era ispirato, lieto che io ripercorressi i suoi itinerari. Mai come in questo caso la letteratura cresce su se stessa, e se ne vanta. Il lettore deve partecipare, come in un gioco, all’invenzione dello scrittore”. La regia. Lunaria è sempre una favola, la favola della luna, che vuole far sognare il pubblico affascinato da sempre dall’astro poetico. Per Consolo la sua caduta “rappresenta l’allontanamento della poesia dal mondo”, poesia che è invece illusione necessaria contro la precarietà della storia e della vita (Scende la luna; e si scolora il mondo, aveva scritto Leopardi ne Il tramonto della Luna).La regia di questo allestimento punta a riportare Lunaria ad alcune delle sue matrici originarie: il cunto e l’opera dei pupi. La tradizione infatti in Consolo si mescola arditamente all’elaborazione poetica e all’artificio letterario. Un solo attore, Pietro Montandon, da voce e gesto a tutti i personaggi, partendo dall’essere in primo luogo il narratore-cuntista dell’opera. Un baule da teatro, un leggio e un praticabile palcoscenico su cui si “interpretano” i vari personaggi e la storia, citano insieme narrazione e teatro. Consolo stesso asseriva che “le didascalie, pur conservando in qualche modo la loro funzione di indicazione mimetica e ambientale, vogliono assumere anche dignità di testo, sono insomma didascalie che ambiscono ad essere recitate da un eventuale personaggio (il Narratore)”. Montandon prende per mano il suo pubblico e lo guida con ironia, ma anche con mano ferma e mente fredda nei meandri non sempre facili dell’opera di Consolo, facendolo assistere ad un gioco letterario, ma anche teatrale, che diverte con l’astrusità dei vari linguaggi, il paradosso di alcune situazioni (l’Accademia dei Platoni Redivivi che cercano di dare “spiegazione” alla caduta della luna), l’ironia di alcuni personaggi (Messer Lunato, Cerusici, Dona Sol, e altri), da emozioni con il linguaggio poetico del Viceré e la versificazione dei Villani e delle Villanelle, ultimi baluardi di un mondo dove rimane ancora la poesia. La scenografia disegna in modo astratto la corte del Viceré di Sicilia e la contrada senza nome. Il gioco musicale è arricchito da effetti sonori sulle tante voci di Montandon. L’attore PIETRO MONTANDON per lunghi anni interprete nella compagnia Mummenshanz, con Lunaria Teatro straordinario interprete di Maruzza Musumeci di Andrea Camilleri e de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello.
www.lunariateatro.it info@lunariateatro.it 
Tag: Genova
Il ponte sul canale di Sicilia
Gostanza, di nobile e ricca famiglia di Lipari, ama, riamata, il povero pescatore Martuccio. Per l’impossibile amore, il giovane abbandona l’isola, si fa corsaro per il Mediterraneo. Gostanza, avuta notizia che Martuccio era morto, disperata, sale su una barca per andare alla ventura e lasciarsi morire, ma il vento la sospinge e la fa approdare sulla costa di Barberia, nei pressi di Susa. Sulla spiaggia la fanciulla s’imbatte in una donna che parla latino e che è al servizio di pescatori cristiani. Questo è l’argomento della Novella Seconda della Giornata Quinta del Decamerone di Boccaccio. In cui, al di là della storia d’amore che poi felicemente si concluderà, ci colpisce il fatto che pescatori cristiani, trapanesi, tranquilli soggiornassero e pescassero nelle acque della musulmana Tunisia, di Susa, oggi Sousse. E ci conferma nella consapevolezza che ancora nel medioevo quel canale, quel breve braccio di mare tra la Sicilia e le coste africane, libiche tunisine algerine, non fosse ancora frontiera, barriera fra due mondi, ma una via di comunicazione e di scambio, che quelle acque anzi venissero allora percorse solo in un senso, dai lavoratori di Sicilia, di Calabria, di Sardegna, che volendo sfuggire alla fame cercavano fortuna in quelle ricche terre degli “infedeli”. Provetti “tonnaroti”, lavoratori delle tonnare, pescatori di alici e di sarde, di spugne e di coralli, da Trapani, da Pantelleria, da Lampedusa, s’avventuravano sulle loro esili barche per quel canale, e insieme contadini, pastori, murifabbri, minatori da ogni parte del nostro Meridione.
S’ interruppe questa comunicazione, questa provvidenziale emigrazione, con la dominazione turca sulle coste africane e quella spagnola in Sicilia, con l’insorgere delle guerre corsare. Carlo V si spinse fino in Tunisia per combattere e umiliare il nemico. La battaglia di Lepanto significò lo scontro più alto e simbolico fra le due fedi, i due imperi, quello cristiano e quello ottomano. Vittoria di Lepanto che però non riuscì a domare, a scemare le incursioni barbaresche nelle nostre contrade. E corsari si fecero anche ammiragli e principi cristiani, incursioni praticarono sulle coste africane, razziando uomini e cose, riducendo in schiavitù. Ai mercati di schiavi di Algeri o di Tunisi corrispondevano quelli cristiani di Livorno o di Genova. Scrive Braudel in Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità degli universi concentrazionari'”.
Prigionia in Algeri patirà Miguel de Cervantes, che già aveva pagato il suo tributo alla guerra nella battaglia di Lepanto con l’amputazione di una mano. Lascerà memoria di quella sua triste esperienza nel Don Chisciotte e in altre sue opere.
Si hanno notizie ancora dettagliate, precise, di quel mondo di allora sulle coste africane nel secentesco libro del frate Diego de Haedo Topographia e Historia Generai de Argel. Dal quale si apprende, fra l’altro, che una nuova, massiccia emigrazione avveniva allora di italiani nel mondo ottomano. Erano, costoro, emigranti della fede, cristiani vale a dire rinnegati, che si facevano musulmani, “turcos deprofesión”, che divenivano capi corsari, razziatori nelle loro stesse terre d’origine, mercanti di schiavi.
Finisce questa pagina tremenda, questa lunga guerra corsara fra le due sponde del Mediterraneo, nel 1830, con la conquista di Algeri da parte dei francesi. Ma si apre anche in quella data, nel Maghreb, la piaga del colonialismo.
Riprende l’emigrazione italiana nel Maghreb nei primi anni dell’Ottocento. È un’emigrazione questa volta intellettuale e borghese, di fuoriusciti politici, di professionisti di imprenditori. Liberali, giacobini e carbonari, si rifugiano in Algeria e in Tunisia. Scrive Pietro Colletta nella sua Storia del reame di Napoli: “Erano quelli regni barbari i soli in questa età civile che dessero cortese rifugio ai fuoriusciti”.
E ancora negli anni ’30, ’40 e fino all’Unità, reduci da congiure, moti rivoluzionari repressi, qui si rifugiano. Dopo i falliti moti di Genova, in Tunisia approda una prima volta, nel 1836, Garibaldi, sotto il falso nome di Giuseppe Pane. Nel 49 ancora si fa esule a Tunisi.
A Tunisi s’era stabilita da tempo una nutrita colonia di imprenditori, commercianti, banchieri ebrei provenienti dalla Toscana, da Livorno soprattutto, primo loro rifugio dopo la cacciata del 1492 dalla Spagna. Conviveva, la nostra comunità, insieme alla ricca borghesia europea, un misto di venti nazioni, che s’era stanziata a Tunisi. Accanto alla borghesia, v’era poi tutto un proletariato italiano di lavoratori stagionali, pescatori di Palermo, di Tra-pani, di Lampedusa che soggiornavano per buona parte dell’anno sulle coste maghrebine. Ma la grossa ondata migratoria di bracciantato italiano in Tunisia avvenne sul finire dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, con la crisi economica che colpì le nostre regioni meridionali.
Si stabilirono questi emigranti sfuggiti alla miseria nei porti della Goletta, di Biserta, di Susa, di Monastir, di Mahdia, nelle campagne di Kelibia e di Capo Bon, nelle regioni minerarie di Sfax e di Gafsa. Nel 1880 nel Consolato italiano erano registrate 12.000 presenze italiane, ma molti sfuggivano alla registrazione, e fra questi, naturalmente, gli irregolari, renitenti alla leva o colpevoli di reati.
Nel 1911, le statistiche davano una presenza italiana di 90.000 unità. Alla Goletta, a Tunisi, in varie altre città dell’interno, v’erano popolosi quartieri che erano chiamati “Piccola Sicilia” o “Piccola Calabria”. Si aprono scuole, istituti religiosi, orfanotrofi, ospedali italiani. La preponderante presenza italiana in Tunisia, sia a livello popolare che imprenditoriale (i collegamenti marittimi nel Canale di Sicilia erano di compagnie italiane, italiana, dei Rubattino, era la compagnia che costruiva la ferrovia Tunisi-Algeria), fece sì che la Francia si attivasse con la sua sperimentata diplomazia e con la sua solida imprenditoria, per togliere all’Italia questa supremazia. Tutto questo portò al Trattato del Bardo del 1881 e qualche anno dopo alla Convenzione della Marsa, che stabilirono il protettorato francese sulla Tunisia.
“L’Italia non è abbastanza ricca per pagarsi il lusso di un’Algeria” aveva dichiarato il ministro degli Esteri Visconti Ventosa dell’allora governo di Benedetto Cairoli. La Francia, con il protettorato, iniziò la sua politica di espansione economica e culturale in Tunisia, aprendo scuole gratuite, diffondendo la lingua francese, concedendo, su richiesta, agli stranieri residenti la cittadinanza francese. Anche sotto il protettorato, l’immigrazione di lavoratori italiani in Tunisia continuò sempre più massiccia. Ci furono vari episodi di naufragi, di perdite di vite umane nell’attraversamento del Canale su mezzi di fortuna. La reggenza francese, di fronte a quel continuo affluire di diseredati, ricorse ai rimpatri. Nei primi cinque anni del Novecento ben 13.000 furono rimpatriati. Quelli già inseriti, al di là o al di sopra di ogni nazionalismo, erano organizzati in sindacati, società operaie, società di mutuo soccorso, patronati degli emigranti. Nel 1914 giunge a Tunisi Andrea Costa, in quel momento vicepresidente della Camera. Visita le regioni dove vivevano le comunità italiane. Così dice ai rappresentanti dei lavoratori: “Ho percorso la Tunisia da un capo all’altro; sono stato fra i minatori del Sud e fra gli sterratori delle strade nascenti, e ne ho ricavato il convincimento che i nostri governanti si disonorano nella propria viltà, abbandonandovi pecorinamente alla vostra sorte”.
I riflessi che la guerra di Libia, la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale e il dopoguerra poi hanno avuto sulla comunità italiana di Tunisia è storia molto complessa per poterla qui riassumere. Rimandiamo perciò al libro di Nullo Pasotti, Italiani e Italia in Tunisia, libro dal quale abbiamo attinto per stendere questa memoria.
La fine degli anni ’60 segna la data fatidica dell’inversione di rotta della corrente migratoria nel Canale di Sicilia, dell’inizio di una storia parallela, speculare a quella nostra. A partire dal 1968 sono tunisini, algerini, marocchini che approdano sulle nostre coste. Approdano soprattutto in Sicilia, a Trapani, si stanziano a Mazara del Vallo, il porto dove erano approdati i loro antenati musulmani per la conquista della Sicilia.
A Mazara, una comunità di 5.000 tunisini riempie quei vuoti, nella pesca, nell’edilizia, nell’agricoltura, che l’emigrazione interna italiana aveva lasciato. Questa prima emigrazione maghrebina nel nostro paese coincide con lo scoppio di quella che fu chiamata la quarta guerra punica, la ” guerra” del pesce, il contrasto vale a dire fra gli armatori siciliani e le autorità libiche e tunisine. In questi con-fitti, quelli che ne pagavano le conseguenze erano gli immigrati arabi, i quali, oltre ad essere sfruttati, venivano di tempo in tempo perseguitati. Odiosi episodi sono avvenuti, in quella parte meridionale della Sicilia, di “caccia al tunisino”.
“. Su questa prima emarginazione maghrebina in Sicilia, un giovane sociologo di Mazara, Antonio Cusumano, ha scritto un libro documentato, preciso, Il ritorno infelice, pubblicato nel 1976 da Sellerio.
Sono passati trent’anni dall’inizio di questo fenomeno migratorio. Da allora, nessuna previsione, nessuna progettazione, nessun accordo fra governi, fino a giungere all’emigrazione massiccia, inarrestabile di disperati che fuggono dalla fame e dalle guerre, emigrazione che si è cercato di arginare con improvvisati metodi duri, drastici, violando anche quelli che sono i diritti fondamentali dell’uomo.
Di fronte a episodi di contenzione di questi disperati in gabbie infuocate, di ribellioni, fughe, scontri con le forze dell’ordine, scioperi della fame e gesti di autolesionismo, si rimane esterrefatti. Ci tornano allora in mente le parole che Braudel riferiva a un’epoca passata: “In tutto il Mediterraneo l’uomo è cacciato, rinchiuso, venduto, torturato…”.
Mediterraneo
Viaggiatori e Migranti
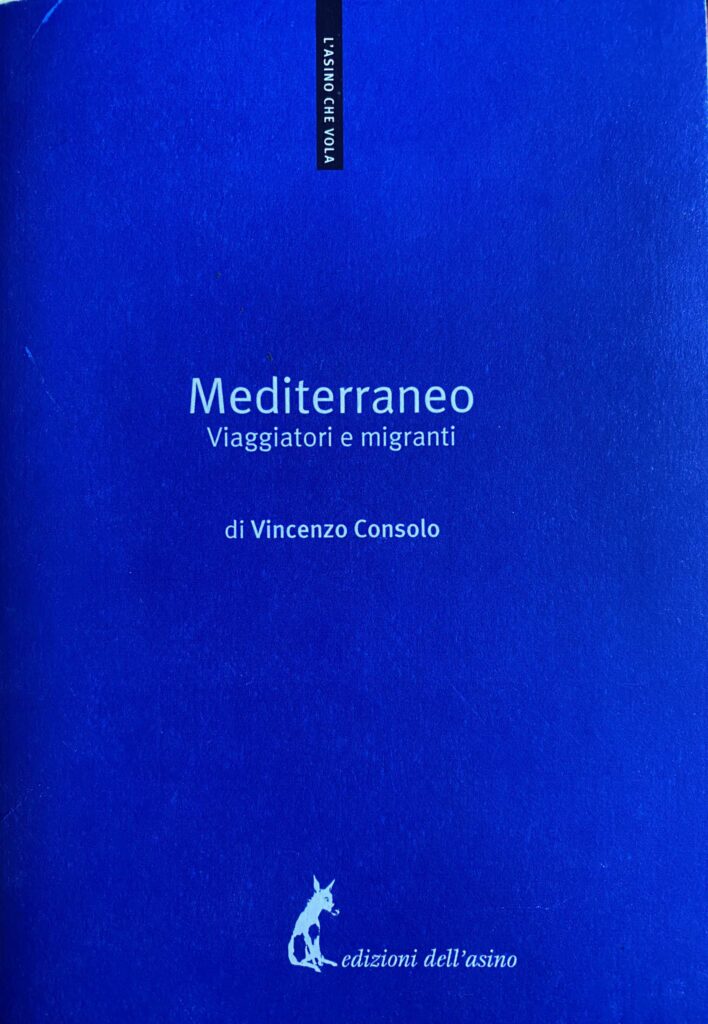
CARAVAGGIO IN SICILIA
Vincenzo Consolo
Caravaggio e ancora Caravaggio. Mostre e mostre si sono allestite e continuano ad allestirsi del pittore, da quelle ormai storiche del 1938 a Napoli, del 1951, ’53, ’58 e ’73 nel Palazzo Reale di Milano, al Caravaggio in Sicilia di Palazzo Bellomo di Siracusa nel 1984, alla palermitana del 2001 dal titolo Sulle orme di Caravaggio, a quella romana dello stesso anno Caravaggio e i Giustiniani, al Caravaggio – due capolavori a confronto, del 2003, ancora a Palazzo Bellomo, al Caravaggio, ultimo tempo: 1606-1610 del 2004 a Napoli, e la discussa e discutibile mostra di Caravaggio a Milano del 2005 e, infine, la bella mostra di Amsterdam di quest’anno in cui sono messi a confronto due grandi: Caravaggio e Rembrandt. Ci accorgiamo così che è lui,Caravaggio,il più attuale dei pittori, lui a dirci che questo nostro è ancora un tempo secentesco, controriformistico, un tempo di rischi e di incertezze, di pesti e di violenze. Che la vera realtà è unaluce che squarcia la cortina buia del mondo, che grazia e santità dimorano nell’umanità più sofferente, emarginata.
Ho enumerato varie mostre di Caravaggio, ma ne ho omessa una, a dir poco singolare. E’ una mostra itinerante del 2001, ideata dal collezionista ed esperto d’arte Giuseppe Salzano e patrocinata dall’Arma dei Carabinieri, nella persona del generale Roberto Conforti, comandante del Nucleo per la tutela del patrimonio artistico. Quella mostra permetteva la visione dopo trent’anni d’invisibilità, di un capolavoro di Caravaggio, la Natività dell’Oratorio di San Lorenzo di Palermo. Viaggiava, quella grande tela di quasi tre metri per due, insieme ad altri nove capolavori, insieme a un Antonello da Messina, a un Carracci, un Renoir…Ma erano quadri quelli, ahinoi, in “figura di funzione”, erano perfette copie di opere trafugate, eseguite da provetti copisti, i quali sono così salvati, sosteneva il Solzano, dall’occulto mondo dei falsari, veniva loro data dignità mettendoli al servizio della legalità.
E così ha fatto un sovrintendente alle antichità siciliano, con i tombaroli promovendoli a custodi di siti archeologici (ma non sappiamo se questa operazione abbia eliminato o almeno attenuato lo scavo clandestino).
La mostra delle copie, dicevamo, in cui spiccava la copia della Natività del San Lorenzo di Palermo, uno dei quattro capolavori lasciati in Sicilia da Caravaggio.
Nel novembre del 1996, le cronache riportavano la deposizione al processo,- chiamato maxiprocesso per il numero di imputati, – alla Corte d’Assise di Palermo del mafioso pentito Marino Mannoia, il quale, dopo la sequela di omicidi, confessava anche il furto, nel 1969, all’esordio della sua attività delinquenziale, della Natività dell’Oratorio di San Lorenzo.
Scriveva un cronista di Palermo:”L’incidente, che segnò la sua carriera di ladro, fu una maldestra operazione con una tela di Caravaggio, la Natività custodita, si fa per dire, in una chiesa del centro di Palermo. Marino Mannoia era stato incaricato di rubare il quadro da un anonimo committente, danaroso esperto d’arte. Il Mannoia si presentò all’appuntamento con il dipinto sottobraccio, arrotolato alla meglio. Srotolata l’opera, il mandante del furto scoppiò in lacrime: la ruvida mano del Mannoia l’aveva danneggiata irreparabilmente. Il Caravaggio non fu mai ritrovato, né il pentito ha saputo o voluto dire che fine abbia fatto”. Già, che fine ha fatto la Natività di Palermo ? E chi era quell’esperto danaroso che ha commissionato il furto,così sensibile da sciogliersi in lacrime di fronte al quadro distrutto?
Questa sarà stata di certo un’indagine infruttuosa per gli inquirenti, ma potrebbe essere un affascinante argomento per uno scrittore di romanzi polizieschi.
Ma torniamo al Caravaggio, al Caravaggio in Sicilia. I suoi primi contatti, la sue prime frequentazioni siciliane avvengono a Roma, nella città eterna, dove il giovane pittore era giunto da Milano nel 1592. Aveva 21 anni. Lavora subito, il Merisi, nella bottega di Lorenzo Carli, detto Lorenzo Siciliano, bottega che si trova nei pressi dell’ospedale dei poveri la Consolazione, al limite di Campo Vaccino. L’allievo del milanese Peterzano, dipinge per Lorenzo Siciliano “teste per un grosso l’una et ne faceva tre al giorno” racconta il biografo Giulio Mancini. Là, nella bottega di Lorenzo Siciliano, lavora anche il giovane siracusano Mario Minniti, che diverrà suo modello per la Fuga in Egitto, per il Suonatore di liuto e per altri quadri di quel periodo. Il Minniti passerà poi con Caravaggio nella bottega di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino. In quella bottega Caravaggio dipinge splendide nature morte, fra cui la famosa Canestra di frutta che Federico Borromeo si porterà a Milano.
Siamo del 1594, in gennaio, mese in cui s’interrompe bruscamente la collaborazione di Caravaggio col Cavalier d’Arpino. La causa è poco chiara, ma ci dice il Mancini”Fra tanto un calcio di cavallo gonfia la gamba né ne un chirurgo acciò non fusse visto et da un bolttegaro siciliano amico alla Consolazione…”Da queste annotazioni manoscritte del Mancini si deduce che è il “siciliano bottegaio”, cioè Lorenzo Carli, ad accompagnare l’infortunato Caravaggio all’ospedale della Consolazione, in cui è priore il siciliano Giovanni Butera. Illo Butera commissiona al Caravaggio delle opere, fra cui il Suonatore di liuto. Quadro che Gioacchino Di Marzo ricorda a Catania nella raccolta di Rosario Scuderi Buonaccorsi. E pure di quel periodo è il Bacchino malato (supposto autoritratto). Dopo la malattia, Caravaggio ha i primi rapporti col cardinale Francesco Maria de Monte, quindi è accolto nel palazzo dei Giustiniani e dei Mattei.
Sono di questo periodo la Santa Caterina, i Bari, la Buona ventura, Giovane con un cesto di frutta, Giuditta e Oloferne, San Giovannino, Maddalena, San Giovanni Battista. E sono ancora di questo periodo le grandi commissioni per la cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi (San Matteo e l’angelo, Vocazione di San Matteo, Martirio di San Matteo) e per la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo (Martirio di San Pietro e Conversione di San Paolo); e ancora: Madonna dei pellegrini in Sant’Agostino, la Deposizione, la Madonna dei Palafrenieri.
Ho citato sopra il palazzo Mattei della romana via Castani. Un palazzo, quello, che, parafrasando Calvino chiamerei “dei destini incrociati”. Palazzo dove è stato ospite Leopardi e Stendhal. Ma, prima di questi due scrittori, vi era stato Caravaggio. Nel 1601, il cardinale Gerolamo Mattei e i fratelli Ciriaco e Asdrubale ospitano nel loro palazzo Caravaggio, il quale per loro dipinge la Cena di Emmaus e la Cattura di Cristo.
Ma nel 1606 è la rottura, la fine di questa stagione di benessere e di fama. E’ il 28 maggio di quell’anno infatti l’episodio della Pallacorda in Campo Marzio, l’uccisione di Ranuccio Tomassoni da parte di Caravaggio, il quale, a sua volta ferito, è soccorso nel palazzo Colonna da Costanza Sforza Colonna, e quindi, inseguito da “bando capitale”, viene fatto rifugiare tra Palestrina, Zagarolo e Paliano, feudi dei Colonna.
Nel 1607, guarito, si trasferisce a Napoli. Qui dipinge pale d’altare per confraternite e privati (Le opere di misericordia). Nel luglio del 1607 è nell’isola di Malta, nella capitale La Valletta. Qui dipinge, oltre il San Gerolamo e il Ritratto del cavaliere Alof de Wignacourt, la grande tela della Decollazione di San Giovanni Battista. E firma per la prima volta nel sangue questo suo quadro (Motto cavalleresco ”e sanguine virtutem traho”- vedi riferimento di Verga alla famiglia Trao del Mastro-don Gesualdo).
E ancora là, a Malta, per il ferimento in uno scontro con un cavaliere di giustizia, Caravaggio è messo in prigione. Fugge dalla prigione e il 6 ottobre 1608 approda a Siracusa. Fugge di notte dal Forte Sant’ Angelo, il Caravaggio, nel bel mezzo di parate, caroselli e clamori per la celebrazione dell’anniversario della battaglia di Lepanto. Riesce a fuggire da quel forte per l’aiuto dell’ammiraglio della flotta maltese don Fabrizio Sforza, figlio di Francesco e di Costanza Colonna, marchesi di Caravaggio, al cui servizio era stato il “maestro di case” Fermo Merisi, padre di Michelangelo. E’ sempre sotto la protezione degli Sforza e dei Colonna, Michelangelo Merisi, nel borgo Caravaggio, a Milano, a Roma. E’ sempre protetto da principi e cardinali, malgrado il suo porsi nella marginalità, tra ribelli, bande di violenti, prostitute e ragazzi di vita, il suo porsi contro i gesuiti e gli ortodossi pittori controriformati.
Il 6 ottobre del 1608 Caravaggio approda dunque nel Porto Grande di Ortigia. Aveva viaggiato, confuso in un manipolo di marinai fiamminghi, sulla speronara del raìs Leonardo Greco. Così ci racconta Pino Di Silvestro nel suo romanzo, che poggia su una precisa documentazione La fuga, la sosta. Caravaggio a Siracusa (Rizzoli, 2002). A Siracusa è accolto, Michelangelo Merisi, nel convento dei frati Minori Cappuccini sopra l’Acradina. Dove è curato e amorevolmente assistito dai frati e quindi affidato, come chiede lo Sforza nella lettera raccomandatizia al guardiano padre Raffaele da Malta, a don Vincenzo Mirabella, musicista e storico di Siracusa. Ed è il Mirabella, il “cavaliere squisito, dall’intelletto concettoso”, come lo definisce Caravaggio in una lettera al cardinale Del Monte, è don Vincenzo a fare da méntore al lombardo nel viaggio, per i vari strati o gironi, nella profondità storica di Siracusa. Viaggio nella contemporanea città controriformista, d’inquisizione e ispanica militarizzazione, di ricchezza e miseria, di religiosità popolare e di superstizione, fino alla Siracusa della solarità dei templi, dei teatri e degli anfiteatri greci e romani, alla Siracusa delle latomie, fra cui quelle profonde e brulicanti del Paradiso, in cui penosamente lavorano i cordari e in cui è l’Orecchio di Dionisio, nome dato dallo stesso Caravaggio a quel cunicolo scavato nel tufo. E scrive don Vincenzo Mirabella nel suo Dichiarazione della pianta delle antiche Siracuse…:”…avendo io condotto a vedere questa carcere quel pittore singolare dei nostri tempi Michel Angelo da Caravaggio, egli, commiserando la fortezza di quella, mosso da quel suo ingegno unico imitatore delle cose di natura, disse: Non vedete voi come il tiranno per voler fare un vaso che per far sentir le cose servisse,non volle altronde pigliare il modello che da quello che la natura per lo medesimo effetto fabbricò. Onde si fece questa carcere a somiglianza d’un orecchio”. Ed è ancora il Mirabella a convincere il Senato a commissionare al pittore il grande quadro del Seppellimento di Santa Lucia per la chiesa extra moenia di Santa Lucia al Sepolcro, nell’antica zona dell’Acradina. E’ lui, il Mirabella, che difende il pittore dall’accusa di blasfemia, da parte dell’autorità religiosa, del grasso arcivescovo Saladino, per l’eterodossia iconografica del quadro (la costante eterodossia caravaggesca). In questo quadro, come nella Decollazione del Battista di Malta, è l’ambiente, lo spazio che prevale. I personaggi, clero e fedeli, sono relegati, quasi schiacciati contro l’alta parete di tufo, nella penombra d’una latomia. E il gonfio corpo della fanciulla, di Lucia, con la testa mozza, è steso a terra e s’intravede tra le quinte in primo piano dei corpacci ignudi di due interratori. I quali sono forse in Caravaggio la memoria lontana di due monatti che sotterrano i corpi del padre Fermo e del nonno Bernardino, morti per la peste in Lombardia del 1576. E nella fanciulla là stesa a terra è forse la memoria della madre Lucia. Il corpo della martire è chiuso tra la piccola schiera degli astanti in pena e i corpacci in primo piano, come dicevamo, di due “manigoldi giganteschi” (Longhi), di due becchini. Sembra questa una scena dell’Amleto, quella del cimitero in cui Ofelia sta per essere seppellita. Ma i due interratori siracusani, facchini di porto o cordari, non possono avere la sofisticata dialettica del becchino shakespeariano. Qui piuttosto lo sguardo è condotto, attraverso le quinte dei due interratori in primo piano, al corpo a terra della santa e quindi, nel centro, al diacono dal drappo rosso e dalla mestissima espressione. E sembra, quello del giovane, il dolore di Caravaggio per la madre morta Lucia. Chissà se Manzoni, ricercando sul cardinal Federico Borromeo, possessore del famoso Canestro di frutta di Caravaggio, non si sia imbattuto in Fermo e Lucia, genitori del pittore, e che con questi due nomi “caravaggeschi” abbia voluto intitolare la prima stesura del 1823 del romanzo che diverrà poi I promessi sposi.
Scriveva Roberto Longhi nel suo Caravaggio del 1952 che, fra i quadri del pittore in Sicilia, la Sepoltura di Santa Lucia era il più guasto. Questo perché per secoli quel capolavoro era rimasto nell’antica chiesa presso il mare, aggredito dalle intemperie e soprattutto dalla salsedine.Pesantemente ritoccato nell’800 con pretese conservative, il quadro è stato poi più volte restaurato e la penultima volta, prima dell’attuale restauro a Palermo, nel 1979 nell’Istituto Centrale del Restauro. E il direttore dell’Istituto, Michele Cordaro, un allievo di Brandi, ci dà ragguaglio di questo restauro nel catalogo della mostra del 1984 a Palazzo Bellomo, Caravaggio in Sicilia.
E scriveva Cesare Brandi il 10 aprile 1977 sul Corriere della sera: “I fedeli caravaggeschi, che oramai sono legione, chiedevano a gran voce che il capolavoro restituito a una nuova vita non fittizia, non torni a marcire nel luogo che l’aveva quasi cancellato.” Ma i frati del convento di Santa Lucia al Sepolcro continuano a reclamare la restituzione del dipinto. Ma i fedeli caravaggeschi, oltre a temere, come Brandi, l’ulteriore deterioramento del quadro, temono altresì che un esperto danaroso e “sensibile” possa commissionare a un picciotto, a un qualche Marino Mannoiaq, il furto del quadro in quella chiesa accessibile come l’oratorio di San Lorenzo di Palermo. Ma scrivevano nel 1996, nel fascicolo Il seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio, Giuseppe Voza e Gioachino Barbera:”…la collocazione del Seppellimento nella sua ubicazione originaria è fuori discussione, malgrado il parere contrario di Cesare Brandi e la presa di posizione di intellettuali come Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, i quali, in occasione della mostra del 1984, volevano farsi promotori di un appello rivolto alle autorità religiose e politiche regionali chiedendone la musealizzazione”. Non sappiamo delle autorità religiose, del cardinale di Palermo o del vescovo di Siracusa cosa oggi risponderebbero a quell’appello. Ma sappiamo con certezza della risposta delle autorità politiche regionali, autorità rappresentate in Sicilia da Totò Cuffaro e dai suoi assessori alla Regione.
Ma torniamo al Seppellimento, a questo capolavoro che ha ispirato alcune mie pagine del libro L’olivo e l’olivastro (Milano, 1994)
(Lettura del brano)
A Siracusa sembra che Caravaggio abbia rincontrato il suo antico compagno di bottega a Roma Mario Minniti. Il Minniti si muoveva allora, nella sua attività di pittore, per canali francescani. Il generale dell’ordine era in quel tempo il padre Geronimo Errante, oriundo di Polizzi Generosa, e per questi canali francescani sembra si muova anche Caravaggio per la Sicilia. Nel dicembre del 1608 lascia Siracusa e va a Messina, dove rimane per otto mesi, fino all’agosto del 1609. Qui ha la prima commissione dal ricco mercante genovese Giovan Battista de’ Lazzari, la magnifica Resurrezione di Lazzaro per la chiesa dei Crociferi. Dal Senato ha la committenza de L’Adorazione dei pastori per la chiesa extra muros di Santa Maria della Concezione dei padri Cappuccini. Opere, queste due, oggi nel Museo di Messina, accanto al Polittico di San Gregorio di Antonello.Dipinge ancora per il conte Adonnino la Visione di San Gerolamo, oggi a Worcester, USA. La Salomé con la testa del Battista, oggi nel palazzo Reale di Madrid, L’Annunciazione, oggi a Nancy. E quindi su committenza del barone Nicolao Di Giacomo le Storie della passione di Cristo. E scrive il di Giacomo: “Nota delli quatri fatti fare da me Nicolao di Giacomo: Ho dato la commissione al signor Michiel’Angelo Morigi da Caravaggio di farmi le seguenti quatri: Quattro storie della passione di Gesù Cristo da farli a capriccio del pittore delli quali ne finì uno che rappresenta Christo colla croce in spalla; La Vergine Addolorata e dui manigoldi, uno sona la tromba, riuscì veramente una cosa bellissima, opera pagata onze 46. L’altri tre s’obbligò il pittore portarmeli nel mese di agosto con pagarli quanto si converrà da questo pittore che ha il cervello stravolto”. Di queste committenze del di Giacomo sembra sia superstite l’Ecce Homo del Palazzo Rosso di Genova. “Ha il cervello stravolto” dice il di Giacomo di Caravaggio. Sì, siamo in questa estrema stagione siciliana di Caravaggio, di fronte a un uomo dal “cervello stravolto”, siamo di fronte a un uomo mai sereno, in un accentuato momento di dolore e di furore, come se quel nobile genio, avvertisse i passi terribili della conclusione della sua vicenda umana.
E un momento di abbandono, di tenerezza lo ha a Palermo, con la Natività o Adorazione dei pastori con i Santi Francesco e Lorenzo, che è stato nell’Oratorio di San Lorenzo fino al 1969. Scrive Roberto Longhi: “L’altro “Presepio” dell’Oratorio di San Lorenzo a Palermo, dipinto dal Caravaggio nel 1609 già sulla via del ritorno, è il meglio conservato (e anche il meglio pulito) dei suoi dipinti siciliani”. E dico qui tra parentesi che è poco credibile la versione di Marino Mannoia del disfacimento della tela appena srotolata. Ma continuo col Longhi : “Ritornando sui suoi passi pare che l’artista quasi voglia rievocare le vecchie Sacre Conversazioni lombarde. Ma tutte nuove sono le scoperte nei semitoni ombrosi dei due animali del presepio, nel San Giuseppe in giubbetto verde elettrico e nella grande ritrosa della lustra canizie; nell’angelo, di nuovo “bresciano”, ma che spiomba dall’alto come un giglio scavezzato dal proprio peso; nel bambino miserando, abbandonato a terra…” Dopo questo umile, sereno idillio, s’imbarcherà per Napoli (pensiamo dalla Cala, su una speronara). E da lì a Napoli, ancora guai: sulla porta della locanda del Consiglio sarà raggiunto dai sicari del suo rivale maltese e massacrato di botte. Da Napoli manderà a Roma il suo ultimo messaggio: Il Davide con la testa del Golia (che si crede il suo autoritratto), oggi alla Galleria Borghese. E infine il suo accostarsi a Roma, le sue febbri, la sua morte sulla spiaggia di Porto Ercole. Così finisce quest’uomo geniale, questa lama di luce vivida che ci ha rivelato la verità del mondo.
Milano, 10 aprile 2006
Genova, Fenicia d’occidente Vincenzo Consolo
*
Chimica industriale! – esclamarono tutti insieme. Tutti, vale a dire mio padre e i tre zii, soci della ditta commerciale fondata da mio nonno: compravano, loro, l’olio che si produceva nella zona, nei frantoi dei proprietari terrieri dei paesi dei Nèbrodi, riempivano cisterne e cisterne di vagoni ferroviari e spedivano agli industriali Costa di Genova, i quali imbottigliavano quell’olio insieme ad altro ligure toscano o pugliese, con l’etichetta Olio Dante.
Chimica industriale! – esclamarono in coro durante la riunione per stabilire a quale facoltà universitaria mi sarei dovuto iscrivere, io, figlio e nipote tanto studioso che aveva appena conseguito brillantemente la licenza liceale. La chimica industriale, poiché loro avevano progettato di promuoversi da commercianti ad industriali, costruire là in paese una raffineria e imbottigliare l’olio come i Costa di Genova. E quindi io, divenuto chimico, avrei dovuto dirigere l’impresa. Il più deciso, nell’imporre a me quegli studi, era lo zio Giovanni, il maggiore esperto, tra i suoi fratelli, di olio. Gli portavano, i venditori, i campioni in bottigliette. Stappava, ne versava in bocca un sorso, suggeva, schioccava la lingua, ingoiava e subito sentenziava: due gradi, tre gradi, quattro gradi… E quindi passava alla prova scientifica, con l’olio dentro l’ampolla mischiato a una soluzione che lo colorava di viola, agitato e riversato in un cilindretto centimetrato che rivelava il grado di acidità. L’analisi papillare dello zio e quella tecnica raramente discordavano.
Io, al centro di quel consesso nell’ufficio della ditta, messo di fronte a quelle due terribili parole, chimica industriale, dissi timidamente, arrossendo: “Lettere classiche voglio studiare…” Ci fu un silenzio di meraviglia, d’imbarazzo. Che venne rotto dallo zio Giovanni.
– Ma… Ma quelli sono studi per femmine! – disse.
– Si scivolò quindi verso ingegneria, architettura, medicina, farmacia, economia… Ed io sempre, cocciuto: “No, no, lettere voglio fare!”.
Mio padre allora, impietosito, mi venne incontro, avanzò un compromesso.
– Senti, – disse – una via di mezzo è giurisprudenza… Quella ti apre molte strade, puoi decidere poi, da qui a quattro anni, quello che vuoi fare: avvocato, giudice, notaio, amministratore d’azienda…
– E si guardarono, i quattro, ammiccando: un chimico sicuramente pensarono, avrebbero potuto assumerlo, mentre io, da leguleio, avrei amministrato e diretto la loro industria.
– Accettai. Tanto, pensai, avrei continuato a studiare lettere per conto mio, di nascosto, avrei continuato a leggere romanzi e poesia.
– E dove vuoi andare a studiare, a Palermo, a Messina…. – chiese mio padre.
– No, no, – intervenne uno zio – sempre su quei treni, avanti e indietro… Finisce che si sbanda, che non studia. Al Nord, lo mandiamo al Nord! A te dove piacerebbe andare, a Bologna, a Milano, a Torino?…
– A Milano – risposi deciso. A Milano avevo sempre pensato, dov’erano stati Verga e Capuana, dov’erano allora Vittorini e Quasimodo, dov’era Montale.
E fu così che m’installai nella capitale lombarda, in una casa di piazza Sant’Ambrogio attaccata al portico della basilica, quella “fuori mano” del Giusti, e divenni pensionante, l’unico della signorina Colombo, un’anziana (così sembrava a me allora diciottenne) che vestiva sempre di nero, parlava solo in dialetto e lamentava che le sue giovani nipoti, due gemelle, erano scappate di casa per andare a Nomadelfia, a lavorare nella città dei ragazzi di don Zeno Saltini. Nella piazza, in un grande edificio, era ubicato il coi, Centro Orientamento Immigrati. Là giungevano i tram provenienti dalla stazione Centrale e scaricavano masse di emigranti meridionali che, dopo le visite mediche e disbrigo di pratiche burocratiche, sarebbero andati a lavorare nelle miniere belghe o nelle fabbriche di Svizzera e Francia. Si determinavano, in quegli anni del Dopoguerra, i destini di molti italiani. Era quella la storia che allora più m’interessava, che cercavo di capire con la lettura di libri sulla questione meridionale, i libri di Gramsci, Dorso, Salvemini o Carlo Levi. Letture appassionate fatte insieme al doveroso e penoso studio del diritto privato, filosofia del diritto o economia politica.
Fu uno dei primi mesi del mio soggiorno milanese, che un giorno, di primo mattino, spuntò alla pensione della signorina Colombo lo zio Giovanni, l’esperto di olio, il più grande e più autorevole dei quattro fratelli.
Mi disse: – Io vado a Genova dai Costa. Tu vieni con me.
Giunti alla stazione Principe, c’incamminammo verso piazza Dante, dov’era il grattacielo con gli uffici dei Costa. Lo zio andava con passo veloce, malgrado il peso del valigione, io rallentavo per guardare la gente, mi fermavo per ammirare le facciate dei magnifici palazzi di quella fitta città verticale, delle chiese, mi beavo nel ritrovare la mia luce marina, lasciati i grigiori e le nebbie di Milano.
– Svelto, svelto, cammina. Ho l’appuntamento alle quattro precise. Salimmo, dentro il veloce ascensore, fino al diciassettesimo piano del grattacielo. E fummo introdotti nell’ufficio di uno dei Costa, Giacomo credo si chiamasse. Un signore dall’aria severa, ma dal tratto gentile, ascoltava con attenzione il parlare impacciato e affannoso dello zio Giovanni; io guardavo, al di là di una grande vetrata, il mare in fondo solcato da navi, guardavo la conca del porto con i denti dei suoi ponti, delle sue banchine, sognavo di salire su una di quelle navi e di andare, andare…
Lo zio mi scosse dall’ineducata distrazione, dall’incanto, stringendomi forte a un braccio. Io volsi subito lo sguardo verso quel benevolo signore dietro la scrivania.
– Questo mio nipote studia a Milano. Giurisprudenza – disse con un sospiro – Ma noi speriamo che dopo la laurea verrà giù a lavorare nell’azienda.
E quel signore sorrise, dubbioso sicuramente, nel vedere la mia aria svagata, sognante, di un mio avvenire di azienda, di praticità, di affari.
Dormimmo a Genova, lo zio ed io, e l’indomani, separandoci, egli sarebbe tornato in Sicilia ed io a Milano. Ma dopo che il treno si mosse e lo zio scomparve alla vista, decisi di restare a Genova, solo, libero, ancora per qualche giorno, di conoscere quella città. E la percorsi nei suoi carruggi, via Prè, via del Campo, piazza Banchi, la Ripa, strade strette e affollate, piene di vita, movimento. Mi riportavano, quelle strade, a Palermo, alla Vucciria, al Capo, ai Lattarini, a Ballarò.
Fu quella per me una giornata di gioia, di scoperte. E una giornata infine anche di tristezza, in cui vidi, verso sera, partire una grande nave piena di emigranti, di gente che avrebbe raggiunto gli Stati Uniti o l’Argentina. I parenti, sul molo, salutavano e piangevano.
Comprai in un negozio sotto i portici di Ripa, un souvenir, una sfera di vetro con dentro una nave, una nave che spariva dietro la neve, se appena la sfera si scuoteva. Rimase da allora e ancora oggi quella sfera come ricordo della nave di emigranti che partiva. Ricordo anche di Genova e del suo destino marinaro, di Colombo e Andrea Doria, di tutti i naviganti del Mediterraneo ed oltre le Colonne d’Ercole. Di questa città forte e tenace, di piccola terra e di infinito spazio marino, di ogni inimmaginabile avventura e di conquista prodigiosa. Da quella piccola conca del suo porto nacque la storia della grande Genova, della repubblica della fantasia e del coraggio. Marina, Genova, come Marsiglia Napoli o Istanbul. Ummelumà, la madre del mondo, chiamarono i Turchi Costantinopoli. È madre Istanbul, è madre Napoli “de Italia gloria y aun del mundo lustre”, come la elogia Cervantes; madre Istanbul e così Barcellona e Algeri. Ma Genova è padre, padri sono i suoi navigatori avventurosi, i suoi sagaci imprenditori, simili a quelli che partivano dagli angusti porti fenici, Biblo o Sidone, e scoprivano l’ignoto occidente mediterraneo.
[i] In Genova per noi, Testimonianze di scrittori contemporanei raccolte da Massimo Bacigalupo, Alberto Beniscelli, Giorgio Cavallini e Stefano Verdino, Genova: Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2004, pp. 36-40. Stesso testo, col titolo: Ho fatto l’emigrante per cagioni di cuore, «Stilos», supplemento di «La Sicilia», 20 luglio 2004.
Pubblicato anche su “La mia isola è Las Vegas”
Arnoldo Mondadori Editore, aprile 2012