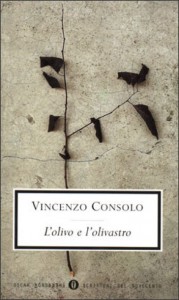Osservatorio Bibliografico della Letteratura
Italiana Otto – novecentesca
Anno II, numero 6 -7
Settembre 2012
Rosalba Galvagno
«Sicilia, Sicilia mia, mia patria e mia matria»
Variazioni consoliane sulla Sicilia, e altro
Il racconto intitolato Il disastro storico può fare da cornice, in ragione della sua bruciante attualità, alla ricognizione del bel libro postumo di Vincenzo Consolo, ricchissimo di memorie, ironico e spassoso per alcuni tratti, implacabile e beffardo per altri, che ci ha ispirato alcune riflessioni.1
Il «disastro» è quello che spazza via la storia, in quanto catapulta l’uomo in uno stato naturale di nudità, smarrimento e animalità, sottraendolo appunto alla storia tanto faticosamente costruita.
Nelle calamità naturali, terremoti, alluvioni, eruzioni, oltre alle vittime umane e ai danni materiali, uno dei disastri maggiori è quello forse immediatamente inavvertibile ma che subito si produce e fa sentire i suoi effetti per generazioni future. È questo il disastro storico, il disastro della storia. Quando un terremoto, per esempio, squassa e polverizza città o tessuti umani fortemente storicizzati, che nei secoli avevano cioè sviluppato una loro particolare storia, una loro cultura, una loro civiltà, oltre a distruggere vite e documenti e beni, ributta indietro i superstiti dal piano della storia al piano della natura, dell’esistenza: in pochi secondi essi fanno balzi indietro di secoli.
Passati quei pochi secondi, in cui è preda di un terrore cosmico, l’uomo, spogliato di ogni segno storico, nudo e smarrito, scatena il suo istinto, la sua animalità.2
A dimostrazione di questa disumanizzazione Consolo cita due fatti emblematici, agghiaccianti, prodottisi all’indomani del terremoto nella valle del Belice del gennaio 1968. Uno riguardava il disinteresse e l’empietà quasi dei superstiti nei confronti dei loro morti e l’altro il costituirsi di branchi di cani famelici, predatori di sangue e putridume. C’è da meravigliarsi allora, s’interroga lo scrittore, se in questi momenti sbucano fuori i cosiddetti sciacalli, che scavano tra le macerie? Come ad esempio a San Francisco dopo il terremoto e l’incendio del 1906, dove i predoni venivano sommariamente impiccati, o dopo il terremoto di Messina e Reggio Calabria, dove i predoni venivano passati per le armi. Ma vi è un’altra forma di sciacallaggio, quello a freddo, razionale, che nasce al di fuori del teatro del disastro, non più degli sciacalli caldi o freddi e in un secondo tempo, come lo sciacallaggio del politico, del giornalista, dell’industriale, del generale. Ma non c’è fine a questa deriva, poiché c’è il terzo momento, non più degli sciacalli caldi o freddi, è quello delle iene, degli speculatori e profittatori della ricostruzione, insomma dei ladri e arraffatori di tangenti: «Quelli che, fingendo di ricostruire, mostruosamente continuano a
1 V. CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, Mondadori, Milano 2012. Il volume raccoglie 52 racconti, così preferiva chiamarli l’autore, scritti tra il 1957 e il 2011, di cui alcuni inediti. «Questo libro», si legge alla fine del conciso e accurato risvolto di copertina, «l’ultimo che ha personalmente concepito e voluto, restituisce intatta la sua lezione ai lettori di oggi e di domani».
2 Ivi, p. 64. Già in «La Stampa», 5 febbraio 1978.
distruggere, ancora a spogliare quelle popolazioni colpite dal disastro della loro cultura, della loro storia, a relegarle per sempre ai margini dell’esistenza».3
Nel lungo racconto, Un giorno come gli altri, composto di alcuni gustosissimi episodi4, Consolo, tra le varie peripezie e meditazioni da cui è occupato nel corso di una sua giornata milanese, si sofferma anche, mentre è intento ad un lavoro sul poeta Lucio Piccolo, su un suo ricorrente dilemma, sulla differenza cioè tra lo scrivere e il narrare, tra la mera operazione di scrittura impoetica estranea alla memoria che è lo scrivere, e quell’operazione poetica di scrittura invece che attinge quasi sempre alla memoria, e che è il narrare.5 Il narratore viene addirittura assimilato a un grande peccatore, che merita una pena come quella dantesca degli indovini, dei maghi, degli stregoni. E tra gli indovini menzionati e condannati da Dante Consolo cita, non a caso, Tiresia, colui al quale toccò come punizione di essere trasformato in donna («Ed anche “di maschio in femmina” diviene, come Tiresia, il narratore»), cioè, come ogni vero scrittore, di femminizzarsi e di avere così accesso ad un sapere (e un godimento) altro, proibito e peccaminoso:
Riprendo a lavorare a un articolo per un rotocalco sul poeta Lucio Piccolo. Mi accorgo che l’articolo mi è diventato racconto, che più che parlare di Piccolo, dei suoi Canti barocchi, in termini razionali, critici, parlo di me, della mia adolescenza in Sicilia, di mio nonno, del mio paese: mi sono lasciato prendere la mano dall’onda piacevole del ricordo, della memoria. “Invecchiamo” mi dico malinconicamente, “invecchiamo”. Ma, a voler essere giusti, che io sia invecchiato è un fatto che non c’entra molto col mio scrivere. È che il narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, a quella lenta sedimentazione su cui germina la memoria, è sempre un’operazione vecchia arretrata regressiva. Diverso è lo scrivere, lo scrivere, per esempio, questa cronaca di una giornata della mia vita il 15 maggio 1979: mera operazione di scrittura, impoetica, estranea alla memoria, che è madre della poesia, come si dice. E allora è questo il dilemma, se bisogna scrivere o narrare. Con lo scrivere si può forse cambiare il mondo, con il narrare non si può, perché il narrare è rappresentare il mondo, cioè ricrearne un altro su carta. Grande peccato, che merita una pena, come quella dantesca degli indovini, dei maghi, degli stregoni:
Come ‘l viso mi scese in lor più basso
Mirabilmente apparve esser travolto
Ciascun tra ‘l mento e ‘l principio del casso [petto];
ché da le reni era tornato ‘l volto,
ed in dietro venir li convenìa,
perché’l veder dinanzi era lor tolto.
Inf., XX, 10-15
Il tipo particolare di punizione che il nostro scrittore paventa per il narratore è dunque quella dantesca dell’immagine torta,6 un’immagine paradossale (il contrappasso
3 Ivi, p. 65. Una fine analisi del tema del disastro nei romanzi di Consolo ha fatto D. FERRARIS, La syntaxe narrative de Consolo: pour une orientation du désastre, in Vincenzo Consolo éthique et écriture, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 2007, pp. 91-105.
4 Ivi, pp. 87-97, già in «Il Messaggero», 17 luglio 1980, quindi in Enzo Siciliano (a cura di), Racconti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 1983 (I Meridiani), pp. 1430-42, poi nel vol. III della nuova edizione dell’antologia (Mondadori, Milano 2001, pp. 392-403).
5 Ivi, p. 92.
6 «com’io potea tener lo viso asciutto /quando la nostra imagine di presso / vidi sì torta, che ‘l pianto delli occhi/le natiche bagnava per lo fesso» (Inf., XX, 21-24, corsivi nostri). È opportuno rammentare che gli indovini sono collocati nella IV bolgia dell’VIII cerchio (delle Malebolge) dell’Inferno, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida.
dantesco) che fa degli indovini degli esseri condannati ad avere «‘l viso travolto», girato all’indietro:
Però il narratore dalla testa stravolta e procedente a ritroso, continua Consolo, da quel mago che è, può fare dei salti mortali, volare e cadere più avanti dello scrittore, anticiparlo… Questo salto mortale si chiama metafora. Quando sono da solo mi sfogo a mangiare le cose più salate e piccanti. Evito finalmente la minestrina, la paillardina e la frutta cotta. Mangio bottarga, sàusa miffa (“interiora di tonno salate”), olive con aglio e origano, peperoncini, caciocavallo, cubbàita (“torrone di zucchero e sesamo”)… Poi, nel pomeriggio, non c’è acqua che basti a togliermi la sete.7
Si sarà avvertito il passaggio apparentemente incongruo, un vero e proprio salto mortale, che lo scrittore opera nel brano appena letto, dove sta descrivendo la curiosa condizione del narratore-mago dalla testa stravolta ma dotato della capacità di volare rispetto allo scrittore di cronaca, ed ecco che, ex abrupto, nel racconto stesso si produce in re una dislocazione metaforica attraverso il salto semantico dall’incontinenza della parola fraudolenta degli indovini all’incontinenza della gola, per la quale i golosi sono flagellati dalla pioggia e straziati da Cerbero nel III cerchio dell’Inferno (canto VI).
Ma c’è di più. Questo frammento emblematico, come la citazione dantesca mostra, del cosiddetto procedimento palinsestico della scrittura di Consolo, esibisce anche una dimensione metatestuale, metaforica anch’essa, che coincide con l’esatta definizione retorica della figura della metafora riportata negli Elementi di retorica di Heinrich Lausberg, al paragrafo intitolato Tropi di dislocazione o di salto,8 di cui l’esempio consoliano costituisce una sorprendente e ineccepibile realizzazione (narratore-mago stravolto=goloso-assetato).
Su una sua precisa definizione di racconto, «racconto ibrido» per l’esattezza, e quindi sull’essenza della narrazione, Consolo ritornerà a distanza di dieci anni da Un giorno come gli altri (1980), nel bellissimo testo intitolato Memorie (1990), 9 dove, sintomaticamente, viene ripreso il tema del disastro e dei suoi corollari: l’opposizione fondamentale tra esistenza e storia, che si duplica in quella di oriente e occidente, natura e cultura e altre ancora:
Io sono d’una terra, la Sicilia (ma quante altre terre nel modo somigliarono, somigliano o somiglieranno alla Sicilia!) dove, oltre l’esistenza, anche la storia è stata da sempre devastata da tremende eruzioni di vulcani, immani terremoti, dove il figlio dell’uomo e il figlio della storia non hanno conosciuto altro che macerie di pietra, squallidi, desolanti ammassi di detriti attorno a zolfare morte. “In una manciata di polvere vi mostrerò la paura” dice Eliot.
Dicevo sopra di una mia ideale geografia letteraria siciliana, dicevo di un oriente e di un occidente. Ora, questo paese10 che mi ha dato i natali ha la ventura, il destino di trovarsi ai confini, alla confluenza di due
7 CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 92-93.
8 «I tropi di dislocazione (o salto) […] presentano rispettivamente tra il significato proprio della parola sostituita (“guerriero” […]) e il significato proprio della parola sostituita tropicamente (“leone” […]) o un rapporto di somiglianza con il modello (metafora “guerriero/leone” […]) o un rapporto di contrari (ironia: “coraggioso/vigliacco” […])», H. LAUSBERG, Elementi di retorica, Il Mulino, Bologna 1969, p. 127.
9« Il Valdemone», I, 1, febbraio 1990, pp. 7-9, in CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 134-138.
10 Si tratta di Sant’Agata di Militello più su evocata: «Fin dal primo sguardo sul mondo, fin dai primi bagliori dei ricordi – e sono scene isolate, fotogrammi luminosi incorniciati dal nero dell’immemorabile – si è impresso, Sant’Agata, dentro di me per sempre», ivi, p. 135.
regni, dove si perdono, sfumano, si ritraggono in una sommessa risacca le onde lunghe della natura e della storia. Lasciando, su questa remota spiaggia dell’incontro, segni indistinguibili e confusi. Remota spiaggia, limen, finisterre, ma anche luogo sgombro, vergine, terra da cui rinascere, ricominciare, porto da cui salpare per inediti viaggi. Nato qui ho preso coscienza, a poco a poco, d’aver avuto il privilegio di trovarmi legato all’ago di una bilancia i cui piatti possono restare in statico equilibrio o pendere, da una parte o dall’altra, il peso della natura o della cultura. E non è questo poi l’essenza della narrazione? Non è il narrare, come dicevo, quell’incontro miracoloso, di ragione e passione, di logica e di magico, di prosa e poesia? Non è quest’ibrido sublime, questa chimera affascinante?
Mi sono ispirato, narrando, a questo mio paese, mi sono allontanato da lui per narrare altre storie, di altri paesi, di altre forme. Però sempre, in quel poco che ho scritto, ho fatalmente portato con me i segni incancellabili di questo luogo.11
Di questo racconto pieno di aneddoti curiosi come quello divertentissimo della festa dall’editore dove è ospite Saul Bellow, importa soprattutto ricordare la pagina dedicata alla descrizione dello studio di Consolo nella sua casa di Milano. Una pagina autobiografica, come tantissime di questo bel libro, che ci invita ad entrare nel luogo più intimo dello scrittore, un luogo magico direi, alla cui immagine saranno in parte ispirate le indimenticabili descrizioni di studi e biblioteche presenti nei grandi romanzi.12
Il mio studio è una stanza con tre pareti rivestite di libri, anche nello spazio tra i due balconi vi sono libri (dal balcone, giù in fondo alla strada, oltre i due castelli daziarii della Porta, vedo il famedio del Cimitero Monumentale, dove al centro, sotto la cupola, è il sarcofago di Manzoni) e libri si accumulano per terra e sul bàule di canne che fa da tavolino davanti al divano-letto. Le librerie sono degli scaffali aperti di legno grezzo, comprati alla Rinascente, e la polvere si accumula sui libri, penetra tra le pagine, li invecchia precocemente. Sui ripiani degli scaffali, davanti ai libri, appoggio oggetti: temperini, uccelli di legno, teste di pupi siciliani, pezzetti di ossidiana, di lava, conchiglie… Sull’unico spazio vuoto, alle spalle del mio tavolo di lavoro, ho appeso i “miei quadri”: un disegno di un San Gerolamo nella caverna, nudo, seduto a terra, intento a leggere un libro appoggiato sulle ginocchia, un gran leone dietro le spalle e un teschio vicino ai piedi; un libro aperto, con le parole cancellate con tratti di china e una sola in parte risparmiata, raccon, incollato e chiuso in una teca di plexiglas, opera di un artista concettuale; due planimetrie secentesche, di Palermo e di Messina, strappate dal libro di Cluverio Siciliae antiquae descriptio. Questo dei libri antichi strappati, dei libri bruciati, dei libri perduti è un fatto che mi ossessiona. Ossessiona al punto che sogno sempre di trovare libri antichi, rotoli, cere, tavolette incise.13 Una volta mi sono calato dentro un’antica biblioteca sotterranea, forse romana, dove, ben allineati nelle loro scansie al muro, erano centinaia e centina di rotoli: cercavo di prenderli, di svolgerli, e quelli si dissolvevano come cenere. Un mio amico psicanalista, al quale ho raccontato questo mio sogno ricorrente, mi ha spiegato che si tratta di un sogno archetipico.
Mah… Fatto è che mi appassionano i libri sui libri, sulle biblioteche, sui bibliofili. E il libro che leggo e rileggo, come un libro d’avventure, è Cacciatore di libri sepolti. Come in questo tardo pomeriggio di
11 Ivi, pp. 137-138.
12 V. CONSOLO, Il sorriso dell’ignoto marinaio, a cura di Giovanni Tesio, Einaudi Scuola, Torino 1995 (1976), pp. 3940, ID., Nottetempo casa per casa, Mondadori, Milano 1994 (1992), pp. 30-32.
13 Sull’aneddoto del sogno, parzialmente variato, Consolo tornerà successivamente «C’è questo ipogeo, c’è la visione dell’ipogeo continuamente e credo che sia dovuto al fatto che io cerco di partire sempre dalle radici più profonde e quindi anche le immagini di questi luoghi sotterranei, di queste caverne, siano un po’ il corrispettivo della profondità della lingua e della profondità della storia. Andare fino alle radici per poi risalire verso le zone della comunicazione, le zone della società. Sono luoghi che mi hanno sempre affascinato. È indecente raccontare i propri sogni, però devo dire che un mio sogno ricorrente è un sogno archeologico, un sogno che poi ho scoperto faceva anche il padre della psicanalisi assieme a Freud che era Jung. Nel sogno io mi calo in dei sotterranei dove scopro degli oggetti antichi, vasi o rotoli di pergamena, che mi danno molta gioia. Ho interpellato un mio amico psicanalista e mi ha detto che è un sogno positivo e quindi evidentemente questo sub-conscio emerge nella mia scrittura. La mia ricerca linguistica anche in quel senso, io cerco le parole che vengono da lontananze storiche, di lingue antiche, greco, latino, arabo e quindi c’è questo bisogno di ripartire dalla profondità. In tutti i miei libri c’è l’evocazione di questi luoghi sotterranei.» Cfr. Intervista con Vincenzo Consolo a cura di Dora Marraffa e Renato Corpaci, http://www.italialibri.net/, 2003, corsivi nostri.
maggio, qui nella mia stanza al terzo piano di una vecchia casa di Milano. A poco a poco non sento più il rumore delle macchine che sfrecciano sui Bastioni, mi allontano, viaggio per l’Asia minore e l’Egitto, sprofondo in antichità oscure, indecifrate.14
Una variante e perfino un equivalente di questi libri antichi sono per Consolo le antichità archeologiche, come quelle cui si accenna in un altro affascinante racconto, Le vele apparivano a Mozia,15 che descrive un viaggio in Sicilia fatto nell’aprile del 1984 con Fabrizio Clerici, Guttuso e altri per un fastoso matrimonio celebrato a Palermo e che li porterà a rifare l’antico itinerario per le stazioni di Segesta, Erice, Selinunte, Cusa, Agrigento e Mozia. Ma Consolo aveva già visitato quest’isola fenicia più di vent’anni prima, ed è di questa prima scoperta dell’isola e della Sicilia fino ad allora solo immaginata oltre la barriera dei Nebrodi, che egli vuole narrare:
Lieve di anni e ancor più lieve di cognizioni, ch’erano quelle miserelle del liceo che m’aveva appena licenziato, da un paesino sulla costa del Tirreno partii alla scoperta della mia Sicilia. Che immaginavo, al di là della barriera dei Nebrodi, da Siracusa a Gela, ad Agrigento, come una vastissima teoria di monumenti, un’unica sequenza di vestigia antiche, una distesa infinita, silente e metafisica, di pietre, di rovine. E subito s’infranse, è naturale, quella mia Arcadia contro il brulichìo, il turbinìo di vita e movimento delle contrade che traversavo.16
Questo racconto rivela l’occasione da cui era scaturita la composizione di Retablo,17 il romanzo ambientato nella Sicilia del Settecento che ha come protagonista un intellettuale e artista milanese di nome Fabrizio Clerici, che compie un viaggio sentimentale e artistico nell’isola seguendo appunto il tradizionale itinerario del Grand Tour. Viceversa, in Le vele apparivano a Mozia, pubblicato un anno dopo il romanzo, nel 1988, Consolo integra l’episodio, mirabilmente descritto in Retablo, della statua del cosiddetto ragazzo di Mozia, fornendo una spiegazione dell’affondamento, nel romanzo, della statua stessa, del sacrificio di questo idolo pur così venerato dal personaggio Clerici e dall’autore Consolo:
Per questa mia memoria della prima visita nell’intatta Mozia, in un mio racconto, Retablo, volli portar via dall’isola la stupenda statua in tunica trasparente del cosiddetto ragazzo di Mozia, quella che nell’ultimo approdo all’isola, nell’84, potei vedere, insieme al pittore Clerici, nel piccolo Museo, chiusa e protetta in una nicchia di tubi neri. Portarla via e farla naufragare, sparire in fondo al mare: come contrappasso o compenso18 di alla morte per acqua del giovane fenicio Phlebas – A current under sea/Picked his bones in whispers – eliotiana creazione; perché quella statua di marmo mi sembrò una discrepanza, un’assurdità, una macchia bianca nel tessuto rosso della fenicia Mozia; mi sembrò una levigatezza in contrasto alla rugosità delle arenarie dei Fenici; uno squarcio, una pericolosa falla estetica nel concreto, prammatico fasciame dei mercanti venuti dal Levante. Come l’arte, infine, un lusso, una mollezza nel duro, aspro commercio quotidiano della vita.19
14 La mia isola è Las Vegas, cit., pp. 95-96.
15 «Il Gambero rosso», supplemento de «il manifesto», 5-6 giugno 1988, ivi, pp. 124-127.
16 Ivi, p. 125.
17 V. CONSOLO, Retablo, con 5 disegni di Fabrizio Clerici, Sellerio, Palermo 1987.
18 «Una corrente sottomarina / gli spolpò le ossa in bisbigli»: T.S. ELIOT, La terra desolata, Rizzoli, Introduzione, traduzione e note di Alessandro Serpieri, Milano 1982, p. 113.
19 CONSOLO, La mia isola è Las Vegas, cit., p. 127.
A distanza, ancora una volta di circa dieci anni, Consolo tornerà con qualche variazione e più distesamente, per ben due pagine, sulla sua amata Mozia nel racconto La grande vacanza orientale-occidentale,20 una struggente rimemorazione dei luoghi delle origini, tra oriente e occidente della sua linea di confine, secondo la sua geografia ideale, che si conclude con una meravigliosa tappa a Selinunte:
L’ultimo approdo della lontana mia estate di privilegio – privilegio archeologico come quello ironicamente invocato da Stendhal, a me concesso da un padre benevolo – fu fra le rovine di Selinunte. Dal mattino al tramonto vagai per la collina dei templi, in mezzo a un mare di rovine, capitelli, frontoni, rocchi di colonne distesi, come quelli giganteschi del tempio di Zeus che nascondevano sotto l’ammasso antri, cunicoli […].
Mi risvegliai l’indomani nel letto della locanda. Per la finestra, la prima scena che vidi del mondo fu la collina dell’Acropoli coi templi già illuminati dal sole.21
Un altro luogo di elezione per Consolo, mirabilmente descritto nei suoi romanzi e in molti racconti, è ovviamente Cefalù, come si legge in La corona e le armi,22 che comincia a guisa di un vero e proprio racconto autobiografico, scritto in terza persona, che narra il viaggio a Palermo, sul camion del padre commerciante, di un bambino, che scopre così per la prima volta l’abbagliante Cefalù, e che prosegue con un commento finale, in prima persona, proprio su questa inaugurale scoperta della meravigliosa cittadina normanna:
[…] ad un tratto, uscendo da un vicolo, si trovarono davanti ad una piazza, una immensa piazza assolata, piena di palme snelle, diritte, alte, con palazzi ai lati e in faccia, sopra una scalinata, una grande chiesa, con due alte e possenti torri, tutta d’oro e arrossata dal sole. Il sole che avvampava pure la grande rocca incombente dietro la chiesa. Egli restò abbagliato, immobile a contemplare quello spettacolo che lo intimoriva e lo affascinava. Mai aveva visto tanta bellezza, tanta imponenza, tanto sfolgorio…
[…]
Questo abbozzo di racconto, che potrebbe intitolarsi Il viaggio, vuole dire della prima “visione” del duomo di Cefalù di uno come me, per esempio, cresciuto in una zona ibrida, in una zona di confluenza tra la provincia di Messina e di Palermo. Zona senza incidenza e caratteri particolari, dove la storia, remotissima e labile, ha finito per essere sopraffatta dalla natura. Zona quindi di esistenza, di eventologia quotidiana. Il passaggio al di là di quel confine che amministrativamente separa le due province e che si localizza nel paese di Finale, è stato come un oltrepassare le colonne d’Ercole, l’impressione incancellabile di progredire in una dimensione nuova, sconosciuta, la dimensione delle tracce storiche, dei segni chiari della storia; di entrare cioè in una zona di realtà narrabile. E Cefalù è stata un approdo, un luogo d’elezione e di passione.23
È recente l’eco dei festeggiamenti per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, non possono quindi non essere menzionati almeno due testi che trattano lo scottante tema dell’Unità d’Italia dalla prospettiva consoliana, una prospettiva per nulla celebrativa e tuttavia profondamente, autenticamente italiana e unitaria, come quella dei maggiori scrittori siciliani di cui Consolo naturalmente ha fatto tesoro. Si sbaglia a ritenere che Verga, De Roberto, Pirandello, Sciascia e perfino Tomasi di Lampedusa abbiano avuto una posizione ambigua nei confronti dell’unificazione della nazione o addirittura una posizione antiunitaria. Semplicemente, e indipendentemente dal loro
20 «Alias», supplemento de «il manifesto»,7 agosto 1999, ivi, pp. 166-167.
21 Ivi, pp. 167-169.
22 «Giornale di Sicilia», 17 marzo 1981, ivi, pp. 98-102.
23 Ivi, p. 101.
credo politico, hanno letto e analizzato da scrittori (non da storici) il fondamentale capitolo del Risorgimento siciliano, rilevandone i paradossi e le inevitabili imposture. Consolo fa altrettanto con una punta di soave ironia però, che è mancata, e pour cause, ai suoi predecessori. Cominciamo da Il più bel monumento,24 che ricostruisce la curiosa vicenda della costruzione, sempre procrastinata, del monumento a Garibaldi che la cittadina di Marsala decide di erigere, solo nel 1978:
La notizia ci giunge da Marsala. Ricordate? Il porto di Allah, il vino Marsala, i Mille e Garibaldi. E proprio a quest’ultimo, al gran Condottiero, si riferisce la notizia. Scrive un quotidiano siciliano, in data 18 febbraio 1978: “L’eroe dei due Mondi e i suoi Mille avranno un’opera alla memoria nella città che lo vide sbarcare 118 anni fa…” Un’opera alla memoria è un monumento che la Regione siciliana ha deciso di erigere, finalmente in quella città, affidandone l’incarico allo scultore Giuseppe Mazzullo. Chi avrebbe sospettato che proprio Marsala non avesse mai eretto un monumento all’eroe? Marsala, che lo accolse per prima quella mattina dell’11 maggio del 1860, barbuto e biondo capellone, caciotta ricamata in testa, camicia rossa, poncho e sciabolane, già eroe, già storico, già monumento?25
E poi arrivò Bixio, l’angelo della morte è un altro racconto assai istruttivo che non solo ricostruisce, ma mette in relazione, in modo storicamente impeccabile, da un lato la vicenda della concessione, da parte di Ferdinando I, di alcuni feudi del Brontese (i feudi del convento benedettino di Santa Maria di Maniace, del comune di Bronte e dell’Ospedale di Palermo) nonché del titolo di Duca all’ammiraglio Nelson, per ringraziarlo dell’aiuto prestatogli durante la repressione della Repubblica napoletana nata il 22 gennaio 1799, e, dall’altro, la vicenda della strage di Bronte del 2 agosto 1862, provocata, tra l’altro, dall’usurpazione delle terre demaniali da parte della Ducea a danno dei contadini. Questa strage, come è noto, verrà ferocemente repressa da Bixio non senza, almeno a quanto afferma Benedetto Radice, il precedente accordo concesso agli inglesi da Garibaldi per soffocare la rivolta di Bronte.
Piccolo grande Gattopardo26 è il titolo-calembour di un racconto spiritoso e nostalgico. Un ricordo del grande poeta Lucio Piccolo cugino dell’autore del Gattopardo. Consolo rimemora il suo primo incontro col poeta, seguito da numerosi altri:
Frequentai Piccolo per anni, andando da lui, come per un tacito accordo, tre volte la settimana. Mi diceva ogni volta, congedandomi: «Ritorni, ritorni, Consolo, facciamo conversazione». E la conversazione era in effetti un incessante monologo del poeta che io ascoltavo volta per volta ammaliato, immobile nella poltrona davanti a lui. Era per me come andare a scuola da un gran maestro, a lezione di letteratura, di poesia, impartita da un uomo di sterminata cultura, “che aveva letto tous les livres nella solitudine delle sue terre di Capo D’Orlando”, come scrisse Montale. Piccolo, dopo l’esordio dei Canti barocchi, aveva suscitato molte curiosità fra i letterati. E lì, nella sua villa, si erano recati per conoscerlo in tanti: Piovene, Bassani, Pasolini, Bernari, Camilla Cederna, Corrado Stajano, Vanni Scheiwiller, Alfredo Todisco… Con Salvatore Quasimodo mi feci io promotore dell’incontro. Nel salone della villa, Quasimodo rimase incantato ad ascoltare Piccolo, ma uscendo, appena giunti nella corte, esclamò, come indispettito, giocando sul nome del barone: «Questo piccolo poeta!»
24 «La Stampa», 9 aprile 1978, ivi, pp. 70-72.
25 Ivi, p. 70.
26 «L’Unità», 11 agosto 2004, ivi, pp. 210-214.
Nel 1963 avevo pubblicato il mio primo romanzo nella mondadoriana collana “Il tornasole”, La ferita dell’aprile, scritto in un linguaggio quanto mai lontano da quello aulico e ricercato di Piccolo. Glielo diedi da leggere e, chiedendogli poi il giudizio, «Troppe parolacce, troppe parolacce!» mi disse.27
Consolo si ricorderà ancora dell’incontro tra Sciascia e Piccolo, sempre combinato da lui, e quindi di quello fra Pasolini e Piccolo avvenuto a Zafferana nel settembre del 1968, in occasione del premio letterario Brancati:
Pasolini, in quei giorni, girava, sulle falde dell’Etna, alcune scene del suo film Porcile. E aspettava con ansia l’arrivo dell’attore francese Pierre Clementi. Il quale arrivò finalmente, là all’albergo Airone dov’eravamo ospitati. Arrivò nella sala da pranzo in compagnia di Pasolini. Io ero al tavolo con Piccolo, il quale, alla vista di quel bellissimo giovane con i capelli fluenti fin sopra le spalle, meravigliato, esclamò: «Cos’è, una donna coi baffi?».28
La mia isola è Las Vegas29 che dà il titolo all’intero volume è un testo tra i più recenti, del 2004, un testo di appena tre pagine attraversato da un’amara e sferzante ironia, che volge uno sguardo sulla Sicilia, ma anche sulla Lombardia, ormai del tutto disincantato, che esclude financo il ricordo dell’isola come di un’immaginaria Arcadia, di un rifugio della e nella memoria. Consolo vi proietta una sorta di derisoria distopia per la quale, se avesse vinto Il Movimento indipendentista siciliano di Finocchiaro Aprile, la Sicilia sarebbe diventata la 49sima stella degli Stati Uniti d’America. Quest’isola in mezzo al Mediterraneo in mano agli americani sarebbe affogata nell’oro. Sarebbe diventata, l’Isola, con casinò, teatri, i più liberi commerci, come Las Vegas o come la Cuba del beato tempo di Fulgezio Batista.30
Mi ha particolarmente colpita in questo racconto l’uso di un termine che non ricordo di avere letto in altre pagine di Consolo. Si tratta della parola «matria» che lo scrittore affianca a «patria» («Sicilia, Sicilia mia, mia patria e mia matria, matria sì perché è lei che mi ha dato i natali, mi ha nutrito, mi ha cresciuto, mi ha educato. Ora sono lontano da lei e ne soffro, mi struggo di nostalgia per lei»).31 Ebbene sul momento ho pensato a un neologismo (è anche un neologismo ovviamente), ma, dalla ricerca effettua sulla LIZ, matria ricorre solo due volte in due lettere di Torquato Tasso. Nella lettera spedita da Ferrara il 7 giugno 1585 a Giulio Caria, Napoli:
Né io son ben sicuro, quanto a gli altri sieno piaciuti i miei poemi; perché con niun altro argomento mi poteva meglio esser dimostrato, che con gli effetti. Ma se Vostra Signoria è un di coloro i quali n’abbiano preso alcun diletto, ne godo fra me stesso per molte cagioni; de le quali è la prima, ch’ella sia di quella nobil patria de la quale io mi vanto; e potrei gloriarmene più ragionevolmente, s’io la chiamassi la mia cara matria32, secondo l’usanza antica di Creti.
In quella spedita da Roma il 6 dicembre 1590 a Francesco Polverino, Napoli:
27 Ivi, pp. 211-212.
28 Ivi, p. 213.
29 «La Sicilia», 15 agosto 2004, ivi, pp. 215-217.
30 Ivi, p. 217.
31 Ivi, p. 215.
32 Corsivo mio.
Perciocché una patria medesima può congiungere tutti gli animi, quantunque per altro alienissimi: e bench’io non fossi de l’istessa, nondimeno è noto a ciascuno che fu patria di mia madre, e di tutti i miei materni antecessori; laonde posso chiamarla, con le voci di Platone, “matria”33 almeno. E non essendo nato sotto altro cielo, né cresciuto in altro seno più lungamente, o più felicemente, ch’in quel de la città di Napoli; non fo deliberazione di lasciar in altra parte l’ossa già stanche di più lungo viaggio, o di più lungo travaglio. Ma io supplico che mi sia lecito di ritornarci […].